#fotografia astratta
Explore tagged Tumblr posts
Text
“Il Giardino Segreto: Ri-Frazioni” – L’arte fotografica si svela al Bio Café di Alessandria
Un evento tra fotografia e riflessione artistica. Sabato 1° febbraio 2025, alle ore 10:30, presso il Bio Café di Alessandria, verrà inaugurata la mostra fotografica collettiva “Il Giardino Segreto: Ri-Frazioni”.
Un evento tra fotografia e riflessione artistica. Sabato 1° febbraio 2025, alle ore 10:30, presso il Bio Café di Alessandria, verrà inaugurata la mostra fotografica collettiva “Il Giardino Segreto: Ri-Frazioni”. L’evento, parte del progetto��Arte Diffusa promosso dall’Associazione Culturale Libera Mente – Laboratorio di Idee, vede protagonisti il fotografo Daniele Robotti e gli allievi del corso…
#Alessandria arte diffusa.#Alessandria cultura#Alessandria eventi culturali#Alessandria mostre 2025#Alessandria news#Alessandria today#Arcobaleno Salvina Corridore#arte al Bio Café#arte contemporanea Alessandria#Arte Diffusa#Arte e Fotografia#Arte e Natura#artisti emergenti Alessandria#Bio Café Alessandria#colori e geometrie#Connessioni In-Visibili#Daniele Robotti#Daniele Robotti docente#Daniele Robotti fotografie#esposizione Alessandria 2025#esposizioni Bio Café#esposizioni fotografiche Alessandria#essenze di forme#Filippo Scarone#fotografia Alessandria#fotografia astratta#fotografia d’arte Alessandria#fotografia Fine Art#Giovanna Vivaldi#Google News
0 notes
Photo










Luigi Veronesi
saggio critico di Luciano Caramel
Fotografie di Giovanni Ricci
Nuove Ed.Gabriele Mazzotta, Milano 1992, 94 pagine, 22 x 24 cm, ISBN 9788820210298
euro 35,00
email if you want to buy :[email protected]
copia firmata con dedica da Luigi Veronesi 1992
mostra galleria ARTE 92, Milano 26 marzo - 30 maggio 1992
Luigi Veronesi nasce a Milano nel 1908.Si iscrive all'istituto tecnico, segue un corso per disegnatore tessile e studia pittura sotto la guida del professor Violante. Mentre approfondisce le sue cognizioni matematiche e fisiche che saranno fondamentali per comprendere l'insieme della sua opera, si avvicina agli artisti che gravitano attorno alla galleria milanese Il Milione dove, appena diciassettenne, espone per la prima volta opere influenzate da Sironi e Modigliani. Si avvicina, anche grazie all'amicizia con Léger conosciuto a Parigi, all'arte non figurativa aderendo nel 1934 al gruppo "Abstraction-Création" e contemporaneamente lavora con la rivista "Campo Grafico". Evidenzia subito interessi molteplici: i lavori grafici lo porteranno a collaborare con le riviste "Casabella" e "Ferrania", la pittura astratta lo avvicina alla musica (alle sue "Quattordici variazioni di un tema pittorico" del 1939 si ispira Riccardo Malipiero con le "Quattordici variazioni di un tema musicale") mentre la fotografia comincia a emergere con tutta la sua forza espressiva. Molte sono le ricerche realizzate tra gli anni Trenta e Quaranta sia in bianco e nero che a colori sperimentando ogni genere di tecnica con una particolare attenzione ai fotogrammi. Nel 1947 entra a far parte del gruppo fotografico "La Bussola" e ne firma il manifesto programmatico, l'anno dopo del MAC ("Movimento Arte Concreta"). Negli anni Cinquanta e Sessanta riceve i primi importanti riconoscimenti (premi per le più diverse attività, partecipazioni a Biennali come quelle di Venezia e San Paolo, mostre personali in Italia e all'estero) e inizia la sua attività didattica all'Accademia di Belle Arti di Brera e poi alla Nuova Accademia di Milano. Negli anni Ottanta e Novanta al rinnovato interesse per la fotografia si accostano interventi di arti applicate con affreschi, progetti di piazze, interventi grafici in esterni. Luigi Veronesi muore a Milano il 25 febbraio 1998.
07/03/23
orders to: [email protected]
ordini a: [email protected]
twitter: @fashionbooksmi
instagram: fashionbooksmilano, designbooksmilano tumblr: fashionbooksmilano, designbooksmilano
#Luigi Veronesi#mostra galleria ARTE 92#Luciano Caramel#copia firmata con dedica#art exhibition catalogue#art books#fashionbooksmilano
3 notes
·
View notes
Text

Ben che si registri un indizio di nuvolare sfilacciamento, in cielo.
E di tramuale rugosità, sul muro.
Più ancora, che un passero rilasci sua ombra.
Perché è matericità su astrazione.
Curioso, no?
E' talmente mirabilmente astratta, la fotografia di Michael Hill, che si tende principiare da quest'ultimo concetto, piuttosto che dalla letteralità della scena.
Si cerca materia su concetto, anziché concetto su materia.
Onde appurare se lo spirito deriva dalla carne, intendo.
Del resto c'è un ulteriore accenno di carnalità.
E' come gioca la luce sul supporto dei fari.
Accarezza il metallo, la luce, su quei tronchi di cono.
Lo fa con voluttà, che s'esprime in avviluppanti progressive gradazioni.
Ma il resto è nitore, cartesianità, concinnitas.
Il resto che è molto più del resto.
E' totalizzante cifra, eppiuttosto.
Grazie Michael.
Ispiratamente dimostri cosa la Fotografia può, nel prosciugare con Poesia.
All rigths reserved
Claudio Trezzani
0 notes
Text
Più a lungo osservate una cosa, più astratta vi apparirà e, ironicamente, anche meno reale.
Ok. Detto da un campione del cosiddetto realismo magico non fa una piega; però poi vai a spiegare al realista documentario che una fotografia - per gli stessi motivi - è sempre astratta e irreale, pur se vera.
It's ok. Nothing to say against this statement since it comes from a champion of the so-called "magical realism". But then it's harder to explain to the supporter of documentary realism that whichever photograph is - for the same reasons - always abstract and unreal, in spite of its truthfulness.
"The longer you look at an object, the more abstract it becomes, and, ironically, the more real" -Lucian Freud
137 notes
·
View notes
Text
OSTINATO ASTRATTISMO
gialloesse fotografia ostinatamente astratta

View On WordPress
0 notes
Text
Evento internazionale del Primo Premio conferito a Filippo Papa, di Elisa Mascia
Con l’arte e la fotografia si vola lontano, assegnato a Filippo Papa FILIPPO PAPA 1° PREMIO ARCHITETTURA ASTRATTA AGLI INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2023 Filippo Papa artista eclettico e versatile conquista un riconoscimento importantissimo a livello mondiale, il suo progetto fotografico dal titolo “Omniscient” presentato in una mostra esclusiva a Venezia all’interno della Biennale Amedeo…

View On WordPress
0 notes
Text
Il drago, nelle fiabe, ha un aspetto terribile. Quello di un serpente alato con molte teste e lingue biforcute, di solito, oppure quello d’una gigantesca lucertola con pupille di fuoco e artigli d’acciaio. Si nutre di vergini e di giovinetti, espelle fumo dalle narici, divora chiunque si avvicini al ponte che protegge il suo reame; […] Nella vita la sua essenza non cambia ma il suo aspetto è diverso. A volte non lo si può neanche definire perché simboleggia una realtà astratta, una situazione che esiste ma non si vede. A volte, non lo si può neanche riconoscere perché si presenta come una persona, cioè un corpo normale, un tronco con due braccia e due gambe, una testa con un naso e una bocca con due occhi. Oriana Fallaci – Un uomo
📷 Ph Jack Davison
5 notes
·
View notes
Text
Il reale e l’immaginario
di Enzo Carli
-- Omaggio a Mario Giacomelli nel ventesimo della sua scomparsa.
Carichi di significati immensi, i dolori e i pensieri della terra sono il motivo delle fotografie di Mario Giacomelli, immagini come farfalle, dietro il vetro di una macchina fotografica. Un’infanzia breve ma che lo ha sempre nutrito; l’idea si fa pensiero itinerante della sua anima e fin dall’inizio la sua è una relazione con il fluire del tempo in un rapporto interiore come riflessione, lamento, diario. Un tempo che Giacomelli tenta di fermare come estensione e giustificazione della memoria. Immagini come autoanalisi, come specchio della sua stessa esistenza, come il “senso” del tempo. La fotografia come rievocazione di interessi che spaziano come contraddizioni, come scelta morale e culturale. Vive nel riscatto di una realtà, forse evocata, forse segnata dalla memoria e dal ricordo, nelle sue pieghe, nei suoi interstizi, nella materia e nei suoi umori, nel riscatto della forma, e nelle sue stagioni, la gioia della creazione e della conoscenza. È attratto da tutto quello che non si può esprimere con le parole della poesia, da tutte quelle vibrazioni che suscitano interrogazioni. La sua fotografia, attraverso il ricordo, con la forza della sua verità, comunicazione, realizzazione e trasformazione, permette una più ampia conoscenza di sé stessi e “…è bello pensare che tutto ciò può essere anche ricreato, trasmesso con i mezzi della nostra civiltà”.
Una sorta di operazione mimetica che pur mantenendo in sé la caratteristica del reale, spazia nel vuoto mentale più spinto. Egli vuole isolare, reificare i reperti emozionali della memoria per concretare il senso e idealizzare l’essenza. Il rapporto che ha con le immagini non è intendiamoci quello del riscatto semantico o di provocare un’operazione estetica (che ne è solo la conseguenza), bensì di essere dentro la sua costruzione, manipolando il ritorno alle cose, costruendo e modificando l’autenticità del referente; il reale immaginato con il pretesto del reale ricostruito. Insomma il rapporto che instaura con le sue immagini è quello non solo del vedere, ma dell’agire, dell’operare con esse, del ritorno alle cose.
Le immagini sono legate da frammenti, tasselli, fili invisibili, dal ritmo modulare in un progetto globale; sia come tentativo romantico per sottolineare l’ancoraggio alle antiche memorie, sia come tentativo vitale, pieno di confuse essenze e di odori recenti, per recuperare l’esistenza. La natura è spesso adottata come matrigna sontuosa, portatrice di un pattern eroico, quello della compenetrazione delle entità e degli umori, quello dello stato puro, della vibrazione all’unisono con le cellule antropiche in un tutt’uno trionfale e benigno (Spoon River). Ma la natura si mostra ferita dalla terribile potenza devastatrice che è quella dell’uomo che ha dimenticato i suoi cicli e le sue stagioni; ecco che il riscatto di Giacomelli che la ritorna vissuta e interiorizzata per placare il fluire del tempo che ha sconvolto ritmi e passioni (Il cantiere de paesaggio).
Nelle immagini umane di Giacomelli c’è sempre questo senso di estetismo dell’angoscia che non è né morale né sociale: è il grido interno dell’uomo che si coniuga con i suoi simili, è il lamento che dà il volto tra intrecci e sovrapposizioni, come si formasse da una nebulosa variegata che mentre appare, per strati, compone l’immagine; sono più campi, più spazi convergenti verso un nucleo focale che anticipa con la sua estrema percezione, il formarsi dell’immagine (Motivo suggerito dal taglio dell’albero come i Paesaggi come le trame nei volti dei Vecchi dell’ospizio).”La vertigine giacomelliana”, potenza psicologica, è astratta per i personaggi del racconto; essi la vivono come uno stato del mondo non negativo, pur apparentemente drammatico, come incomprensibile presenza (Lourdes, l’Ospizio).
Nell’operato di Giacomelli c’è un’irresistibile espansione dinamica interiore che trasferisce nelle immagini, apparenti disordini (Favola per un viaggio verso possibili significati interiori - ferri ritorti) o sono percezioni, tracce della memoria come i Pretini (Io non ho mani che mi accarezzino il volto) che sono collocati un uno spazio fuori dalla gravità e dalla materia, in un etere impalpabile che li pone sospesi, evanescenti e fluttuanti.

© Mario Giacomelli, da Io non ho mani che mi accarezzino il volto, 1961-1963
Un Giacomelli che supera anche l’enfasi di una gestuale teatralità (Ho la testa piena mamma – Il teatro della neve) o il provocante repertorio di lacerazioni e ferite (La terra che muore; Il taglio del bosco). Ora spegne la materia, la imbriglia nei muri opachi, rigidi che si espandono su schemi geometrici, aridi, secchi. L’atteggiamento è mutato, non partecipa più alla vitalità della materia, la lascia congelare nei suoi inevitabili processi organici mentre genera come fosse spinta inerziale, il movimento. Un consapevole intervento mentale che privilegia un progetto di genesi antropologica dove Giacomelli partecipa mimando, intervenendo sulla forma che assorbe l’ambiente, attraverso un tentativo, sconcertante, di intervenire, di animare attraverso il dinamismo gestuale, di proporre cioè nuove forme di vita.
Giacomelli rigenera le immagini servendosi di esse per collocarle in una nuova dimensione della memoria, imprimendo loro quella energia, alimentata dalle passioni essenziali con cui si coniuga al mondo, necessaria a farle vivere come vorrebbe, forzandone palesemente i tempi e gli schemi di sviluppo”… …Fotografare non è solo realtà o impegno politico; io cammino per un’altra strada, con queste immagini (Passato, serie ispirata da una poesia di Vincenzo Cardarelli e dedicata alla Madre del fotografo, morta nel 1986) rimetto tutto in discussione. Voglio rifotografare per riprendere le cose morte e dare loro la vita; voglio rinnovare me stesso nelle contraddizioni per non ripetermi. Non cerco solo di capire la natura bensì di viverla…Vorrei che si tenesse conto del fatto che mi sono servito della terra, dell’immaginazione, degli stati d’animo…e che la macchina fotografica è un filtro tra la realtà e l’immaginazione, non uno specchio…..Alcune mie foto sono volutamente equivoche nel senso che ho percepito attraverso queste immagini qualcosa che c’è dentro la poesia; alcune foto sono la memoria della memoria; le cose sono più vecchie o più giovani e le stampe sono sfarinate dal tempo per ricreare il tempo…”.
Le idee liberano le azioni e Giacomelli, percorso da intense pulsioni, feconda la materia all’inizio del ciclo inoculando archetipi animati e mossi che provocano gli effetti sgranati e mangiati delle immagini; tende a riproporre aspetti e forme con attenzione e affetti inediti, a volte sconvolgendo con allarmanti tecniche di ingrandimento (estraniamento e de contestualizzazione) e calando le immagini in atmosfere spettrali e rarefatte dove le stesse presenze allucinanti, vengono plasmate di propria vita si generano dal caos mentale quali forme imitative della realtà.
Giacomelli è stato sempre coinvolto dalla madre terra; dalla fascinazione e amore per la natura e l’ambiente; i suoi paesaggi, le sue terre sono lacerate, lavorate, ferite e grondanti di materia. Questi suoi immensi paesaggi-territori a loro modo esercitano un fascino sensuale e richiamano abrasioni quasi carnali; piatti paesaggi che sembrano impressi direttamente sulla lastra, schiacciati, senza dimensioni e confini richiamano un’epidermide segnata. Natura e cultura si compenetrano, manipolate dal filtro interiore dell’anima, che penetrando nei suoi pertugi, nelle sue pieghe e nei suoi meandri, ci presenta luoghi quasi umorali, densi di sensazioni, brividi e piaceri essenziali.
Giacomelli anima questi paesaggi con la cultura del saggio contadino che ha un rapporto di totale integrazione con la madre terra: egli ara, asporta, taglia, fende, incide, livella, scava ed ecco le trasformazioni come sintesi finale, abbraccio e vertigine ed è tutto l’universo che partecipa, che geme, si concentra e si anima.
La saga magica “La buona terra”, nasconde ancora il trascorrere quieto delle stagioni dove ogni cosa ha il sapore dell’antico rituale e nello stesso tempo del documento popolare come espressione ancora di un nuovo rapporto cultura/natura: il matrimonio sull’aia, il raccolto, la vendemmia, l’uccisione del maiale, i bimbi che giocano sul cortile, la sera tutti raccolti nel calore del camino. Giacomelli con spirito candido e naif fa parlare con le sue immagini la natura di sempre, quella della sua memoria o della memoria dei suoi avi. Tutta la costruzione è impeccabile, pulita, senza violenze; l’uccisione del maiale è l’apoteosi del rituale, il sacrificio obbligato di una vita piena di concretezza esistenziale dove non c’è spazio per gli stereotipi culturali o per le contaminazioni esistenziali che non siano quelle primitive, austere, pulite, forti e sicure proprie della natura nella natura.
La fotografia di Mario cerca sempre di ritrovare il rapporto con la libertà. Attraverso la sua inerzia poetica e contemplativa, cerca di riscoprire le cose leggendole non per il verso solito o per il loro comune aspetto, ma interpretandole e restituendole in altre angolazioni di lettura introducendo nuovi elementi linguistici: i bianchi bruciati, i neri aperti e organici, il mosso, il rallentato, lo sfocato. Si affida alle sue sensazioni, al suo sentire, al suo vedere e percepire. La contemplazione di sé, delle cose dentro e fuori, gli permette di cogliere attimi intensi della vita psichica e relazionale; le segrete ossessioni, il suo delirio d’amore, il suo disgusto, la sua nausea, il suo dolore producono effetti combinati che gli permettono di reinvestire entropicamente forme di energia che usualmente vanno disperse.
In procedimenti del genere sta il succo della “nuova oggettività”: ritrovare come è dovere di ogni ricerca artistica l’autenticità dei rapporti con tutti gli aspetti della vita e della creatività.
Giacomelli sa affrontare temi pesanti e gravi, riportarli nella loro essenza poetica, dignità e sensibilità, senza incorrere nel rischio del retorico ideologico o in stilemi accademici. Rifugge dalle presunzioni; sa bene che non si può chiudere un periodo, che esistono aldilà dei corsi e ricorsi, sintomatiche influenze, che il già visto o il già fatto appartengono alla nostra memoria storica culturale.

© Mario Giacomelli, da La notte lava la mente, 1994-1995
Gli annebbiamenti, le dissolvenze, le alterazioni servono per recuperare alcune funzioni di un tempo che Mario chiama in causa quando gli diventa vitale respirare quell’aria. Ecco l’artificio e l’incantesimo; un Giacomelli presente in un tempo indifferente, cattura le immagini, il loro “corpus”, se ne impadronisce, le filtra con la macchina del tempo da dove riescono ectoplasmi evocati e materializzati sulla tela- carta sensibile; affronta il problema del movimento tirando e allungando i soggetti, caricandoli di bianchi bruciati per sfocarli poi nelle linee di contorno che delimitano i soggetti creando degli strani effetti cinetici. Una sorta di “scatto esistenziale” che sottrae i soggetti all’immobilità prolungata della posa, alla staticità della morte, fornendoli di nuova attualità e presenza, reificati dal loro originario valore. Così negli altri procedimenti; la distanza ottica volutamente sbagliata, lo sfocato, il mosso, il rallentato producono effetti sorprendenti e ci avvicinano di più al grande universo di Giacomelli: nel volto della vecchina all’ospizio le rughe e le trame dello scialle propongono un’unica texture, facendoci perdere d’impatto la nostra sicurezza dell’estetica delle forme chiare e distinte; in più questa nuova oggettivazione simbolica si lega al paesaggio, alle pieghe della terra, alle figure che emergono dal taglio dell’albero.
Si ripete in Giacomelli (Il teatro della neve) la necessità di riprendere particelle fotografiche spogliate di ogni referente semantico e di riproporle in una trascrizione di realtà e immaginazione carica di nuovi significati. Con il procedimento di ingrandimento, nella sua nuova riproposizione, cadono tutti i referenti di realtà e gli stati dell’immaginazione vengono liberati su questa nuova acquisizione di territorio e di spazio. Così un particolare di un vecchio pavimento – e non a caso della sua tipografia- diviene uno stupefacente paesaggio che acquisisce propria promozione ontologica ed estetica, liberato da ogni sistema di riferimento e provenienza. Questa voluta trasformazione dell’immagine da particolare banale in nuovi campi di interpretazione e di sensazioni, fanno cadere ogni nesso con il referente reale. Giacomelli, aprendoci a nuove dimensioni di conoscenza, per proporci il suo reale immaginario, in fondo opera con il procedimento inverso di trasferimento reale: il sortilegio si compie in camera oscura dove tutto viene trasformato, filtrato dalle sue pulsioni e dalle sue emozioni. Un reale immaginario tanto più magico quanto più comune è la provenienza delle immagini.
Giacomelli cavalca le sue intense passioni e propone nuovi procedimenti senza mai rinnegare l’effetto di fotografia e cioè della restituzione sul materiale sensibile di un reale sia pure trasformato ed elaborato; una sorta di recupero della scrittura della luce in un’accezione polivalente, interdisciplinare, contemporanea con l’arte e la cultura.
Voglio sinceramente augurarmi che Mario Giacomelli sia ora e per sempre nella “realtà inutile della poesia”, quel luogo che non ha mai smesso di cercare, e dal quale tornava ogni volta con i racconti dell’anima.
Per non dimenticare, libo a te con una coppa di vino rosso, il sangue della tua terra (quel Lacrima di Morro d’Alba che tanto amavi). Ave atque vale caro e amato Maestro
-----------

Enzo Carli, Jean-Claude Lemagny e Mario Giacomelli, 1995
Biografia essenziale:
Enzo Carli, sociologo, giornalista e fotografo per vocazione e necessità ha organizzato e partecipato a mostre, dibattiti e convegni sulla fotografia in tutt’Italia e all’estero. Affettuoso allievo e amico di Mario Giacomelli è stato consulente per Enti Pubblici e Privati e direttore artistico del progetto Europeo di Fotografia Human work con Italia, Germania, Spagna e Romania. Già direttore della scuola di restauro della Provincia di Ancona , è stato docente di cultura e sociologia della Fotografia all’Università di Camerino –facoltà di architettura- e di Fotografia per la moda all’Università di Urbino-Dipartimento di Comunicazione- già Direttore del Dipartimento Comunicazione della FIAF ha partecipato come consulente per conto della Biblioteca Nazionale di Francia, BNF, alla mostra internazionale su Mario Giacomelli-Metamorfosi e come coordinatore del catalogo critico ce per la mostra di Giacomelli a Tokio, Museo della Fotografia/Galerie Berthet Paris. Coordinatore del gruppo fotografico I fotografi del Manifesto dal 1995 al 2008, delle verifiche e le relative mostre e manifestazioni a livello nazionale è stato insignito del Premio nazionale di fotografia Gentile da Fabriano 2013 per il Manifesto Passaggio di Frontiera, del Premio nazionale della Critica, Nettuno Fotofestival 2015 e del premio internazionale Nicola Ciletti per la didattica della fotografia 2020. Autore di numerose pubblicazioni di cultura, storia e didattica della fotografia (Fabbri Edizioni, Alinari, Charta, il Lavoro Editoriale, Gribaudo, Adriatica Editrice, Quattroventi, Istituto Poligrafico,Mediateca delle Marche, Comunità Europea, Lussografica,Regione Marche, Musinf, Ideas, Metropolitan Museum of Photography di Tokyo, Ed. NADiff conversation, Japan ecc.) ha esposto le sue fotografia in Italia e all’Estero. Durante l’inizio della pandemia è stato direttore artistico di ViVi, Fotografia Virtuale. Collabora a Fotopadova dal 2016.
5 notes
·
View notes
Photo

finestra della mensa. #abstract #art #abstractart #photography #lamp #window #flowers #fotografia #astratta #finestra #lampione #fiori #photovogue #back2thebase #casadiringhiera #riccardodelfantiphotography #riccardodelfantifotografia
#fiori#lampione#back2thebase#flowers#fotografia#photovogue#lamp#abstract#astratta#finestra#photography#window#abstractart#casadiringhiera#riccardodelfantiphotography#riccardodelfantifotografia#art
2 notes
·
View notes
Text
Corpo digitale
Premessa: io mi occupo d’arte non di Corona, per cui mollate il colpo ossessionati dalla paura, dal fermo macchina o quant’altro: fuori di qui. Già da tempo, molto prima che impazzasse il virus, si capiva dove saremmo arrivati. Una questione che avrebbe bisogno di molte più pagine di questo foglio, ma che l’attuale situazione illumina di luce eccezionale. Ne approfitto.
Che lo schermo piatto non da oggi occupi una parte notevole delle giornate di tutti è incontestabile. Solo i lavoratori con le mani sono esenti da quest’abitudine, ma costituiscono una minoranza sempre più esigua (vista anche la diffusione di telefonini che fanno le veci del computer). Tutti gli altri passano gran parte della giornata con la faccia rivolta al piccolo o grande schermo, al punto che qualcuno parla addirittura di trasformazione antropologica. Gli stessi bambini infatti preferiscono i videogiochi ai giocattoli tradizionali (per non parlare dei “bambini che fummo”, che non ne possedevano ed erano costretti a costruirseli). La trasformazione antropologica quindi è già in atto. Ripeto cose stranote.
Che ne è dell’arte in questa situazione? Che nessuno si allarmi è già significativo. Abbiamo cominciato a subire la trasformazione già ai tempi della Pop Art, alla quale hanno posto un’ultima debole resistenza sia la Land Art che l’Arte Povera, ma il fiume è comunque uscito dagli argini e le immagini piatte sono dilagate in modo impressionante (il successo della fotografia come arte ne è una conseguenza). Fenomeno nel fenomeno, si sono moltiplicate tutte le operazioni possibili da una “pesca miracolosa”nel piccolo schermo: gli artisti sedicenti tali per la maggior parte si sono dedicati a questa pratica, felici di utilizzare il comodo mezzo e insensibili all’appiattimento delle loro percezioni.
Il primo ad aver puntato il dito sulla questione (e ad averle dato un esito artistico, a modo suo naturalmente, forse un po’ brusco, un po’ didascalico, con risultati che solo a dieci anni dalla sua morte sono arrivati a convincere il grande mercato) è stato Fabio Mauri (1970). Ma cerchiamo il punto. La differenza fondamentale che esiste tra ciò che lo schermo consegna al nostro organo visivo e ciò che vediamo fuori da esso in poche parole è questa: nel primo caso è diretta e nel secondo riflessa, nel senso che raggiunge da fuori l’oggetto che, reagendo, riflettendo la luce, consegna ai nostri occhi anche la sua forma e la sua distanza. La ricezione di queste invece, nel caso della luce degli schermi avviene per analogia, non si tratta più di sensazione diretta, ma mnemonica, cioè in qualche modo si frappone il cervello. Più sinteticamente: ciò che la luce emessa dietro lo schermo esclude sempre è il corpo dell’oggetto.
Colui che avrà già subìto la trasformazione antropologica farà un’enorme fatica a seguirmi, ma voglio ricordargli che l’ossessione per questa esclusione risale addirittura alla notte dei tempi e ha generato la matematica, il numero, il digitale appunto: non poter raggiungere il cielo stellato, ben prima di Pitagora, è all’origine del Mito, l’arte dei nostri padri. De Kooning, disperato, diceva: “le stelle del firmamento sono quelle che posso toccare con le mie mani sul cavalletto”.

L’arte, tutta l’arte, anche la pittura, per non parlare della scultura e dell’installazione, risulta privata di una sua potenzialità e non si tratta solo del tramonto dei così detti “valori plastici”, bensì della presenza del corpo vero e proprio, fatto naturalmente di peso e di distanza, oltre che di qualità di superficie. Non è qualcosa che un artista possa trascurare. Prima di tutto si perde, tutti perdono, il rapporto con l’arte che ci ha portato fin qui, quella del passato, anche del passato recente. E’ un fatto gravissimo di cui è addirittura impossibile valutare le conseguenze. Ma per rimanere all’immanenza, la virtualità dello sguardo ci priva in maniera sostanziale di qualcosa di cui è impossibile fare a meno, perché corpo non è una parola astratta, concettuale o virtuale, ma un insieme di qualità concrete rilevabili attraverso i sensi con i quali lo abbiamo sempre percepito. (Per dirci questo, tra l’altro, FM proiettava il Vangelo sul torace di Pasolini).

La cosa grave su cui voglio puntare l’attenzione è che tutti nei confronti di questo fatto dimostrano una sorta di ottundimento, di assuefazione inconscia (la trasformazione antropologica). Direi che è in atto una forma grave di dissociazione: si è persa la consapevolezza dell’importanza di tutti i sensi nel rapporto con un’opera d’arte. Potrei fermarmi qui, ma sono abbastanza vecchio per consentirmi di uscire finalmente dalle righe e dichiarare: che ne faccio del mio sesso? Che ne faccio del profumo di una capigliatura femminile nel momento supremo del coito? Cosa ne è della lingua a cui piace esplorare la superficie di pesca di una giovane pelle, del naso con cui assaporo l’odore delle sue pieghe? Nessuno ha mai pensato che è attraverso l’organo del tatto per eccellenza che si fanno i bambini, che è con quella operazione esclusiva che viene fuori un uomo completo di tutti i suoi cinque sensi? Bene, l’arte che privilegia la comunicazione attraverso la vista è anche tutto questo, è anche peso e distanza. In tre parole: corpo, corpo e corpo. Per converso, sarà un caso che la sessualità ha assunto un’importanza sociale così rilevante? Una dissociazione in corso, in favore di un unico senso, proprio quello escluso dall’arte!
Ci vorrebbe un volume per approfondire la questione e ce ne vorrebbe un altro per mettere in luce l’origine di questo disastro, le responsabilità di chi ha introdotto quel cuneo fra gli occhi e gli altri sensi, il cuneo cui accennavo sopra: il cervello, un certo tipo di cervello! Non parlo di Pitagora naturalmente: si tratta di una responsabilità condivisa, in qualche modo frutto di un’empasse che il pensiero più profondo ha subìto ormai più di un secolo fa. Sarebbe ridicolo ora fare nomi e cognomi. All’inizio di quello scorso un uomo di grande sensibilità aveva lanciato l’allarme, Tolstoi. Si è imboccata una china, raccogliamo i frutti messi in campo addirittura dall’Illuminismo, la sua Dialettica.
Ma per tornare a noi, all’attualità,l’arte, che già agonizzava grazie al Pop e al cosiddetto “Concettuale” (come se potesse esistere un oggetto artistico che non faccia pensare), con la distanza sociale, le lezioni digitali, gli smart phone a manetta e soprattutto il terrore di qualsiasi contatto, sta agonizzando. Il Corona, alleato della paura di vivere, di rischiare, gli darà il colpo mortale.
Amen
Ma alcuni bonzi si appiccheranno il fuoco in piazza.
FDL
2 notes
·
View notes
Photo

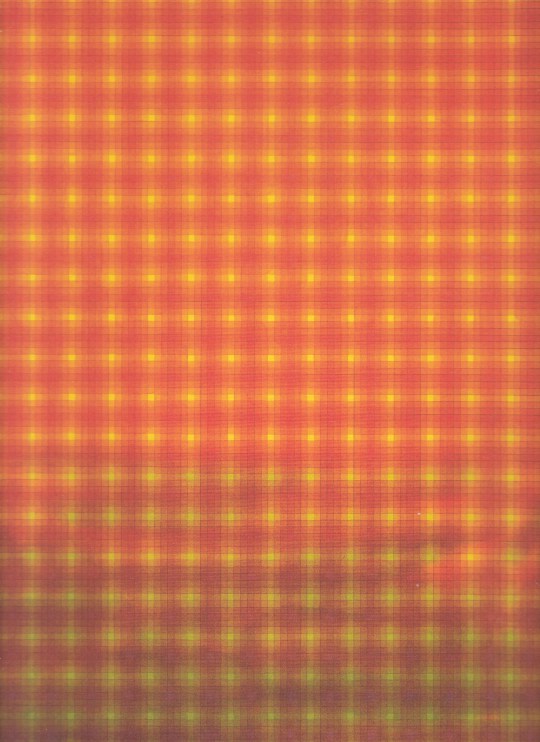

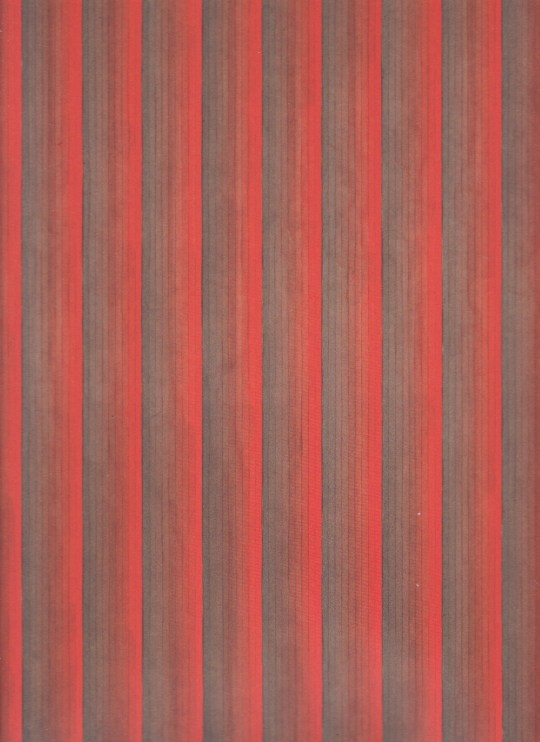
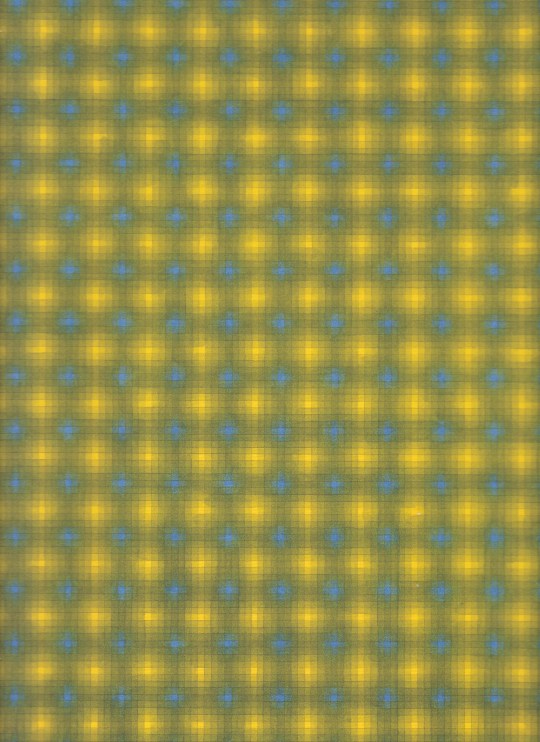


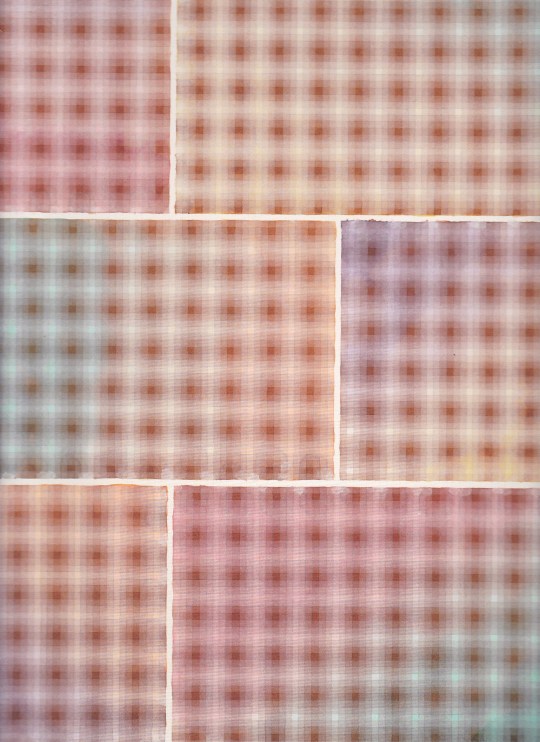
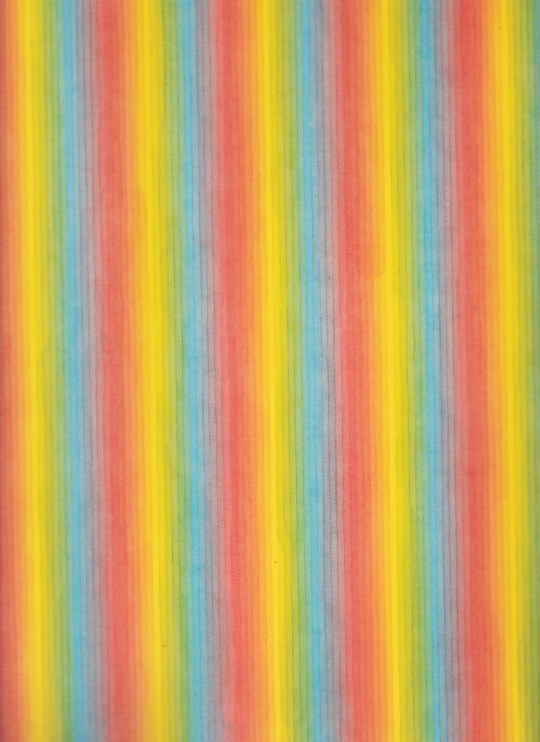
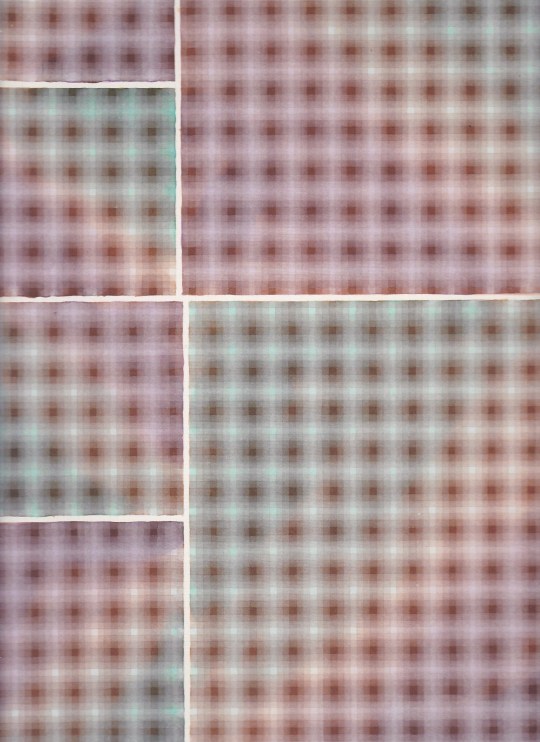
Peter Schuyff Quaranta
Forty Watercolors Amsterdam 03-05-2020
Edited by Wilfried Dickhoff & Stevie Guy
Text by Scott Griffin
wdpress, Berlin 2021, 88 pages, 82 reproductions, 40 x 30 cm, ISBN 978-3-9818181-6-1
euro 98,00
email if you want to buy :[email protected]
La carriera di Peter Schuyff in Italia inizia con una personale nella galleria di Lucio Amelio a Napoli nel 1987, stesso anno in cui a New York Leo Castelli decise di dedicargli una personale.
Peter Schuyff inizia a lavorare quando l’estetica postmoderna della società occidentale entra in crisi a causa di un pensiero che teorizzava l’impossibilità da parte della cultura pittorica e non, di creare una presa diretta sul mondo di allora perchè considerato ormai scomparso dietro precessioni di immagini. Questi cambiamenti portarono ad un allontanamento da quelle che erano le scelte teoriche e linguistiche del neoespressionismo che al centro del suo operato poneva il suo mondo interiore e il suo lavoro.
Si fanno strada in questo modo ricerche e protagonisti dell’arte fino ad allora considerati minori, che colgono l’occasione per adottare differenti mezzi espressivi: si va così dal concettuale, all’installazione alla fotografia e ad altre forme d’arte a svantaggio della pittura e della sua centralità.
Il movimento che vede coinvolto Peter Schuyff è un tipo di pittura geometrico-astratta che si contrappone in maniera netta agli ideali del neoespressionismo, al punto da creare una tendenza e un movimento a parte che si identifica per l’appunto con il nome di Neo-Geo. Tra i maggiori esponenti del movimento si ricordano Peter Halley ma anche Helmut Federle e in maniera minore, ma non certo per importanza, lo stesso Peter Schuyff.
Peter Schuyff esplora con le sue forme l’universo della geometria riscoprendone la sua reale poetica.
30/11/22
orders to: [email protected]
ordini a: [email protected]
twitter: @fashionbooksmi
instagram: fashionbooksmilano, designbooksmilano tumblr: fashionbooksmilano, designbooksmilano
#Peter Schuyff#Quaranta#Forty Watercolors#Neo-Geo#contemporary art books#wdpress Berlin#fashionbooksmilano
8 notes
·
View notes
Text




Abito talare dialoga con drappeggio senza epidermica presenza.
Abito talare dialoga con drappeggio con epidermica presenza (capo voltato ; indizio di mano).
Abito talare dialoga con drappeggio non senza umana espressione da frange corniciato.
Abito talare dialoga con drappeggio in presenza di gesto (mano delicatamente scosta frange).
Il processo è inverso rispetto a reificazione.
Perché l'essere umano esprime ipso facto vibrazione.
Ergo, la progressiva comparsa di fisicità par configurare un contrasto alla reificazione istessa.
Al fare dell'uomo cosa, intendo.
Ma la fotografia reca in nuce i crismi dell'astrazione.
Così, se un corpo è intellegibile sol pel suo rivestimento (senza evidenze d'animatoria senzienza) la summentovata reificazione si fa virtuosa.
Perché la danza avviene tra forme e colori, in una sorta di subliminarietà del segno.
Ecco, il segno.
Qui complica l'equazione, il segno.
Perché i paramenti denotano comunicazionale intenzione ch'esorbita l'istanza artistica.
Siamo dunque in presenza di pluriplanarità e proteiformità del visibile:
- l'interpretazione fattuale che si dà al contenuto (cerimonia)
- la traslazione astratta che scaturisce dal cullarsi tra forme e colori senza curarsi del simbolo
- la codificazione del succitato simbolo alla luce del significato che è convenzionalmente attribuito.
Ma l'umano, non sfugge.
Per definizione, esso vivifica.
Liricamente, vivifica.
Sì, alligna poesia, lì.
Mano scosta tenda.
Mano, o dito.
Il gesuita Marko Ivan Rupnik diffusamente dissertò sul non toccarsi degli indici, in Sistina.
Io m'occupo di fotografia, epperò.
E quando vedo palpitazione emergere da oggettualità, delibo l'afflato.
All rights reserved
Claudio Trezzani
0 notes
Photo

Claude Oscar Monet
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=699&biografia=Claude+Monet
“Donne in giardino (6) Decide di utilizzarla per una composizione all’aperto. Questa, infatti, è la prima sfida. La seconda sfida è rappresentare il movimento, la luce e lo spazio in modo omogeneo, dando l’impressione che la scena sia viva. Tra gli elementi caratteristici che richiamano alla pittura impressionistica di quel periodo sottolineiamo: la luce che svolge un ruolo predominante, l’uso del colore steso a tocchi e macchie e la sensazione visiva che regala una nuova idea di definizione degli oggetti e delle forme.
La colazione sull'erba (7) Dipinge un’opera che mostra la luce nell’attimo stesso in cui si pone sugli abiti, sui volti e sulla natura che circonda le persone protagoniste del dipinto.
Campo con papaveri (2) Il soggetto preferito dell’artista è la trasformazione della realtà che avviene con il cambiare della luce e con il passare del tempo. La donna in primo piano è la moglie di Monet, Camille, e il bambino è il figlio Jean. I due vengono raffigurati sia in primo piano nella parte destra sia nella linea dell’orizzonte seminascosti dall’erba e dai fiori. Queste due figure costruiscono una linea retta obliqua che struttura il quadro.
Lo stagno delle ninfee (3) Monet, ancora una volta, ci regala piccole e irregolari pennellate utilizzando macchie di colore e dipingendo uno scorcio della natura che risulta, agli occhi di chi l’ammira, impareggiabile. Le tonalità usate maggiormente dall’artista sono sicuramente quelle del verde, che si fondono tra loro creando una suggestiva ed unica sinfonia di colori. In sintesi, il dipinto regala agli occhi di chi lo vede, un senso di quiete e di riposante contemplazione.
Ninfee blu (8) La ricchezza dei dettagli, lo studio dei colori e l’attenzione quasi maniacale verso la luce e i riflessi che piante e alberi producono sull’acqua dello stagno, rendono la sua, una collezione di dipinti unici all’interno del contesto dell’Impressionismo. Il quadro non presenta un punto di fuga né un orizzonte. Monet, infatti, in “Ninfee blu” ricostruisce solo una parte dello stagno e concentra tutta la sua attenzione sui suoi particolari, sui dettagli che costituiscono quel quadrato magnifico in cui si posa il suo sguardo. E allo sguardo dello spettatore sembra che quella parte dello stagno sia infinita. La pennellata di Monet è libera e il risultato è un quadro quasi astratto. Ma la parte più interessante del quadro “Ninfee blu” è proprio questa, cioè la totale libertà di Monet nel rappresentare ciò che gli interessa e il suo sforzo nel trasformare il dipinto quasi in un’immagine astratta.
La Rue Montorgueil a Parigi. Festa del 30 giugno 1878 (5) La tecnica utilizzata da Monet è quella impressionista: in quest’opera le sue brevi e veloci pennellate servono proprio a descrivere l’energia che anima la festa. Le bandiere che sventolano da ogni finestra colorano tutta la strada e i colori sono quelli della Francia contemporanea. Questo dipinto, che sembra una fotografia e che immortala un pezzo di storia della Francia repubblicana, segna forse una linea di confine oltre la quale, simbolicamente e pacificamente, almeno per quel giorno, i francesi vedono arrivare la modernità.”
1 note
·
View note
Text

È una figura astratta, ed è un po' il concetto dell'astrattismo stesso. Nella forma puoi vederci quello che vuoi ed è nella forma stessa che trovi il significato. Questo concetto può essere considerato "il dettaglio", la cosa che non tutti notano. Io qui dentro ci vedo la natura, oscura nelle ombre, nitida nella luce.
Tante foto non nascono con il pensiero che poi andrò ad associargli. La fotografia è ciò che viene prima, istintiva e che colpisce. Dopo viene invece la didascalia, la riflessione e l'interpretazione del dettaglio raccolto istintivamente, quell'attimo che altrimenti sarebbe andato perduto. Il contenuto delle didascalie mi viene proposto dalla vita stessa, e può essere una chiacchierata, una canzone alla radio, parole rubate in treno da quelli che parlano qualche sedile più in là, o tante altre cose.
Dalle chiacchierate con R. che ringrazio tanto.
13 notes
·
View notes
Text
Discorso intorno alla fotografia del buco nero M87. Ovvero: i poeti devono riappropriarsi del cosmo. D’altronde, Pascoli cantava “le solitarie Nebulose” e Majakovskij voleva interrogare Einstein
Sembra l’occhio di Sauron, la pupilla che ti fissa dal fitto del cosmo, ti risucchia, con inesplicabile seduzione. Per alcuni è un anello che sta realizzando la sua forma, incandescente, ad altri pare la carezza di un angelo, l’ultimo amen prima dell’incomprensibile, la traccia dell’innocente sull’oscuro che smargina.
*
L’uomo, intendo, è impastato di linguaggio: le cose non esistono nella loro definizione ‘scientifica’, ma per la natura linguistica che le anima. Per questo, mi sembra irritante dare al buco nero appena fotografato – impressionante: fotografare il cuore di tenebra, fermare l’assedio dell’oscurità – e alla galassia che lo ammanta la didascalia M87. Facciamo una gara lirica a chi assegna, a questo occhio indimenticabile, il nome più bello.
*
Quando ero piccolo avevo un libro di mitologia greca e uno sul cosmo. Mi sembravano la stessa cosa. Il mito non serve a spiegare l’ignoto, il cosmo. Al contrario, serve a tracciarlo nella nostra mente, che è linguistica, e nella nostra carne, che è affettiva. L’uomo ragiona ancora per ‘storie’, non per incestuose cronache di logaritmi.
*
L’Event Horizon Telescope ha fotografato per la prima volta un buco nero: l’intuizione astratta di un uomo trova conferma nella natura del cosmo. Che raffinatezza. Il buco nero M87 si trova nel cuore dell’Ammasso della Vergine, che è costituito da 87 galassie visibili, molte delle quali si chiamano Leda, altre Virgo, ovviamente, con un numero identificativo al fianco. Tra poco chiamo Ian Solo e mi getto nell’improbabile.
*
Da bravo cristo, fiero della propria ignoranza, sfoglio il The Astrophisical Journal Letters, dove un articolo dettagliato, First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of Supermassive Black Hole. Intorno a questa idea dell’ombra del buco nero sarei pronto a scrivere un poema. Ci capisco poco, va da sé. Questo è l’esordio introduttivo: “I buchi neri sono una predizione fondamentale della teoria della relatività generale (Einstein 1915). Una definizione caratteristica dei buchi neri è il loro ‘orizzonte degli eventi’, un confine casuale nello spaziotempo da cui nessuna luce può sfuggire (Schwarzschild 1916)”.
*
Leggendo del buco nero e della profezia realizzata di Einstein, mi viene in mente quanto ricorda Roman Jakobson in quel libro miracoloso, Una generazione che ha dissipato i suoi poeti. “Nella primavera del 1920 tornai a Mosca, stretta nella morsa dell’assedio. Portai nuovi libri europei e notizie sul lavoro scientifico dell’Occidente. Majakovskij mi fece ripetere più volte il mio resoconto confuso della teoria generale della relatività… ‘Io sono assolutamente convinto che la morte non ci sarà. I morti saranno resuscitati. Troverò un fisico che mi spieghi punto per punto il libro di Einstein’. Per me in quell’istante si rivelò un Majakovskij completamente diverso: l’imperativo di una vittoria sulla morte lo possedeva… In quel tempo Majakovskij era preso dall’idea di inviare a Einstein un radiotelegramma di saluto: alla scienza del futuro da parte dell’arte del futuro”.
*
Majakovskij e Einstein: che incontro clamoroso sarebbe stato. Poesia e scienza, in effetti, sono uno. L’ascesa al cosmo la fa più la poesia che la scienza, perché l’uomo, ripeto, è una creatura linguistica, che ha i verbi nel sangue. Si costruisce una nave per atterrare sulla luna perché qualcuno, per secoli, la luna la ha cantata, la ha ‘creata’ con il linguaggio, con la poesia.
*
Che scienza e poesia siano abbracciate è un concetto limpido ai poeti. Lo sapeva Walt Whitman (“Amo lo spirito scientifico – essere sicuri ma non troppo, la volontà di abbandonare le idee quando le prove le contraddicono: questo è buono – mantiene le vie aperte – dà vita, pensiero, affetto, umanità, la possibilità di ritentare dopo un errore, dopo una ipotesi sbagliata”), lo ha ribadito Saint-John Perse dalla tribuna del Nobel: “è il pensiero disinteressato di scienziati e poeti che è onorato, qui. E qui almeno una volta non guardateli come fratelli ostili: stanno esplorando lo stesso abisso, varia solo il loro modo di investigazione… In verità, ogni creazione della mente è prima di tutto ‘poetica’ nel senso proprio della parola; e finché esiste un’equivalenza tra i modi della sensibilità e l’intelletto, è la stessa funzione che si esercita al principio nelle imprese del poeta e dello scienziato… Il mistero è comune, comunque. E la grande avventura della mente poetica non è in alcun modo secondaria rispetto agli avanzamenti, drammatici, della scienza moderna. Gli astronomi sono stati scossi dalla teoria dell’universo in espansione, ma non ve n’è di meno, di espansione, nella morale infinita dentro l’uomo, dentro il suo universo”.
*
Come si sa, Giovanni Pascoli è un poeta eminentemente ‘cosmico’, esaspera le necessità abissali di Leopardi. Ne Il ciocco, il più vasto dei Canti di Castelvecchio, Pascoli canta “le solitarie Nebulose”, “il folgorio di Vega”, la “cripta di morti astri, di mille/ fossili mondi”, “i Soli” che “la neve della Eternità cancella”. Pascoli è orientato alle galassie, ai mondi che nascono e si sfasciano, all’incredibile attualità dei tempi. La sua, va da sé, non è una descrizione ‘scientifica’, quella non serve: il poeta mette le ali alla scienza perché scorge il lembo dell’invisibile, solletica i misteri, dentro e fuori di noi, che poi altri, con altre armi, andranno a esplorare.
*
E poi? E poi c’è Montale, il grande tagliagole della galassia, che negli Ossi di seppia ci dice “Non domandarci la formula che mondi possa aprirti”, e allora il poeta si concentra sul suo ombelico, non più telescopico, non più microscopio che sonda i misteri dell’animo, ma piscina di una illustre non vita. Da Montale – un assoluto genio – ai poeti casalinghi nel proprio ego di oggi, si spalanca un buco nero.
*
Un bel libro divulgativo, Origini. Quattordici miliardi di anni di evoluzione cosmica (Codice, 2005), scritto da due scienziati, Neil deGrasse Tyson e Donald Goldmisth, conclude così: “Ogni nuovo modo di aumentare la conoscenza annuncia l’apertura di una nuova finestra sull’universo… Se ci imbarchiamo in questo viaggio non è per un semplice desiderio, ma per il mandato, conferitoci dalla nostra specie, di ricercare il nostro posto nel cosmo. Quello che abbiamo scoperto, i poeti lo hanno sempre saputo”. Il libro è serrato da una citazione dai Quattro quartetti di Thomas S. Eliot.
*
Sui giornali, oggi, intorno al buco nero, mi sarei atteso i versi di un poeta, che in quel buco, icona dell’insondabile, ci avrebbe gettato, a far pasto del mai visto. Invece. I poeti devono riappropriarsi del cosmo, perché il cosmo è una deflagrazione linguistica. (d.b.)
L'articolo Discorso intorno alla fotografia del buco nero M87. Ovvero: i poeti devono riappropriarsi del cosmo. D’altronde, Pascoli cantava “le solitarie Nebulose” e Majakovskij voleva interrogare Einstein proviene da Pangea.
from pangea.news http://bit.ly/2G4xjgt
1 note
·
View note
Photo

Esposizione di fotografia astratta su pannelli legno con aperitivo Sabato 10 Settembre 2022 ▪️Give your love and support my work. I have to show this message in the world. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Free Visual Art Academy https://www.ledameschools.com/ https://www.lucabrogi.com/ #ledameschools #lucabrogiartist #themuseumofmodernart #worldpressphoto #artbasel #ratedmodernart #art #contemporaryart #roozdaily #lucabrogiphotographer #artsy #saatchi_gallery #sothebys #whitecube #christiesinc #friezeartfair #saatchiart #abstract.mag #brooklynmuseum #centrepompidou #artspace #victoriamirogallery #frieze_magazine #installationmag #stoprape #endviolence #noviolencia #noviolenza (presso Peschino) https://www.instagram.com/p/CiN25FfsBH5/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#ledameschools#lucabrogiartist#themuseumofmodernart#worldpressphoto#artbasel#ratedmodernart#art#contemporaryart#roozdaily#lucabrogiphotographer#artsy#saatchi_gallery#sothebys#whitecube#christiesinc#friezeartfair#saatchiart#abstract#brooklynmuseum#centrepompidou#artspace#victoriamirogallery#frieze_magazine#installationmag#stoprape#endviolence#noviolencia#noviolenza
0 notes