#personificazione in poesia
Explore tagged Tumblr posts
Text
"Primule" è una poesia che celebra il risveglio della natura e il ritorno della vita dopo l’inverno. Ada Negri utilizza la metafora della fioritura per trasmettere un senso di rinnovamento e speranza, elementi che caratterizzano la sua poetica.
#Accademia d&039;Italia.#Ada Negri#Ada Negri poesia#analisi poetica#autobiografia poetica#Critica letteraria#Emozioni in poesia#FATALITA&039;#fiori e poesia#immagini poetiche#insegnanti e scrittrici#introspezione femminile#Introspezione poetica#letteratura italiana#Letteratura sociale#Lirismo#maternità e poesia#natura e poesia#Novecento#ottimismo in poesia#personificazione in poesia#poesia e speranza#poesia e stagione#poesia femminile#poesia italiana#Poesia naturalistica#poesia simbolica#poesie sulla natura#poetesse del XIX secolo#poetesse italiane
0 notes
Text
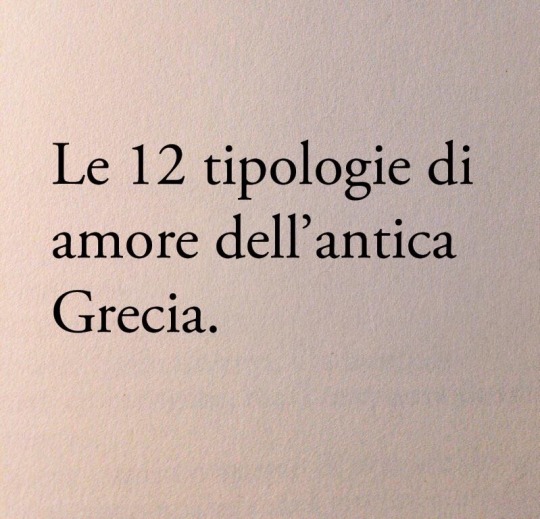
Jorge Luis Borges sosteneva che gli antichi greci furono i primi a pensare, ci hanno dato la poesia, la scienza, la filosofia razionale, che tutta la cultura a noi pervenuta nel corso dei secoli derivi dai greci.
I filosofi greci distinguevano l’amore in 12 tipologie diverse a seconda delle diverse emozioni umane e sfumature del sentimento:
Agape (αγάπη)
Agape è l’amore incondizionato, anche non ricambiato. Va al di là delle forze umane, è un amore puro e senza alcuna aspettativa. Viene utilizzato nei vangeli e nella religione.
Eros (έρως)
Eros è la tipologia di amore più conosciuta. Dio greco della fertilità, il suo tipo di amore rappresenta quello passionale, il desiderio carnale. Veniva definito in termini di irrazionalità, perché il desiderio ardente avrebbe potuto portare alla follia.
Philia (φιλία)
Philia indica un tipo di amicizia profonda. Amicizia come vincolo di fiducia e lealtà, come fondamenta di un rapporto solido e suggellato dalla bellezza della condivisione. Amare ed essere amati.
Storge (στοργή)
Storge è l’amore nei confronti della famiglia o dei parenti, tipico dei consanguinei, deriva da “stergo” che significa amare teneramente.
Philautia (φιλαυτία)
Philautia è l’amore per sé stessi, l’amor proprio, fonte di perfezionamento e benevolenza è definito come forma di egoismo positivo.
Mania (μανία)
Mania associato all’amore è il desiderio incondizionato di amare e possedere, l’amore tossico che vive (apparentemente) solo attraverso il possesso di ciò che brama, il partner come oggetto del desiderio. Distruttivo.
Charis (χάρις)
Charis è forse la tipologia d’amore più ambita tanto quanto appagante: idilliaco. Entrambi i partner si amano allo stesso modo, sia fisicamente che spiritualmente.
Himeros (ἵμερος)
Himeros è l’amore che arde di desiderio fisico, impulsivo, irrefrenabile, l’amore folle. Desiderio carnale, non ascolta ragioni e va appagato nell’immediato.
Anteros (αντέρως)
Anteros, fratello di Eros (si narra fossero inseparabili) è l’amore corrisposto con il rispettivo coniuge/compagno e indica la stabilità sentimentale.
Pragma (πρᾶγμα)
Pragma è associato all’amore maturo di lunga data, ma anche al compromesso e alla pazienza. Fare uno sforzo per dare amore piuttosto che solo per riceverlo.
Pothos (Πόθος)
Pothos è la personificazione del rimpianto e del senso di nostalgia che si prova quando una persona amata è lontana. È anche identificato con l’amore adolescenziale, l’infatuazione, il desiderio prima dell’incontro.
Thelema (θέλημα)
Thelema è l’amore nei confronti di ciò che si fa, il proprio lavoro, il piacere di fare qualcosa, il desiderio voler fare e non è rivolto quindi ad una persona.
— manuela g.
#frasi#citazioni#amore#libro#love#frasi citazione#frasi libro#antica grecia#manuela g.#manuelag.#mare#letteratura#citazioni libro#classic lit art#arte
819 notes
·
View notes
Text
Jorge Luis Borges sosteneva che gli antichi greci furono i primi a pensare, ci hanno dato la poesia, la scienza, la filosofia razionale, che tutta la cultura a noi pervenuta nel corso dei secoli derivi dai greci.
I filosofi greci distinguevano l’amore in 12 tipologie diverse a seconda delle diverse emozioni umane e sfumature del sentimento:
Agape (αγάπη) - Agape è l’amore incondizionato, anche non ricambiato. Va al di là delle forze umane, è un amore puro e senza alcuna aspettativa. Viene utilizzato nei vangeli e nella religione.
Eros (έρως) - Eros è la tipologia di amore più conosciuta. Dio greco della fertilità, il suo tipo di amore rappresenta quello passionale, il desiderio carnale. Veniva definito in termini di irrazionalità, perché il desiderio ardente avrebbe potuto portare alla follia.
Philia (φιλία) - Philia indica un tipo di amicizia profonda. Amicizia come vincolo di fiducia e lealtà, come fondamenta di un rapporto solido e suggellato dalla bellezza della condivisione. Amare ed essere amati.
Storge (στοργή) - Storge è l’amore nei confronti della famiglia o dei parenti, tipico dei consanguinei, deriva da “stergo” che significa amare teneramente.
Philautia (φιλαυτία) - Philautia è l’amore per sé stessi, l’amor proprio, fonte di perfezionamento e benevolenza è definito come forma di egoismo positivo.
Mania (μανία) - Mania associato all’amore è il desiderio incondizionato di amare e possedere, l’amore tossico che vive (apparentemente) solo attraverso il possesso di ciò che brama, il partner come oggetto del desiderio. Distruttivo.
Charis (χάρις) - Charis è forse la tipologia d’amore più ambita tanto quanto appagante: idilliaco. Entrambi i partner si amano allo stesso modo, sia fisicamente che spiritualmente.
Himeros (ἵμερος) - Himeros è l’amore che arde di desiderio fisico, impulsivo, irrefrenabile, l’amore folle. Desiderio carnale, non ascolta ragioni e va appagato nell’immediato.
Anteros (αντέρως) - Anteros, fratello di Eros (si narra fossero inseparabili) è l’amore corrisposto con il rispettivo coniuge/compagno e indica la stabilità sentimentale.
Pragma (πρᾶγμα) - Pragma è associato all’amore maturo di lunga data, ma anche al compromesso e alla pazienza. Fare uno sforzo per dare amore piuttosto che solo per riceverlo.
Pothos (Πόθος) - Pothos è la personificazione del rimpianto e del senso di nostalgia che si prova quando una persona amata è lontana. È anche identificato con l’amore adolescenziale, l’infatuazione, il desiderio prima dell’incontro.
Thelema (θέλημα) - Thelema è l’amore nei confronti di ciò che si fa, il proprio lavoro, il piacere di fare qualcosa, il desiderio voler fare e non è rivolto quindi ad una persona.
6 notes
·
View notes
Video
youtube
Greek Mythology: Story of Astrea
vergine stellare simboleggiante la giustizia figlia di Astreo e di Eos[1].
Astrea era sorella di Pudicizia che lasciò la terra insieme a lei quando finì l'età dell'oro.
Astrea era la dea vergine dell'innocenza e della purezza ed era associata alla costellazione della Vergine[1].
Scesa sulla terra nell'età dell'oro, diffuse i sentimenti di bontà e di giustizia ma, disgustata dalla degenerazione morale del genere umano si rifugiò nelle campagne e supraggiunta l'età del bronzo, scelse di ritornare in cielo dove oggi risplende nell'aspetto della costellazione della Vergine[2].
In epoca romana[modifica | modifica wikitesto]
Virgilio scrisse:
«Già ritorna la vergine (Astrea), ritornano i regni di Saturno, cioè i regni dell'età dell'oro,»
(Publio Virgilio Marone, Egloga IV vv 3-4)
per celebrare Augusto suo protettore.
Ovidio scrisse :
«Vinta giace la bontà, e la vergine Astrea, ultima degli dei, lascia la Terra madida di sangue»
(Publio Ovidio Nasone, Le metamorfosi, I, vv. 149-150)
In tarda epoca fu associata alla dea Dike, che era figlia di Zeus e Temi e rappresentava la personificazione del giusto giudizio.
In epoca moderna[modifica | modifica wikitesto]
Castiglione delle Stiviere, colonna della giustizia con statua della dea
Nel XVI secolo Ludovico Ariosto nell'Orlando furioso descrive l'imperatore Carlo V come colui, che unificando tutti i regni della cristianità, avrebbe fatto tornare di nuovo la dea della giustizia sulla Terra.
Nel 1816 il poeta Vincenzo Monti compose una poesia, Il ritorno di Astrea, che giocava sull'assonanza tra Astrea e l'Austria, che tornava a dominare Milano dopo la parentesi napoleonica.
a star virgin symbolizing justice, daughter of Astraeus and Eos[1].
Astraea was the sister of Modesty who left the earth with her when the golden age ended.
Astraea was the virgin goddess of innocence and purity and was associated with the constellation of Virgo.
She came down to earth in the golden age, spread feelings of goodness and justice but, disgusted by the moral degeneration of mankind, she took refuge in the countryside and, when the Bronze Age arrived, she chose to return to heaven where today it shines in the aspect of the constellation of Virgo[2].
In Roman times[edit]
Virgil wrote:
"Already the virgin (Astraea) returns, the kingdoms of Saturn, that is, the kingdoms of the golden age, return."
(Publius Virgil Maron, Eclogue IV vv 3-4)
to celebrate Augustus, his protector.
Ovid wrote:
"Goodness lies vanquished, and the virgin Astraea, the last of the gods, leaves the Earth drenched in blood"
(Publius Ovidius Nasone, The Metamorphoses, I, vv. 149
0 notes
Text
"Affannata la nebbia" di Cipriano Gentilino
Poesia alta che si apre con una personificazione intensa che prelude ad altri ornamenti retorici di grande effetto semantico. La lirica, in versi liberi, è contenuta nella silloge “Parabole”, NullaDie, 2021, Premio della Giuria nella settima edizione del Concorso letterario Vitulivaria- memorial Gerado Teni, conferito all’autore per aver dimostrato un tratto particolarmente originale nella…

View On WordPress
0 notes
Text
termitato
tic tac l'orologio scalpita
nel suo quadrante vetrato
tic tac l'orologio palpita
come un cuore innamorato
tic tac l'orologio scorre
come un fiume nel suo letto
tic tac l'orologio percorre
con te la vita nel ghetto
tic tac l'orologio scandisce
quelle poche ore in cui la vita ti tradisce
1 note
·
View note
Text
L’Egenio Oneghin, Puskin e il primo dèmone del nichilismo russo

Il ritratto di Eugenio Oneghin che Puskin dipinge nel primo capitolo del suo romanzo in versi offre più di un motivo a chi voglia apprezzare la qualità di una poesia non riducibile alle maniere romantiche della tradizione europea. Vi è nella coloritura del personaggio di Onegin una baldanza e un ritmo canzonatorio (e anche di ‘canzone’) che travalica le affettazioni di altri acclamati eroi ‘byroniani’, inclini a suggellare nel disincanto una sorta di passionale autoaffermazione.
In Onegin la erosione dell'ideale non esalta la personalità individuale ma la dispone al gioco distruttivo fine a sé stesso della ironìa. Proprio perché in lui non vive più la coscienza di un ‘io’ da opporre al mondo ma la percezione di un distacco irrimediabile dal senso e dalla esperienza collettiva. Entra in funzione un elemento tipico dello spirito russo quando perde lo stimolo alla coralità ("Il popolo compone, noi ci contentiamo di elaborare",disse il contemporaneo Glinka, enunciando indirettamente le condizioni della esperienza estetica e lirica russa).

Seguiamo lo sguardo di Puskin sul protagonista: Onegin si afferma nel dettaglio, nel ritmo di un carattere individuale come la silhouette di un figurino su carta. Vi si nota un’ immedesimazione quasi autobiografica e compiacente che bordeggia il tono sarcastico quando Eugenio entra in società abbigliato come un ‘dandy’ all'ultima moda -ovviamente ‘di Londra’- e parla perfettamente francese ballando la polacca mazurca con tanto di inchino (‘volete di più? Per la gente/ era assai caro e intelligente’).
Sulla innaturalezza dello Onegin giovin signore occidentalizzato e pietroburghese, ’artificiale’ come la sua città, si concentra il nucleo della ispirazione poetica: ne derivano antitesi efficaci e congeniali ad una melodia dei versi che lascia trasparire l' ordito di un dramma appartenente alla Russia risvegliata alla modernità del secolo XIX. Onegin, si sa, ‘aveva il dono fortunato/ di sfiorare in conversazione/ agevolmente ogni argomento’; e da ‘bravo alunno delle mode’ derideva Teocrito e Omero, ‘ma Adamo Smith però leggeva’ e non era punto dalla minima voglia ‘di rovistare in profondo/ la polverosa storia del mondo’.
Eugenio Onegin appare il protagonista di un già annunciato fallimento: è in sé stesso una caricatura, un derivato, il prodotto psicosociale di un connubio impossibile, anima ‘russa’ e ‘moda’ europea. Un ritratto intraducibile al punto che il dettaglio, dice ironicamente Puskin, non si può riferire senza l'ausilio della espressione forestiera: ‘ma parola russa non c'é/ per 'pantalons','frac' e ‘gilet'… ".
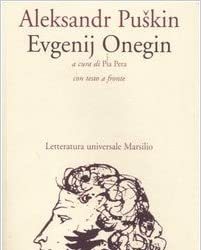
Nell'animo del poeta, del decabrista, del raffinato intellettuale Puskin si agitano molte passioni: cosa è veramente Onegin? Ci si può leggere il suo autoritratto? Nella scrittura poetica Puskin diventa lo spietato osservatore della sua immagine pubblica, mondanamente ridotto a letterato alla moda tra appuntamenti cortesi, salotti e spettacoli di teatro.
E' una dissociazione che si riconosce al momento di definire il suo disagio di vivere: quasi uguale al britannico ‘spleen’ ma esprimibile piuttosto con la parola russa ‘chandrà’, uno stato dell'anima che guarda freddamente alla vita (‘nulla ormai più lo smuoveva/ di niente più si accorgeva"…).
E' la presenza della ‘chandrà’ a suggerire il motivo nichilistico che sostiene l'andamento del poema. Esso procede per otto capitoli che snodano il romanzo in versi tra puntigliose descrizioni di oggetti, azioni, ambienti e situazioni umane .

L' amore ‘wertheriano‘ appare sottotono come appendice della trama la quale va oltre il destino dei personaggi -da Tatiana a Lenskij alla volubile Olga- e non suggerisce architetture conclusive proprio perché non vi è altro al di fuori dell' avventura senza limiti e cioè sprofondata nel ‘nulla’ di Eugenio Onegin, questo ‘dandy’ insoddisfatto della sua identità la quale ormai gli appare come abito tagliato in foggia d'altre lingue, d' altre culture, d' altre civiltà.
Ben oltre il tributo alle nuove mode poetiche – ‘quello stile oscuro e fiacco-scrive Puskin-che chiamiamo Romanticismo’- siamo in presenza di una temperie espressiva corrispondente ad elementi tipici dello ‘spirito russo’, al contrastato rapporto con la cultura occidentale europea, abito troppo misurato per un sentimento che si riconosce nella perdita di misura, quando abbandona le vie di una liturgìa dei suoni, delle immagini, delle parole tradizionali.
Puskin supera molti codici espressivi riducendoli alla vena sincera di un canto che mescola citazioni culturali a motivi della tradizione russa: dalla invocazione alla terra (con omofonìa tra l'oraziano ‘O rus!‘ e la parola Russia) ai romanzi di formazione (Rousseau, Richardson) a Shakespeare e Chateaubriand, tutto è ragione di presentare l'anima bella di Tatiana, questa Gretchen col samovàr destinata ad incarnare la persistenza di costume morale, grazia e regola, che aveva nel nome sentore ‘di antichità e di serva’, stemperando il suo sentimentalismo nel gioco permanente delle felici abitudini’.

E spetterà significativamente a Tatiana, personificazione dei valori tradizionali, il ruolo di eroina di una catastrofe da camera come quella dell'amore non corrisposto da Onegin e vissuto idealmente-letterariamete come vuole la ‘moda romantica’, come il ribelle infelice Werther o il senza pari Grandison (‘che invece a noi fa venir sonno’). E sarà Vladimir Lenskij, l'amico aspirante poeta, innamorato e tradito dalla vivace Olga, testimone ancor più fedele di un certo sentimentalismo mescolante ‘Lindori e Leandri del cuore’ con la lettura di Chateaubriand e Goethe per avvincere nel tono elegiaco il cuore della amata.
Sappiamo come andrà a finire: con Tatiana respinta e congiunta in matrimonio ad un onesto benestante e Lenskij ucciso in duello dall'amico Onegin dopo avere egli teso con successo una trappola di seduzione ad Olga durante un ballo in una residenza di campagna.
Morale: sono i sentimentali e i beneducati a soccombere nel gioco della vita, o pure nel sogno leggero di un gioco passionale ‘accomodato’ da versioni letterarie, o meglio inautentiche. Così il pensiero poetante e ‘spiritoso’ (‘Geistreich’, ricco di spirito, aveva scritto Hegel nella Fenomenologia sul potere della ironìa ) perviene ad una composizione davvero ‘diabolica’ del romanzo in versi, capo d'opera della letteratura russa.

Onegin, eroe del tempo moderno, è già in qualche modo aldilà del bene e del male, supera l'orizzonte romantico ed anticipa nel connubio caratteriale di freddezza e ironìa la temperie di un Kirillov e di un Raskolnikov.
Non a caso Dostoevskij apporrà in calce a ‘I dèmoni’ i versi di una omònima poesia di Puskin la cui allusività è più che eloquente: ‘...Non c'é traccia! Siamo perduti, cosa fare? / Un demònio ci conduce per il campo / e ci fa girare di qua e di là / Quanti sono ? Dove ci portano ? / Perché si lamentano così ? / Forse seppelliscono un folletto / O pure celebrano le nozze di una strega....’.
Quel che in Dostoevskij è definizione psicologica in Puskin è azione, situazione, ambiente e fisiognomica. Onegin mette in scena con più di mezzo secolo d'anticipo il tipo del dèmone dostoevskijano. Questo profilo umano che lascia dietro di sé la romanticheria letteraria e fissa lo sguardo senza mèta del nichilismo non fu perseguito da Puskin in consapevolezza piena: ma scomponendo i tratti della sua stessa personalità-metà Onegin, metà Lenskij- egli ottenne uno straordinario effetto lirico con voce narrante fuori campo che assume i tratti del canto popolare, storia sceneggiata da intepretare coralmente in una pubblica recita di versi.
Non a caso del resto la lettera d'amore di Tatiana a Onegin è mandata a memoria ancora oggi dalle ragazze russe (‘…Perché da noi siete venuto ? / In questo villaggio spento / io non avrei mai conosciuto / né voi né il mio aspro tormento…’) e tutto il poema in versi è ricco di digressioni (paesaggi di Russia, coloriture fiabesche, vita di campagna, canti di giovincelle in primavera, vita di società, inverni ghiacciati, sogni divinatori) che sposano il sottile e raffinato gusto letterario ad un impulso emozionale di grande portata per la vita russa, i suoi colori, le sue forme, le sue immagini inconfondibili.
Se molti guardarono a Puskin come fonte di ispirazione letteraria o musicale lo si deve alla sua capacità di riassumere i più disparati fattori del sentimento russo. Anche l' occidentalizzante Ciaikovskij nel suo arioso sinfonismo lo amò (come del resto per altri versi Musorgskij) riconoscendovi gran parte di quel patetismo eloquente che pure gli apparteneva: languore ed esultanza, attimi di esaltazione e di depressione, e la capacità di stemperare in architetture brillanti e garbate le pulsioni del sentimento.
Temperamento lirico, amante del ritmo nella parola e nella strofa, Puskin si nutre della intensità di immagine e del suo potenziale figurativo (amico e protettore di pittori, è da ricordare la sua intimità col raffinato ritrattista di gran dame, Brijullov). Valga la precisionedi dettaglio, istante, sensazione e immagine con cui si narra un attimo del duello tra i due ex amici, Onegin e Lenskij: "…Brillano le pistole / lucenti e sollevate contro il sole./ Si sente già picchiettare / la bacchetta, i piombi che entrano / in canna e il cane scattare. Grigiastro rivolo scende / nel fondello la polvere, mentre / rialzano l'acciarino avvitato / stretto....".
In questa poesia del particolare Puskin rivela originali qualità per il motivo lirico dell'immagine che scandisce ritmi di azione, modula i toni della parola in una perfezione di verso. Capriccioso e folleggiante, temperamento visivo e rappresentativo, Puskin ebbe il merito di fare ‘poesia solenne, grandiosa e come fuori del tempo con elementi e oggetti particolari, minuti, consistenti, insomma quotidiani e contingenti’( T. Landolfi). In questa paradossale leggerezza è tutta la sua profondità: il fine intellettuale allevato alla scuola europea, il decabrista non slavofilo, l' uomo elegante attraversato dalle passioni, poteva solamente accennare al profilo di una vita morale della poesia.
Ma il suo Onegin, nato come romanzo byroniano, prese col tempo una andatura che rovesciava le sue premesse, mettendone radicalmente in dubbio la consistenza. E quel progressivo rigetto di moduli romantici, oltre a segnare il più autentico travaglio del poeta, avrebbe anticipato la fioritura successiva di una delle più straordinarie stagioni della letteratura russa.
2 notes
·
View notes
Text
Rivista Fare Voci, maggio 2020
https://farevoci.beniculturali.it/
In viaggio con Tobia
Giampaolo De Pietro, “Dal cane corallo”
di Ilaria Battista
A volte, se siamo fortunati, un quadrupede ci sceglie come compagni e decide di portarci a spasso attraverso la vita. Magari pensiamo di essere noi a tenere il guinzaglio ma, in verità, come intuisce Giampaolo De Pietro in questo suo nuovo libro “Dal cane corallo”, il passo lo decide qualcun altro, e quel qualcuno non siamo noi. A volte, se siamo fortunati, un quadrupede decide di insegnarci parole nuove, e se siamo così intelligenti da ascoltare, scopriamo di parlare nuove lingue, i cui suoni prima ci erano del tutto sconosciuti, perché vedevamo il mondo a misura d’uomo, e non a misura di quadrupede. A volte, se siamo fortunati, e se teniamo gli occhi bene aperti, possiamo assistere ad antichi rituali che coinvolgono il quadrupede, che sia il corteggiamento di un cespuglio o la rincorsa di un sacchetto gonfiato dal vento. A volte, se siamo fortunati, il quadrupede ci insegna ad ascoltare il giusto, il dovuto, perché il quadrupede non spreca parole, non spreca fiato, anzi ce ne fa dono, non si fa domande inutili che vadano al di là del suo prossimo pasto e anche quando si rivolge al cielo per una preghiera, non chiede cose impossibili, che lo sa già che certe cose non si chiedono. Non perché sia inutile chiedere, ma perchè in certi casi è più utile tacere. A volte, se siamo fortunati, il quadrupede non occorre che sia in pelo e bava e ossa, puo’ essere anche di carta impastata di parole, il riflesso di un cane esistente e scodinzolante che arriva fino a noi. Giampaolo De Pietro ha avuto la fortuna di essere scelto da Tobia, ha avuto la capacità di ascoltarlo, di accogliere le nuove parole che Tobia gli ha insegnato e noi siamo fortunati che abbia scelto di condividerle, così che anche noi, fortunati lettori, ci trovassimo a fare un pezzo di strada guidati da un cane col naso di velluto e un mantello giallo, battezzato Tobia, il cane corallo.
(il libro è illustrato dai disegni di Francesco Balsamo)
Dal libro:
Tobia mi ha dato molto fiato col fiuto esagerato è un cane naso di velluto
Tobia vestito di giallo un cane col mantello che sa far la corte ai cespugli
Tobia è pure una papera un leoncino impaurito un fenicottero un fiore d’acanto
*
Quando rimprovero il cane divento un tantino più uomo idiota poi lui si affaccia alla fontana con un salto e beve alla mia salute e a quella dell’anziano signore lì di fronte seduto per il di lui favore e consiglio di ridurre il getto d’acqua (dice a me, il cane approva, forse) per agevolarlo a dissetarsi un poco meglio; Tobia beve un altro sorso e mi dirige verso casa, non prima di aver ringraziato con l’occhietto destro, la coda a dondolo, me al guinzaglio
*
Santi e stelle cadenti vi chiedo in pubblico quattro Piccole cose come favori da parte del mio cane: un po’ di coraggio in più, di tolleranza nei confronti della gatta vicina, di qualche possibilità di andarsene a spasso da solo – dunque qualcosa che ha a che fare con l’emancipazione – e, pure nessun’altra puntura di vespa o fastidio o ronzio di ape, e tanta salute e qualche biscotto straordinario *** (una cagnolina disposta a darsi non so, non si chiede forse a un santo e neppure a una stella in caduta)
*
Chissà se, poi, e come, semmai, gli animali s’immaginano la morte coi loro occhi bui dai loro brividi, coi denti e le paure gli sguardi penombrati
(forse sono liberi da quest’altro impiccio, forse non lo hanno, lo fiutano, lo difendono)
forse una protezione del cuore li distacca li avviluppa domando le domande?
Chissà che salti in alto e tuffi in largo che vertigini e altri colori e immaginazioni chissà che acrobatici sogni bianchi neri, rossi…
*
Tobia Uno scherzo In coda O uno scodinzolio
Intervista a Giampaolo De Pietro:
Partiamo dalla dedica che apre la raccolta, “Tu non sai quanto fiato mi dai”. Può sembrare una frase semplice, ma secondo me racchiude tante verità della vita in comune bipede quadrupede. Hai più fiato perché ti ritrovi a correre dietro al tuo maestro di avventure e diventi un atleta della rincorsa, ma hai più fiato anche perché scopri luoghi che prima non avevi mai riconosciuto, pur avendoli sempre visti, perché parli con altri bipedi accompagnatori di quadrupedi a cui prima non avresti regalato neanche un respiro di ciao; e secondo me soprattutto perché escono dalla tua bocca parole di cui non sospettavi l’esistenza, e lo fanno con una naturalezza, che è appunto un ordinario respirare. Ti riconosci in questa descrizione o la tua idea di fiato era qualcosa di completamente diverso? Hai detto naturalezza, quello che inseguo e che proprio per natura dovrebbe portarci a imitare un tantino il modo degli animali, quello del respiro che ci rende tutti esseri viventi. Il fatto di esserne – in forme diverse – consapevoli. Io ci proverò sempre! Tu non sai quanto fiato mi dai, quasi un cantato, più che una dedica, è un motivo.
Una delle immagini più poetiche che ricorrono nei tuoi versi è quella di Tobia che fa la corte ai cespugli. Leggendoti disegno nella mente un cane molto compito, a se stesso molto presente, dai tratti eleganti, come un gentiluomo dei tempi passati che intrattiene con gli arbusti silenziose ed essenziali conversazioni a cui si addicono parole antiche. Si intravede la scelta accurata che hai fatto delle parole che descrivono le emozioni condivise in questi passi compiuti a sei zampe. Sono versi nati spontaneamente o sono frutto di un’accurata revisione linguistica, di un continuo lavorarci accanto? Un gentiluomo dei tempi passati: dici, di Tobia – sorrido, sai che ho sempre cercato di non trasformarlo, ma proprio come immagine in me (in mente o nei miei pensieri “figurati”), in una personificazione? Di una figura umana, s’intende – piuttosto, un giovanissimo antico bambino con la coda e il manto, le orecchie ipersensibili e il fiuto straordinario: dunque, una creatura meravigliosa, meravigliosamente attenta, naturalmente, alla vita, così dentro e pure fuori la circolarità dell’esserci (senza “problemi amletici”!), inesorabilmente, veramente! Non vuol dire che sia “più” o “meglio” di noi umani, ci tengo a considerare che tra i versi questa “sfida” non esiste né sussiste, perché io, cioè chi li ha scritti, non sento di avere il bisogno di rapportare noi e gli animali in questa pseudo-competizione, chi meglio chi peggio, chi più chi meno, no no. Ah, sulle scelte linguistiche, neppure direi. Naturalezza, si scrivevano i versi, inizialmente, ovvero passeggiando dall’inizio (avevo sempre desiderato avere un cane amico, sin da bambino, finché non è arrivato lui, il cane corallo, grazie alla mia amica Marcella), prima erano parole-cucciole, poi parole che respiravano lunghe passeggiate. Io vivevo un periodo particolarmente difficile. E le parole non mi trovavano, né io potevo averne, di libere. Lui sì, non ne aveva, era il lessico giusto, il silenzio, il fiato che c’era e c’è. Ho cercato di fiutare i versi, di lasciarmi scrivere da loro, come sempre credo di dover imparare a fare. E ho avuto, come dici tu, un maestro, sono stato fortunato! Ho molto limato, alla fine, quando i testi hanno preso la direzione, nonché mia volontà di essere e diventare libro.
La preghiera che indirizzi ai santi e alle stelle cadenti a nome di Tobia è così intima che ad un certo punto mi sono chiesta chi dei due parlasse a nome dell’altro. È Giampaolo che chiede a nome di Tobia un po’ di tolleranza in più, un po’ di coraggio e un po’ di dolcezza, o è Tobia che chiede tutto questo per Giampaolo usando la sua voce? La preghiera mi ha fatto tanto sorridere, è nata spontanea, ed era anche commovente. Ogni preghiera secondo me dovrebbe sorridere e insieme commuovere. Care stelle cadenti… viste da me (i cani vedranno le stelle cadenti?), i santi (i cani li hanno conosciuti nel corso della storia, certo) li ho interpellati come per una chiacchierata un poco magica un poco stramba, nel chiedere loro alcune cose da parte del cane, che non aveva un suo modo di domandare (pregare è un po’ chiedere?!?), domandare una grazia? Scodinzolando, a piccoli ululati e con gli occhi e i salti, il cane corallo ci riusciva, i cani possono allora avere un modo molto naturale di pregare! Ma dico forse, mi leggesse qualche “serioso credente”, potrebbe prendermi alla lettera. Comunque, era un gioco, rispettosissimo, ed anche un mio modo, forse (c’era, fra le varie richieste) di voler proteggere India, la bellissima gatta nera dei vicini, dalla non proprio simpatia che Tobia, davvero un cane-dingo (sì, elegante e antico e pure molto selvaggio! E non amico dei gatti ahimè) dimostrava quando la incontrava.
Ai tuoi versi si accompagnano le immagini, un tutt’uno quasi necessario. Versi e immagini sono per te due mondi che scorrono paralleli e che possono esistere uno senza l’altro o due mondi che si contaminano uno con l’altro e che non potrebbero esistere separatamente? I disegni di Francesco Balsamo sono arrivati in seguito, quasi un modo per stare tra la parola e il fiato, come un altro elemento necessitato per far sì che tutto potesse raggiungere la naturalezza desiderata. Credo che le immagini possano dire tanto, tutto talvolta, senza la parola. Che la parola possa immaginare al punto massimo e altro, non necessitando di immagine. E credo pure che insieme, senza “parlarsi addosso”, possano creare persino inventare e sostenere il peso impossibile della poesia. Forse non sono né verbo né soggetto, in tal caso, ma udito. (???) e… ci fosse anche il suono? Cinema, magari!
Ci pensi mai a come sarebbero le tue parole se Tobia non ti avesse scelto come compagno di viaggio? C’è un panorama e insieme una cuccia una stanza così silenziosa e pacifica. Lì scodinzolo anche io. Lì imparo ciò che ho imparato e imparerò da un amico così. E da qui probabilmente scaturiranno altre scritture solitarie, altro respiro e viaggio verso. Altri abbecedari inediti, non proprio uman(oid)i. Ho ritrovato questo, tra i file-corallini, ad esempio:
(…) [la erre di arma. Ancora. La doppia di guerra. La discendenza di rorido. Nulla che accomuni opposte nature? Qualche lettera mai giunta o Raggiunta. Rabbia che abbuia, abbaia meglio il cane Il cane rosso, il cane corallo.
In chiusura di libro c’è un testo di Robert Lax….
Sì, dopo un commiato che apre un silenzio possibile, incontriamo Robert Lax, uno strepitoso (semplicemente) poeta americano che mi accompagna da quando l’ho scoperto – nei suoi versi c’è l’incontro tra un cane-stante e un uomo-visitatore, il cane gli chiede che facesse lì (se fosse, per l’appunto un “passante/visitatore”) e l’uomo risponde di sì, il cane allora gli chiede di prenderlo con sé. Ecco, cosa accade. Ci si adotta, e la domanda è a cerchio, un cerchio. Come il sole, come il tempo che spazia in (con, su, per, tra, fra – di, a, da) quest’immenso affetto.
1 note
·
View note
Text
jalousie et littérature
Nel Rinascimento la gelosia è elemento nuovo, non affrontato particolarmente nella precedente produzione classica. Questo viscerale sentimento si presenta con due diverse interpretazioni. Una prima positiva, percepita infatti come una componente necessaria nel percorso amoroso che, se affrontata nel modo corretto, può portare a una maturazione della persona e della relazione. Contrariamente, la seconda interpretazione ha connotazione negativa poiché vede nella gelosia un ostacolo, un’antitesi dell’amore inquinato da quest’emozione che consuma, intacca e sporca la purezza del sentimento amoroso. Troviamo però un aspetto comune nei testi che affrontano il tema: la volontà di definire quasi fisicamente la gelosia, associandovi una personificazione e un’attenta analisi degli effetti che ha sul geloso. L’ennesimo tentativo dell’uomo di rendere tangibile, esplicabile l’irrazionale così da credere, conoscendolo, di poterne essere padrone. Boccaccio, nel Filocolo, riprende la personificazione dell’invidia di Ovidio adattandola alla gelosia e descrivendola come una donna anziana, solitaria, che vive in una grotta oscura. Successiva alla raffigurazione è poi la descrizione di ciò che provoca la gelosia attraverso opposizioni che la contrappongono all’amore. I due sentimenti vengono quindi percepiti come diametralmente opposti e si crede impossibile la coesistenza di questi. La struttura di Boccaccio (personificazione seguita dagli effetti provocati) verrà ripresa da Lorenzo de’ Medici nelle Selve , in particolar modo nella prima, dove vi è però un elemento innovativo: il tentativo di risalire alla nascita del sentimento che viene considerata mitologica e quindi lontana dall’uomo . Il racconto dell’origine della gelosia è seguito da una preghiera dell’autore di allontanare questo sentimento infernale che logora e danneggia la razionalità dell’individuo. La gelosia viene infatti condannata poiché altera la visione della realtà, aspetto particolarmente evidente ne L’Orlando furioso dove il protagonista cerca scusanti e pretesti per non accettare la liason tra Angelica, e Meodoro, suo rivale. La rabbia che ne consegue viene però causata dalla gelosia stessa e mai dall’amata: anche Sannazaro nella sua opera Sonetti e canzoni maledice la passione e mai la donna. Costante è quindi il ruolo della poesia come mezzo di analisi e liberazione dalle proprie emozioni. Torquato Tasso nella raccolta Rime amorose (1591) definisce la gelosia come una delle più intense passioni e l’accusa di obbligare l’individuo a chiudersi in se stesso, quasi impedendogli di tornare alla realtà e alla verità dei fatti. Secondo Tasso, il geloso è sopraffatto da “larve”, fantasmi che rendono incerta la realtà e il sentimento amoroso, e la gelosia genera conseguentemente una carnevalizzazione del mondo dove non è più possibile comprendere la verità. Lo considera, tuttavia, un passaggio necessario e inevitabile nel corso della relazione e afferma l’esistenza di un limite entro cui la gelosia diventa ostacolo. Sottile è quindi il confine tra una gelosia sana, portatrice di riflessione e maturazione, e un incontrollabile desiderio di possesso che conduce al deterioramento di sé e del rapporto.
Martina
1 note
·
View note
Link
Babbo Natale è nato durante la guerra di secessione americana. Settant'anni prima della Coca Cola, è stato il padre del fumetto politico moderno, il tedesco Thomas Nast, a creare l'immagine di Santa Claus che conosciamo oggi: gioviale, barba bianca, panciuto, in pelliccia con un cappello di lana in testa che dona i regali prendendoli da un sacco sopra una slitta trainata dalle renne. Era il 3 gennaio del 1863. E fino a quella vignetta pubblicata sull’Harper's weekly papà natale era ritratto solo in due modi: come il vescovo San Nicola o nelle sembianze di uno spilungone emaciato dal volto cattivo. Ma all'esercito unionista serviva una figura rassicurante per superare l'inverno più difficile della guerra di secessione.
Per questo nella vignetta del 1863 la divisa di Babbo Natale richiama la bandiera degli Stati Uniti: pantaloni a strisce e giacca a stelle, 34 come gli Stati federati di allora, compresi quelli del Sud. Il vestito bianco e rosso arriverà dopo 33 vignette dello stesso genere pubblicate da Nast ogni anno fino al 1886 in cui Santa Claus scende con il sacco dentro i camini, legge le lettere seduto in panciolle sulla scrivania, sgrida i bambini cattivi e fa sedere sulle sue gambe quelli buoni per sentire i loro desideri. Nel 1881 pubblica la versione iconica che plasmerà l’immaginario del Novecento: Santa Claus con le guance rosse, la pipa sottile in bocca e i regali sottobraccio. C’è anche una spada attaccata alla cintura, ma l’amore del vignettista per le armi non è rimasto. Il punto è che Nast aveva già definito i caratteri di Santa Claus quarant’anni prima della copertina di Life Magazine del 12 dicembre del 1923, considerata da molti la nascita del Babbo Natale commerciale in cui beve del whisky per sponsorizzare la compagnia White Rock.
Per creare il Babbo Natale moderno, Nast prese l’idea della slitta trainata dalle renne con un sacco pieno di doni dalla descrizione fatta da Clement Moore nella poesia Una visita da san Nicola del 1823. Dai personaggi del folklore tedesco prese l’idea di un uomo barbuto dai tratti gnomeschi. Anche se il presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln lo aveva definito: «Il nostro miglior sergente di reclutamento» per la capacità di coinvolgere le truppe con le sue vignette, Nast era nato a Landau, nel Regno di Baviera, in una delle città più fortificate d’Europa. A sei anni, con la mamma e la sorella era emigrato a New York e già a 15 anni aveva iniziato a lavorare disegnando fumetti politici per i giornali.
Nella vignetta del 1863, Santa Claus in the Camp, il primo regalo del moderno Babbo Natale è raccapricciante: un burattino di legno con una corda legata intorno al collo. Non è Pinocchio ma la versione pupazzo del presidente confederato Jefferson Davis. Eh sì, il creatore di Santa Claus amava il politicamente scorretto. Spesso nelle sue vignette ritraeva irlandesi ubriachi e vescovi cattolici come coccodrilli che dal fiume attaccano giovani studenti. Nast non aveva lo spirito del Natale classico: considerava le scuole cattoliche una minaccia per i valori americani. Quando si dice l’eterogenesi dei fini.
Per problemi economici nel 1890 Nast fu costretto a pubblicare una raccolta delle sue vignette di Babbo Natale: Christmas drawnings for the Human Race. Il libro contribuì a togliere l’associazione di Santa Claus con San Nicola o con gli obiettivi propagandistici di trenta anni prima. Rimase solo l’idea di giovialità del Natale. Terreno perfetto per rendere poi l’uomo barbuto simbolo del Natale commerciale. Nell'introduzione alla raccolta l'editore precisa: «Queste immagini si appellano non a supportare una particolare denominazione religiosa o un partito politico, ma alla delizia universale nel più felice dei giorni festivi, amato dalle più tenere tradizioni domestiche. Il Natale è la festa di tutti; ma è soprattutto la giornata dei bambini. Le fantasie grottesche e ariose dell'infanzia che si aggrappano a Babbo Natale, come il buon genio del Natale, sono riprodotte su queste pagine».
E dire che Santa Claus non è l'unico personaggio più famoso creato da Nast. Il padre del fumetto politico americano ha creato il simbolo politico del Partito Repubblicano, l’elefante, e ha reso popolare l’uso dell’asino come simbolo degli avversari del Partito Democratico. Le sue caricature spietate e provocatorie dei politici che decideva di appoggiare, sempre repubblicani, o distruggere riuscivano a spostare l'opinione di molti elettori. Fu definito The president maker, per aver influenzato almeno sei elezioni presidenziali tra il 1864 e il 1884. Non a caso da Ulysses Grant a Chester Arthur, tutti i presidenti degli Stati Uniti eletti erano membri del Great Old Party. C’è il suo zampino anche nella popolarizzazione dell'icona dello Zio Sam, la personificazione degli Stati Uniti a cui aggiunse il pizzetto bianco. C’è anche un po’ d’Italia nella vita di Nast. Nel 1860 disegnò una serie di vignette sulla spedizione dei Mille nel Sud Italia che seguì fisicamente come corrispondente del The Illustrated London News. Contribuì così alla popolarità di Giuseppe Garibaldi negli Stati Uniti. In fondo con una camicia rossa e una barba l’eroe dei due mondi era il modello perfetto per il papà di Babbo Natale.
1 note
·
View note
Text
"Febbraio" di Vincenzo Cardarelli: il mese ribelle che annuncia la primavera. Recensione di Alessandria today
Un ritratto poetico vivido e dinamico del tempo che cambia.
Un ritratto poetico vivido e dinamico del tempo che cambia. Vincenzo Cardarelli, con la sua poesia “Febbraio”, ci regala un ritratto vivido e dinamico di uno dei mesi più imprevedibili dell’anno. Attraverso immagini potenti e un linguaggio essenziale, il poeta personifica febbraio come un ragazzo irrequieto e dispettoso, che rompe la quiete dell’inverno e annuncia l’arrivo di marzo, il mese del…
#Alessandria today#Cardarelli biografia#Cardarelli poesia#Febbraio#Google News#grandi poeti italiani#italianewsmedia.com#letteratura e clima#letteratura italiana#mutamenti atmosferici#Pier Carlo Lava#poesia breve#poesia classica#poesia contemporanea#poesia e cambiamento#poesia e immagini#poesia e natura#poesia e natura umana#poesia e personificazione#poesia e realtà#poesia e tempo#poesia e tradizione#poesia e vento#poesia emozionale#poesia evocativa#poesia filosofica#poesia italiana#poesia lirica#poesia per riflettere#poesia simbolica
1 note
·
View note
Quote
E nella notte nera come il nulla, a un tratto, col fragor d'arduo dirupo che frana, il tuono rimbombò di schianto: rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, e poi vanì. Soave allora un canto s'udì di madre, e il moto di una culla.
Giovanni Pascoli
Il poeta paragona il suo stato di vita attuale ad una notte nera come il nulla, al vuoto più assoluto, all’apatia, alla mancanza emozioni forti e positive. Si sente così schiacciato dai suoi problemi da vedersi come parte di quell’oblio. Ad un tratto, come se tutto quello che stesse passando non fosse abbastanza, il fragore di un tuono improvviso, inaspettato e spaventoso scosse tutto il suo universo interiore. Ma fu solo un attimo: svanì con la stessa rapidità con cui arrivò. Spaurito ed intimorito il poeta si sente smarrito come n bambino che si sveglia in preda ad una crisi di pianto. Ed ecco che entra in gioco il nido: la sensazione di sicurezza che a famiglia gli provoca. Una nuova figura si affaccia a contrapporsi allo sgomento: un dolce canto da parte di un’amorevole madre che scuotendo la culla dove il suo bambino riposa cerca di calmarlo e di proteggerlo da tutto ciò che lo circonda.
Pascoli perse suo padre la notte di San Lorenzo e la madre qualche mese dopo. Sua sorella lo abbandonò sposandosi ed il poeta, una volta rimasto solo, si rintana nel suo essere ancora un fanciullo nel cuore, in grado di distruggere le cose immense e di ingrandire quelle molto piccole per trovare la sua felicità, il suo posto nel mondo. Nonostante tutte le sue continue delusioni il poeta riesce ancora a trovare un modo per uscire da quello stato di costante abbandono: la poesia. Alla luce di ciò si può anche supporre che la madre sia la personificazione della Poesia che lo culla nei momenti di massima disperazione.
Spesso si pensa agli autori di prose e versi come uomini noiosi da dover studiare per forza per prendere un voto a scuola e si dimentica di guardarli come esseri umani con sentimenti reali, speranze, illusioni e delusioni. Uomini e donne che soffrirono come noi e che, come noi, cercarono un modo per stare meglio e lo trovarono nella poesia.
Anche noi come Pascoli dovremmo trovare la nostra cura nelle cose che più amiamo in modo da poterci salvare con loro e poterci far salvare da loro.
#giovanni#pascoli#tuono#canto di madre#culla#fragore#vuoto#nera#nulla#notte#poesia#citazione#madre#consolazione#disperazione#paura#aiuto#ragione di vita#autori#versi#prose#scuola
67 notes
·
View notes
Photo

QUESTO VISIBILE PARLARE - PARTE VENTUMESIMA - DE AMORE
Andrea Cappellano, un intellettuale del medioevo, sapeva molte cose sull’amore e sulla provocazione. Scrisse un libro sull’amore (De Amore) nel quale si afferma in maniera perentoria che a rendere nobile un uomo non è la nobiltà; che a renderlo felice e vivo non può essere il denaro o il potere o le cariche; e che a renderlo libero non può essere il lavoro perché la libertà si trova solo nell’amore, e al lavoro si possono dedicare solo quelli che non conoscono l’amore. Il suo libro sull’amore era senza dubbio una provocazione: alla bellezza.
Nell’immagine “Frau Minne trafigge con una freccia il cuore dell’amante”, miniatura tratta da “ Romans arthuriens” di Robert de Boron, manoscritto edito tra il 1270 e il 1290, conservato a Parigi, presso la Bibliothèque Nationale de France, Ms. fr. 95, f. 24 (immagine rilasciata con "Licence Ouverte/Open Licence", tramite BnF). Frau Minne è una personificazione dell'amore cortese nella letteratura tedesca medio-alta. Frau Minne viene spesso affrontata direttamente nella poesia del Minnesang, di solito dall'amante struggente che si lamenta del suo stato, ma appare anche nelle più lunghe poesie di Minnerede e nelle opere in prosa.
Testo di Pier Paolo Di Mino
Ricerca iconografica a cura di Veronica Leffe.
https://www.libroazzurro.it/index.php/note/questo-visibile-parlare/230
1 note
·
View note
Text

La Primavera è un dipinto a tempera su tavola (203 x 314 cm) di Sandro Botticelli, databile tra il 1478 e il 1482 circa. Realizzata per la villa medicea di Castello, l'opera d'arte è conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze.
Si tratta del capolavoro dell'artista, nonché di una delle opere più famose del Rinascimento italiano. Vanto della Galleria, si accostava anticamente con l'altrettanto celebre Nascita di Venere, con cui condivide la provenienza storica, il formato e alcuni riferimenti filosofici. Lo straordinario fascino che tuttora esercita sul pubblico è legato anche all'aura di mistero che circonda l'opera, il cui significato più profondo non è ancora stato completamente svelato.
In un ombroso boschetto, che forma una sorta di semi-cupola di aranci colmi di frutti e arbusti sullo sfondo di un cielo azzurrino, sono disposti nove personaggi, in una composizione bilanciata ritmicamente e fondamentalmente simmetrica attorno al perno centrale della donna col drappo rosso e verde sulla veste setosa. Il suolo è composto da un verde prato, disseminato da un'infinita varietà di specie vegetali e un ricchissimo campionario di fiori: nontiscordardimé, iris, fiordaliso, ranuncolo, papavero, margherita, viola, gelsomino, ecc.
I personaggi e l'iconografia generale vennero identificati nel 1888 da Adolph Gaspary, basandosi sulle indicazioni di Vasari, e, fondamentalmente, non sono più stati messi in discussione. Cinque anni dopo Aby Warburg articolò infatti la descrizione che venne sostanzialmente accettata da tutta la critica, sebbene sfugga tuttora il senso complessivo della scena.
L'opera è, secondo una teoria ampiamente condivisa, ambientata in un boschetto di aranci (il giardino delle Esperidi) e va letta da destra verso sinistra, forse perché la collocazione dell'opera imponeva una visione preferenziale da destra. Zefiro, vento di sud ovest e di primavera che piega gli alberi, rapisce per amore la ninfa Clori (in greco Clorìs) e la mette incinta; da questo atto ella rinasce trasformata in Flora, la personificazione della stessa primavera rappresentata come una donna dallo splendido abito fiorito che sparge a terra le infiorescenze che tiene in grembo. A questa trasformazione allude anche il filo di fiori che già inizia a uscire dalla bocca di Clori durante il suo rapimento. Al centro campeggia Venere, inquadrata da una cornice simmetrica di arbusti, che sorveglia e dirige gli eventi, quale simbolo neoplatonico dell'amore più elevato. Sopra di lei vola il figlio Cupido, mentre a sinistra si trovano le sue tre tradizionali compagne vestite di veli leggerissimi, le Grazie, occupate in un'armoniosa danza in cui muovono ritmicamente le braccia e intrecciano le dita. Chiude il gruppo a sinistra un disinteressato Mercurio, coi tipici calzari alati, che col caduceo scaccia le nubi per preservare un'eterna primavera.
INTERPRETAZIONE FILOSOFICA
Ernst Gombrich, nel 1945, e, dopo di lui, negli anni cinquanta Wind e negli anni sessanta Panofsky, lessero la Primavera addirittura come il manifesto del sodalizio filosofico ed artistico dell'Accademia di Careggi. Vi si narrerebbe come l'amore, nei suoi diversi gradi, arrivi a staccare l'uomo dal mondo terreno per volgerlo a quello spirituale.
La scena si svolgerebbe nel giardino sacro di Venere, che la mitologia colloca nell'isola di Cipro, come rivelano gli attributi tipici della dea sullo sfondo (per es. il cespuglio di mirto alle sue spalle) e la presenza di Cupido e Mercurio a sinistra in funzione di guardiano del bosco, che infatti tiene in mano un caduceo per scacciare le nubi della pioggia (anche se egli viene insolitamente raffigurato in una posizione che lo rende estraneo al resto della scena). Le Tre Grazie rappresentavano tradizionalmente le liberalità, ma la parte più interessante del dipinto è quella costituita dal gruppo di personaggi sulla destra, con Zefiro, la ninfa Cloris e la dea Flora, divinità della fioritura e della giovinezza, protettrice della fertilità. Zefiro e Clori rappresenterebbero la forza dell'amore sensuale e irrazionale, che però è fonte di vita (Flora) e, tramite la mediazione di Venere ed Eros, si trasforma in qualcosa di più perfetto (le Grazie), per poi spiccare il volo verso le sfere celesti guidato da Mercurio.
Oltre alle teorie di Marsilio Ficino e la poetica del Poliziano, Botticelli s'ispirò anche alla letteratura classica (Ovidio e Lucrezio), soprattutto per quanto riguarda la metamorfosi di Cloris in Flora; tuttavia, il centro focale della composizione è Venere, che secondo l'ideologia neoplatonica sarebbe la rappresentazione figurata del suo mondo secondo il seguente schema:
Venere = Humanitas, ovvero le attività spirituali dell'uomo
Tre Grazie = fase operativa dell'Humanitas'
Mercurio = la Ragione, che guida le azioni dell'uomo allontanando le nubi della passione e dell'intemperanza
Zefiro-Cloris-Flora = la Primavera, simbolo della natura non tanto intesa come stagione dell'anno quanto forza universale ciclica e dal potere rigenerativo.
Per Erwin Panofsky ed altri storici dell'arte, e non solo, la Venere della Primavera sarebbe la Venere celeste, vestita, simbolo dell'amore spirituale che spinge l'uomo verso l'ascesi mistica, mentre la Nascita raffigurerebbe la Venere terrena, nuda, simbolo dell'istintualità e della passione che ricacciano gli individui verso il basso.
Numerose sono le proposte di lettura per le Grazie. Il loro movimento di alzare e abbassare le braccia ricorda filosoficamente il principio base dell'amore (da Seneca), la Liberalità, in cui ciò che si dà viene restituito. Esse possono rappresentare anche tre aspetti dell'amore, descritti da Marsilio Ficino: da sinistra, la Voluttà (Voluptas), dalla capigliatura ribelle, la Castità (Castitas), dallo sguardo malinconico e dall'atteggiamento introverso, e la Bellezza (Pulchritudo), con al collo una collana che sostiene un'elegante prezioso pendente e dal velo sottile che le copre i capelli, verso la quale sembra stare per scoccare la freccia Cupido. Secondo Esiodo le tre fanciulle divine sono invece Aglaia, lo Splendore, Eufrosine, la Gioia e Talia, la Prosperità. Latinizzate divennero Viriditas, Splendor e Laetitia Uberrima ovvero l'Adolescenza, lo Splendore e la Gioia Piena, o Letizia Fecondissima (Marsilio Ficino nel "de amore").
Claudia Villa (italianista contemporanea) è portata a considerare che i fiori, secondo una tradizione che ha origine in Duns Scoto, costituiscono l'ornamento del discorso e identifica il personaggio centrale nella Filologia, per cui riferisce la scena alle Nozze di Mercurio e Filologia rovesciando anche le identità dei personaggi che stanno alla nostra destra. Così la figura dalla veste fiorita è da vedersi come la Retorica, la figura che sembra entrare impetuosamente nella scena come Flora generatrice di poesia e di bel dire, mentre il personaggio alato, che sembra sospingere più che attrarre a sé la fanciulla, sarebbe un genio ispiratore.
In tale contesto interpretativo diventa difficile giustificare i colori freddi con cui è rappresentato il personaggio, a meno che l'autore non volesse affidare a questa scelta la smaterializzazione e il carattere spirituale dell'ispirazione poetica. Può risultare invece più comprensibile il disinteresse alla scena che sembra mostrare Mercurio, dio dei Mercanti.
STILE
Nell'opera sono leggibili alcune caratteristiche stilistiche tipiche dell'arte di Botticelli: innanzitutto l'innegabile ricerca di bellezza ideale e armonia, emblematiche dell'umanesimo, che si attua nel ricorso in via preferenziale al disegno e alla linea di contorno (derivato dall'esempio di Filippo Lippi). Ciò genera pose sinuose e sciolte, gesti calibrati, profili idealmente perfetti. La scena idilliaca viene così ad essere dominata da ritmi ed equilibri formali sapientemente calibrati, che iniziano dal ratto e si esauriscono nel gesto di Mercurio. L'ondeggiamento armonico delle figure, che garantisce l'unità della rappresentazione, è stato definito "musicale".
In ogni caso l'attenzione al disegno non si risolve mai in effetti puramente decorativi, ma mantiene un riguardo verso la volumetria e la resa veritiera dei vari materiali, soprattutto nelle leggerissime vesti.
L'attenzione dell'artista è tutta focalizzata sulla descrizione dei personaggi, e in secondo luogo delle specie vegetali, che appaiono accuratamente studiate, forse dal vero, sull'esempio di Leonardo da Vinci che in quell'epoca era già artista affermato. Minore cura è riservata, come al solito in Botticelli, allo sfondo, con gli alberi e gli arbusti che creano una quinta scura e compatta. Il verde usato, come accade in altre opere dell'epoca, doveva originariamente essere più brillante, ma col tempo si è ossidato arrivando a tonalità più scure.
Le figure spiccano con nitidezza sullo sfondo scuro, con una spazialità semplificata, sostanzialmente piatta o comunque poco accennata, come negli arazzi. Non si tratta di un richiamo verso l'ormai lontana fantasia del mondo gotico, come una certa critica artistica ha sostenuto, ma piuttosto dimostra l'allora nascente crisi degli ideali prospettici e razionali del primo Quattrocento, che ebbe il suo culmine in epoca savonaroliana (1492-1498) ed ebbe radicali sviluppi nell'arte del XVI secolo, verso un più libero inserimento delle figure nello spazio.
TECNICA
La tecnica usata nel dipinto è estremamente accurata, a partire dalla sistemazione delle assi di notevoli dimensioni che, unite tra loro, formano il supporto. Su di esse Botticelli stese una preparazione diversificata a seconda delle zone: beige chiaro dove vennero dipinte le figure e nera per la vegetazione. Su di essa il pittore stese poi la colorazione a tempera in strati successivi, arrivando a effetti di grande leggerezza.
1 note
·
View note
Text

Il Parnaso, Anton Raphael Mengs, 1760-1761, affresco.
Mengs trascrive pittoricamente i principi fondamentali del “vero stile” teorizzati da Johann Joachimm Winckelmann, col quale il pittore boemo era intellettualmente in sintonia ed in stretto rapporto di amicizia. Il primo evidente elemento stilistico presente nell’opera consiste nell’ordine dispositivo dei personaggi, collocati intorno alla figura centrale di Apolllo, dio della musica e personificazione stessa della poesia, che ne scandisce un calcolato equilibrio compositivo, con cinque delle leggiadre muse collocate alla sua destra e cinque accomodate alla sua sinistra, tutte sospese in posture differenti ed un tanto ampollose. Dietro i personaggi si può osservare un paesaggio costruito alla bisogna, secondo le esigenze compositive, tipicamente neoclassico, sereno e ospitale, complice e benevolo, in una accezione della natura in senso neoplatonico. Nella composizione è visibile l’ammirazione dell’artista verso l’antichità classica, fonte di eccelse virtù e di dotte metafore, non disgiunte dai genuini impulsi vitali dell’uomo.
L'affresco si trova su una parete di villa Albani (Roma).
1 note
·
View note
Text
Libri: GAIA, di Gregorio Asero
Libri: GAIA, di Gregorio Asero
A Gaia, personificazione della terra, dea primigenia dall’inesauribile forza creatrice, origine stessa della vita, si ispira il poeta Asero: a Gaia, Gea, Madre Terra, al nostro pianeta oggi cosi martoriato, dedica le sue liriche sperando “che la poesia possa salvare dalle brutture che l’animo umano può generare”. In questa raccolta racconta le sue esperienze e le sue emozioni nell’osservare la…

View On WordPress
0 notes