#filosofia per non filosofi
Explore tagged Tumblr posts
Text
Al caffè degli esistenzialisti di Sarah Bakewell: Un viaggio tra filosofia, libertà e Parigi. Recensione di Alessandria today
Esplorare il mondo dell’esistenzialismo in compagnia di Sartre, de Beauvoir, Camus e altri grandi pensatori
Esplorare il mondo dell’esistenzialismo in compagnia di Sartre, de Beauvoir, Camus e altri grandi pensatori Recensione Al caffè degli esistenzialisti. Libertà, Essere e Cocktail di Sarah Bakewell è un’opera che invita il lettore a esplorare il mondo dell’esistenzialismo, una delle correnti filosofiche più influenti del XX secolo, attraverso una prospettiva intima e coinvolgente. Bakewell, con…
#Al caffè degli esistenzialisti#Albert Camus#Alessandria today#angoscia e libertà#angoscia esistenziale#caffè filosofici#cocktail e filosofia#concetti di esistenza#corrente esistenzialista#divulgazione filosofica#esistenzialismo e libertà#esistenzialismo oggi#Fazi Editore#filosofi a Parigi#filosofia accessibile#Filosofia del XX secolo#filosofia e vita quotidiana#filosofia esistenzialista#filosofia moderna#filosofia per non filosofi#Heidegger filosofia#introspezione e filosofia#italianewsmedia.com#Jean-Paul Sartre#letteratura e filosofia#letteratura filosofica#libertà e filosofia#libertà e scelta#libri sulla libertà#libro su esistenzialismo
0 notes
Text
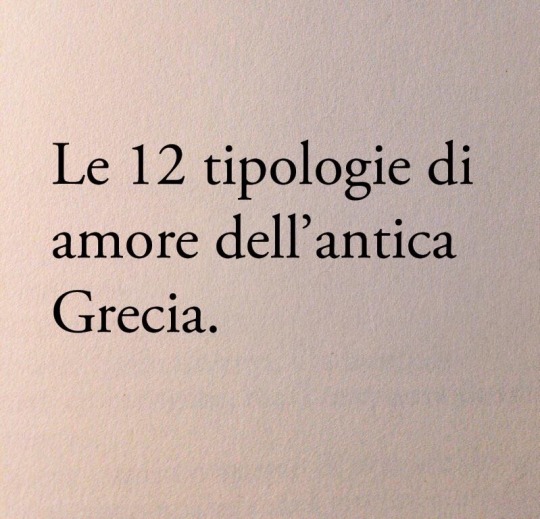
Jorge Luis Borges sosteneva che gli antichi greci furono i primi a pensare, ci hanno dato la poesia, la scienza, la filosofia razionale, che tutta la cultura a noi pervenuta nel corso dei secoli derivi dai greci.
I filosofi greci distinguevano l’amore in 12 tipologie diverse a seconda delle diverse emozioni umane e sfumature del sentimento:
Agape (αγάπη)
Agape è l’amore incondizionato, anche non ricambiato. Va al di là delle forze umane, è un amore puro e senza alcuna aspettativa. Viene utilizzato nei vangeli e nella religione.
Eros (έρως)
Eros è la tipologia di amore più conosciuta. Dio greco della fertilità, il suo tipo di amore rappresenta quello passionale, il desiderio carnale. Veniva definito in termini di irrazionalità, perché il desiderio ardente avrebbe potuto portare alla follia.
Philia (φιλία)
Philia indica un tipo di amicizia profonda. Amicizia come vincolo di fiducia e lealtà, come fondamenta di un rapporto solido e suggellato dalla bellezza della condivisione. Amare ed essere amati.
Storge (στοργή)
Storge è l’amore nei confronti della famiglia o dei parenti, tipico dei consanguinei, deriva da “stergo” che significa amare teneramente.
Philautia (φιλαυτία)
Philautia è l’amore per sé stessi, l’amor proprio, fonte di perfezionamento e benevolenza è definito come forma di egoismo positivo.
Mania (μανία)
Mania associato all’amore è il desiderio incondizionato di amare e possedere, l’amore tossico che vive (apparentemente) solo attraverso il possesso di ciò che brama, il partner come oggetto del desiderio. Distruttivo.
Charis (χάρις)
Charis è forse la tipologia d’amore più ambita tanto quanto appagante: idilliaco. Entrambi i partner si amano allo stesso modo, sia fisicamente che spiritualmente.
Himeros (ἵμερος)
Himeros è l’amore che arde di desiderio fisico, impulsivo, irrefrenabile, l’amore folle. Desiderio carnale, non ascolta ragioni e va appagato nell’immediato.
Anteros (αντέρως)
Anteros, fratello di Eros (si narra fossero inseparabili) è l’amore corrisposto con il rispettivo coniuge/compagno e indica la stabilità sentimentale.
Pragma (πρᾶγμα)
Pragma è associato all’amore maturo di lunga data, ma anche al compromesso e alla pazienza. Fare uno sforzo per dare amore piuttosto che solo per riceverlo.
Pothos (Πόθος)
Pothos è la personificazione del rimpianto e del senso di nostalgia che si prova quando una persona amata è lontana. È anche identificato con l’amore adolescenziale, l’infatuazione, il desiderio prima dell’incontro.
Thelema (θέλημα)
Thelema è l’amore nei confronti di ciò che si fa, il proprio lavoro, il piacere di fare qualcosa, il desiderio voler fare e non è rivolto quindi ad una persona.
— manuela g.
#frasi#citazioni#amore#libro#love#frasi citazione#frasi libro#antica grecia#manuela g.#manuelag.#mare#letteratura#citazioni libro#classic lit art#arte
812 notes
·
View notes
Text
chi vinse veramente quando Einstein e Bergson discussero sul tempo?

Albert Einstein al College de France
La sera del 6 aprile 1922, durante una conferenza a Parigi, il filosofo Henri Bergson e il fisico Albert Einstein si scontrarono sulla natura del tempo in uno dei grandi dibattiti intellettuali del XX secolo. Einstein, che allora aveva 43 anni, era stato portato da Berlino per parlare alla Société française de philosophie della sua teoria della relatività, che aveva affascinato e scioccato il mondo. Per il fisico tedesco, il tempo misurato dagli orologi non era più assoluto: il suo lavoro dimostrava che eventi simultanei erano simultanei in un solo sistema di riferimento. Di conseguenza, aveva, secondo un editoriale del New York Times , "distrutto spazio e tempo" ed era diventato una celebrità internazionale. Fu braccato dai fotografi dal momento in cui arrivò a Parigi. L'aula magna era gremita quella sera di aprile.
Seduta tra la folla radunata c'era un'altra celebrità. Bergson, che allora aveva 62 anni, era altrettanto famoso a livello internazionale , in particolare per il suo best-seller L'evoluzione creatrice (1907), in cui aveva reso popolare la sua filosofia basata su un concetto di tempo e coscienza che chiamava " la durée " (durata). Bergson accettava la teoria di Einstein nel regno della fisica, ma non poteva accettare che tutti i nostri giudizi sul tempo potessero essere ridotti a giudizi su eventi misurati da orologi. Il tempo è qualcosa che sperimentiamo soggettivamente. Lo sentiamo passare intuitivamente. Questa è la "durata".
Il loro dibattito iniziò quasi per caso. L'incontro di aprile era stato convocato per riunire fisici e filosofi per discutere della teoria della relatività, ma Bergson si presentò con l'intenzione di ascoltare. Quando la discussione si spense, tuttavia, fu pressato a intervenire. Con riluttanza, si alzò e presentò alcune idee dal suo libro di prossima uscita, Duration and Simultaneity (1922). Come Jimena Canales ha documentato nel suo libro The Physicist and the Philosopher (2015), ciò che Bergson disse nella mezz'ora successiva avrebbe dato il via a un dibattito che avrebbe riverberato per tutto il XX secolo e fino al XXI. Avrebbe cristallizzato controversie ancora vive oggi, sulla natura del tempo, l'autorità della fisica rispetto alla filosofia e la relazione tra scienza ed esperienza umana.
Bergson iniziò dichiarando la sua ammirazione per il lavoro di Einstein: non aveva obiezioni alla maggior parte delle idee del fisico. Piuttosto, Bergson contestò il significato filosofico dei concetti temporali di Einstein e incalzò il fisico sull'importanza dell'esperienza vissuta del tempo e sui modi in cui questa esperienza era stata trascurata nella teoria della relatività.
Sebbene Einstein fosse costretto a parlare in francese, una lingua di cui aveva una scarsa padronanza, impiegò solo un minuto per rispondere. Riassunse la sua comprensione di ciò che Bergson aveva detto e poi liquidò le idee del filosofo come irrilevanti per la fisica. Einstein credeva che la scienza fosse l'autorità sul tempo oggettivo e che la filosofia non avesse alcuna prerogativa di intervenire. Per concludere la sua confutazione, dichiarò: "Non esiste un tempo del filosofo; esiste solo un tempo psicologico diverso dal tempo del fisico".

Henri Bergson nel 1908.
Ma nonostante quello che molti hanno finito per credere sul dibattito iniziato quella notte, Einstein si sbagliava. Esiste un terzo tipo di tempo: il tempo del filosofo.
Quando Duration and Simultaneity fu pubblicato più avanti nello stesso anno, il dibattito di Bergson con Einstein divenne più pubblico e diffuso, coinvolgendo molti altri fisici e filosofi. Ma man mano che si diffondeva, iniziarono ad apparire delle crepe nelle affermazioni del filosofo. L'argomentazione dimostrava che Bergson aveva frainteso un importante aspetto tecnico della teoria della relatività speciale di Einstein, in particolare per quanto riguarda la dilatazione del tempo (la differenza nel tempo trascorso, misurata da due orologi, dovuta alle loro velocità relative). A causa di questo fallimento, molti giunsero a credere non solo che Einstein avesse vinto il dibattito, ma che la filosofia della durata non avesse alcuna attinenza con il mondo della fisica. Bergson iniziò ad apparire fuori dal contatto con l'avanguardia della scienza. Come scrisse il filosofo Thomas L Hanna nel 1962:
Le teorie di Einstein ricevettero gradualmente una verifica sempre più drammatica, mentre le teorie di Bergson appassirono sulla vite. La migliore spiegazione per l'impressionante fallimento di Bergson ... [è che] non era sufficientemente esperto delle prospettive e dei problemi della matematica e della fisica.
Perfino il premio Nobel Ilya Prigogine e la filosofa Isabelle Stengers, che simpatizzavano con la filosofia di Bergson nel loro libro rivoluzionario L'ordine dal caos (pubblicato per la prima volta in francese nel 1978), scrissero che egli aveva "evidentemente frainteso la teoria della relatività di Einstein".
Ma un esame ravvicinato dell'opera di Bergson non conferma questi giudizi sbilanciati. Non era in contatto né con la scienza né con la matematica. In effetti, era abile in matematica: aveva vinto un prestigioso premio di matematica e il suo primo lavoro pubblicato era su una rivista di matematica. E sebbene si sbagliasse su un aspetto tecnico della teoria della relatività, aveva ragione su qualcosa di più fondamentale: il tempo non è solo ciò che misurano gli orologi. Deve essere compreso in altri modi che attingono direttamente alla nostra esperienza della durata.
Bergson ha insistito sul fatto che la durata propriamente detta non può essere misurata.
Per comprendere la visione del tempo del filosofo francese, dobbiamo tornare agli anni '80 dell'Ottocento, quando stava lavorando alla sua tesi di dottorato. Questo lavoro sarebbe stato pubblicato come il suo primo libro nel 1889, noto in inglese come Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness , quando aveva 30 anni. Il contributo chiave del libro è l'idea che il tempo non è spazio. Di solito immaginiamo il tempo come analogo allo spazio. Lo immaginiamo, ad esempio, disposto su una linea (come una linea temporale di eventi) o un cerchio (come un anello di meridiana o un quadrante di orologio). E quando pensiamo al tempo come ai secondi su un orologio, lo spazializziamo come una serie ordinata di unità discrete, omogenee e identiche. Questo è il tempo dell'orologio. Ma nella nostra vita quotidiana non viviamo il tempo come una successione di unità identiche. Un'ora sulla poltrona del dentista è molto diversa da un'ora con un bicchiere di vino con gli amici. Questo è tempo vissuto. Il tempo vissuto è flusso e cambiamento costante . È 'divenire' piuttosto che 'essere'. Quando trattiamo il tempo come una serie di unità uniformi e immutabili, come punti su una linea o secondi su un orologio, perdiamo il senso di cambiamento e crescita che definisce la vita reale; perdiamo il flusso irreversibile del divenire, che Bergson chiamava 'durata'.
Pensa a una melodia. Ogni nota ha la sua distinta individualità mentre si fonde con le altre note e i silenzi che vengono prima e dopo. Mentre ascoltiamo, le note passate indugiano in quelle presenti e (specialmente se abbiamo già sentito la canzone prima) le note future potrebbero già sembrare risuonare in quelle che stiamo ascoltando ora. La musica non è solo una serie di note discrete. La sperimentiamo come qualcosa di intrinsecamente duraturo.
Per misurare qualcosa, come volume, lunghezza, pressione, peso, velocità o temperatura, dobbiamo stabilire l'unità di misura in termini di uno standard. Ad esempio, un tempo il metro standard era stabilito essere la lunghezza di una particolare barra di platino lunga 100 centimetri conservata a Parigi. Ora è definito da un orologio atomico che misura la lunghezza di un percorso di luce nel vuoto in un intervallo di tempo estremamente breve. In entrambi i casi, il metro standard è una misura di lunghezza che ha essa stessa una lunghezza. L'unità standard esemplifica la proprietà che misura.
Bergson insisteva sul fatto che la durata vera e propria non può essere misurata. Per misurare qualcosa, come volume, lunghezza, pressione, peso, velocità o temperatura, dobbiamo stabilire l'unità di misura in termini di uno standard. Ad esempio, un tempo il metro standard era stabilito essere la lunghezza di una particolare barra di platino lunga 100 centimetri conservata a Parigi. Ora è definito da un orologio atomico che misura la lunghezza di un percorso di luce nel vuoto in un intervallo di tempo estremamente breve. In entrambi i casi, il metro standard è una misura di lunghezza che ha essa stessa una lunghezza. L'unità standard esemplifica la proprietà che misura.
In Tempo e libero arbitrio , Bergson sosteneva che questa procedura non avrebbe funzionato per la durata. Affinché la durata possa essere misurata da un orologio, l'orologio stesso deve avere una durata. Deve esemplificare la proprietà che dovrebbe misurare. Per esaminare le misurazioni coinvolte nel tempo dell'orologio, Bergson considera un pendolo oscillante, che si muove avanti e indietro. In ogni momento, il pendolo occupa una posizione diversa nello spazio, come i punti su una linea o le lancette in movimento sul quadrante di un orologio. Nel caso di un orologio, lo stato attuale, l'ora attuale, è ciò che chiamiamo "adesso". Ogni "adesso" successivo dell'orologio non contiene nulla del passato perché ogni momento, ogni unità, è separata e distinta. Ma non è così che sperimentiamo il tempo. Invece, teniamo insieme questi momenti separati nella nostra memoria. Li unifichiamo. Un orologio fisico misura una successione di momenti, ma solo l'esperienza della durata ci consente di riconoscere questi momenti apparentemente separati come una successione. Gli orologi non misurano il tempo; lo facciamo noi. Ecco perché Bergson credeva che il tempo dell'orologio presupponesse il tempo vissuto.
Bergson si rese conto che abbiamo bisogno dell'esattezza del tempo dell'orologio per le scienze naturali. Ad esempio, per misurare il percorso che un oggetto in movimento segue nello spazio in un intervallo di tempo specifico, dobbiamo essere in grado di misurare il tempo con precisione. Ciò a cui si opponeva era la sostituzione surrettizia del tempo dell'orologio con la durata nella nostra metafisica del tempo. Il suo punto cruciale in Tempo e libero arbitrio era che la misurazione presuppone la durata, ma la durata in ultima analisi sfugge alla misurazione.
Einstein aveva una diversa comprensione del tempo. Nel suo articolo 'On the Electrodynamics of Moving Bodies' (1905), sosteneva di aver definito il tempo interamente in termini oggettivi. Utilizzando 'certi esperimenti fisici immaginari' come procedure o test oggettivi, diede definizioni per i concetti di 'tempo', 'sincrono' e 'simultaneo'. Egli scrive:
"Dobbiamo tenere conto che tutti i nostri giudizi in cui il tempo gioca un ruolo sono sempre giudizi di eventi simultanei . Se, per esempio, dico: "Quel treno arriva qui alle 7 ", intendo qualcosa del tipo: "Il fatto che la lancetta piccola del mio orologio punti sulle 7 e l'arrivo del treno sono eventi simultanei".
Le definizioni basate su tali "esperimenti fisici immaginari" avrebbero continuato a supportare le idee di Einstein sulla relatività. Per Einstein, il "tempo" di un evento è "ciò che è dato simultaneamente all'evento da un orologio stazionario situato nel luogo dell'evento, questo orologio essendo sincrono, e in effetti sincrono per tutte le determinazioni di tempo, con un orologio stazionario specificato". Questa definizione usa la simultaneità tra un evento locale e un orologio locale per definire il tempo dell'evento. Ma ciò che conta come cosiddetta simultaneità locale dipende dall'esperienza diretta di qualcuno che percepisce sia l'evento che l'orologio insieme in un "adesso" soggettivo. Come sostenne Bergson nel dibattito del 1922, la simultaneità locale è sempre qualcosa che viene percepito da esseri coscienti. Gli orologi non si leggono da soli. Inoltre, la simultaneità locale è relativa al percettore: ciò che è localmente simultaneo per un microbo intelligente con un orologio delle dimensioni di un microbo, per usare l'esempio di Bergson, differisce da ciò che è localmente simultaneo per un percettore umano con un orologio. Ciò significa che le definizioni di Einstein non sono completamente oggettive: si basano sull'esperienza soggettiva del tempo del percettore per la loro significatività, non solo su procedure o test oggettivi. Solo un osservatore cosciente può stabilire la simultaneità tra un evento e un orologio. Per leggere un orologio, devi già sapere che ore sono , e questo è qualcosa che nessun orologio può dirti.
Il vero errore di Einstein fu quello di non omettere la durata dalla teoria della relatività speciale
Bergson accettò che, affinché i fisici potessero misurare momenti esatti (vale a dire, identificare con precisione il tempo di un evento), dovevano semplificare l'esperienza continua del tempo e astrarre dal concetto di durata. Non si oppose a questo genere di astrazioni. Ciò a cui si oppose fu la sostituzione surrettizia dell'istante (un intervallo temporale infinitesimale il cui passaggio è istantaneo) alla durata nella metafisica del tempo. Si opponeva al modo in cui Einstein aveva dimenticato che il concetto di istante ha senso solo come semplificazione astratta della nostra esperienza concreta della durata. Bergson voleva che Einstein vedesse che il concetto intuitivo o esperienziale di simultaneità, che si basa sulla nostra esperienza vissuta della durata, giaceva sepolto nella definizione a sostegno della teoria della relatività. Stava richiamando l'attenzione su un'amnesia dell'esperienza nella fisica matematica.
Queste obiezioni ebbero scarso impatto su Einstein, sia nel 1922 che negli anni successivi. Per il fisico, la prova finale era semplicemente se la sua teoria funzionava. Comprendere l'esperienza vissuta del tempo non lo avrebbe aiutato nella sua teoria, motivo per cui riteneva la durata irrilevante, e non c'è niente di sbagliato in questo. Il suo vero errore non fu quello di omettere la durata dalla teoria della relatività speciale. Piuttosto, era sua opinione che il tempo fisico, definito attraverso le misurazioni degli orologi, fosse più fondamentale del tempo vissuto.
A questo punto potresti obiettare: la durata non è solo qualcosa che accade dentro le nostre teste? La nostra esperienza del tempo che passa non è forse un'illusione cognitiva che nasce da un'attività misurabile nel nostro cervello? Ad esempio, se due luci vengono giudicate simultanee o sequenziali, o come una singola luce in movimento, dipende non solo dalla quantità di tempo tra di esse, ma anche da come si relazionano all'attività cerebrale del percettore. Allora perché non possiamo dire che la nostra esperienza della durata è solo il risultato del nostro cervello che leviga dettagli fini e granulari in modo che il tempo sembri scorrere?
Questo ci porta alla confutazione finale di Einstein della sera del 1922: "Non esiste un tempo del filosofo; esiste solo un tempo psicologico diverso dal tempo del fisico". Ciò che intendeva con "tempo psicologico" era che la nostra esperienza interna del tempo poteva essere allineata con il tempo dell'orologio esterno e che ciò avrebbe potuto consentire agli esperti di descrivere in modo significativo le nostre percezioni. Questa idea di un tempo psicologico, tuttavia, non affronta la questione filosofica più fondamentale sollevata da Bergson: la durata non è la stessa cosa del tempo psicologico.
La misurazione del tempo, sia in fisica che in psicologia, è sempre a valle dell'esperienza vissuta della durata
Quando i neuroscienziati studiano la percezione del tempo, applicano il tempo dell'orologio ai correlati neurali, alle indicazioni comportamentali e ai resoconti verbali del tempo vissuto. Ciò consente loro di apprendere informazioni preziose su come il cervello umano analizza il tempo. Consente inoltre loro di produrre descrizioni in terza persona che collegano la coscienza al cervello come sistema fisico. Ma queste descrizioni in terza persona non sono sufficienti a spiegare l' esperienza in prima persona della durata. Rimane un divario inspiegato tra cervello e coscienza.
La durata ci aiuta a dare un senso a questa lacuna. Per produrre le loro descrizioni, i neuroscienziati si affidano alla loro esperienza in prima persona del tempo. Lo fanno ogni volta che leggono gli orologi e misurano gli intervalli di tempo in laboratorio; ogni volta che applicano il tempo dell'orologio a processi biologici e comportamentali osservabili; e ogni volta che deducono aspetti della durata che possono estrarre e stabilizzare come oggetti di pensiero e attenzione. In effetti, tutto il loro lavoro si svolge all'interno del tempo vissuto. Tuttavia, non possono mai uscire da questa esperienza e spiegarla in modo esaustivo. La durata viene opportunamente ignorata. Per queste ragioni, è sbagliato pensare che l'idea di durata di Bergson possa essere assimilata all'idea di tempo psicologico nel senso che intendeva Einstein. La misurazione del tempo dell'orologio, sia in fisica che in psicologia, è sempre a valle dell'esperienza vissuta della durata.
Einstein non capì questo punto. Bergson pensava che un'attenta analisi filosofica della teoria della relatività avrebbe dimostrato che l'intelligibilità del tempo misurabile dell'orologio era inestricabile dal tempo vissuto: questo era il compito che si era prefissato in Duration and Simultaneity . Sfortunatamente, il suo messaggio si perse nel dibattito a causa di un errore commesso nel suo trattamento della relatività speciale. Questo errore è il motivo per cui così tanti credevano che Einstein avesse "vinto" il loro dibattito. È parte del motivo per cui le teorie di Bergson "appassirono sulla vite" per tutto il XX secolo.
Il nocciolo dell'incomprensione di Bergson risiedeva nella sua lotta per conciliare le sue visioni filosofiche con le realtà empiriche della teoria di Einstein. In Tempo e libero arbitrio , Bergson aveva sostenuto che esiste un tempo universale di durata a cui partecipa tutta la coscienza. Confrontato con le idee di Einstein, cercò di conciliare la sua convinzione in una durata singolare e universale con i tempi plurali della teoria della relatività speciale. Il modo in cui lo fece fu sostenere che la pluralità di tempi dovesse essere considerata strettamente matematica piuttosto che fisicamente reale.
Bergson si è concentrato sul fenomeno della dilatazione del tempo. La dilatazione del tempo è la differenza nel tempo trascorso misurato da due orologi a causa delle loro velocità relative. L'orologio più veloce è quello a riposo e quello più lento è in movimento. Ma non esiste uno stato assoluto di riposo nella teoria della relatività. Ogni osservatore può considerare se stesso come a riposo mentre considera gli altri (ad esempio, altri sistemi di riferimento) come in movimento. Ecco perché la dilatazione del tempo influenza sempre l'orologio dell'"altro" osservatore considerato in movimento rispetto a quello considerato a riposo.
Bergson ragionò che, poiché non esiste un sistema di riferimento assoluto nella teoria della relatività speciale (e i sistemi di riferimento non subiscono accelerazione), le situazioni degli osservatori sono simmetriche e intercambiabili, e quindi la pluralità di tempi dovrebbe essere considerata solo matematica, e non fisicamente reale. E se i molti tempi fossero considerati strettamente matematici, allora potrebbero essere resi coerenti con l'unico tempo reale di durata. È qui che Bergson si è smarrito.
La dilatazione del tempo esiste solo in relazione ad un altro sistema di riferimento e può essere vista solo dall'esterno
Si è concentrato sul cosiddetto paradosso dei gemelli , in cui un gemello rimane sulla Terra mentre il fratello viaggia nello spazio su un razzo a una velocità prossima a quella della luce e poi torna sulla Terra alla stessa velocità. Secondo la teoria della relatività speciale, quando confrontano i loro orologi (che erano costruiti e sincronizzati in modo identico all'inizio del viaggio), è trascorso più tempo per il gemello rimasto sulla Terra e sembra essere invecchiato più del fratello. Bergson ha respinto questa idea. Ha sostenuto che, finché le situazioni dei gemelli erano rigorosamente identiche e non c'era accelerazione, l'orologio di ritorno non avrebbe mostrato alcun rallentamento al suo arrivo sulla Terra. A suo avviso, i tempi dell'orologio non erano fisicamente reali. Erano solo astrazioni matematiche. Ma Bergson si è dimostrato in errore. La dilatazione del tempo, prevista dalla relatività speciale, è stata confermata sperimentalmente come fenomeno fisico nel 1971.
Bergson aveva sostenuto due cose, una errata e l'altra corretta. Era un errore affermare che la dilatazione del tempo non è fisicamente reale, ma aveva ragione nell'affermare che nessuno sperimenta la dilatazione del tempo del proprio sistema di riferimento. La dilatazione del tempo esiste solo relativamente a un altro sistema di riferimento e può essere vista solo dall'esterno. Ciò significa che la dilatazione del tempo non è una misura del tempo di nessuno all'interno del proprio sistema di riferimento. Un sistema di riferimento è un'astrazione, non un dominio concreto dell'esperienza, e può essere specificato solo relativamente a un altro sistema di riferimento. E quindi, Bergson aveva ragione nell'affermare che ogni gemello sperimenta solo il proprio tempo. Questo punto, tuttavia, come molti altri, è stato ignorato o trascurato da Einstein.
Bergson ha insistito sul fatto che il gemello in viaggio non avrebbe sentito il rallentamento del tempo. Per notare la dilatazione del tempo, avrebbe dovuto stare fuori dal suo sistema di riferimento e confrontare le letture dell'orologio con il gemello rimasto sulla Terra. Senza questo confronto, la dilatazione non sarebbe stata notata perché non avrebbe sentito il rallentamento del tempo. Qualcuno potrebbe sostenere che Bergson ha trascurato la dipendenza dell'esperienza dall'attività cerebrale, che rallenta anche nel gemello in viaggio, il che significa che il flusso di coscienza del viaggiatore sarebbe trascorso più lentamente rispetto a quello del fratello. Tuttavia, questo rallentamento non sarebbe stato notato dal viaggiatore. La velocità di passaggio più lenta esiste, o è ci�� che è, solo rispetto all'altro sistema di riferimento sulla Terra. Quindi non ha senso dire che il gemello in viaggio sperimenta un tempo diverso da quello del suo gemello. Entrambi sperimentano la durata, sebbene le loro esperienze individuali di durata siano particolari per loro. Nelle parole di Bergson, un gemello che sperimenta un tempo diverso è un "fantasma", una "visione mentale" o un'"immagine", che appare alla prospettiva del gemello sulla Terra.
Bergson pensava che se una misurazione del tempo perdeva la sua connessione con la durata, non era realmente una misurazione del tempo. E questo è ciò che credeva fosse accaduto ai diversi tempi della relatività speciale. Per Bergson, non c'era durata nella concezione di dilatazione del tempo di Einstein. La dilatazione del tempo si manifesta solo come una differenza tra le letture dell'orologio o una differenza tra le linee del mondo (i percorsi unici degli oggetti attraverso lo spaziotempo) calcolate da un fisico. Ma nessuno sperimenta una diversa velocità di passaggio. Tale differenza non può essere sperimentata direttamente perché non appena ti trasponi mentalmente nel sistema di riferimento in cui si verifica la dilatazione del tempo, la dilatazione del tempo scompare e riappare nel tuo sistema di riferimento originale. Qui, Bergson aveva ragione.
Nel secolo trascorso dal 1922, la distanza concettuale tra il fisico tedesco e il filosofo francese sembra essersi ridotta. Si scopre che esiste un modo per conciliare le idee di Bergson con la teoria della relatività speciale, anche se nessuno dei partecipanti al dibattito sembra averlo notato. Come ha suggerito il filosofo Steven Savitt , la durata può essere intesa come il passaggio del tempo locale o "proprio", il tempo misurato da un orologio che segue la linea di universo di un oggetto all'interno di un sistema di riferimento (ad esempio, seguendo un gemello che lascia la Terra alla velocità della luce). In altre parole, il tempo proprio può essere inteso come tempo di orologio misurabile basato sulla durata propria di un osservatore all'interno di un sistema di riferimento.
Ma questa riconciliazione implica che la durata è molteplice, non una, cosa che Bergson voleva evitare perché credeva che la durata fosse singolare e universale. Secondo questa riconciliazione, il passaggio del tempo è sempre dato da una prospettiva sperimentata nell'Universo e mai dall'esterno. La durata è molteplice perché non c'è un limite superiore al numero di possibili prospettive e linee di mondo associate. Ogni persona, ogni insetto, ogni roccia, ogni cosa , ha la sua linea di mondo. E ciascuna di queste linee di mondo riflette un passaggio unico attraverso il tempo e una possibile esperienza di durata. Meglio ancora, ogni linea di mondo rappresenta la distillazione di un flusso di durata unico, poiché una linea di mondo è un'astrazione matematica, mentre il passaggio (l'esperienza del tempo che passa) è concreto. L'Universo pullula di tempi e potenziali ritmi di durata. Ciò significa che non esiste una vista a volo d'uccello temporale dell'Universo che voli sopra e contempli tutti questi tempi come uno.
I tempi misurabili e i ritmi durazionali possono differire, ma l'esperienza del tempo che passa è in definitiva incommensurabile.
Attraverso questi tempi brulicanti e ritmi durazionali, possiamo vedere come la cosiddetta teoria dell'universo a blocchi , che si è pensato derivasse dalla teoria della relatività, vada fuori strada. Secondo questa teoria, il passaggio del tempo è un'illusione perché il passato, il presente e il futuro costituiscono tutti un singolo blocco nello spaziotempo quadridimensionale. Ma è impossibile concepire la realtà contemporanea di tutti gli eventi in un tale universo a blocchi senza adottare una prospettiva a volo d'uccello (o a volo di Dio) esterna all'Universo e al passaggio della natura. Riconciliare Bergson ed Einstein ci mostra che non può esserci una tale visione temporale a volo d'uccello dell'Universo. Non c'è modo di vedere al di fuori e al di sopra dei percorsi disparati attraverso lo spaziotempo e dei diversi ritmi di durata.
E tuttavia, nonostante questi tempi proliferanti, c'è un senso in cui la durata è anche singolare e universale, come pensava Bergson. Il tempo misurato presuppone sempre lo stesso ineliminabile fatto concreto della durata o del passaggio temporale. I tempi misurabili e i ritmi durazionali possono differire, ma l'esperienza del tempo che passa è in ultima analisi incommensurabile e resiste alla spiegazione in termini di qualsiasi altra cosa. Come sosteneva il matematico e filosofo Alfred North Whitehead più o meno nello stesso periodo di Bergson, possiamo individuare la caratteristica del passaggio della natura e descrivere la sua relazione con altre caratteristiche della natura, ma non possiamo spiegarla derivandola da qualcos'altro, come le unità temporali di un orologio. Quando misuriamo secondi, ore o altri intervalli temporali, misuriamo il tempo trascorso, che dipende dall'esperienza della durata. Ma, come sappiamo, la durata non può essere pienamente compresa misurando questi intervalli.
Poiché il tempo dell'orologio presuppone l'esperienza della durata, affermare che la durata e l'"adesso" sono un'illusione, come fece Einstein, elimina il terreno su cui deve poggiare la scienza. Indagare su quel terreno e acquisire intuizioni cognitive in esso sono il compito della filosofia, che trascende la scienza. C'è un tempo del fisico e un tempo dello psicologo. Ma c'è anche un tempo del filosofo, che sta al di sotto di entrambi e che Einstein non riuscì a cogliere.
Il dibattito iniziato la sera del 6 aprile 1922 e che si è esteso per tutto il XX secolo rappresenta un'occasione mancata per spostare la nostra visione scientifica del mondo oltre il suo punto cieco , ovvero la sua incapacità di vedere che l'esperienza vissuta è la fonte permanente e necessaria della scienza, comprese le teorie astratte nella fisica matematica. A posteriori, possiamo vedere che il dibattito è stato uno sfortunato malinteso. Le idee di Bergson ed Einstein sono più allineate di quanto entrambi abbiano realizzato durante le loro vite. Combinando le loro intuizioni, acquisiamo una comprensione di qualcosa di fondamentale. Tutte le cose, noi compresi, incarnano durate diverse mentre si muovono attraverso l'Universo. Non esiste un tempo unico. Attraverso i suoi tentativi di mostrare a Einstein un mondo nascosto di durata che passa sotto la relatività speciale, Bergson continua a ricordarci qualcosa di dimenticato nella nostra visione scientifica del mondo:
l'esperienza è la fonte ineliminabile della fisica.
9 notes
·
View notes
Text
Ma sul serio, quale sadomasochistico desiderio ci spinge ancora a voler essere membri attivi di questa società? E con membri attivi intendo cazzi tesi che si agitano a voler essere per forza qualcosa, a far parte di qualcosa, a rientrare in una qualche categoria. Essere un membro della società è faticoso. Prima lo ammettiamo, prima ce ne rendiamo conto e prima ci liberiamo dalla necessità di dover essere un cazzo teso perché no, non siamo all'altezza: il cazzo non si tende manco per sbaglio. Abbiamo voglia poi di prendere antidepressivi e affidarci a psicoterapie a volte anche abbastanza dubbie. Non siamo all'altezza degli standard che ci siamo prefissati: siamo dei cazzetti mosci tristi e piagnucoloni. Basta, amen. Ma tornando alla fatica e soprattutto tornando alla società: francamente viene l'ansia solo a guardarla. Se sei una donna devi essere fragile ma con le palle, emancipata a forza che mi chiedo dove inizia l'emancipazione e finisce la sottomissione perché a me pare solo che cambia il padrone ma sempre a novanta stiamo messe; se sei un maschio devi essere maschio, femmina, etero, bi, con i muscoli ma che ti piacciono i gattini, spolverare e cucinare, però devi essere pure stronzo, uno stronzo dal cuore d'oro che ti fai curare perché io sono la tua crocerossina però ehi non ti ci abituare! Sbracciati e curami pure tu, diventa dottore. E in tutto questo non ho parlato delle dinamiche che si attivano nei social: fai delle foto e devi essere un content creator; pubblichi cibo e devi essere un food influencer; pubblichi foto di tette e devi farti onlyfans; ti trucchi e devi essere una di quelle che sponsorizza ecc ecc ecc. E questo solo nei rapporti tra comune gente mortale, tra cazzetti mosci insomma! Nel mondo del lavoro le cose forse vanno pure peggio: lauree, master, dottorati, attestati, diplomi di vario tipo alternando cucina, scrittura di codici, filosofia. Ok, il mondo è bello perché vario ma sembra solo un accumulo di escrementi cacati dal capitalismo il cui obiettivo è solo rendersi sempre più impossibile. Ma come tutti i belli e dannati, più è impossibile più ci piace perché ci piace soffrire, e poi ci lamentiamo perché siamo dei depressi malati ansia. Qual è la soluzione a tutto questo? E che ne so. Lascio ai filosofi contemporanei l'arduo compito di trovarci una via d'uscita. Per quel che mi riguarda ho le energie talmente contate che non ho voglia né tempo di entrare in questo circolo vizioso. Se l'uomo è stato pensato fino ad ora come un essere sociale, che ha bisogno della società bene, ha talmente esasperato questo bisogno che adesso la società è diventata solo un sinonimo di sofferenza.
25 notes
·
View notes
Text
Questo uomo no, #137 - Quello che parla dei libri che non ha letto per dimostrare di non sapere le cose di cui parla

Mi scuso in anticipo per la parentesi molto personale, ma certe cose fanno davvero troppo ridere e credo sia giusto farne esempio utile a più persone possibile.
Di per sé il tipo di maschilista di cui parlo non sarebbe un soggetto nuovo, rappresenta l'ennesima versione di ignorante che merita un posto nella Armata delle Tenebre. Però in questo caso mi ha molto colpito che l'ignoranza venisse proprio da una categoria alla quale appartengo: quella di chi lavora in filosofia. In più (ignoranza al quadrato?) parlando di un libro che affronta argomenti di filosofia: il mio ultimo.
Il soggetto in questione - non importa il nome come non importa il titolo del mio libro, tanto è una scenetta che puntualmente si ripete a ogni libro che tratti di problemi di genere commentato da chi lavora con la filosofia - si produce su un social in un primo commento che già da solo, secondo la nota "Lewis' Law", giustifica l'esistenza del libro stesso:

Ovviamente non mi sento colpevole affatto, visto che descrivo semplicemente chi sono secondo concetti assolutamente non colpevolizzanti - se li si conosce e li si sa usare. Non vorrei citarmi addosso di nuovo, ma qui si legge evidentemente una coda di paglia enorme, resa rogo fiammeggiante dalla maschia immagine di un Platone intento a prendermi a pugni. Almeno forse mi riterrebbe degno dei suoi colpi; uno che scrive usando i concetti in questo modo probabilmente a Platone farebbe tanto schifo da non volerlo toccare manco per menarlo.
Ma il meglio deve ancora venire: sollecitato da un suo "amico" sui social, il nostro lascia la prova che il libro di cui parla non l'ha letto, o se l'ha letto ha capito cose che non erano nel libro ma già nella sua testa:
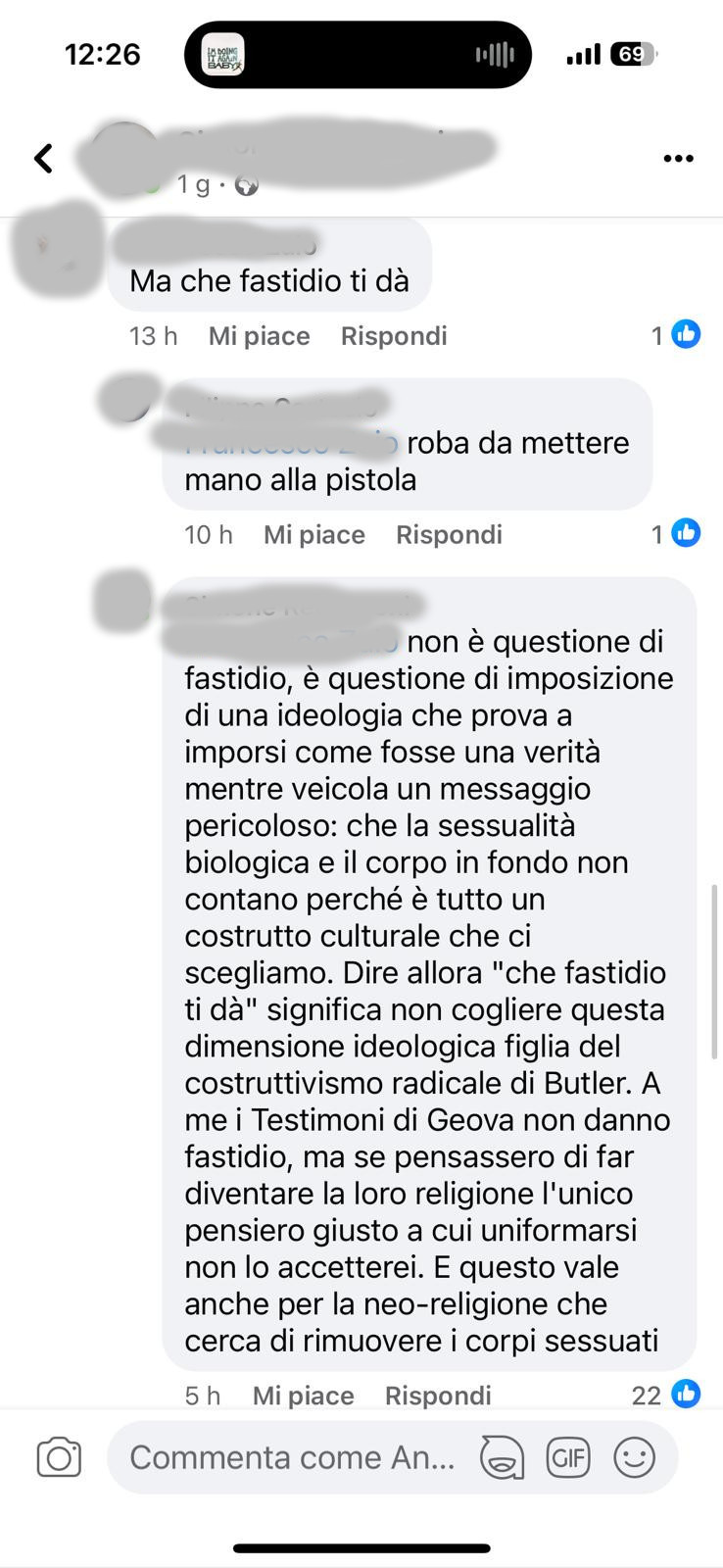
Basta anche solo leggere la quarta di copertina o le bandelle del mio libro per rendersi conto che lamento proprio (tra le altre cose) il fatto che i filosofi hanno sempre messo molto poco, nel loro lavoro, del loro corpo sessuato. In più, Butler praticamente non la cito manco per sbaglio; essendo una post-strutturalista, forse "costruttivista" come viene detto ma certo non fenomenologa come lo sono io, non "uso" in nessun modo il suo pensiero.
Poi vabbè, tutta la pomposa storiella su ideologia e religione rientra nella solita retorica ignorante "antigender" che come vedete è stata ben assimilata senza un briciolo di ricerca o di critica anche da chi ha una cattedra universitaria in filosofia (sì, il soggetto autore delle parole sopra riportate rientra in questa nobile categoria).
Ah, per chi se lo chiedesse: sì, il commento in cui si invoca la pistola (di altro "amico" suo di social) sarebbe da querela, ma già non ho tempo da perdere con gli ignoranti, figuriamoci con i loro amici.
Il problema non è essere d'accordo o no con quello che scrivo eh, figuriamoci. Intravedo un problema più grande nell'essere un cattedratico di filosofia e professare maschilismo ignorante senza neanche rendersene conto. Che è esattamente uno degli argomenti del mio ultimo libro.
Non posso che ringraziare pubblicamente l'autore di questa involontaria ma utile dimostrazione di quanto sostengo. Aggiungo che no, questo uomo no.
11 notes
·
View notes
Text
Stamattina ho incontrato per caso il mio prof di filosofia del liceo.
Si ricordava - Ballarini, Francesca!, dall'altra parte del piazzale mi evoca, con le sue bustine di dolcetti in mano - della nostra classe "estrosa" (dixit), la tesina su Chagall, su Raffaella Carrà, su 2001 Odissea nello spazio, col videoregistratore che entrava nell'aula dell'esame. Ridevo, che avessimo piazzato una bandiera eccentrica senza volerlo, il primo anno delle tesine ispirate per la maturità.
Soffrivamo i suoi compiti in classe, eppure lui, adorabile, ce li riproponeva a crocette da 100 domande, così imparavamo, sì, ma a memoria. Erano inferno, non uscivamo di casa per studiare, solo filosofia tralasciando il resto, materia feroce da assemblea di classe, ridotto a esercizio matematico e nient'afflato, come potevi spiegarglielo?, lui convinto, continuava a credere nelle mille crocette.
Che strana commistione tutt'ora, quest'uomo scapecciato, tenero, interessato e preparato sui suoi ex alunni, ci enumera senza passi falsi, vorrei abbracciarlo e assieme spiattellare che Lo sa? non ricordo un fico di Kant.
Mi chiede cosa faccio anzi lo sa bene, ci cerca in internet, le vedo le cose che fai, e ora e ora su cosa lavori? mi mostra i pacchetti, meringhe e spaccasassi per i parenti di Milano, passa di palo in frasca, il pensiero corre come un tomo di filosofi vocianti, mi parla dei prèsidi passati, del liceo ora, degli extra corsi a scuola — tu facevi teatro vero? Ah, le crocette sisi, le faccio ancora, vi preparano per il futuro.
E poi mi ricordo di tua mamma, dice — guarda un po' lontano, ma ci fa sempre, son io che guardo lontano, mentre lui guarda lontano,
La ricordo bene, si faceva sentire, era una presenza vivida, fa cenno da solo di sì con la testa, approva, critica, autocritica chi lo sa
(di sicuro ricorda le noie, penso io, il dibattito, il fuoco appassionato di mamma, quanto poteva aver portato la nostra ragione in classe)
La ricordo bene
(così la capacità di dire, di cercare il giusto, difficile spiegarne la teoria, tutta pratica, un po' di maieutica, più rivoluzionaria)
Guarda lontano — è lì la sua pratica, il ricordo di lei nel mondo, qualsiasi
Scuote i capelli — e in me intanto risale il fuoco del se sa, se non lo sa,
Beh quando ti capita me la saluti?
mamma rappresentante dei genitori, dalle elementari al liceo, croce e delizia, ispirazione e desperazione, figurati per quegli anni di crocette
Mamma non c'è più, dall'anno scorso, sorrido mentre lo dico perché provo a non farmi rompere la voce
che invece si spacca come un fico maturo,
sbrodola, ma mi riprendo, ci metto una fetta di pane:
Ma sono felice che se la ricordi così!
Certo, lui guarda in basso, guarda su, preme le labbra per me, sorride
fulgida filosofia senza crocette.
31 notes
·
View notes
Text
Nessuna AI è stata maltrattata per scrivere questo testo. Il racconto di Kalistos e la Follia della Verità
C’è un tempo in cui gli uomini credono di possedere la verità, ma è solo allora che la verità li possiede.
Prologo: L’ascesa di Kalistos
C'era una volta, nell'antica Ellade, un uomo di nome Kalistos, il cui nome significava "il più bello e il migliore". Figlio di Cléon, un umile artigiano di anfore, Kalistos crebbe con l'ossessione di superare le sue origini modeste. Da giovane si allenò duramente nelle palestre di Atene, imparando l'arte della retorica dai sofisti e affinando la sua mente con le opere dei grandi filosofi. Il suo cuore era divorato da un unico desiderio: essere riconosciuto come il più saggio e il più giusto tra gli uomini.
Il giorno in cui il re di Eleusi indisse un concorso di sapienza per scegliere il prossimo consigliere di corte, Kalistos si presentò con l'arroganza di chi già conosce l'esito. Nella piazza gremita, sbaragliò ogni rivale con la forza della sua logica, il suo arguto parlare e la sua capacità di umiliare gli avversari con domande capziose. Alla fine, il re disse:
— "Kalistos, hai dimostrato una mente più affilata di un rasoio di bronzo. D’ora in poi sarai il mio consigliere e siederai al mio fianco come la voce della ragione."
Da quel giorno, Kalistos si convinse di essere l’uomo più saggio della terra.
Capitolo I: La tentazione della Verità
Con il passare degli anni, Kalistos divenne celebre in tutta la Grecia. Ogni città lo chiamava per risolvere dispute e sciogliere enigmi. Con la fama, però, crebbe anche il suo orgoglio. Kalistos non si limitava a giudicare le questioni, ma si ergeva a portatore di verità assoluta.
Un giorno, mentre camminava per le vie di Delfi, decise di visitare il tempio di Apollo. Entrato nel santuario, vide la Pizia, la sacerdotessa dell’oracolo, seduta sul tripode, circondata da vapori sacri. Kalistos si avvicinò e, con tono sprezzante, chiese:
— "Pizia, se tu sei così saggia, dimmi: qual è la verità più alta che un uomo possa conoscere?"
La sacerdotessa rise, una risata antica e profonda. Poi rispose con voce fumosa:
— "La verità più alta è quella che muta, come il fumo che vedi intorno a me. Chi crede di possederla, ne è solo prigioniero."
Kalistos non diede peso alle sue parole. Anzi, rise di lei e uscì dal tempio convinto che quella vecchia pazza non sapeva di cosa parlava.
Capitolo II: Gli incontri sul sentiero
Kalistos si mise in viaggio per tornare a Eleusi. Sulla strada, incontrò tre figure che avrebbero cambiato il suo destino.
1. Il Vecchio Pastore
Kalistos trovò un vecchio pastore seduto su una pietra, intento a intrecciare una corda di giunco. L’uomo, con il volto segnato da rughe profonde, osservava il cielo con occhi socchiusi.
— "Cosa osservi, vecchio?" chiese Kalistos.
— "Guardo il volo degli uccelli", rispose il pastore.
— "Sciocco! Gli uccelli non rivelano nulla. Io ho studiato la logica e la filosofia, non c’è nulla negli uccelli che possa insegnare agli uomini."
Il pastore scosse il capo e disse:
— "Forse non hai mai visto un uccello cercare il nido. Anche lui pensa di conoscere la via, ma spesso sbaglia ramo e si ritrova perso."
Kalistos rise, e con tono altezzoso, replicò:
— "Io non sono un uccello. Io non sbaglio mai strada."
2. La Donna Silente
Più avanti, Kalistos trovò una donna seduta sul ciglio della strada. Aveva uno sguardo immobile e profondo, come se vedesse il mondo senza aver bisogno degli occhi.
— "Donna, perché non parli? Sei forse muta?" disse Kalistos.
Lei lo fissò, senza dire nulla.
— "Credi che il silenzio sia saggezza? Io ti dico che la vera saggezza è nella parola chiara e definita!"
La donna si alzò e si avvicinò lentamente, poi posò una mano sul petto di Kalistos e sussurrò:
— "Le parole sono catene quando credi di avere ragione su tutto."
Il cuore di Kalistos fu scosso per un attimo, ma il pensiero gli scivolò via come acqua su pietra.
3. Il Ragazzo Sognatore
Infine, Kalistos incontrò un giovane intento a scolpire una statua di argilla.
— "Ragazzo, chi stai raffigurando?" chiese.
— "Il mio sogno", rispose il ragazzo, "ma ogni volta che finisco la scultura, la distruggo e la ricomincio."
— "Stolto!" esclamò Kalistos. "Il sogno va reso eterno. Non devi rifarlo, devi portarlo a compimento!"
Il ragazzo lo fissò con uno sguardo carico di stupore e disse:
— "Se il sogno non muta, muore."
Questa volta, Kalistos sentì qualcosa rompersi dentro di lui, ma non capì cosa fosse.
Capitolo III: La Rivelazione della Donna del Vento
Quando Kalistos tornò a Eleusi, il re lo convocò.
— "Kalistos, una donna misteriosa è giunta a corte. Porta con sé un vento che muta ogni cosa. Ho bisogno di te per giudicarla."
Quando Kalistos entrò nella sala del trono, trovò la donna del vento. Era la stessa donna silente che aveva incontrato lungo il cammino. I suoi occhi ora erano fiamme azzurre.
— "Kalistos", disse la donna, "tu hai camminato su questa terra come se la verità ti appartenesse. Ma io ti dico che la verità è vento e non pietra."
Con un soffio, la donna agitò l'aria. Improvvisamente, tutte le colonne della sala iniziarono a oscillare. Kalistos vide le pareti muoversi e sentì il pavimento traballare.
— "Cosa fai, strega? Vuoi distruggere la casa del re?"
— "Non distruggo, Kalistos. Ti mostro ciò che è sempre stato. Nulla è fermo. Nulla è definitivo."
Kalistos sentì il suolo crollare sotto i suoi piedi e, per la prima volta, provò paura. Cadde in ginocchio.
— "Chi sei, o dea?" chiese tremante.
— "Io sono Ananke, la Necessità. Sono colei che spezza le certezze. Non esiste verità che non cambi. Ricorda: chi si crede giusto sarà umiliato. Chi si crede saggio sarà confuso. Torna a essere il Kalistos che voleva imparare, non il Kalistos che crede di sapere tutto."
Il vento cessò. Le pareti si fermarono. Tutto tornò normale, tranne Kalistos.
Epilogo: La Discesa
Kalistos tornò al tempio di Apollo e si inginocchiò davanti alla Pizia.
— "Ora so che non so", disse.
La Pizia rise.
— "Bentornato, uomo. Hai incontrato Ananke. Lei viene solo quando la superbia è così alta da toccare il cielo."
Da quel giorno, Kalistos non fu più giudice, ma maestro di domande. Non disse mai più "so", ma sempre "forse".
E così visse il resto della sua vita, in bilico tra la certezza e il dubbio, come l’uccello che cerca il ramo giusto per il suo nido.
Chi crede di conoscere la verità assoluta è il primo a perdersi nel labirinto delle sue certezze.
5 notes
·
View notes
Text

“Quale momento della vita non sarebbe triste, difficile, brutto, insipido, fastidioso, senza il piacere, e cioè senza un pizzico di follia?” (Erasmo Da Rotterdam)
“Siate affamati, siate folli” (Steve Jobs)
“Elogio della follia” (Moriae encomium), scritto nel 1509, è una delle opere più celebri di Erasmo da Rotterdam. Questo saggio satirico, pubblicato per la prima volta nel 1511, si presenta come un discorso pronunciato dalla Follia stessa, che si fa portavoce di una critica pungente alla società del suo tempo, denunciandone le contraddizioni e le ingiustizie.
Il testo è scritto in un periodo di grande fermento culturale e religioso in Europa, caratterizzato dalla nascita dell'Umanesimo e dai primi segnali di riforma religiosa. Erasmo, figura centrale di questo movimento, si opponeva alle pratiche corrotte della Chiesa e alla superstizione popolare. “Elogio della follia”riflette queste tensioni, utilizzando l'ironia per mettere in luce le ipocrisie della società.
L'opera è strutturata come un discorso in cui la Follia, personificata, elogia se stessa e i vantaggi che porta agli esseri umani. La Follia si rivolge direttamente al lettore, creando un senso di intimità e coinvolgimento. Utilizza un linguaggio vivace e provocatorio, ricco di giochi di parole, paradossi e riferimenti classici. La narrazione è caratterizzata da un tono ironico e spesso sarcastico, che invita il lettore a riflettere sulle norme sociali e sui valori condivisi.
Erasmo utilizza la Follia per mettere in discussione le convenzioni sociali, la corruzione della Chiesa, l'ipocrisia dei nobili e la stupidità dei cittadini comuni. Sotto il velo della Follia, l'Autore critica i teologi dogmatici, i filosofi razionali e gli ecclesiastici, evidenziando il loro distacco dalla realtà e dalla vera saggezza. La Follia afferma che molti dei più rispettati membri della società sono, in effetti, i più folli.
L'opera elogia la follia come una condizione che porta alla gioia e alla spensieratezza, mentre razionalità e saggezza spesso portano alla sofferenza. La Follia sostiene che vivere senza il peso della razionalità e delle aspettative sociali consente di apprezzare la vita in modo più profondo. Erasmo esplora, dunque, l'idea che la follia possa essere una forma di saggezza. Questo paradosso invita il lettore a riconsiderare il valore della razionalità in contrapposizione alla libertà di pensiero. L’Autore sottolinea la vulnerabilità e le contraddizioni dell’essere umano. La Follia mette in luce come tutti, in un modo o nell'altro, siano soggetti a follie e illusioni. Questo riconoscimento dell'umanità comune serve a smantellare la presunzione di superiorità dei "saggi" e a promuovere un senso di umanità condivisa.
“Elogio della follia” ha avuto un impatto significativo sulla letteratura e sul pensiero occidentale. La sua critica sociale e religiosa ha ispirato generazioni di pensatori e scrittori, contribuendo al dibattito sulla ragione e la follia. La sua pubblicazione ha anche suscitato reazioni contrastanti, da ammirazione a condanna, soprattutto da parte dei sostenitori della Chiesa.
“Elogio della follia”è un'opera fondamentale che combina satira, filosofia e critica sociale. Con il suo stile incisivo e la sua profonda introspezione, continua a essere rilevante nel contesto contemporaneo, invitando il lettore a riflettere sulla natura della follia e sulla società in cui vive. La Follia, con la sua ironia, rimane una figura potente che ci sfida a riconsiderare le nostre convinzioni più radicate.
La Follia non è solo un tema, ma un invito a esplorare nuove prospettive, a riconoscere la bellezza del vivere e a considerare che, in fondo, tutti portiamo un po' di follia dentro di noi.
2 notes
·
View notes
Text
“ «Vi era una donna allora in Alessandria — narra la Storia ecclesiastica del contemporaneo Socrate [Scolastico], avvocato alla corte costantinopolitana — il cui nome era Ipazia. Costei era figlia di Teone, filosofo in Alessandria, ed era giunta a un tale culmine di sapienza da superare di gran lunga tutti i filosofi della sua cerchia, ricevere in eredità (diadochè) l'insegnamento della scuola platonica derivante da Plotino, esporre a un libero uditorio tutte le discipline filosofiche [...]. Da ogni parte accorrevano a lei quanti volevano filosofare.» Ipazia «aveva raggiunto un tale vertice d'efficacia nell'insegnamento, ed era così giusta e saggia e così straordinariamente bella e attraente» che gli allievi s'invaghivano di lei, si legge in Suida, il lessico bizantino del X secolo, nel lungo articolo intitolato Ipazia, o della faziosità degli Alessandrini. Le notizie di Suida derivano da due narrazioni, oggi perdute, del tempo di Giustiniano: quella, vera o presunta, di Esichio di Mileto e la Vita di Isidoro, ultimo sacerdote del tempio di Serapide, composta dall'ultimo scolarca dell'Accademia di Atene, il neoplatonico Damascio; di questa ci restano assai scarni frammenti. È presumibile sia la prima a dichiarare che Ipazia, «essendo per natura più dotata del padre, non si fermò agli insegnamenti tecnico-matematici praticati da lui ma si diede alla filosofia vera e propria, e con valore: pur essendo donna ella indossava il tribon [il mantello dei predicatori cinici] e andava per le vie del centro della città a spiegare pubblicamente a chiunque volesse ascoltarla Platone, Aristotele o qualcun altro dei filosofi.» “
---------
Brano tratto da Ipazia, l’intellettuale, saggio di Silvia Ronchey raccolto in:
AA. VV., Roma al femminile, a cura di Augusto Fraschetti, Laterza (collana Storia e Società), 1994¹; pp. 214-15.
#Silvia Ronchey#Ipazia l’intellettuale#femminicidio#scienziate#Impero Romano d'Oriente#saggistica#letture#leggere#libri#Storia delle donne#saggi#citazioni#civiltà romana#filosofia#Alessandria d'Egitto#oscurantismo#cristianesimo#astronome#fanatismo religioso#basso impero#donne intellettuali#filosofe#Storia della Chiesa#razionalismo#parabolani#settarismo#intellettuali del passato#insegnanti#maestri#educatori
24 notes
·
View notes
Text
ἡ μὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι
Ho trovato un modo di parlare di filosofia che mi soddisfa, quindi, nonostante gli scarsi risultati di pubblico, continuerò nel mio racconto quasi più per tenermi compagnia che per insegnare qualcosa agli altri. Disegno molto in questo periodo, è la mia nuova passione, ma la filosofia mi fa sempre da sottofondo, perché è questo il bello: se non ci si aspetta da lei la salvezza, ma solo la compagnia dei filosofi, allora tutto diventa più leggero e non ci sente traditi dalla verità. Ovviamente siamo eterni, non ci salverà la filosofia, siamo già salvi da sempre (non ci credi perché sei uno sporco relativista? Tanto meglio, se sei uno sporco relativista allora relativizzati pure tu e non rompere le palle).
11 notes
·
View notes
Text
Abbiamo dato alle necessità di equilibri accademici la priorità sul progresso della filosofia come scienza, iniziato a tollerare di chiamare filosofi sempre i professori per il fatto di avere una cattedra, mai gli studenti per il fatto di essere geniali. Se sei un genio diventi professore e se sei un professore automaticamente sei un genio. Dove sarebbe oggi la scienza se il controllo fra pari nella comunità scientifica funzionasse così?
Un insieme di persone che non tollerano che la genialità possa esserci dove loro non la vedono, dove loro non la controllano.
2 notes
·
View notes
Text
Current reading
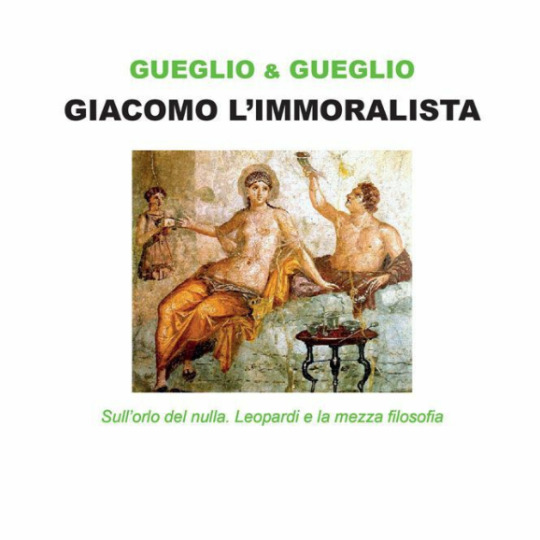
"[…] il pensiero leopardiano si costruisce faticosamente, di giorno in giorno, di rimando in rimando; e vive in quei grovigli, in un andirivieni tendenzialmente interminabile e comunque interminato. Non abbiamo innanzi a noi un oggetto soddisfatto di sé, preciso e chiuso su se stesso come un sonetto; ma un maestoso caos: vivo, inquieto, che cerca di estendersi sino ai confini dell’universo per riportarne una mappa accurata, munita di commento e note: perché l’esplorazione operata da Leopardi è esplorazione di filologo; la sua acribia è acribia di filologo. Con un filo di ironia potremmo apparentare anche il suo scetticismo e relativismo alla cautela con la quale il filologo contempla i risultati del proprio lavoro: consapevole che per quanto accuratamente abbia condotto l’indagine non può aver tenuto conto di tutte le variabili; sicché il lavoro rimane sempre aperto, provvisorio: un eterno preludio pronto ad agganciare una divagazione, ad accogliere una smentita o una contraddizione. Probabilmente è proprio questa insolente apertura a sconcertare e irritare i filosofi. E tutti noi, in fondo, che avremmo bisogno di rigirare fra le mani un oggetto chiaro e ben tornito e invece siamo costretti ad addentarci in un territorio pieno di insidie e praticamente inesplorabile."
Ma l'intelletto umano è capace di contenere al tempo stesso opinioni e dogmi dirittamente fra se contrarii, e di contenerli conoscendone la scambievole, inconciliabile contrarietà. (Zibaldone, 3151)
In questo secolo, stante la filosofia, e stante la liaison che hanno acquistata tutte le cognizioni tra loro, ogni menomo soggetto facilissimamente diviene vastissimo. Tanto più è necessario, volendo pur fare un libro, che uno sappia limitarsi, che attenda diligentemente a circoscrivere il proprio argomento, sì nell'idea de' lettori, e sì massimamente nella propria intenzione; e che si faccia un dovere di non trapassare i termini stabilitisi. (Zibaldone, 4484)
2 notes
·
View notes
Text
Sisifo, il re di Efira, era famoso nella mitologia greca per la sua ingegnosità; era infatti così intelligente da ingannare la morte due volte, facendo arrabbiare gli dèi. Questi si vendicarono condannando Sisifo a un tormento eterno negli inferi: doveva far rotolare un enorme masso fino alla cima di una collina. Quando arrivava in cima, il masso rotolava di nuovo verso il basso e lui doveva ricominciare tutto da capo, all’infinito.
Al giorno d’oggi, qualsiasi compito che combini tedio, lotta, stress e inutilità può essere definito un “supplizio di Sisifo”. Pensate ai cosiddetti duct-taper, cioè quelli che lavorano per un servizio clienti e che hanno il compito di trattare con persone arrabbiate tutto il giorno, mentre intanto le condizioni che creano questa aggressività dei clienti non cambiano mai. [...] Si potrebbe anche affermare che tutta la vita è un supplizio di Sisifo: mangiamo per avere di nuovo fame e facciamo la doccia per sporcarci di nuovo, giorno dopo giorno, fino alla fine.
Assurdo, non è vero? Albert Camus, filosofo e padre di un’intera scuola di pensiero chiamata assurdismo, la pensava così. Nel suo libro del 1942, Il mito di Sisifo, Camus individua in Sisifo l’icona dell’assurdo, notando che “il suo disprezzo per gli dèi, il suo odio per la morte e la sua passione per la vita gli valsero quella pena indicibile in cui tutto l’essere è proteso verso il non realizzare nulla”. Se questo non vi fa venire voglia di accendervi una sigaretta senza filtro, non so cosa possa farlo.
Sarebbe facile concludere che una visione assurdista della vita escluda la felicità e porti chiunque abbia un po’ di buon senso a disperare per la propria esistenza. Eppure, nel suo libro, Camus conclude che “bisogna immaginare Sisifo felice”. Può sembrare impossibile, ma in realtà questa svolta inaspettata nella filosofia della vita e della felicità di Camus può aiutarvi a cambiare prospettiva e a vedere le vostre lotte quotidiane in modo nuovo e più equanime.
La sofferenza infinita e l’infelicità sono intese come temi dominanti della vita nelle filosofie d’oriente e d’occidente. La prima nobile verità del buddismo è che la vita è sofferenza. Allo stesso modo, il filosofo cristiano del diciassettesimo secolo, Blaise Pascal, scrisse della nostra “costante infelicità” e dei futili sforzi per combatterla: “Gli esseri umani cercano il riposo lottando contro le difficoltà; e quando le hanno vinte, il riposo diventa insopportabile”. In entrambe le tradizioni, la felicità non è che una breve interruzione del triste ritmo della vita.
[...continua]
Articolo completo qui Come trovare la gioia in una vita degna di Sisifo di Arthur C. Brooks, 19/03/2023
11 notes
·
View notes
Text
Filosofi che hanno cambiato opinione
Solo dopo la morte di Platone, il suo padre spirituale, Aristotele lascia l'Accademia di Atene e si trasferisce in Asia Minore. E solo lì (con la sicurezza conferita dalla distanza?) ha il coraggio di rinnegare per la prima volta la teoria del suo grande maestro, la teoria in seno alla quale è cresciuto dall'età di diciassette anni per i vent'anni successivi. Platone ha completamente sbagliato, sostiene Aristotele. Non ha senso parlare di "idee" astratte che non abbiamo la capacità di vedere o percepire. Ogni nostro tentativo di discutere ciò che è oltre la nostra esperienza è destinato a fallire. Di conseguenza la filosofia deve limitarsi all'indagine di ciò che è alla portata dei nostri sensi, già di per sé argomento che suscita grande meraviglia. "Addio dunque idee platoniche, perché non avete più significato di una canzoncina, la la la" scrive Aristotele. E' una frase talmente rozza e decisa, che subito sorge la domanda:
Quand'è accaduto questo stravolgimento totale delle sue idee? Che il dubbio sia germogliato in lui già durante gli studi all'accademia, e lui abbia taciuto per non offendere l'onore del suo padre spirituale, o forse è stata la morte di Platone, la liberazione dalla sua ombra pesante, a permettere la svolta del pensiero? Ci sono state delle fasi intermedie sulla strada per la grande eresia, o una mattina Aristotele si è svegliato a casa sua, nella città portuale di Asso, ha guardato le concrete barche dei pescatori, le tangibili reti per i pesci, e all'improvviso ha capito tutto? E un'altra domanda, per la quale, naturalmente, non abbiamo né mai avremo una risposta univoca: cosa sarebbe accaduto se Platone fosse vissuto molto, molto più a lungo? Aristotele si sarebbe alzato una sera, di fronte a tutti gli allievi, per affrontare il suo padre spirituale faccia a faccia?
Eshkol Nevo
3 notes
·
View notes
Text
La filosofia dell'esoterismo
La filosofia dell'esoterismo

La filosofia dell'esoterismo
La psicologia esoterica, condivide gran parte del terreno della filosofia. Essa è un diverso progetto di verità che ritrova la sua peculiarità all'interno delle filosofie che hanno animato l'esoterismo, ma anche soprattutto vuole ricostruire un rapporto oltre che con il passato della filosofia, in cui il <<discorso>> sulla psiche era appunto di pertinenza filosofica e non scientifica, anche con il presente della filosofia.
Tra le filosofie contemporanee in cui la psicologia esoterica può trovare il suo innesto, abbiamo quella particolare forma di esistenzialismo formulata da Heidegger e dai filosofi che hanno portato avanti il suo pensiero. Fu lo stesso Heidegger ad offrire un nuovo terreno di sviluppo alla metafisica e un senso nuovo alla filosofia come discorso sull'essere e sull'esistere relativo in particolare alla posizione dell'uomo rispetto all'uno e all'altro ambito.
L'uomo come <<esserci>>, presenza nel mondo, diventa, infatti, la cosa unica, dove questa distinzione è annullata per realizzare il mistero umano in cui l'essere non può essere distinto dal suo <<ci>>. Nei vangeli della rivoluzione scientifica abbiamo inseguito il paradosso si un soggetto puro separato dal suo mondo che poteva diventare un oggetto di studio, un soggetto sopra e un mondo sotto.
L'uomo esiste perchè partecipe dell'essere, ma esiste anche in quanto presente nel mondo e non possiamo immaginarci altrimenti. Essere e mondo diventano quindi nell'uomo cosa unica, l'esserci (il dasein).
E' sotto questa luce che la psicologia esoterica trova il suo riferimento filosofico, poiché ogni scienza si propone di conoscere l'ente e niente altro, essa non si chiede che cosa sia questo niente altro, il niente. L'esperienza del niente non è però un'esperienza <<comprensibile>>, ma piuttosto emotiva dell'uomo percorso dall'angoscia: essa è un'emozione, un'esperienza psichica e per certi versi un'esperienza mistica di enso contrario quando si fa pura, quando cioè l'angoscia come esperienza del nulla si fa così profonda da non consentire all'ente di apparire e di significare, l'abisso contro l'assoluto, non coglibile razionalmente, ma solo attraverso il sentimento: l'anima ha però la capacità di illuminare l'ente, essa ha in sé la luce che rende possibile la rivelazione dell'ente dal niente in quanto ente per l'essere esistenziale dell'uomo. Il niente quindi è la condizione per cui l'ente si svela ad un essere aperto alle cose. Per vedere le cose occorre che siano illuminate, l'apertura dell'uomo alle cose è questa luce.
La verità, in greco a-l'éteia (non-nascondimento), è manifestazione , svelatezza, tutta la Cabala è un'interpretazione simbolica di questo svelarsi del non manifesto (ain soph aur). Appare appunto lampante che se c'è un non-nascondimento esiste anche un <<nascondimento>> (léte) che sta dietro alla manifestazione.
Alla verità come manifestazione si contrappone la non verità del nascondimento, cioè l'immanifesto, e la non verità come errore.
Se la verità è non-nascondimento, il nascondimento appare essenziale alla verità, proprio come l'immanifesto alla manifestazione, nell'albero cabalistico. Esso è in realtà quell'orizzonte cui volgono lo sguardo il misticismo, la Cabala e la stessa magia che si riferiscono a questa fonte sotterranea, che come nascondimento precede ogni svelamento, il mistero che precede il disvelarsi del manifesto.
Una psicologia esoterica che voglia dirsi tale deve riportare l'attenzione dell'anima sul mistero, senza tuttavia distoglierla completamente dall'ente manifesto, ma trovando invece un equilibrio ideale, come abbiamo visto per esempio parlando dell'ecospiritualità. Per fare questo l'anima come presenza nel mondo, ha bisogno innanzitutto di comprendersi e di conoscersi, prima di andare ad esplorare i rapporti con il circostante, e quindi necessita di un modello della psiche che sarà naturalmente esotericamente orientato.
#Annalisa Lanci#psicologia esoterica#psicologia#esoterismo#anima#spirito#mente umana#buio e luce#buio e luce tra cielo e terra#tra cielo e terra
6 notes
·
View notes
Text
Jorge Luis Borges sosteneva che gli antichi greci furono i primi a pensare, ci hanno dato la poesia, la scienza, la filosofia razionale, che tutta la cultura a noi pervenuta nel corso dei secoli derivi dai greci.
I filosofi greci distinguevano l’amore in 12 tipologie diverse a seconda delle diverse emozioni umane e sfumature del sentimento:
Agape (αγάπη) - Agape è l’amore incondizionato, anche non ricambiato. Va al di là delle forze umane, è un amore puro e senza alcuna aspettativa. Viene utilizzato nei vangeli e nella religione.
Eros (έρως) - Eros è la tipologia di amore più conosciuta. Dio greco della fertilità, il suo tipo di amore rappresenta quello passionale, il desiderio carnale. Veniva definito in termini di irrazionalità, perché il desiderio ardente avrebbe potuto portare alla follia.
Philia (φιλία) - Philia indica un tipo di amicizia profonda. Amicizia come vincolo di fiducia e lealtà, come fondamenta di un rapporto solido e suggellato dalla bellezza della condivisione. Amare ed essere amati.
Storge (στοργή) - Storge è l’amore nei confronti della famiglia o dei parenti, tipico dei consanguinei, deriva da “stergo” che significa amare teneramente.
Philautia (φιλαυτία) - Philautia è l’amore per sé stessi, l’amor proprio, fonte di perfezionamento e benevolenza è definito come forma di egoismo positivo.
Mania (μανία) - Mania associato all’amore è il desiderio incondizionato di amare e possedere, l’amore tossico che vive (apparentemente) solo attraverso il possesso di ciò che brama, il partner come oggetto del desiderio. Distruttivo.
Charis (χάρις) - Charis è forse la tipologia d’amore più ambita tanto quanto appagante: idilliaco. Entrambi i partner si amano allo stesso modo, sia fisicamente che spiritualmente.
Himeros (ἵμερος) - Himeros è l’amore che arde di desiderio fisico, impulsivo, irrefrenabile, l’amore folle. Desiderio carnale, non ascolta ragioni e va appagato nell’immediato.
Anteros (αντέρως) - Anteros, fratello di Eros (si narra fossero inseparabili) è l’amore corrisposto con il rispettivo coniuge/compagno e indica la stabilità sentimentale.
Pragma (πρᾶγμα) - Pragma è associato all’amore maturo di lunga data, ma anche al compromesso e alla pazienza. Fare uno sforzo per dare amore piuttosto che solo per riceverlo.
Pothos (Πόθος) - Pothos è la personificazione del rimpianto e del senso di nostalgia che si prova quando una persona amata è lontana. È anche identificato con l’amore adolescenziale, l’infatuazione, il desiderio prima dell’incontro.
Thelema (θέλημα) - Thelema è l’amore nei confronti di ciò che si fa, il proprio lavoro, il piacere di fare qualcosa, il desiderio voler fare e non è rivolto quindi ad una persona.
6 notes
·
View notes