#Chiesa medievale
Explore tagged Tumblr posts
Text
850 Anni della Diocesi di Alessandria: un Convegno per Esplorare le Radici della Città.Un viaggio storico tra fede, politica e cultura medievale il 21 e 22 febbraio 2025
In occasione del 850° anniversario della Diocesi di Alessandria (1175-2025), il 21 e 22 febbraio2025 si terrà il convegno “Fondare una Città, fondare una Chiesa. Alle origini di Alessandria”, presso il Palatium Vetus della Fondazione Cassa di Risparmio di
In occasione del 850° anniversario della Diocesi di Alessandria (1175-2025), il 21 e 22 febbraio2025 si terrà il convegno “Fondare una Città, fondare una Chiesa. Alle origini di Alessandria”, presso il Palatium Vetus della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Piazza della Libertà 28). Un evento di grande rilevanza storica e culturale, che offrirà uno sguardo approfondito sulla nascita…
#850 anni Diocesi Alessandria#Alessandria e il Barbarossa#Alessandria medioevo#Alessandria today#Barbarossa#celebrazioni Alessandria#celebrazioni storiche#Chiesa e politica#Chiesa medievale#conferenze storiche#convegno storico#cultura e religione#Diocesi di Alessandria#eventi accademici#eventi culturali Alessandria#eventi storici 2025#Fondazione Cassa di Risparmio Alessandria#fondazione di Alessandria#Google News#Istituto Storico Italiano per il Medioevo#italianewsmedia.com#Palatium Vetus#Pier Carlo Lava#Pontificio Comitato di Scienze Storiche#potere comunale medievale#ricerca storica#riforme ecclesiastiche#storia Alessandria#storia del Piemonte#storia della chiesa
0 notes
Text

io ci scherzavo sul fatto che il papa andasse con matilde mentre studiavo per l'esame di storia medievale ma non pensavo fossero.......gossip storicamente accertati.... the scream i scrumpt...
#mi stavo riguardando la lezione da casa bevendo un tè e mi sembrava veramente di stare al bar a sentire il gossip del prof#il MATILDE DI CANOSSA???? è stata la mia reale reazione al prof che parlava come se stessi guardando una puntata di beautiful#un ringraziamento a tutte le persone che mi hanno consigliato di seguire il corso di storia della chiesa medievale: avevate ragione#uni
4 notes
·
View notes
Text
" Giunto quasi alla fine della sua vita, malatissimo, [Francesco d'Assisi] sapeva di non poter più rivedere quelle terre lontane verso cui si era mosso con tanto entusiasmo; la rinuncia non chiude interamente in negativo i suoi sogni di evangelizzazione ecumenica, perché porta a un ripensamento e a un diverso recupero di quel grandioso progetto. Non ci sono luoghi o interlocutori privilegiati: il presepio di Greccio spegne il bisogno del viaggio verso la Terrasanta e della sua difesa; non c'è bisogno di attraversare il mare per vibrare d'emozione né di imporre la fede, ritenuta la vera, con le armi e la violenza. Betlemme è ovunque, anche a Greccio, perché deve essere prima di tutto nei cuori: «Quasi nova Bethlehem de Graecio facta est», Greccio è divenuta una nuova Betlemme.
Tommaso [da Celano] insiste sulla gioia mai provata prima, né dai fedeli, né dal sacerdote, evidentemente incapace anche lui, prima della predica di Francesco, di intendere profondamente il mistero che sta celebrando. Di fronte alle carenze del clero, alla tiepidezza della fede dei cristiani, gli uni e gli altri immemori del sacrificio divino, il Bambino ha gli occhi chiusi, dorme di un sonno prossimo alla morte. Se gli infedeli non hanno conosciuto Cristo, i cristiani lo hanno dimenticato. "
Chiara Frugoni, Vita di un uomo: Francesco d'Assisi, introduzione di Jacques Le Goff, Einaudi (collana ET Saggi n° 824), 2006⁶; pp. 113-114.
[Prima edizione: 1995]
#Chiara Frugoni#letture#leggere#saggistica#saggio storico#Francesco d'Assisi#presepio#XIII secolo#presepe#Greccio#Storia medievale#Natale#natività#tradizioni#Storia d'Italia#Storia del Medioevo#Terrasanta#Lazio#presepe vivente#Storia delle religioni#semplicità#Chiesa Cattolica#cristianità#Jacques Le Goff#cristianesimo#vangeli apocrifi#rievocazioni#Betlemme#pellegrinaggi#Terra Santa
6 notes
·
View notes
Text
Nelle cartoline di Corinto Corinti: Firenze medievale (seconda parte)
si consiglia di ingrandire le immagini cliccandoci sopra ovvero Firenze che non c’è più: la chiesa di Sant’Andrea Fabio Borbottoni, la chiesa di Sant’Andrea a sinistra nel dipinto Tra le architetture della vecchia Firenze medievale vittime della rivoluzione urbana dell’architetto Poggi va ricordata la bella chiesa eretta tra via Calimala e via Pellicceria: Sant’Andrea, nell’omonima piazza,…

View On WordPress
#Corinto Corinti Le 36 chiese di Firenze nell&039;anno 1000#Fabio Borbottoni#Firenze che non c&039;è più#la chiesa di Sant&039;Andrea#map of old Florence#Nelle cartoline di Corinto Corinti: Firenze medievale (seconda parte)
0 notes
Text
ARTE / Eccezionale scoperta a Verucchio: dal convento francescano spuntano affreschi ignoti del Trecento. "Pitture di qualità eccelsa, forse del giottesco Pietro da Rimini"
Lo straordinario ritrovamento è avvenuto per caso in Santa Croce a Villa Verucchio, nel Riminese, esplorando un pertugio tra un muro e il coro. Al via il restauro e lo studio, che aiuterà a chiarire anche la storia del convento.
Lo straordinario ritrovamento è avvenuto per caso in Santa Croce a Villa Verucchio, nel Riminese, esplorando un pertugio tra un muro e il coro. Al via il restauro e lo studio, che aiuterà a chiarire anche la storia del convento. Il Cristo in Pietà raffigurato nella lunetta, di straordinaria qualità pittorica. Trovare affreschi medievali ancora sconosciuti, e per giunta di grande qualità, non è…

View On WordPress
#affreschi#Arte#arte medievale#chiesa di Santa Croce a Villa Verucchio#Emilia Romagna#In evidenza#restauri#Rimini#Rocca Malatestiana#Verucchio
0 notes
Text

SENSI DELL'ARTE - di Gianpiero Menniti
I FERMENTI NASCOSTI DELLA RIFORMA
Ecco una delle opere del Botticelli "maturo", influenzato dallo spirito della Firenze di Savonarola, il riformatore "ante-litteram" che a differenza di Lutero subì con la scomunica una sorte tragica. Non è dato sapere quanto la conversione verso la materia della trascendenza, legata all'iconografia cristiana, fosse dovuta a un moto dell'animo oppure alla fine dei fasti medicei e con loro alla committenza del "Magnifico" e della sua cerchia. Tuttavia, lo stile rimane inconfondibile, ormai radicato in un'estetica che non smette mai la ricerca della bellezza e dell'armonia di forme e tratti espressivi. Semplicemente, è trasposta in un nuovo campo del racconto per immagini. Ma qui, a colpire è la separatezza tra il luogo dell'avvenimento celeste (l'incoronazione della Vergine) e la consapevolezza partecipe dell'assemblea dei Santi confinati al di sotto, sulla terra. Era già accaduto alcuni anni prima con la "Pala di San Marco" dello stesso autore. Questa struttura del tema evangelico si affermerà, da lì in avanti, come uno strappo tra la modernità e il modello medievale, rappresentato, per esempio, dalle opere del "Beato Angelico" sul medesimo soggetto: quasi a marcare una distanza impossibile da colmare perfino per le figure dei Santi. Come un fardello pesante, l'esistenza terrena può solo aspirare alla beatitudine dell'ultraterreno. La fede e le opere non rappresentano una misura sufficiente. Non vi è libertà e nessuna certezza della grazia, il destino rimane segnato dal mistero. Questa è forse la traccia pittorica di un sentimento religioso che altrove, nella secolare crisi di autorevolezza del papato, stava meditando la riforma. Che in Italia, l'ancoraggio alla Chiesa di Roma, ha sopito in un limbo cocente ma inespresso. Sorprendente Botticelli.
- Sandro Botticelli (1445 - 1510): "Incoronazione della Vergine e Santi", data incerta tra il 1498 e il 1508, Villa La Quiete, Firenze
21 notes
·
View notes
Text

Scorcio del bellissimo borgo medievale di Cleto (Petramala in dialetto locale, Kletè, Κλητή in greco antico ) un piccolo comune della provincia di Cosenza, posto sulle colline di fronte alle Isole Eolie posto sul versante esterno della Catena Paolana ai piedi del Monte Sant'Angelo, nell'alta valle del torrente Torbido, affluente del fiume Savuto. arroccato tra le colline, con le sue stradine medievali e il maestoso l Castello Normanno con vista panoramica, la Chiesa di San Michele Arcangelo, passando per Palazzo Arnone e i sentieri naturalistici nei dintorni che invitano a escursioni nella natura incontaminata È conosciuto come il "Comune dei due castelli", perché sul territorio comunale esistono due castelli medioevali: il Castello di Petramala (di epoca normanna, tardo-bizantino) e il Castello di Sabuci (di epoca angioina, XIII secolo).
3 notes
·
View notes
Text
Quando l'asino non vuol camminare, raglia!
La disinformazione neotemplarista su San Giorgio Martire.


Care lettrici e cari lettori, come alcuni di voi sapranno, in questo lungo periodo ho ben altre cose serie a cui pensare, però sapete bene anche, quanto io mi fomenti nel momento in cui dei complottisti o negazionisti, imperversanti nel mondo "storico", si mettono ad emanar sentenze su argomenti che non dovrebbero toccare nemmeno con un bastone da rabdomante.
Questa volta tocca alla splendida chiesa di San Giorgio Martire, nel centro urbano di Petrella Tifernina in alto Molise, una cittadella che, tutta intorno, si sviluppa a guisa di quella veglia basilica, in cui, per molto tempo, ho passato periodi della mia adolescenza, quando mio padre, circa 16 anni fa, svolse numerosi sopralluoghi e studi di ricerca in compresenza del parroco Don Domenico, della sua associazione e di tanti accademici, archeologi, storici dell'arte e dell'architettura, molisani e d'oltre Regione.
Ora, come da tempo accade, è presa di mira anche da alcuni neo-templaristi, che purtroppo hanno visto troppi film d'azione sul medioevo, e soprattutto, troppi sulle leggende dei cavalieri Templari e delle crociate nella fattispecie, che vedono l'ordine come fautore di cose con le quali mai era stato legato, in tal caso, l'arrivo del culto per San Giorgio Martire nella penisola italiana, che a detta di talune pagine ed "eruditi", sarebbe sopraggiunto solo nel basso medioevo, al seguito delle crociate.
Vogliate concedermi una riflessione a riguardo, poiché affermazioni di questo tipo, ricopiate e ricalcate dalle pagine sensazionalistiche ed esoteriste, ed anche da parte di alcuni storici "non addetti ai lavori", sono assolutamente false e in evidente contrasto con la storia del nostro paese, seguendo un'ottica primitiva, oggi superata ampiamente dal mondo universitario e più propriamente storiografico.
Passerò pertanto a discutere su due punti salienti di questa lunga riflessione:
1) l'icona di San Giorgio
2) la lunetta del Magister Alferio.
Nel primo caso, viene asserita da taluni individui, la datazione della formella di San Giorgio Martire, al XIII secolo inoltrato, una cosa che assolutamente stride con qualsiasi nozione di storia dell'arte esistente, soprattutto per l'inesistente plasticità e tridimensionalità del bassorilievo, che nelle proporzioni ed irregolarità delle forme, nonché staticità dei corpi, si accosta al gran numero di produzioni di scalpellini di ambito centromeridionale tra la fine del X e la prima metà del XII secolo, con una netta evoluzione graduale tra gli stilemi arcaici preromanici di epoca longobarda/bizantina, e quelli romanici d'epoca normanna/sveva, che con la seconda fase sfocieranno nel protogotico svevo-angioino, seguendo una ripresa sempre più marcata di elementi classici, elaborazione nelle proporzioni, espressività e plasticità degli elementi, che si noterà principalmente in cantieri come quello di Santa Maria Maggiore a Monte Sant'Angelo, Santa Maria della Purificazione a Termoli, San Giovanni in Venere a Fossacesia, Santa Maria e San Leonardo a Siponto, San Clemente a Casauria e tante altre località tra Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia ed anche Basilicata e nord della Calabria.
Per delucidazioni aggiuntive consiglio vivamente la lettura del libro: Molise medievale cristiano, Edilizia religiosa e territorio (secoli IV - XIII),di Federico Marazzi, Manuela Gianandrea, Francesco Gangemi, Daniele Ferraiuolo, Paola Quaranta, and Alessandra Tronelli.
Sulla rarità di icone preromaniche occidentali, che raffigurino il santo nell'atto di uccidere il drago, vorrei preventivamente chiarificare non sia esattamente così, la rarità è circoscritta quasi unicamente per il territorio italiano, e rarità non è sinonimo di inesistenza se il vocabolario me lo consente.
Si rammenti che nella penisola, già nel VI e nel secolo successivo si attesta la presenza del culto di San Giorgio Martire, escludendo in toto la teoria di una giunta dell'agiografia georgiana solo al seguito della sua Legenda Aurea, ma già attestata da fonti indirette ed apocrife, precedenti di molto ai secoli delle crociate, che vedrebbero la componente del mostro o drago, giungere nei territori dell'Est Europa e dell'Occidente, a cavallo tra il X e l'XI secolo, ed addirittura, essere postulata proprio in "territorio europeo" con una evoluzione graduale, che vede l'aggiunta, nella sua agiografia, del salvataggio della principessa dal drago, simbolo del demonio, una dicotomia tra bene e male che incarna tutta la storia della teologia stessa e dei santi martiri, che null'ha a che fare con le crociate, se non essere parte di esse, tanto che nel corso della prima crociata, troviamo informazioni che ci fanno capire in Occidente fosse già ben nota l'iconografia cavalleresca di Giorgio, tanto che più tardivamente, addirittura, sarebbe sviluppatasi in Oriente, adottando il mostro dall'icona di San Teodoro.
L'imago del cavaliere che sconfigge il maligno in realtà, ivi si riferiva all'imperatore Costantino, come ci riporta il biografo Eusebio da Cesarea, una icona imperiale diffusa in molte aree mediorientali, ma che principalmente era posta sulla facciata del suo palazzo imperiale, tanto da ipotizzare che in realtà i crociati furono indotti ad indentificarla come icona del santo, solo tramite una loro conoscenza di essa, già appurata e radicalizzata tra l'est Europa, l'area costantinopolitana, e naturalmente altre regioni e nazioni dell'Europa occidentale, in cui non poteva mancare certamente l'Italia, cuore pulsante delle vie pellegrinali, di commercio ed anche delle crociate stesse ed ancor prima, delle milizie d'ogni tipo, la storia della Longobardia Minor dovrebbe aver già insegnato molto.
Tornando al San Giorgio di Petrella, la sua figura trova un riscontro iconografico, molto vicino a quello delle icone ancora primitive, che precedono lo sviluppo pieno del suo programma simbologico-agiografico, fiorito in maniera solida dopo la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine.
Che però già esisteva tra il X e l'XI secolo.In special modo, queste icone sono caratterizzate dalla assenza di elementi come la principessa, dove gli unici individui sono Giorgio, il cavallo e il drago/mostro-serpente alato, trafitto dalla lancia del soldato.
Questi elementi iconografici sono diffusissimi nelle pitture rupestri della Cappadocia (XI sec.), ed anche negli affreschi di San Marzano in provincia di Taranto (X-XI sec.), e nel bassorilievo della Cattedrale di San Paolo ad Aversa (X-XI sec.), e l'elenco di esempi su San Giorgio ed il drago possono proseguire per molto, ma mi fermerò a questi per il momento.
A fare da contorno in tutto ciò, vi è lo stile che caratterizza la scultura petrellese, una formella con caratteri iconografici bizantini, ma dalle proporzioni incoerenti e scarsa plasticità, una costante delle produzioni lapidarie che hanno toccato vari insediamenti come Santa Maria della Strada a Matrice, Ma anche altri come a Guardialfiera, Roccavivara, Guglionesi, Petacciato, Cercemaggiore e così via, tutti edifici integri alternati a resti erratici o di reimpiego, databili tra una più antica manualità dell'VIII e IX secolo, ed una lieve evoluzione tra X ed XI, con un cambiamento ulteriore nel XII ed infine un distacco abissale con le produzioni dei secoli XII-XIII e XIII-XIV, che agli antipodi posseggono la Fraterna di Isernia da un lato, e la Cattedrale di Larino dall'altro.
L'arretratezza negli attributi e nello stile figurativo, fanno retrocedere presumibilmente la datazione come di consueto, tra il termine del decimo secolo e l'anno mille, come parte di uno dei primi cantieri che videro l'evolversi dell'impianto basilicale tra stadio pre-romanico e romanico "normanno", una doppia fase che si sposerebbe bene con la successiva ulteriore trasformazione del complesso, al seguito di un cataclisma, forse uno smottamento del terreno di fondazione o un sisma, che comportò un drastico cambiamento nell'assetto impiantistico, ed un enorme riuso dei resti del precedente tempio, per approfondimenti in merito, consiglio la lettura del volume: "Medioevo in Molise: Il cantiere della chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina" dello storico dell'arte Francesco Gandolfo, che a suo tempo avemmo il piacere di conoscere nel corso delle ricerche sul campo.
Da qui ci si sposta alla questione invece di altri elementi, come il portale maggiore, che si mostra con uno pseudoprotiro e facciata che rientra nelle caratteristiche del pre-romanico e romanico locale (vedi Matrice), con una lunetta che presenta un evidente caso di rimontaggio, come in altri punti dell'edificio, forse proprio nel corso della trasformazione dell'intero orientamento della struttura, pur presentandosi nel complesso, al suo stato originale, con stilemi a girale, fitomorfi, scene apocalittiche e creature zoomorfe inscritte dentro cornici tipiche dei cantieri, specialmente benedettini, dell'XI-XII secolo, come appunto chiarisce un ulteriore dettaglio della lunetta maggiore, la firma dell'esecutore, tal "ALFERIO DISC(IP)OLO GEO(RGI)", come si può leggere tramite una attenta analisi ravvicinata dell'incisione (e non da fotografie sbiadite, tra l'altro, che permettono egualmente di leggervi quanto detto poc'anzi).
La tradizione locale (che tradizione non è), vuole attribuire la lunetta ad un tale MAG(ISTER) EPIDIDIVS, che in realtà nasce da una approssimativa lettura dei pochi caratteri esistenti, da parte del Carandente, presa per buona da alcuni eruditi ma priva di fondamento, specie se si considera che il nome Epididio sia quasi totalmente inesistente persino per alto e basso medioevo, e per trovarvi una spiegazione, dovrebbe quantomeno essere posto in teoria come una abbreviazione, ma al momento resta una fantasiosa ricostruzione del secolo scorso, già accantonata dalla comunità accademica.
Altro strafalcione del Carandente si riporta nella data incisa al lato destro della lunetta, "MDECIM", per il quale, secondo una idea di attribuzione tarda, doveva leggersi (Anno Domini) Millesimo Duecentesimo Undicesimo (1211), non potendo però constatare per l'epoca, che nessuno dei fregi e bassorilievi della basilica, potesse essere avvicinabile a questi anni, privi di ogni caratteristica sopracitata.
Il suo errore è da contestualizzarsi nella mentalità locale di almeno uno o due secoli fa, dove il territorio molisano venne circoscritto, dal punto di vista artistico e culturale, ad una terra con "produzioni di ambito locale, o minore", con delle eccezioni senza alcun nesso, prima dei contributi che hanno permesso, da 30-40 anni, ad oggi, di sfatare tutto ciò, ed anzi, di riscoprire l'alveo culturale quale era il Molise, un territorio tra Abruzzo Citeriore, Terralaboris, Capitanata e così via, più comunemente territorio che possiamo definire proprio centro della Longobardia Minor, e successivamente, parte del Regno di Sicilia settentrionale.
Un cuore pulsante di "scuole", botteghe e cantieri ecclesiastici ed anche nobiliari, che hanno permesso l'evoluzione e il proliferare, di queste componenti artistiche, esattamente come dei movimenti, ove era cruciale il ruolo delle vie di comunicazione, per esempio la Via Francigena, le sue arterie meridionali, i tratturi e così via, che hanno permesso soprattutto, di capire negli anni passati, il motivo di una espansione di medesimi archetipi, stilemi e caratteristiche culturali riscontrabili nello stesso tempo in più parti dell'Europa, dall'Italia all'Est, al Medio-Oriente fino ad arrivare in Francia, Spagna e naturalmente Regno Unito, tante realtà che, ovviamente, si sono fuse con quanto era già presente in questi paesi.
Le componenti estere sono sempre state il fondamento base della storia dell'arte, sia in età longobarda, con influenze bizantine, occidentali ed arabe, sia con i normanni, ed ovviamente sotto Federico II di Svevia, dove si può dire fosse nata l'architettura gotica italiana (e non solo), ereditata ed espansa sotto il dominio angioino e perfezionata dai motivi orientaleggianti catalani con gli aragonesi, mentre non va trascurata la parentesi di ambito veneziano trecentesco/quattrocentesco, e anche quella del gotico abruzzese (XIII-XIV sec.).
Dopo aver riportato questo grande aneddoto sul conto del Molise, per il quale ampiamente ha dibattuto e pubblicato la professoressa Maria Stella Calò Mariani, seguita da Francesco Aceto e da Giuseppe Basile, ma anche dallo stesso Bertaux e molti prima e dopo di loro, ritorniamo alla epigrafe di Petrella.
Più semplicemente, questa attestazione in caratteri latini, di per sé in contrasto con quelli evidenziati in tutto il territorio centro-italiano del '200, (vedi la data sul campanile di Santa Maria della Strada), non si riferirebbe affatto al 1211, bensì al 1010, (AD) M(illesimo)DECIM(o), semanticamente più accurata e meno costrittoria della versione del Carandente, avvicinandosi perciò alle scene cavalleresche del campanile di Petacciato, forse ascrivibili per stile ai medesimi fregi della lunetta, che troverebbe riferimento nella vicenda della Battaglia di Canne del 1018, con la presenza forse della più antica immagine di un cavaliere normanno e di due cavalieri bizantini in lotta.
Questa lettura non solo trova riscontro nei caratteri, ma anche nello stile arcaico che compone interamente la basilica ed i suoi bassorilievi, taluni di epoca precedente, ed altri del cantiere d'appartenenza, al quale sarebbe dovuto seguire un altro cantiere come si può evincere da un unico elemento duecentesco (o trecentesco) presente nella navata destra della chiesa, un semicapitello piatto, con motivo di foglie di acanto molto plastiche ed estruse, poggiato su un’acquasantiera in disuso, mai impiegato, ma che nel suo stile sembra essere ascrivibile ai cantieri di Santa Maria e San Pardo a Larino e di Sant'Emidio ad Agnone, ma per quanto riguarda il complesso, pare in realtà esserci una totale assonanza con i cantieri delle basiliche di San Giorgio, San Bartolomeo e San Mercurio a Campobasso (IX-X-XI sec.), alcuni elementi di Sant'Andrea a Jelsi (XI sec.), San Giovanni Rotobonis a Oratino (La Rocca) (IX-X sec.), e così via.
Senza contare che, per rievocare momentaneamente le questioni del culto per San Giorgio, nella Longobardia Minor e nei territori circostanti, sono attestate molteplici ecclesie dedicate al Santo Martire, tutte tra VII-VIII e IX secolo, che farebbero già intendere quanto non sia assolutamente fondata la supposizione sul suo culto giunto solamente dopo i risvolti della prima crociata, alla fine dell'XI secolo, ricordando ulteriormente a chi legge, che stessa sorte capitò per il vescovo di Myra, Nicola, detto anche San Nicola di Bari almeno dal 1087 in poi, ma che già era ampiamente venerato dal VI secolo, persino nella nostra regione, con chiese e badie risalenti al X secolo, la più vicina alla mia posizione proprio a Petacciato, presso il luogo di sepoltura dell'abate Adamo di Tremiti, poi Sant'Adamo confessore.
La verità di tutto ciò è molto diversa, spesso dei gruppi neotemplaristi, pur di mettere i Templari al di sopra di ogni argomento storico, finiscono per affidargli la paternità di cose che non gli sono appartenute, o meglio, che non hanno creato loro ma che essi possono solo aver sposato successivamente alla loro nascita.
Quest'anno per esempio sono già dovuto intervenire dopo un convegno neotemplarista al Cinema Sant'Antonio di Termoli, in cui si sono susseguiti una marea di sproloqui nei confronti dell'Agnus Dei (Agnello di Dio, o Agnello Crucifero), presente in una moltitudine di forme nelle facciate delle nostre chiese antiche, che un "meneghino" ha definito come simbolo templare, e che queste chiese fossero state costruite perciò dai Templari, nonostante questi stesse mostrando dei fregi dell'VIII e del IX-X secolo, ed uno della prima metà dell'XI, tutti elementi che sono antecedenti sia all'ordine di San Giovanni Gerosolimitano (Ospitalieri), sia ai cavalieri Templari, con una forte affinità di carattere evangelico invece, ispirazione ancestrale di tutte le maestranze che che hanno costruito "i pilastri della terra" in cui noi veneriamo i nostri idoli.
Ecco perché non smetterò mai di ripetere una sola cosa:Studiate, studiate e STUDIATE!!!
Bibliografie di riferimento.
•San Giorgio e il Mediterraneo, in Atti del II Colloquio internazionale per il XVII Centenario (Roma, 28-30 novembre 2003), a cura di G. De' Giovanni-Centelles, Città del Vaticano, 2004.
•La Storia di Varzi, Vol. II, di Fiorenzo Debattisti, 2001.
•Jacopo da Varazze, Legenda Aurea, Einaudi, Torino 1995.
•Eduardo Ciampi, Mino Freda, Paolo Palliccia, Paolo Velonà, San Giorgio e il Drago: l'indispensabile mito. Storia, Metastoria, Arte e Letteratura, Roma, Ed. Discendo Agitur, 2023.
•Medioevo in Molise, il cantiere della Chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina, Di Walter Angelelli, Manuela Gianandrea, Francesco Gandolfo, Francesca Pomarici, 2012.
•Bianca Maria Margarucci Italiani, San Giorgio Martire fra Oriente e Occidente, 1987.
•Pagani e Cristiani. Forme e attestazioni di religiosità del mondo antico in Emilia, XI, 2012.
•San Giorgio e il drago riflessioni lungo un percorso d'arte, Di Sebastiano Giordano, 2005.
•Il Molise medievale e moderno, storia di uno spazio regionale, Giovanni Brancaccio, 2005.
•Italian Romanesque Sculpture, An Annotated Bibliography, Di Dorothy F. Glass, 1983.
•Gycklarmotiv i romansk konst och en tolkning av portalrelieferna på Härja kyrka, Di Jan Svanberg, 1970.
•Molise, appunti per una storia dell'arte, Luisa Mortari, 1984.
•Carlo Ebanista, Alessio Monciatti, Il Molise medievale, archeologia e arte, 2010.
•Federico Marazzi, Molise medievale cristiano, edilizia religiosa e territorio (secoli IV-XIII), 2018.
•L'arte georgiana dal IX al XIV secolo, A cura di Maria Stella Calo' Mariani, Volume 1, 1986.
•L'arte del duecento in puglia di maria stella calo mariani. fotografie di paolo monti u.a, Di Maria Stella Calò Mariani, 1984
#italia#medioevo#storia#archeologia#arte#cultura#storia dell'arte#San Giorgio Martire#San Giorgio#iconografia#iconografiabizantina#iconografiacristiana#Normanni#longobardi#Arte#heritage#Molise#Petrella Tifernina#Magister Alferio
4 notes
·
View notes
Text
Le radici catalane di Alghero
Introduzione
Alghero, spesso chiamata la "Barceloneta" della Sardegna, è una città unica nel panorama italiano grazie alla sua profonda eredità catalana. Questo articolo vi porterà in un viaggio nel tempo, esplorando come l'influenza della Catalogna si manifesti ancora oggi in architettura, lingua, festività e cucina.

Architettura Catalana
Camminando attraverso il centro storico di Alghero, si notano le evidenti influenze catalane nelle strutture cittadine. La Cattedrale di Santa Maria, costruita nel XVI secolo, è un esempio preminente con il suo imponente campanile e la facciata gotico-catalana. Anche la Chiesa di San Francesco, con il suo chiostro, rispecchia lo stile architettonico tipico della Catalogna, offrendo ai visitatori un assaggio di storia medievale immerso nel cuore del Mediterraneo.

La Lingua Algherese
Il catalano di Alghero è una lingua vivace e una delle ultime eredità del dominio catalano in Italia. Oggi, questa lingua è parlata quotidianamente da una parte della popolazione e insegnata nelle scuole locali. La città è orgogliosa di questa sua caratteristica unica e promuove attivamente la conservazione del dialetto attraverso iniziative culturali e l'uso di segnaletica bilingue.

Festività e Tradizioni
Le festività di Alghero sono un vibrante riflesso delle sue radici catalane. La festa di Sant Joan, per esempio, è celebrata con fuochi d'artificio e falò sulla spiaggia, in un evento che richiama sia locali che turisti. Anche durante la Settimana Santa, le processioni e le cerimonie religiose mostrano una forte influenza catalana, mescolando devozione e tradizione in un'atmosfera solenne e coinvolgente.

Gastronomia Ibrida
La cucina algherese offre una fusione deliziosa di sapori sardi e catalani. Piatti come la paella algherese combinano ingredienti locali con tecniche di cucina catalane, risultando in una pietanza che è diventata simbolo della città. Altri esempi includono l'aragosta alla catalana, che viene servita con olio e condimenti tipici della Sardegna e tecniche di preparazione catalane, creando un mix gustoso che delizia il palato.

Impatto Culturale e Sociale
La cultura catalana ha plasmato non solo la lingua e le tradizioni di Alghero, ma anche l'identità della sua gente. Gli Algheresi conservano un forte senso di appartenenza a questa eredità culturale, che si riflette nel loro modo di vivere, nelle loro pratiche sociali e nella valorizzazione delle proprie tradizioni.

La ricchezza culturale di Alghero offre una prospettiva unica sulla storia e l'evoluzione di una città che ha saputo conservare e onorare le sue radici catalane nel tempo. Per chi desidera scoprire di più su questa incantevole città e sperimentare l'ospitalità locale, visitate Villa Grazia B&B Alghero, dove potrete immergervi completamente nell'atmosfera algherese e godere di un soggiorno indimenticabile.

2 notes
·
View notes
Text
Chiesa medievale
della cittadina di Voss
.

La chiesa di pietra di Voss sorge sul sito di un antico tempio pagano. Alla metà del XIII secolo qui venne costruita una chiesa di pietra in stile gotico. Con la Riforma luterana furono rimossi molti elementi originali, ma si sono conservati l’altare in pietra e la caratteristica guglia lignea. La vetrata istoriata del 1923 commemora il 900° anniversario della conversione al cristianesimo di Voss.
La chiesa è sfuggita miracolosamente alla distruzione durante gli intensi bombardamenti tedeschi che avevano occupato nel 1940, la Norvegia.
La chiesa in pietra di Voss fu costruita nel 1277 e può ospitare circa 500 persone. Il sito dell'attuale chiesa potrebbe essere stato occupato un tempo da un tempio pagano. Nel 1023, il re Olaf Haraldsen visitò Vossevangen per convertire il popolo al cristianesimo. La tradizione dice che costruì una grande croce di pietra nel sito, che fu probabilmente il primo luogo di culto cristiano a Voss e divenne la chiesa principale di Hordafylket durante il Medioevo.
La prima chiesa qui era costruita in legno, ma fu sostituita da una chiesa in pietra nel 1277. In una lettera reale risalente al 1271, il re Magnus Lagabøte espresse la sua soddisfazione per il fatto che i parrocchiani avrebbero sostituito l'edificio in legno con uno in pietra, e sollecita la prosecuzione e il completamento di questo compito. Quando fu terminata nel 1277, la chiesa fu dedicata a San Michele.
MAGGIORI INFORMAZIONI : www.visitvoss.no
www.bergen-guide.com


.
7 notes
·
View notes
Text
seriamente pensando di seguire un corso di STORIA DELLA CHIESA MEDIEVALE qualcuno mi fermi e mi faccia ragionare vi prego
#in realtà sto prendendo in considerazione due corsi più legati all’archeologia..oggettivamente ganzi#ma penso che forse ci sarebbero cose più utili al mio percorso??? ma io non so in cosa voglio specializzarmi#corso di archeometria presentato come corso semplice quando so che in altri atenei è un corso durissimo….mmmmmm….#lunedì ho lezione. non ho scelto i corsi.#uni
12 notes
·
View notes
Text

L TEMPIETTO DI BRAMANTE IN SAN PIETRO IN MONTORIO
Considerato tra i simboli più eminenti dell'arte rinascimentale, il tempietto del #Bramante , ubicato in San Pietro in Montorio, venne commissionato dalla regina Isabella di Spagna come ex voto. La data di progettazione dell'opera oscilla tra il 1502 ed il 1510. Sicuramente essa ebbe molto successo tanto da essere lodata, nel tempo, da grandi architetti come Palladio e Serlio oltre che dal Vasari. Il tempietto doveva ricordare e celebrare il martirio di Pietro il quale, secondo alcune tradizioni di origine medievale, non si sarebbe svolto sul Monte Vaticano ma sul Mons Aurum (Montorio, toponimo tardo antico/medievale che indica il Gianicolo e, di conseguenza, la chiesa dedicata appunto a Pietro).
La costruzione sovrasta una cripta circolare, probabilmente resto di un edificio preesistente, il cui centro indica il luogo dove sarebbe stata piantata la croce del martirio.All'epoca di Bramante la cripta era probabilmente ritenuta parte del Tropeion Petri, un piccolo monumento con cui la tradizione indicava il luogo del martirio di San Pietro.
Il tempietto avrebbe dovuto rappresentare il fulcro di un cortile circolare poi non realizzato (l'attuale è di forma quadrangolare), così da evidenziare la perfetta simmetria dell'impianto.
#architettura#arquitectura#architecture#bramante#rinascimento#renassaince#art#arte#rome history#gianicolo#ticonsigliounposto#storiedarte#monumenti#roma#rome#rom#visitareroma#conoscereroma#meisterwerk#kunst#kunst und kultur#kunstwerk#allontanarsidallalineagialla
5 notes
·
View notes
Text
La Cattedrale di Bisceglie ❤️





Noi di Esplorandolacittà vi portiamo alla scoperta della Cattedrale di Bisceglie! Situata nel cuore del centro storico di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani (ma storicamente legata alla provincia di Bari fino al 2004), la Cattedrale di San Pietro Apostolo è un vero gioiello del romanico pugliese. Noi di Esplorandolacittà siamo rimasti incantati da questo monumento che domina Piazza Duomo con la sua imponenza e il suo fascino medievale.
La costruzione della Cattedrale iniziò nel 1073, sotto i Normanni, per volere del conte Pietro di Trani, e fu completata solo nel 1295, quando venne consacrata. Pensate: più di due secoli per darle vita! La sua facciata in pietra chiara è un mix affascinante: il portale romanico, con le sue bifore e monofore, racconta l'originaria semplicità medievale, mentre il grande finestrone barocco in alto è un'aggiunta del XVIII secolo, dopo un terremoto che impose interventi di restauro. Entrando, ci siamo persi nella bellezza delle tre navate, separate da colonne slanciate, e nel matroneo con trifore che sembrano quasi sospese. Il coro ligneo intagliato è un capolavoro che ci ha lasciati a bocca aperta!
Sotto la Cattedrale c'è una cripta speciale, costruita nel 1167 per custodire le reliquie dei santi patroni di Bisceglie: Mauro, Sergio e Pantaleone. La storia racconta che questi tre martiri cristiani, uccisi nel 117 d.C., furono sepolti in contrada Sagina e poi traslati qui dal vescovo Amando. Le loro urne di pietra sono ancora lì, sotto tre altari, e visitarle è come fare un tuffo nel passato. Durante il Rinascimento, grazie al duca Francesco II Del Balzo, la cripta fu risistemata con un tocco di eleganza che si sente ancora oggi.
Accanto alla Cattedrale, il palazzo vescovile ospita il Museo Diocesano, dove noi di Esplorandolacittà consigliamo di fare un salto: dipinti, sculture e argenti vi aspettano per svelare altri pezzi della storia biscegliese. E poi c'è il porto antico a due passi, con i resti dei moli settecenteschi, che rende il tutto ancora più suggestivo.
Insomma, la Cattedrale di Bisceglie non è solo una chiesa: è un racconto di fede, arte e resilienza che noi di Esplorandolacittà siamo felici di condividere con voi. Pronti a esplorarla?
𝓔𝓼𝓹𝓵𝓸𝓻𝓪𝓷𝓭𝓸𝓵𝓪𝓬𝓲𝓽𝓽𝓪 (𝓜&𝓛)
#bisceglie, #cattedraledibisceglie, #vacanzeabisceglie, #amarelapuglia, #bellezzedelterritorio, #esplorandolacittà
1 note
·
View note
Text
I luoghi turistici più importanti del Cairo e Alessandria.

Il Cairo, o Cairo El Moez come è stato chiamato dove ha resistito e conquistato le invasioni dei nemici nel corso della storia, l'imponente capitale del mondo arabo e la capitale dell'Egitto, è una città immaginaria per godersi la storia antica. È possibile visitare l'Egitto attraverso EGITTO TOURS forniti da Il Cairo top tours.
La città dei mille minareti, come è stato chiamato, è famosa per l'abbondanza di minareti, la loro diversità e la differenza nella loro architettura con la differenza del califfato in epoca islamica, una città da cui si può viaggiare per l'epoca islamica e medievale, nonché per l'era faraonica quando si vedono le piramidi. È possibile prenotare i migliori viaggi da Cairo brevi pacchetti di vacanze per godersi l'antica storia egiziana.
Assicurati di visitare le moschee e i loro numerosi musei, in particolare il Museo Egizio, che include i tesori dei Faraoni e la camera delle mummie, quindi conosciamo i luoghi turistici più belli del Cairo. Prenota il tuo tour ora 3 giorni di sosta al Cairo per vedere il posto fantastico.
Piramidi di Giza: Non ci può essere posto più sorprendente al mondo di questo grande edificio, senza dubbio è una delle vere meraviglie dell'antichità, è l'unica delle Sette meraviglie del mondo antico che si trova ancora e l'eredità più simbolica dell'Egitto. È possibile prenotare i migliori viaggi attraverso EGITTO TOUR CLASSICI con i migliori prezzi da Il Cairo top tours.
Le tre piramidi e la statua della Sfinge, sono un patrimonio mondiale dell'UNESCO, e una delle prime cose da fare in un viaggio in Egitto, perché sono tra le attrazioni turistiche in Egitto. Non appena si visita, si ottiene una sensazione di energia e stupore che emana da questi antichi giganti, miracoli di matematica e astronomia nella costruzione. È possibile prenotare i migliori viaggi da PACCHETTI DI VIAGGIO EGITTO consiglia di visitare siti Egitto.
Ci sono molti hotel con vista diretta sulle piramidi, svegliarsi, fare colazione e una vista di questo lavoro di ingegneria millenario sarà per sempre uno dei migliori ricordi del tuo viaggio in Egitto. Prenota ora il tuo tour Breve vacanza al Cairo in 4 giorni per godere di un meraviglioso soggiorno al Cairo.
Immergiti nei corridoi del Museo Egizio del Cairo tra le mummie e i tesori dei Faraoni e delle statue, la stanza del tesoro di Tutankhamon e la Stanza della Mummia. Non pensare nemmeno di andare senza una guida che ti spieghi la sua storia o senza studiare prima i pezzi più importanti, sono enormi e puoi impazzire. Prenota il tuo tour ora 2 giorni al Cairo per una breve vacanzaper godere della visione delle culture egiziane.
Distretto di Al-Hussein-Fatimid Cairo, che testimonia i più bei monumenti di Fatimid Cairo, dove la famosa Moschea Al-Azhar, la Moschea Al-Hussein, la famosa via Al-Mu'izz, la moschea del sovrano Amr Allah e la famosa area di Khan al-Khalili sono una delle attrazioni turistiche più importanti in Egitto. Prenota ora il tuo tour Vacanza Breve al Cairo 2 giorni per vedere la meravigliosa architettura egiziana.
Old Egypt district-Old Cairo: una delle migliori zone turistiche in Egitto e i quartieri più belli del Vecchio Cairo pieno di attrazioni turistiche e testimonianza di civiltà storiche, dove la Città Vecchia di Fustat, la strada complesso religioso, La Chiesa pensile e la storica moschea Omar ibn al-Aas, e il muro del flusso di occhi. È possibile prenotare i migliori viaggi attraverso 3 giorni al Cairo per una breve vacanza per esplorare questo luogo fantastico.
I luoghi turistici più importanti di Alessandria: Ad Alessandria, la storia respira, come testimoniano il famoso Castello Qaitbay, la biblioteca di Alessandria, le catacombe di Kom el-Shoqafa, la più grande necropoli romana in Egitto e una delle più importanti attrazioni turistiche in Egitto. È possibile visitare l'Egitto attraverso Brevi Pause al Cairo 3 giorni per visitare i migliori monumenti monumentali rinomati in Egitto.
Oggi è possibile visitare la nuova biblioteca di Alessandria e dei suoi musei, il mercato, il Castello Qaitbay, il teatro romano, il palazzo del re Farouk nel famoso Parco Montazah, il monastero di Santa Mina e il Museo dei gioielli reali. È possibile visitare l'Egitto attraverso 4 giorni Breve Pausa al Cairo per godersi i pacchetti vacanza.
Oppure fai una passeggiata notturna sulla Corniche di Alessandria e sul ponte Stanley e visita il monumento del Milite ignoto nel quartiere di Manseya, e goditi le bancarelle e i famosi caffè culturali di Alessandria in stile greco o trascorri una giornata straordinaria a Bahri e prova i deliziosi piatti a base di pesce dei residenti di Alessandria direttamente sul mare in un'atmosfera divertente e fantasiosa. È possibile prenotare i migliori viaggi di Breve pausa al Cairo in 5 giorni per esplorare questo luogo fantastico.
@Cairo top tours
0 notes
Photo





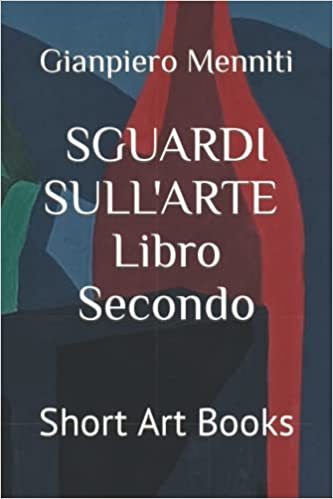
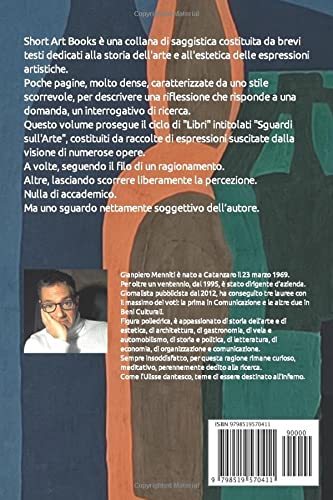
Da: SGUARDI SULL’ARTE LIBRO SECONDO - di Gianpiero Menniti
LA PIETRA DEL SENTIMENTO
Giovanni Pisano, figlio del famoso Nicola, può essere considerato, assieme al padre, tra gli artefici sommi della scultura medievale italiana del XIII secolo. Secolo nel quale, in Italia, si affermano istituzioni comunali ormai mature e tuttavia vibranti nelle loro dinamiche politiche, centri floridissimi di un’economia nuova che rispecchia la rivoluzione commerciale avviatasi con poderosa progressione fin dal X e XI secolo. Città ricche e forti che hanno bisogno di dare voce a sé stesse attraverso opere monumentali di grande magnificenza, ex voto alla loro potenza. In questo clima sociale, Giovanni, dopo aver a lungo coadiuvato il padre nella bottega di famiglia (nella quale s’istruì anche Arnolfo di Cambio) fino alla morte di questi avvenuta nel 1284, avviò iniziative di notevole rilevanza prima a Siena e poi, nel 1297 a Pistoia dove venne chiamato a realizzare il pulpito della Chiesa dedicata a Sant’Andrea. In particolare, la lastra che narra la “Strage degli Innocenti“ viene inserita nel ciclo della vita di Gesù per rivelare la violenza umana più efferata, la malvagità che sospinge verso il male e la connessa ambiguità dell’essere macchiato dal peccato non redento. La lastra segue, nella struttura del racconto, un andamento diagonale che ha due vertici alti nella figura di Erode intronato che comanda la strage, mandante crudele e partecipe animato della tragedia, ed in quella del soldato che solleva senza pietà il povero corpo di un piccino ignara vittima di un gesto orribilmente sadico; all’opposto di questi, in basso, si trovano la scena di una madre che tenta di proteggere il proprio bambino dall’assalto implacabile di un soldato pronto a colpire mentre nel vertice basso ulteriore è colta la pena insostenibile di un’altra madre ormai sconvolta e prostrata dal dolore nella fissità del corpo senza vita del proprio tenero innocente. Una scena infernale verso la quale, significativamente, la figura spiccata al centro ed in alto di una donna non osa più guardare coprendosi il volto. Una scena animata da un movimento che gronda dolore e violenza inaudite: questo è il dolore che salva le anime dei credenti; questa è la violenza che le condanna all’eterna pena dell’inferno. Il talento dell’artista è essenzialmente nella capacità di condurre ad una visione coinvolgente e persino disperata dell’atto narrativo. Una capacità somma che lo rende in grado di trasformare la materia in sentimento, quindi di superare la materia stessa costituendola come puro strumento di stile. Stile capace di assorbire con sapiente tecnica i limiti prospettici del piano bidimensionale grazie alle possibilità dell’altorilievo, che mancano invece al pittore. Al quale non rimarrà la scoperta della prospettiva per sopperirvi.
- Giovanni Pisano (1248 - 1315): Lastra della "Strage degli Innocenti", 1297, Pulpito del Duomo di Pistoia
- In copertina: Maria Casalanguida, "Bottiglie e cubetto", 1975, collezione privata
5 notes
·
View notes
Text
La Chiesa Madre di San Marco d'Alunzio al Tramonto: Uno Spettacolo Indimenticabile
La Chiesa Madre di San Marco d’Alunzio, intitolata a San Nicolò di Bari, è un edificio di culto situato nel cuore del borgo medievale di San Marco d’Alunzio, in Sicilia. Costruita tra il 1584 e il 1800, la chiesa presenta una facciata caratterizzata da tre portali in marmo rosso locale e un elegante rosone. L’interno, a navata unica, custodisce pregevoli opere d’arte, tra cui un tabernacolo in…
#Aerial View#Architecture#Building Exterior#Chiesa Madre#chiesa madre di san marco d&039;alunzio#Cityscape#Cultures#Dusk#Famous Place#History#ITALIA#ITALY#Landscape#Messina#new#Night#Outdoors#Roof#san marco d&039;alunzio#Sicilia#Sicily#Sunset#Tramonto#Travel#Travel Destinations#TRAVEL PHOTOGRAPHY#turismo#viaggi
0 notes