#lettere biografiche
Explore tagged Tumblr posts
Text
Van Gogh, l’uomo: un viaggio nella vita di Vincent attraverso le sue lettere. Silvana Ramazzotto Moro esplora l'uomo dietro il genio in un'opera unica
Un ritratto umano di Vincent Van Gogh. Con il libro “Van Gogh, l’uomo”, edito da Guido Miano Editore nel dicembre 2024, Silvana Ramazzotto Moro offre un contributo prezioso alla comprensione dell’uomo dietro il celebre pittore.
Un ritratto umano di Vincent Van Gogh. Con il libro “Van Gogh, l’uomo”, edito da Guido Miano Editore nel dicembre 2024, Silvana Ramazzotto Moro offre un contributo prezioso alla comprensione dell’uomo dietro il celebre pittore. L’autrice, appassionata di filosofia, letteratura e arte, si immerge nelle lettere di Van Gogh per restituire al lettore una visione autentica e priva di…
#2024 pubblicazioni#Alessandria today#Alessandro today#analisi tematica Van Gogh#arte e filosofia#arte e spiritualità.#arte giapponese#Arte moderna#Autoritratto#biografia intima#biografia Van Gogh#Critica letteraria#cultura e arte#Enzo Concardi#Google News#Guido Miano#Guido Miano Editore#Guido Miano Milano#introspezione artistica#italianewsmedia.com#japonisme#letteratura artistica#lettere biografiche#lettere di Van Gogh#Letture consigliate#malattia Van Gogh#malintesi su Van Gogh#Michele Miano#narrativa biografica#Pier Carlo Lava
0 notes
Text
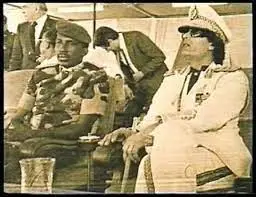
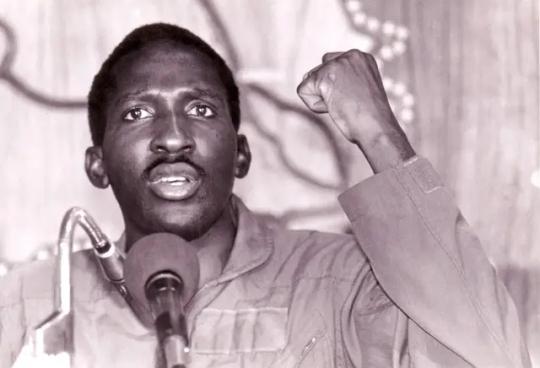
Senza inoltrarci in quelle che sono le informazioni biografiche del grande e unico Thomas Sankara, partiamo subito a razzo sottolineando che costui, la prima cosa che fece una volta al potere nel 1983 fu disfarsi del nome “Alto Volta”. Prese due parole, una della lingua Moré e una della lingua Dioula, e le mise insieme: Burkina Faso. Tradotto in italiano più o meno è come dire “la terra degli uomini integri”. Questo fu il principio, il seguito è la parte più bella. Cos’è che fece Sankara per il suo popolo?
Avviò una campagna di alfabetizzazione a livello nazionale, aumentando il tasso di alfabetizzazione dal 13% nel 1983 al 73% nel 1987;
Fece piantare oltre dieci milioni di alberi per prevenire la desertificazione;
Diede il via ad una serie di costruzioni di strade e una ferrovia per unire la nazione, senza l’ausilio di aiuti stranieri;
Aprì la strada alle donne all’interno delle sfere governative e rese effettivo il congedo di gravidanza durante l’istruzione;
Bandì le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e la poligamia a sostegno dei diritti delle donne (in maniera sana, niente femminismo e altri derivati della Scuola di Francoforte);
Ridistribuì la terra dai feudatari e la diede direttamente ai contadini, (esattamente come fece Pëtr Arkad’evič Stolypin il più grande uomo politico russo prima di essere assassinato e di cui abbiamo parlato in un articolo a lui dedicato e a cui Putin non è degno di lucidare nemmeno le scarpe). Con Sankara, la produzione di grano del Burkina Faso è passata in tre anni da 1700 kg per ettaro a 3800 kg per ettaro.
Ma questo non è tutto, c’è ancora una questione da affrontare, la più importante: il debito. Quello che Sankara voleva più di ogni altra cosa era eliminare gli aiuti internazionali dal quale il paese (così come tutta l’Africa) dipendeva, fonti di assistenzialismo e impedimento per uno sviluppo interno. Egli gridò al mondo la verità, ossia che i prestiti finanziari servissero solo a produrre il debito tramite il quale gli usurai ai vertici delle banche centrali e private potevano controllare e indirizzare l’azione governativa in tutta l’Africa, esattamente come continuano e continueranno a fare. Egli aveva predetto ciò che sta accadendo proprio in questo momento, ossia una guerra su larga scala ai popoli della terra e non tra i paesi. Egli lo disse a chiare lettere che gli stati operano tutti sotto la stessa unica regia. Proprio ora, come abbiamo sottolineato altre volte, stiamo vivendo questa guerra che è incentrata sulla popolazione europea, in particolare sul piano economico, al fine di farla farla cadere e aderire al grande reset, attraverso il suo inserimento nel blocco euroasiatico, epicentro della Sinarchia Universale, conosciuta più comunemente come Nuovo Ordine Mondiale.
Ciò che decretò la condanna a morte di Sankara fu il discorso sul debito del 29 luglio del 1987 pronunciato ad Addis Abeba in occasione del vertice dell’Organizzazione dell’unità africana dove erano presenti i leader di tutti i paesi del continente. Sankara evidenziò come l’eliminazione del debito fosse di vitale importanza per lo sviluppo dell’Africa e che dovesse essere affrontato con una strategia comune a tutti gli stati africani. Corre voce a tal proposito che il Burkina Faso dipendeva (e tutt’ora dipenda) dalla Francia. Corre voce che Parigi era (ed è) di gran lunga il suo principale donatore di aiuti, fornendo circa 60 milioni di dollari ogni anno, i quali costituivano il 40% del bilancio del Burkina Faso già negli anni ’80. E corre voce che il Paese già a quel tempo dovesse alla Francia circa 155 milioni di dollari e che il debito pubblico consumava un quarto delle entrate statali. Ebbene, l’unica cosa vera di tutte queste voci è l’ultima. I debiti non erano e non sono con la Francia, bensì con la Banca centrale degli Stati dell’Africa Occidentale (BCEAO) di cui abbiamo parlato prima, governata dalla Banca per i Regolamenti Internazionali che abbiamo analizzato prima, il cui governatore, come detto, è membro del WEF. La BCEAO nasce nel 1959 ed è l’unica autorizzata ad emettere moneta (il Franco CFA che nei programmi futuri dovrebbe trasformarsi nella Eco) nei paesi che abbiamo visto prima: Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea – Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo. La banca risponde direttamente alla Lazard Frères e alla famiglia Concordia, rami francesi del gruppo Rothschild, ecco perché erroneamente si attribuisce alla Francia un dominio che in realtà di francese ha poco o nulla. Certo questo lo si comprende solo se si conosce la vera storia dei potentati dietro alle colonie prima e del neocolonialismo tutt’ora in atto poi; quindi, chi è che muove i paesi gli uni contro gli altri? Chi è che finanzia guerre, rivoluzioni,, colpi di stato e tutte quelle altre cose che conosciamo bene? La risposta è davanti ai nostri occhi.
In tutta onestà, credo che la realtà parli da sola, non penso che ci sia bisogno né di un mio personale punto di vista né chissà che altro. Si può scegliere di guardarla in faccia, oppure credere alle peggiori sciocchezze che vengono propagandate da una parte e dall’altra. Una cosa però la posso dire, ossia che sono sicuro che in questo momento, Sankara a vedere quel pagliaccio di Ibrahim Traoré, si stia rivoltando nella tomba. Dal Sud Africa al Burkina Faso, passando per il Niger e via via tutti gli altri, attraverso questo fil rouge, in Africa si sta preparando il territorio adatto per il Grande Reset. Come abbiamo visto l’Africa è stata sfruttata e martoriata, ma ha ancora tantissimo da offrire e lo spostamento dell’ago della bilancia di cui abbiamo parlato in precedenza è la prova che il peggio per questa bellissima e meravigliosa terra deve ancora arrivare. Vi lascio con tre estratti significativi di quel famoso discorso di Thomas Sankara pronunciato ad Addis Abeba poco prima di essere ucciso da Blaise Compaoré, servo dell’usurocrazia che gli succedette al potere per ben ventisei anni. No, non c’entra la CIA, non c’entra la Francia, queste sono mere storielle di facciata per far sì che le persone guardino il dito e non la luna. La morte di Sankara fu opera degli USURAI.
Estratto 1
«Riteniamo che il debito debba essere visto dalla prospettiva delle sue origini. Le origini del debito vengono dalle origini del colonialismo. Quelli che ci prestano denaro sono quelli che ci hanno colonizzato. Sono gli stessi che gestiscono i nostri stati e le nostre economie. Questi sono i colonizzatori che hanno indebitato l’Africa attraverso i loro fratelli e cugini. Noi non avevamo collegamenti con questo debito. Quindi non possiamo pagarlo. Il debito è il neocolonialismo, in cui i colonizzatori si sono trasformati in “assistenti tecnici”. Dovremmo piuttosto dire “assassini tecnici”. Ci presentano denaro, come se il sostegno di qualcuno potesse creare sviluppo. Ci è stato consigliato di rivolgerci a questi istituti di credito. Ci sono stati offerti dei buoni accordi finanziari. Siamo indebitati per 50, 60 anni e anche di più. Ciò significa che siamo stati costretti a compromettere la nostra gente per oltre 50 anni. Nella sua forma attuale il debito è una riconquista dell’Africa abilmente gestita, intesa a soggiogarne la crescita e lo sviluppo attraverso regole straniere. Così, ognuno di noi diventa lo schiavo finanziario, vale a dire un vero schiavo, di coloro che erano stati abbastanza traditori da immettere denaro nei nostri Paesi con l’obbligo di ripagarlo. Ci viene detto di ripagare, ma non è una questione morale. Non si tratta di questo cosiddetto onore di ripagare o meno. Signor Presidente, abbiamo ascoltato e applaudito il primo ministro norvegese quando ha parlato proprio qui. Lei è europea ma ha detto che l’intero debito non può essere ripagato. Il debito non può essere rimborsato, innanzitutto perché se non lo rimborsiamo, i prestatori non moriranno. Questo è certo. Ma se ripaghiamo, saremo noi a morire. Anche questo è certo. Chi ci ha portato all’indebitamento ha giocato d’azzardo come in un casinò. Finché hanno avuto guadagni, non c’è stato dibattito. No, signor presidente, hanno giocato, hanno perso, questa è la regola del gioco e la vita continua. Non possiamo rimborsare il debito perché non abbiamo i mezzi per farlo. Non possiamo pagare perché non siamo responsabili di questo debito. Non possiamo ripagare ma gli altri ci devono quello che la più grande ricchezza non potrebbe mai ripagare, cioè il debito di sangue. Il nostro sangue è stato sparso.»
Estratto 2
«Non possiamo essere complici. No! Non possiamo andare a braccetto con coloro che succhiano il sangue della nostra gente e vivono del sudore della nostra gente. Non possiamo seguirli nei loro modi omicidi. Signor Presidente, abbiamo sentito parlare di club: il Club di Roma, il Club di Parigi, il club la qualunque. Sentiamo parlare del Gruppo dei Cinque, del Gruppo dei Sette, del Gruppo dei Dieci e forse del Gruppo dei Cento. E che altro? È normale che anche noi abbiamo il nostro club e il nostro gruppo. Facciamo in modo che Addis Abeba diventi ora il centro da cui emergerà un nuovo inizio. Un Club di Addis Abeba. È nostro dovere creare un fronte unito di Addis Abeba contro il debito. Questo è l’unico modo per affermare che il rifiuto di rimborsare non è una mossa aggressiva da parte nostra, ma una mossa fraterna per dire la verità. Inoltre, le masse popolari europee non sono nemiche delle masse popolari africane. Ma coloro che vogliono sfruttare l’Africa sono anche quelli che sfruttano l’Europa. Abbiamo un nemico comune! Quindi il nostro Club di Addis Abeba dovrà spiegare a tutti che quel debito non sarà ripagato!”
Estratto 3
«Vorrei che la nostra conferenza si assumesse l’urgente necessità di dire chiaramente che non possiamo ripagare il debito. Non con spirito bellicoso, ma per impedirci di essere assassinati individualmente. Se il Burkina Faso è il solo a rifiutarsi di pagare, io non sarò più qui per la prossima conferenza! Ma con il sostegno di tutti, di cui ho bisogno, con il sostegno di tutti non dovremmo pagare. In tal modo, dedicheremo le nostre risorse al nostro sviluppo. E vorrei concludere dicendo che ogni volta che un paese africano acquista un’arma, è contro un Paese africano. Non è contro un paese europeo, non è contro un paese asiatico, ma è contro un paese africano. Di conseguenza, dovremmo approfittare della questione del debito per risolvere anche il problema delle armi. Sono un soldato e porto una pistola. Ma signor presidente, vorrei che ci disarmassimo. Quindi miei cari fratelli, con il sostegno di tutti, faremo la pace in casa nostra. Utilizzeremo anche le nostre immense potenzialità per sviluppare l’Africa, perché il nostro suolo e il nostro sottosuolo sono ricchi. Abbiamo abbastanza uomini e un vasto mercato – da nord a sud, da est a ovest. Abbiamo capacità intellettuali sufficienti per creare o per lo meno utilizzare la tecnologia e la scienza ovunque le troviamo. Signor Presidente, formiamo questo fronte unito di Addis Abeba contro il debito. Prendiamo l’impegno di limitare gli armamenti tra i Paesi deboli e poveri. Pistole, mazze e coltelli che compriamo sono inutili. Facciamo anche del mercato africano il mercato degli africani: produciamo in Africa, trasformiamo in Africa, consumiamo in Africa. Produciamo ciò di cui abbiamo bisogno e consumiamo ciò che produciamo invece di importare. Il Burkina Faso è venuto qui mostrando il tessuto di cotone prodotto in Burkina Faso, tessuto in Burkina Faso, seminato in Burkina Faso, per vestire i cittadini del Burkina Faso. La nostra delegazione ed io siamo vestiti dai nostri tessitori e mangiamo i prodotti dei nostri contadini. Non c’è un solo filo proveniente dall’Europa o dall’America o altrove. Non farei una sfilata di moda, ma direi semplicemente che dobbiamo accettare di vivere come africani: questo è l’unico modo per vivere liberi e dignitosi. La ringrazio, signor presidente.”
------
10 notes
·
View notes
Text
Melodramma e poesia si incontrano al Maschio Angioino
Al Maschio Angioino, presso la sala della Loggia, l’Associazione Culturale Noi per Napoli, con il patrocinio morale del Comune di Napoli presenta i lavori del tenore Luca Lupoli, autore del nuovo saggio dal titolo "Il Melodramma di Pietro Metastasio, il Primato del Testo"", edito dalla casa editrice “Pagine", la giornalista, scrittrice, e della docente di materie letterarie Maria Cuono autrice di Tutto con il cuore, la nuova versione di Verso l’orizzonte, edito dalla casa editrice Kimerik". Interverranno alla presente kermesse culturale in qualità di relatori il M° Olga De Maio soprano, il dottor Ermanno Corsi,Direttore e giornalista RAI, il professor Ettore Massarese, la dottoressa Lydia Tarsitano. Modera la dottoressa Daniela Merola, giornalista e scrittrice. La silloge poetica intrisa di sentimenti e personaggi “La mia silloge poetica è rivolta sia ad un pubblico giovanile che adulto, in cui si affrontano temi vari, che vanno dalla guerra, all’abbandono dei cani. È un testo molto scorrevole intriso di sentimenti, dall’amicizia, l’amore, ai ricordi di vita vissuti intensamente, alle paure, ai segreti, alle dediche a persone che hanno fatto parte della mia vita come mia madre, il più grande punto di riferimento, ed a personaggi del mondo dello spettacolo conosciuti durante le loro esibizioni” afferma Maria Cuono. Il saggio su Metastasio al Maschio Angioino ”Questo secondo lavoro editoriale è un saggio storico-culturale incentrato sulla figura del drammaturgo Pietro Metastasio, dopo quello dedicato all’ Opera ed alla figura del compositore partenopeo Mario Persico, pubblicato l’anno scorso con Aletheia Editore, risale ad un periodo della mia vita in cui stavo terminando gli studi e in cui ho deciso di dedicare il suo tempo”, sostiene Luca Lupoli, autore del recente saggio su Metastasio. L’opera, basata su un’accurata analisi dei carteggi di Metastasio, introduce una delle figure più importanti del panorama teatrale Settecentesco: Pietro Metastasio, poeta e librettista italiano, considerato uno dei maggiori esponenti del melodramma, una forma di opera lirica caratterizzata dalla fusione di musica e dramma. Il testo Il testo spazia attraverso il pensiero e la personalità dell’autore, conoscibili grazie alle sue famose lettere, note come i carteggi di Metastasio, attraverso cui è possibile una comprensione più approfondita delle sue relazioni personali e professionali e delle sue idee estetiche. Metastasio è stato il fautore dell’importanza della predominanza del testo sulla musica, tanto da poter poi definire il concetto di teoria metastasiana. L’opera è arricchita dalle ricerche biografiche, bibliografiche e delle fonti condotte dal soprano M° Olga De Maio, con la prefazione del Prof. Ettore Massarese, rinomato regista, attore, docente di Letteratura Teatrale Italiana e Discipline dello spettacolo presso l’Università Federico II di Napoli, mentre la bella grafica della copertina è stata ideata e realizzata dal Prof. Giuseppe De Maio, docente di Arte e grafico. Foto di Didier da Pixabay Read the full article
0 notes
Photo
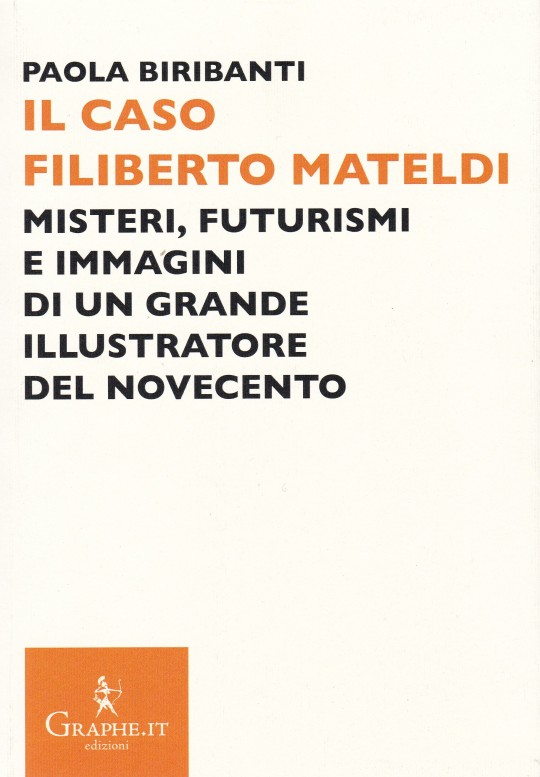


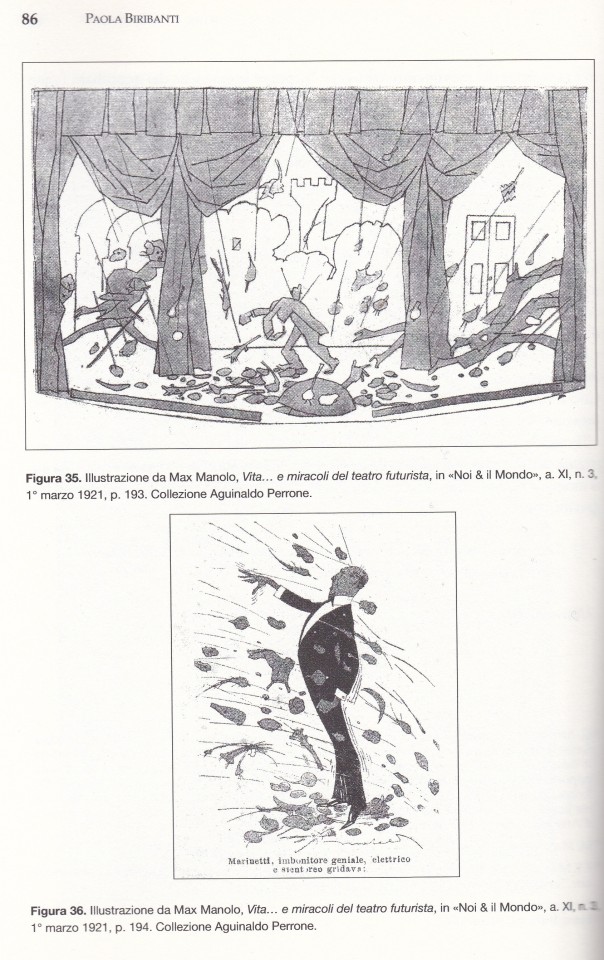
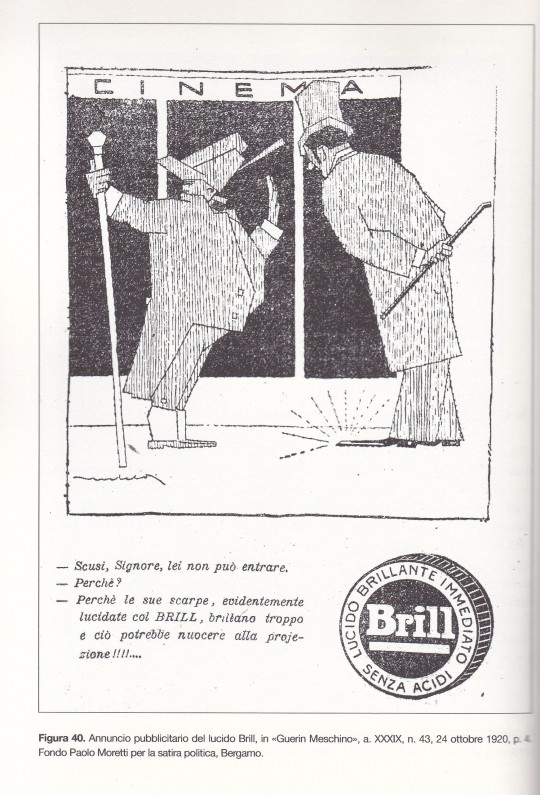
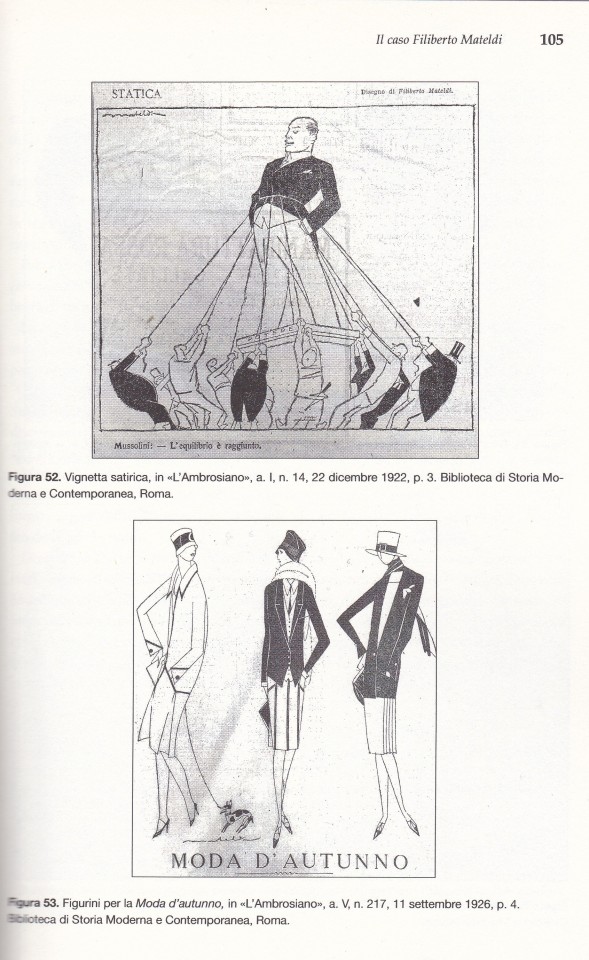

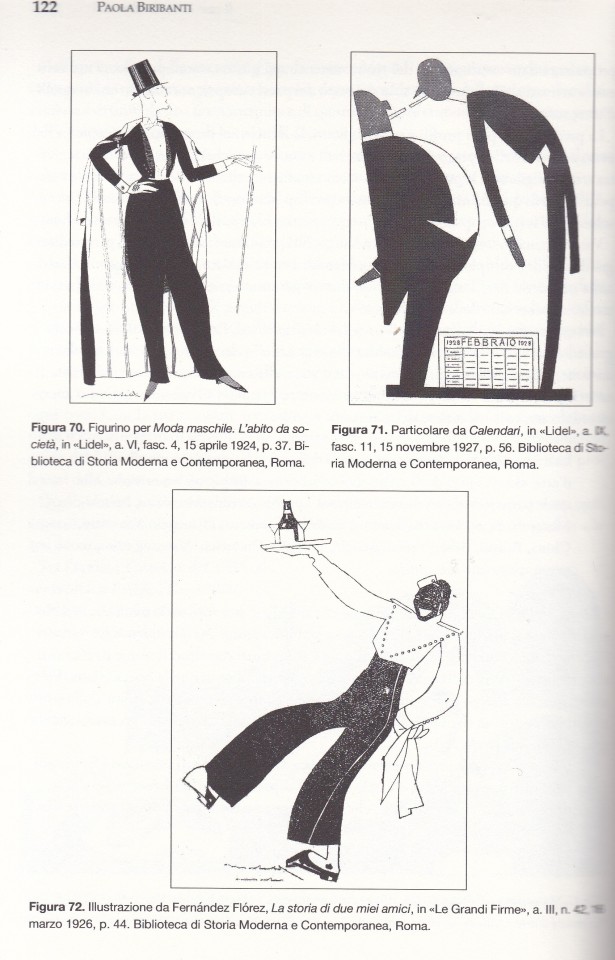
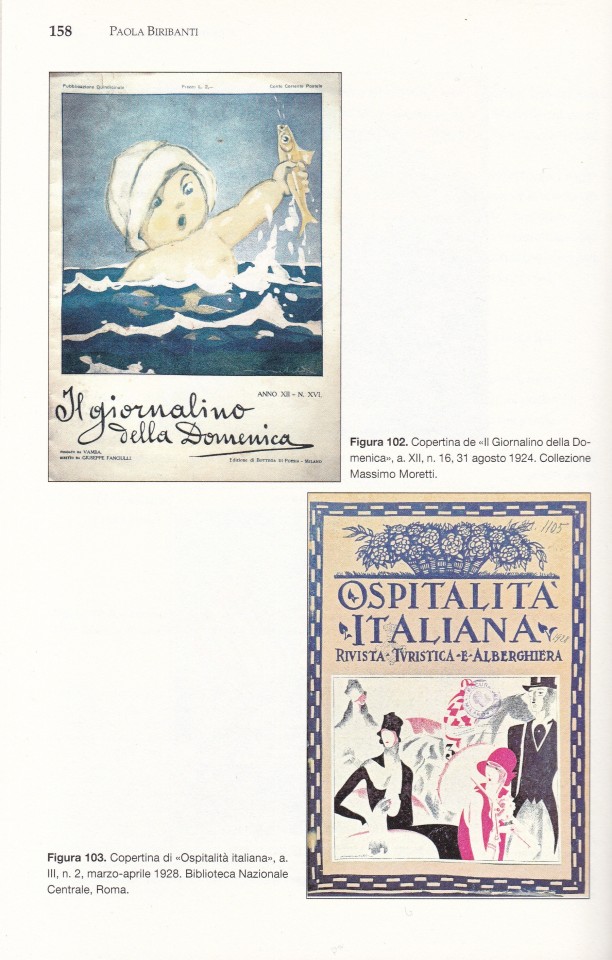

Il caso Filiberto Mateldi
Misteri, futurismi e immagini di un grande illustratore del novecento
Paola Biribanti , prefazione di Gianni Brunoro
Graphe.It Edizioni, Perugia 2021, 172 pagine,ISBN 978-88-9372-118-9
euro 24,50
email if you want to buy :[email protected]
La prima monografia dedicata a uno dei massimi disegnatori italiani. Vignettista satirico tra i più mordaci degli anni Venti, arbiter elegantiae sulle riviste di moda dell’Italia bene degli anni Trenta, illustratore di punta di una pietra miliare della letteratura per l���infanzia come La Scala d’oro UTET, cartellonista innovativo, scenografo, attore presso alcune tra le più importanti compagnie del primo Novecento e capocomico della Compagnia del Teatro Futurista, Filiberto Mateldi è stato un talento multiforme. Indefessamente attivo, in Italia e in Argentina, fino alla morte prematura, nel 1942. Perché, nonostante la fama in vita e il numero e l’importanza delle collaborazioni («Il Giornalino della Domenica», il «Corriere dei Piccoli», «Dea», «Lidel», «Il Balilla», «Pasquino»...), sul maestro e marito di Brunetta Mateldi Moretti, celebrità della grafica di moda, la bibliografia esistente è così scarsa? Perché le notizie biografiche sono tanto vaghe? Grazie a un’approfondita ricerca storico-anagrafica e al prezioso materiale messo a disposizione dagli eredi, Paola Biribanti è riuscita a trovare una soluzione al “caso Mateldi”. Nel corso delle indagini sul personaggio, sono emerse notizie diverse da quelle finora considerate acquisite e particolari che hanno aperto varchi verso la scoperta di nuove e inaspettate dimensioni nella sua vita tumultuosa, che fanno de Il caso Filiberto Mateldi, non solo la prima monografia interamente dedicata a uno dei massimi disegnatori italiani, ma un riferimento imprescindibile per i dati biografici e professionali su di lui. Il volume, impreziosito dalla prefazione di Gianni Brunoro, è riccamente illustrato e corredato di lettere, fotografie, bozzetti e disegni inediti.
22/02/22
orders to: [email protected]
ordini a: [email protected]
twitter:@fashionbooksmi
instagram: fashionbooksmilano, designbooksmilano tumblr: fashionbooksmilano, designbooksmilano
#Filiberto Mateldi#vignettista satirico#arbiter elegantiae#letteratura infanzia#cartellonista#scenografo#Teatro Futurista#Corriere dei Piccoli#Lidel#Brunetta Mateldi#Guerin Meschino#fashionbooksmilano
6 notes
·
View notes
Photo
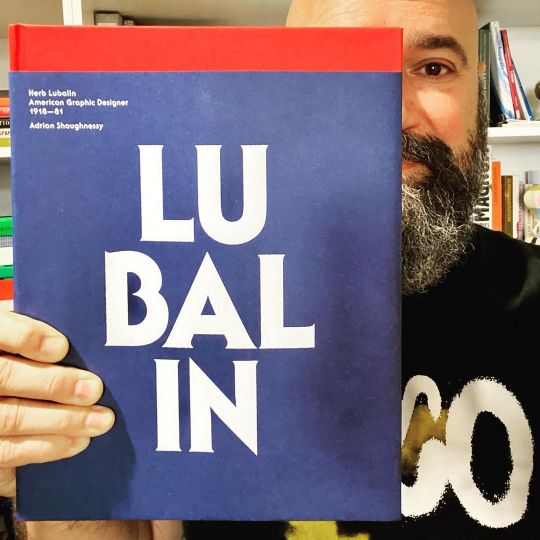
Herb Lubalin. American Graphic Designer. 1918-81. Adrian Shaughnessy. @uniteditions 📚 Esiste un modo per celebrare i 100 anni dalla nascita di uno dei più influenti graphic designer del ‘900? Sì, dedicargli un libro. E che libro! La prima edizione andò esaurita in brevissimo tempo nel 2012 e grazie ad una campagna su Kickstarter sono riuscito ad ottenere questa versione, a cento anni esatti dalla nascita. Una pubblicazione meravigliosa per contenuti e qualità editoriale, per ripercorrere l’incredibile ruolo che ha avuto questo designer newyorkese nell’estetica e nella comunicazione visiva di tutti noi, ancora oggi a 40 anni dalla scomparsa. La monografia definitiva: 70 pagine biografiche con interviste a designer famosi e familiari, e 3 macro sezioni ricchissime di contenuti visivi: Advertising (come molti, è partito da lì), Typography (progettava con le lettere - e in qualche caso le lettere stesse - ma non amava farsi chiamare tipografo) e Editorial (i suoi meravigliosi progetti editoriali, impaginati in modo magistrale). In una parola: Immenso. Può un post spiegare la grandezza di Lubalin. Lo ammetto, non credo proprio. L’uso libero, dinamico ma sempre elegante dei caratteri, il “rifiuto” delle regole tipografiche tradizionali e del rigore modernista con lo scopo di creare una “tipografia��� personale ed espressiva, è qualcosa di unico ancora oggi. Che fossero annunci pubblicitari, marchi o progetti editoriali, le sue composizioni tipografiche riuscivano a diventare contenuti visivi oltre che testuali. E senza l’uso di font stravaganti o senza togliere la possibilità di leggere il testo (Carson spostati). Immenso è dir poco! #booklover #bookstagram #everymonday ••• #chiani #artdirection #illustration #creativedirection #graphicdesign #brandidentity #branding #design #visualdesign #strategy #advertising #packaging #communication #concept #photography #managers & #designers #myartismydirection #designthinking @chianidesign #designboutique #vierijacopochiani #freelance #unicorn #palazzoschio #creativecollective #2021 #vicenza (presso Chiani) https://www.instagram.com/p/CTMb0wnLaxD/?utm_medium=tumblr
#booklover#bookstagram#everymonday#chiani#artdirection#illustration#creativedirection#graphicdesign#brandidentity#branding#design#visualdesign#strategy#advertising#packaging#communication#concept#photography#managers#designers#myartismydirection#designthinking#designboutique#vierijacopochiani#freelance#unicorn#palazzoschio#creativecollective#2021#vicenza
3 notes
·
View notes
Photo

"VOCI POSSIBILI" Laboratorio sulla vocalità contemporanea a cura di Monica Benvenuti & NicoNote Firenze, 20 > 22 settembre 2019 Nell’ambito del Tempo Reale Festival 2019, Y
VOCI POSSIBILI è un percorso di studio e di ricerca rivolto a cantanti, performer, compositori a cura di Monica Benvenuti & NicoNote alias Nicoletta Magalotti
➡ Per accedere al corso non sono richiesti pre-requisiti, non c’è selezione tuttavia è gradita una breve presentazione. Verranno accettate tutte le iscrizioni fino al numero massimo di partecipanti.
VOCI POSSIBILI | Laboratorio sulla vocalità contemporanea II
Nell’ambito del Tempo Reale Festival, Y e di Suoni e musica di ricerca – Formazione 2019
20 > 22 settembre 2019, Villa Strozzi VOCI POSSIBILI | Laboratorio sulla vocalità contemporanea II Un percorso di studio e di ricerca rivolto a cantanti, performer, compositori a cura di NicoNote e Monica Benvenuti Nell’ambito del Tempo Reale Festival, Y e di Suoni e musica di ricerca – Formazione 2019
Ecco un nuovo appuntamento di VOCI POSSIBILI, il percorso di studio sulla vocalità contemporanea iniziato a gennaio di quest’anno, ideato e curato da NicoNote e Monica Benvenuti in collaborazione con Tempo Reale. Rivolto ad allievi di provenienze culturali differenti, si propone di indagare la vocalità contemporanea servendosi di un approccio trasversale. La traiettoria d’indagine di questo corso di studi, vuole essere inclusiva della formazione sia accademica, sia empirica. Il percorso formativo è articolato in appuntamenti di workshop seminariali: il prossimo è previsto per il 20/21/22 settembre 2019, e un terzo appuntamento sarà programmato l’inverno prossimo. Ogni appuntamento di VOCI POSSIBILI è un momento di approfondimento e di studio nuovo ed indipendente, e non è necessario aver frequentato i workshop precedenti. VOCI POSSIBILI vuole essere un momento di studio e di riflessione, di indagine e approfondimento sulla vocalità contemporanea in maniera aperta, sensibile a contributi molteplici, focalizzati su temi che vengono individuati e proposti di volta in volta. Come in un arazzo ogni Voce è un filo che racconta una storia, porta in sé mondi e ne evoca altri. Andremo ad indagare queste vocalità molteplici, nel solco di quelle che si definiscono “extended vocal techniques”.
In questo secondo appuntamento si tornerà a lavorare su brani di John Cage, Kurt Weill, Luciano Berio, Sylvano Bussotti, e su altri che verranno indicati in progress. Si indagheranno partiture che richiamano molte voci, da mondi e fonetiche differenti e richiedono approcci vocali e territori espressivi diversi. Le insegnanti lavoreranno empiricamente nello spazio attraversando fisicamente frammenti di improvvisazione. Dall’analisi della partitura il vocalista giungerà a intercettare innanzitutto una propria aderenza quasi drammaturgica alla partitura, fino alle voci necessarie alla esecuzione. Una ricerca che soggiace allo strumento vocale.
Gli incontri si svolgeranno presso lo Studio B di Tempo Reale, via Pisana 77, Firenze. 20 settembre pomeriggio: ore 14-19 21 settembre mattina: ore 11-13 pomeriggio: ore 14-19 22 settembre mattina: ore 11-14
Costo: 140€
Per iscriversi è necessario inviare entro il 10 SETTEMBRE il modulo di iscrizione opportunamente compilato all’indirizzo: [email protected] accedere al Corso non c’è selezione. Tuttavia è gradito un breve cv. I posti sono limitati a un numero massimo di 20 partecipanti e a un numero minimo di 7. Il workshop non prevede la partecipazione di uditori. L’iscrizione si intende confermata solo se perfezionata dalla compilazione del modulo di partecipazione e dal pagamento anticipato della quota di iscrizione. Ove non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti il Corso non avrà luogo e la quota di iscrizione verrà rimborsata integralmente.
+ info : www.temporeale.it
[programma] [modulo iscrizione]
– Note biografiche:
NicoNote e Monica Benvenuti sono due vocaliste, colleghe nel campo dello spettacolo vivente.
Entrambe si occupano di ricerca del suono e della voce da molti anni con percorsi artistici originali e peculiari. Si sono incontrate dieci anni fa al Teatro dell’Elfo a Milano ospiti del festival “Cantami, o Diva”, originale rassegna sulla vocalità contemporanea.
Monica Benvenuti cantante fiorentina, laureata in lettere e filosofia, nei primi anni della sua carriera si è dedicata prevalentemente al repertorio barocco e classico; in seguito ha sviluppato un interesse specifico per la musica del Novecento e contemporanea, che l’ha portata a esplorare le potenzialità della voce umana in rapporto ai diversi linguaggi, dalla recitazione al canto lirico, attraverso molteplici livelli espressivi.Ha tenuto concerti in Germania, Francia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Svezia, Giappone (Tokio, Suntory Hall), Brasile, Stati Uniti, spesso interpretando musiche a lei dedicate. Nel 2004 e’ invitata da Sylvano Bussotti come protagonista de La Passion selon Sade presso il Teatro de la Zarzuela di Madrid, con la direzione di Arturo Tamayo. Sempre di Bussotti interpreta ancora: nel 2007 l’ opera Silvano-Sylvano, presso l’Accademia di S. Cecilia, in un ruolo scritto per Lei, nel 2008 la prima esecuzione assoluta delle musiche per Rara Film, nel 2013 Furioso di Amneris, Ulrica, Eboli, Azucena e delle streghe, per voce e orchestra, nella Stagione dei Pomeriggi Musicali di Milano, replicato a Lugano nel 2016. Ha cantato all’Opera di Roma nel balletto con la regia di Beppe Menegatti, Georg Trakl e la sorella Grete, rivelazione e declino, come cantante e attrice, a fianco di Roberto Herlitzka. Nel 2007 è protagonista della prima assoluta di Beards del drammaturgo belga Stefan Oertli, eseguita, tra l’altro, al Theatre de la Place di Liegi e al Bozar di Bruxelles.Dopo varie esperienze di teatro musicale, debutta come attrice nel monologo “Non io” di Samuel Beckett, con la regia di Giancarlo Cauteruccio (premio dei critici italiani 2006). Negli ultimi anni ha interpretato Acustica, Pas de Cinq e Der Turm zu Babel di Mauricio Kagel, Como una ola de fuerza y luz di Luigi Nono, diverse edizioni del Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg, nonché moltissime opere vocali di John Cage e Le Marteau sans maître di Pierre Boulez. Ha inciso per Arts, Materiali Sonori, Nuova Era, Sam Classical, ARC Edition, Ema Records, Sheva Collection.(www.monicabenvenuti.com)
NicoNote progetto artistico e alias creato nel 1996 da Nicoletta Magalotti, italiana-austriaca con base nella felliniana Rimini, cantante, performer, compositrice. Artista trasversale, non definibile nella sua unicità produce una cifra personalissima nelle sonorità e nei formati. La sua formazione passa attraverso maestri come Yoshi Oida, Akademia Ruchu, Roy Hart Theatre, Gabriella Bartolomei. Agisce in territori molteplici legati alla musica, al teatro, alle installazioni, al clubbing. Ha all’attivo tour musicali e teatrali in Italia e in tutta Europa, Canada, Argentina, Brasile. A metà degli anni 80 è stata la voce della band Violet Eves, protagonista della new wave italiana con l’etichetta indipendente IRA records di Firenze, insieme a Litfiba, Diaframma, Moda, Underground Life. Negli anni 90 insieme al dj David Love Calò cura un privèe/installazione (all’interno della roboante disco Cocoricò) il Morphine, luogo di radicali sperimentazioni musicali e performative.Nel suo peculiare percorso trasversale è stata diretta più volte da registi quali Romeo Castellucci / Socìetas Raffaello Sanzio, Francesco Micheli, Patricia Allio, Maurizio Fiume, Fabrizio Arcuri e altri, ha collaborato con musicisti di estrazione molto diverse da Patrizio Fariselli degli Area a Mauro Pagani, dai producer house Mas Collective a Teresa De Sio, da Dj Rocca a Piero Pelù e Andrea Chimenti a Ghigo Renzulli, da Roberto Bartoli (Tommaso Lama, Steve Grossman) a Stefano Pilia da Bart Sailer (Wang Inc) a Luca Bergia (Marlene Kuntz) e Davide Arneodo (Perdurabo, Marlene Kuntz), da Enrico Gabrielli a Elisabeth Harnik (Joëlle Léandre) e altri. Una discreta discografia attraversa il suo percorso dal 1985 ad oggi, con varie sigle Violet Eves, Nicoletta Magalotti, AND, Dippy Site, Slick Station e svariati Featurings. A firma NicoNote gli album Alphabe Dream (Cinedelic 2013) poi Emotional Cabaret (Doc Live 2017), l’album “segreto” interamente dedicato a riletture dei Violet Eves, dal titolo Deja V. (Mat Factory 2018). Recentemente ha debuttato a WeReading Festival Itinerante con una lettura sonora dedicata ad Amelia Rosselli. In uscita CHAOS VARIATION V a firma NicoNote & Obsolete Capitalism Sound System (Rizosfera/ RoughTrade 2019) un progetto tra elettronica e filosofia con dediche ad Artaud, Bussotti, Deleuze-Guattari.(www.niconote.net
+INFO:
https://temporeale.it/formazione/voci-possibili-laboratorio-sulla-vocalita-contemporanea-ii/?fbclid=IwAR1F8ySWGI7KICxqMlsjQLneEmzX55nFJvmgsmEbq9DliSNj_j9cjGjvsns
4 notes
·
View notes
Photo

Nuovo post su https://is.gd/Pov43B
Caro alle Muse: Luigi Marti da Ruffano a Pallanza
di Paolo Vincenti
Il poeta salentino Luigi Marti nasce nel 1855 a Ruffano da Pietro ed Elena Manno. La sua era una famiglia della media borghesia delle professioni ma tuttavia indigente a causa dell’alto numero dei suoi componenti. Dovevano infatti pesare non poco sul magro bilancio famigliare quindici figli, come apprendiamo da alcune memorie inedite di Pietro Marti(1863-1933)[1], l’ultimo e il più noto dei suoi fratelli. Pietro infatti fu storico e giornalista, fondò e diresse molte riviste letterarie, ad alcune delle quali collaborò lo stesso Luigi. Esperto di arte e di archeologia, fu Direttore della Biblioteca Provinciale “Bernardini”di Lecce e nonno del famoso poeta Vittorio Bodini[2].
Altri fratelli furono: Donato, il primogenito, Giuseppe, Francesco Antonio, nato nel 1856, Maria Domenica Addolorata, nel 1858, Caterina, Raffaele, nato nel 1859, Pietro Efrem (che morì dopo 3 mesi) nel 1861. La loro fu una famiglia di letterati, a partire da Giuseppe, per il quale Pietro Marti, nelle sue memorie, ha parole di grande lusinga ed ammirazione, sebbene le condizioni di estrema povertà impedirono anche a lui di spiccare il volo verso la gloria artistica. Alfredo Calabrese, Le memorie di Pietro Marti cit., p.33.
Luigi trascorre gli anni della fanciullezza a Ruffano proprio sotto la guida del fratello maggiore Giuseppe, che però scompare prematuramente. A lui il poeta era molto legato, tanto da dedicargli la sua opera Un eco dal Villaggio. Dopo lo smembramento della famiglia (Pietro e Raffaele, per esempio, vennero condotti a Lecce in un orfanotrofio), Luigi, insieme ad Antonio e altri fratelli, si trasferisce a Maglie per gli studi ginnasiali presso il Liceo Capece e poi a Lecce presso il Liceo Palmieri, nel cui Convitto entra con la qualifica di “Prefetto di Camerata”[3], dove consegue il titolo di Dottore in Lettere. Oltre all’amore per la storia e lo scavo erudito, ha una notevole inclinazione per le arti visive, in particolare per il disegno, che però non estrinseca se non in bozzetti che restano manoscritti e nelle illustrazioni di alcune sue opere, arabescate da ornati e volute e piccoli quadrettini. L’amore per il disegno però si riflette nelle sue composizioni poetiche e nei romanzi, in cui si avverte una potenza espressiva che ha la stessa forza del colore sulle tavole pittoriche, specie nelle descrizioni paesaggistiche e degli spettacoli della natura, come dalla critica del tempo gli viene unanimemente riconosciuto. I suoi principali referenti letterari sono il Foscolo e il Carducci.
Maestro elementare a Lecce, con i fratelli Pietro e Raffaele fonda nel capoluogo nel 1884 una scuola privata, che era uno dei due ginnasi privati leccesi insieme a quello del Collegio Argento[4].
Nel 1880 pubblica una delle sue opere più apprezzate e conosciute: Un eco dal villaggio[5]. Quest’opera viene positivamente recensita dallo Stampacchia, da Nicola Bortone, ecc. “In quei versi freme l’animo e l’ingegno di un giovane, che sente profondamente gli affanni del proletariato, e li rende in una forma, alcune volte, rude, ma sempre efficace e solenne”, scrive La Direzione (probabilmente il fratello Pietro Marti) nelle note biografiche del libro Il Salento[6]. L’opera è dedicata “alla memoria di mio fratello Giuseppe morto giovanissimo vissuto a bastanza per conoscere e patire”. Raccoglie poesie di alto impegno civile, in cui l’autore affronta temi come le raccomandazioni, i debiti contratti con gli usurai (“L’obligazione”), la prostituzione minorile, le sperequazioni della giustizia che si dimostra debole con i forti e forte con i deboli (“Ladro di campagna”), il riposo del contadino (“Il villano”). Nell’Introduzione, “A chi legge”, scritta dallo stesso autore, Marti fornisce dei cenni esegetici della propria poesia, alla quale è dedicata la liminare lirica della raccolta (“Alla Poesia”).
Egli è anche un apprezzato giornalista ed assidua è la sua collaborazione ai giornali diretti dal fratello Pietro Marti; in particolare la sua firma compare spesso su “La Voce del Salento”, insieme a quella dell’altro fratello, Raffaele, storico e scienziato, col quale condivide gli interessi eruditi[7]. La musa della poesia invece lo accomuna al fratello Antonio, autore di pregevoli opere liriche[8]. Nel1889, pubblica La Verde Apulia[9]. Nella raccolta, che si compagina di dodici sonetti, insieme ai versi, sono presenti molte note archeologiche, geografiche e storiche, sui luoghi che via via i componimenti toccano, e inoltre disegni illustrativi di mano dello stesso autore, sicché questo libro può essere considerato una summa del talento e delle conoscenze del Nostro. Canta di Leuca e del suo Faro, di Otranto, “Niobe delle città marittime”, di Maglie, dove erano sepolti un fratello ed il padre, di Lecce, “l’Atene delle Puglie”, di Brindisi, con le sue vestigia romane e il suo porto a testa di cervo, di Taranto, di Gallipoli, “molle Sirena’ del mar Jonio”, dei grandi personaggi che hanno illustrato il Salento, come il Galateo, Liborio Romano, Giuseppe Pisanelli. Sono versi che dai critici vengono accostati al Byron e al Foscolo per la loro vigoria ed icasticità.
Nel 1889 pubblica un’altra raccolta poetica, intitolata Liriche[10]. Nella prima pagina è riportato il titolo della Prima sezione, ovvero Odi (Strofe libere), con alcuni versi in epigrafe tratti dalle “Egloghe”(IV) di Virgilio: paulo maiora canamus. Si tratta di componimenti di carattere civile, dall’intonazione sostenuta, che si rivolgono ai principali protagonisti della scena pubblica italiana dell’epoca, a cominciare da Umberto I di Savoia, cui è dedicata l’esordiale lirica, occasionata dall’epidemia di colera che si verificò nel 1884, passando per Victor Hugò (“Nel giorno della sua morte”), Garibaldi (in “Monumento a Caprera. Visione”), e Giosuè Carducci, cui è dedicata “Per i caduti in Africa”. Seguono liriche di argomento salentino, dedicate a Castro, ai Martiri di Otranto, et alia. Si apre poi la seconda sezione, Sonetti, fra i cui versi compaiono ancora personaggi di spicco dell’Italia postrisorgimentale, Garibaldi, Giuseppe Libertini, Giovanni Prati, ma anche personaggi ai quali l’autore si sente evidentemente consentaneo, come Giulio Cesare Vanini, che omaggia con due poesie, Antonio De Ferrariis Galateo, Liborio Romano e Giuseppe Pisanelli.
Accanto alle opere poetiche, produce opere di erudizione varia e disparati argomenti, come Ricordi delle conferenze del R. Provveditore agli Studi Francesco Bruni sulla Ginnastica Educativa, stampata a Lanciano, presso Rocco Carraba, nel 1881, in cui riprende le conferenze tenute dal Provveditore agli Studi della Provincia di Lecce Bruni, che in apertura di libro gli scrive una lettera gratulatoria. Fra le altre opere: Umberto I di Savoia, che è una lunga lirica al Sovrano (nella copia conservata presso la Biblioteca Provinciale di Lecce, sulla prima pagina è scritta una dedica, di mano dell’autore: “Al chiarissimo Dottore Gaetano Tanzarella per stima ed affetto”)[11]; e poi ancora A Vittor Hugò[12], L’Africa a Giosuè Carducci[13], Manfredi nella Storia e nella Commedia dell’Alighieri,[14]Umberto I e la Verde Apulia[15], Manfredi nella Divina Commedia: Conferenza[16], Bonaparte e la Francia: nella mente e nelle opere di Ugo Foscolo[17]. Per motivi di insegnamento da Lecce si trasferisce a Pallanza, in provincia di Novara, dove si sposa e comunque non interrompe la sua attività letteraria.
Nel 1891 esce Un secolo di patriottismo[18]. Nel 1896 è la volta di Il Salento. Poemetto lirico[19]. Questa sua fatica letteraria è pubblicata nella collana “Il Salotto Biblioteca tascabile”, edita da Salvatore Mazzolino e diretta da Pietro Marti, il quale in Appendice scrive delle Annotazioni in cui commenta i vari sonetti con approfondimenti storici e cenni di critica letteraria. Si tratta di un excursus storico sull’antico Salento, scritto in versi: l’autore tocca le città di Lecce, Brindisi, Taranto, Otranto, evocando le antiche vestigia e la gloriosa storia di queste città, e non mancano riferimenti a personaggi illustri del passato quali Vanini, Liborio Romano e Galateo.
Nel 1902 pubblica il poema Dalle valli alle vette Cantiche[20]. La copia conservata presso la Biblioteca Provinciale di Lecce, reca sull’antiporta una dedica autografa dell’autore a Cosimo De Giorgi, mentre la dedica a stampa recita: “A te che mi aleggi d’ intorno”. In epigrafe, subito dopo la dedica, è scritto: “Ho cercato alla profonda quiete delle valli, alla pura sublimità de le vette, il vigore necessario a spogliarmi delle vecchie consuetudini ed aprir l’anima a la nuova fede. Nelle Cantiche che pubblico, si riflette, con le impressioni della natura e della vita, il divenire della mia coscienza”. E la raccolta infatti si apre con “La mia arte”, quasi manifesto programmatico della poetica dell’autore. Il poema è diviso in sezioni: Valle Ossola, Valle Anzasca, Pestarena, Macugnaga, Ascensione, Tra i ghiacci, Valle del Mastellone, Riti e costumi, Valle Canobina, Emigrazioni, Valle Diveria, Ancora in alto, Inno alla natura, per un totale di 68 liriche.
Altre opere creative sono: Conflitto d’anime (Romanzo) e Verso Roma (Nuove cantiche), sulle quali non abbiamo ottenuto ancora riscontri. Inoltre scrive Orazioni, Discorsi, articoli, pubblicati in riviste e volumi miscellanei.
Da Pallanza, per motivi di lavoro, si trasferisce a Salerno, dove muore prematuramente all’età di 56 anni[21]. Questo, appena tracciato, è solo un primo parziale profilo bio-bibliografico del poeta di origine ruffanese, in attesa di ulteriori doverosi approfondimenti.
Note
[1] Alfredo Calabrese, Le memorie di Pietro Marti, in “Lu lampiune” n.1 Lecce, Grifo, 1992, pp.27-34.
[2] Sulla figura dell’erudito Pietro Marti (1863-1933) esiste una cospicua bibliografia. Tra gli altri: Carlo Villani, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, Trani, Vallecchi, 1904, p.578 (nuova edizione Napoli, Morano, 1920, pp-137-138); Domenico Giusto, Dizionario bio-bibliografico degli scrittori pugliesi (dalla Rivoluzione Francese alla rivoluzione fascista), Bari, Società Editrice Tipografica, 1929, pp.187-188; Aldo de Bernart, Nel I centenario della nascita di Pietro Marti, in “La Zagaglia”, Lecce, n. 21, 1964, pp.63-64; Pasquale Sorrenti, Repertorio bibliografico degli scrittori pugliesi contemporanei, Bari, Savarese, 1976, pp.375-376; Ermanno Inguscio, La civica amministrazione di Ruffano (1861-1999). Profilo storico, Galatina, Congedo, 1999, pp.174-175; Paolo Vincenti, Pietro Marti da Ruffano, in “NuovAlba”, dicembre 2005, Parabita, 2005, pp-17-18; Aldo de Bernart, In margine alla figura di Pietro Marti, in “NuovAlba”, aprile 2006, Parabita, 2006, p.15; Ermanno Inguscio, Vanini nel pensiero di Pietro Marti, in “Note di Storia e Cultura Salentina”, Società Storia Patria Puglia, sezione di Maglie, n. XX, Lecce, Argo, 2009, pp.137-148;Idem, Pietro Marti direttore di giornali, in “Terra di Leuca. Rivista bimensile d’informazione, storia, cultura e politica”, Tricase, Iride Edizioni, a. VII, n. 39, 2010, p. 6; Idem, L’attività giornalistica di Pietro Marti, in “Note di Storia e Cultura Salentina”, Società Storia Patria Puglia, sezione di Maglie, n. XXI, Lecce, Argo, 2010-2011, pp.227-234;Idem, Il giornalista Pietro Marti, in “Terra di Leuca. Rivista bimensile d’informazione, storia, cultura e politica”, Tricase, Iride Edizioni, a.VIII, n.40, 2011, p.7;Idem, Liborio Romano e le ragioni del Sud nel periodo postunitario. Il contributo di Pietro Marti sul patriota salentino, in “Risorgimento e Mezzogiorno. Rassegna di studi storici”, n.43-44, dicembre 2011, Bari, Levante, pp.147-161; Idem, Pietro Marti e la cultura salentina. Apologia di Liborio Romano, in “Note di Storia e Cultura Salentina”, Società Storia Patria Puglia, sezione di Maglie, n. XXII, Lecce, Grifo,2012, pp.164-185; Aldo de Bernart, Cenni sulla figura di Pietro Marti da Ruffano, Memorabilia 35, Ruffano, Tip. Inguscio e De Vitis,2012; Ermanno Inguscio, Pietro Marti, il giornalista, il conferenziere, il polemista, in “Note di Storia e Cultura Salentina”, Società Storia Patria Puglia, sezione di Maglie, n. XXIII, Lecce, Argo, 2013, pp.40-58; Idem, Pietro Marti (1863-1933) Cultura e giornalismo in Terra d’Otranto, a cura di Marcello Gaballo, Fondazione Terra D’Otranto, Nardò, Tip. Biesse, 2013.
[3] Aldo de Bernart, Il Salento nella poesia di Luigi Marti, in “Nuovi Orientamenti”, Gallipoli, marzo-aprile 1984, n.85, p.25.
[4]Ermanno Inguscio, Pietro Marti (1863-1933) Cultura e giornalismo in Terra d’Otranto, a cura di Marcello Gaballo, Fondazione Terra D’Otranto, Nardò, Tip. Biesse, 2013, p.34.
[5] Luigi Marti, Un eco dal villaggio, Lecce, Tip. Scipione Ammirato, 1880.
[6] Luigi Marti, Il Salento. Poemetto lirico, Taranto, Mazzolino, 1896, p. 4.
[7] Raffaele Marti (1859-1945) fu autore di moltissime opere, quali: Foglie sparse, Taranto, Tip. Spagnolo, 1907; Gli acari o piaghe sociali. Dramma in quattro atti e cinque quadri, Lecce, Tip. Conte, 1913; Le coste del Salento Viaggio illustrativo, Lecce, Tip. Vincenzo Conte, 1924; Lecce e suoi dintorni. Borgo Piave, S. Cataldo, Acaia, Merine, S. Donato, S. Cesario ecc., Lecce Tip. Gius. Guido, 1925. L’estremo Salento, Lecce, Stabil. Tipografico F.Scorrano e co., 1931. Su Raffaele si rinvia a Paolo Vincenti, Un letterato salentino da riscoprire: Raffaele Marti in “Il Nostro Giornale”, Supersano, giugno 2019, pp.41-43.
[8] Fra le opere di Antonio Marti (1856-1935): Povere foglie, Lecce Tip. Editrice Sociale- Carlino, Marti e Cibaria, 1891, e Scritti vari –Novelle e Viaggi, Intra,Tipografia Bertolotti Paolo e Francesco,1893.
[9] Luigi Marti, La Verde Apulia Lecce, Stab. Scipione Ammirato, 1885.
[10] Idem, Liriche, Lecce Tip. Garibaldi, 1889.
[11] Idem, Umberto I di Savoia, Lecce, Editrice Salentina, 1884.
[12] Idem, A Vittor Hugò, Lecce, Editrice Salentina, 1885.
[13]Idem, L’Africa a Giosuè Carducci Lecce, Stab Tipografico Italiano, 1887.
[14] Idem, Manfredi nella Storia e nella Commedia dell’Alighieri Lecce, Tipografia Salentina, 1887.
[15] Idem, Umberto I e la Verde Apulia, Lecce, Editrice Salentina, 1889.
[16] Idem, Manfredi nella Divina Commedia: Conferenza, Lazzaretti, 1889.
[17] Idem, Bonaparte e la Francia: nella mente e nelle opere di Ugo Foscolo, Pallanza, Tipografia Verzellini,1892
[18] Idem, Un secolo di patriottismo, Pallanza, Tipografia Verzellini, 1891.
[19] Idem, Il Salento. Poemetto lirico, Taranto, Mazzolino, 1896.
[20] Idem, Dalle valli alle vette Cantiche, Milano, La Poligrafica, 1902.
[21] Aldo de Bernart, op.cit.,p. 26.
1 note
·
View note
Photo

Esiste un punto di vista differente sul fondamento ultimo delle conoscenze esoteriche, vale a dire quello dei direttisti, i sostenitori della trasmissione diretta. Per loro è esoterico tutto ciò che si manifesta attraverso un’esperienza spirituale, mistica. Il criterio discriminante, pratico-operativo e soggettivo allo stesso tempo, è l’esperienza del risveglio, l’enstasi. Se il vedista o il teosofo sono tradizionalisti, lo yogi e il sufi sono direttisti. E’ evidente che non c’è contrapposizione assoluta tra le due visioni che al contrario si completano vicendevolmente. Riguardo all’etimologia è curioso notare che nacque prima il termine “essoterico” (che possiamo considerare l’antonimo di esoterico) e il primo ad utilizzarlo fu Aristotele nel 348 A.C. (Politica, VII, 1, 1323 a 22) volendo indicare con esso le sue riflessioni giovanili platonizzanti (andate per lo più perdute) in contrapposizione alle opere più mature, che egli chiama “acroamatica” (infatti come abbiamo detto il vocabolo ‘esoterico’ non esiste ancora). E, cosa ancor più importante, nessuno dei due termini possiede in quella fase il significato ‘occulto’ che gli attribuiamo oggi, ma unicamente un senso cronologico. Luciano di Samosata nel 166 D.C. usa per la prima volta il termine ‘esoterico’ in una sua satira (Vendita di vite) per quanto alcuni ritengano che abbia potuto trarlo da dossografi anteriori come Dicearco o Adrasto. Finalmente con Clemente Alessandrino, nel 208, emerge il significato esoterico del termine ‘esoterico’ (Stromata, V, cap. 9). L’aggettivo descrive una dottrina che ricorre a vari procedimenti di occultamento e contiene un insegnamento segreto e rigeneratore. Piuttosto problematici risultano i tentativi di ripartire in gruppi le varie tipologie di esoterismo che si sono sviluppate nel corse dei secoli. Molto utile e schematica appare la classificazione degli esoterismi ‘morfologici’ proposta da P.Riffard (L’Esoterismo, Vol. I), che istituisce innanzitutto una distinzione in Arti e Scienze, idea onnipresente, le prime per lo più pratiche e le seconde teoriche: Arti ScienzeAlchimia Divinazione Astrologia Divinazione Lerurgia Magia Medicina occulta TalismanicaIniziatica Metafisica Scienza dei cicli Scienza delle lettere e dei nomi Scienza dei movimenti Scienza dei numeri Scienza dei prodigi Ciascuna di esse presenta al suo interno ulteriori rami: per es. nelle arti divinatorie ritroviamo le mantiche (divinazione mediata) e la veggenza (divinazione diretta); oppure nella scienza dei numeri si va dall’aritmosofia all’isopsefia. Naturalmente le varie discipline non vanno considerate in compartimenti stagni, in quanto le intersezioni sono evidenti ed inevitabili. Tra le discipline astrologiche per es. abbiamo la genetlialogia che si occupa della delineazione del carattere e della personalità di un individuo a partire dallo studio del suo Tema Natale. Tale studio determina spesso il riconoscimento di fattori destinici con evidenti ricadute biografiche, quindi l’astrologia genetliaca ha una componente ‘mantica’ (divinatoria). Il fatto si fa ancora più evidente allorquando si prenda in considerazione la previsione degli avvenimenti (per es. attraverso l’analisi dei transiti o delle direzioni). Fonte: l'antro della magia
5 notes
·
View notes
Link
8 MAR 2019 11:20“NICOLA ZINGARETTI HA LA TERZA MEDIA E SI VERGOGNA” - MARIONE ADINOLFI SGANCIA LA BOMBA SUL TITOLO DI STUDIO DEL NEOSEGRETARIO PD – IL SUO STAFF SMENTISCE: "SI ISCRISSE ANCHE ALLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA E SOSTENNE TRE ESAMI" - MA ADINOLFI CHE DA TURBO-CATTOLICONE HA DIVORZIATO, SI E' SPOSATO A LAS VEGAS ED E' UN GIOCATORE SEMI-PROFESSIONISTA DI POKER, HA IL CORAGGIO DI FARE LA MORALE AGLI ALTRI?
Stefano Zurlo per “il Giornale”
Non era il primo della classe. E non ha lasciato tracce memorabili della propria carriera scolastica. Anzi. All'istituto De Amicis, nel quartiere capitolino del Testaccio, il dirigente scolastico Massimo Quercia accoglie i segugi di Open con una battuta che trasuda sarcasmo: «Perché il fratello dell' attore ha pure studiato?» Sembra di stare in un film di Alberto Sordi o, se ci fosse una rima, in un sonetto del Belli.
E invece Nicola Zingaretti ha passato i canonici cinque anni proprio al De Amicis, istituto tecnico, per diventare perito odontotecnico. Un percorso anonimo, grigio ma cosi grigio da suscitare rigurgiti dietrologici, come sempre accade nel nostro claustrofobico Paese quando un personaggio guadagna la ribalta. E allora Mario Adinolfi, presidente del Popolo della famiglia, accende le polveri: «Nicola Zingaretti ha la terza media e se ne vergogna un po'. Infatti in tutte le notine biografiche ai giornali evita di citare il proprio titolo di studio».
Siamo in pieno giallo curriculare, un filone che in Italia ha una straordinaria tradizione: basta pensare ai master generosamente seminati qua e là dal premier Conte, al pasticcio combinato dall'ex ministro Valeria Fedeli che aveva cercato in tutti i modi di rivendere come laurea un più modesto diploma. E poi, naturalmente, scavando un po', si può risalire fino al thriller dai colori scuri ambientato alla Statale di Milano in anni lontani, quando Antonio Di Pietro scivolava silenzioso fra i banchi della facoltà di legge, tanto da alimentare un indimostrato, fantomatico complotto spionistico secondo cui la sua laurea fu confezionata dalle manine esperte di obliqui 007. E dunque Mani pulite fu telecomandata da un' occulta regia.
La storia del fratello di Montalbano, oggi presidente della Regione Lazio e fresco segretario del Pd, è più prevedibile.
Nicola, classe 1965, infanzia nella periferia profonda della Magliana, papà funzionario di banca, arriva fino ai gradini della Sapienza e li si arena.
Lui, che è già un tipo ecumenico e arrotondato, non vuole alimentare polemiche di retroguardia, ma il suo staff lascia filtrare una dichiarazione risolutiva, in attesa dei documenti che arriveranno nei prossimi giorni: «Si iscrisse alla facoltà di lettere e filosofia, numero di matricola 597468, e sostenne tre esami». Con un exploit in storia del risorgimento: 30. E un ottimo 28 in storia dei partiti politici, dove in seguito avrebbe detto la sua. Poi abbandonò i libri, risucchiato dal demone della politica.
Una vicenda ordinaria, senza doppifondi e retroscena, già portata a galla da Enrico Lucci nel corso del programma Nemo. «Me devi dì una cosa - aveva esordito Lucci nella puntata del 23 novembre 2018 - non ti chiederò. Tu... Stavamo insieme all'università, ma te sei laureato?».
Insomma, Lucci e Zingaretti erano compagni di corso e il conduttore televisivo confessa all'onnipresente Open di ricordare benissimo l' allora coordinatore della cellula comunista della Sapienza, Nicola Zingaretti. Da escludere che si tratti di un caso di omonimia. E infatti il successore di Renzi alla guida del Pd non si sottrae alla domanda: «Ahi, ahi, ahi, no. Questa è una delle colpe della mia vita». Un invito a nozze per l' irriverente microfono che subito banchetta su quella frase: «Me lo ricordo, studiava. Studiava tanto. Era tanto serio».
Sberleffi e pagelle. Nel giorno in cui la biografia del governatore e della sua famiglia restituisce un frammento drammatico: la bisnonna materna fu deportata ad Auschwitz. La madre, invece, si salvò fortunosamente. E le beghe scolastiche sono spazzate via dal vento della storia.
0 notes
Photo

Nuovo post su https://is.gd/tPkMjI
Gli Arcadi di Terra d'Otranto (8/x): Donato Maria Capece Zurlo di Copertino
di Armando Polito
Il suo nome pastorale era Alnote Driodio e, se nella scelta di Alnote non ho idea a chi o a cosa si sia ispirato, per Driodio posso solo ipotizzare che si tratti di un nome composto dal greco δρύς (leggi driùs) che significa quercia e ὅδιος (leggi òdios) che significa relativo alle strade, per cui l’allusione sarebbe alla predilezione per i percorsi boschivi, abitudine più che legittima per un pastore arcade che, come vedremo, nei suoi componimenti nomina spesso la quercia. In Arcadia era entrato il 9 giugno 17051.
Di lui mi sono già occupato in http://www.fondazioneterradotranto.it/2015/01/04/donato-maria-capece-zurlo-di-copertino-poeta-e-agente-del-fisco/, dove il lettore potrà trovare più dettagliate notizie biografiche. Qui si intende integrare quanto lì già detto con la riproduzione del testo, con il mio commento, di tutti i suoi componimenti sparsi in raccolte e che sono stato in grado di reperire.
Un primo, cospicuo gruppo, è in Componimenti in lode del nome di Filippo V monarca delle Spagne, recitati dagli Arcadi della colonia Sebezia il dì 2 di maggio 1706 nel Regal Palagio e pubblicati per ordine di Sua Eccellenza dal Dottor Biagio Majola De Avitabile, Vice-Custode della stessa colonia, Parrino, Napoli, 1706, pp. 40-46 e 59-62 (la numerazione romana è mia e continuerà anche per i componimenti di altre raccolte).
I
Che merta1, e avrà di tutto il Mondo impero
dividendo il dominio egli2 con Giove,
giust’è, Lileia3; e a me forz’è, ch’approve
de la tua saggia mente il bel pensiero.
Vanti pur chi che sia superbo, e altero,
o le passate glorie, o pur le nove;
fiso è nel Ciel, che il gran Nome rinove
del primo Augusto i giorni; altro io non chero4.
E presso ‘l fonte, ove tu bella meni
l’armento ,teco assiso a l’aura fresca,
o qual nobil corona intesser voglio;
se delle antiche idee i’ non mi spoglio,
tra quercie, olivo, mirto, e lauri ameni
farò, che ‘l Giglio d’oro5 il pregio accresca.
1 meriti
2 Filippo V
3 Alle pp. 397-405 di Rime scelte di poeti illustri de’ nostri tempi, Frediani, Lucca, 1709, vi sono alcuni sonetti di Biagio Maioli d’ (nome pastorale Agero Nonacride) , fra i qualia p. 403 quello in risposta ad uno di Teresa Francesca Lepoz (errore per Lopez; nome pastorale: Sebetina Lileia) per la tragedia Felindo.
4 chiedo; dal latino quaero.
5 Nello stemma di Filippo V compaiono gigli inquartati d’azzurro.
II
Farò, che ‘l Giglio d’oro6 il pregio accresca7
d’ambe l’Esperie8 a le famose genti;
e l’alloro real serto diventi
di gloria, e di valore, e seme, ed esca9;
e tanto del gran Nome il vanto cresca,
sin che foran10 del Sole i raggi spenti;
o che l’Arcade11 in fin del Ciel rallenti
l’asse12, che di rotar non già gl’incresca13.
E solcando lassuso ormai Boote14
le celesti campagne, anco rivolga
le bellicose, e le benigne stelle.
Da polo a polo separando quelle,
dal nostro ogni maligno influsso tolga,
e mandi pace chi n’è donno15, e pote.
6 Vedi la nota 5 di II.
7 In questo, come nei sonetti successivi fino al n. VII, viene ripreso il verso del precedente.
8 Ἐσπερία (leggi Esperìa), da ἐσπέρα (leggi espèra) che significa sera, occidente, in latino Espèria, era il nome con cui i Greci definivano l’Italia posta ad occidente della Grecia. Qui (siamo in piena guerra di successione tra Spagna e Francia) la voce ha il significato estensivo di Europa.
9 alimento
10 saranno
11 il pastore d’Arcadia
12 Insieme con il precedente sin che foran del Sole i raggi spenti è la figura retorica (consiste nel subordinare l’avverarsi di un fatto a un altro ritenuto impossibile) detta adynaton, che è dal greco ἀδύνατον (leggi adiùnaton), che significa cosa impossibile.
13 rincresca
14 Una delle costellazioni.
15 signore, padrone (in questo caso è Dio); dal latino dominu(m)>*domnu(m) per sincope>donno per assimilazione.
III
E mandi pace chi n’è donno, e pote
a l’Europa, che giace oppressa, e geme
sotto ‘l gravoso d’armi incarco, e freme
più fiero Marte, e regni abbatte, e scote;
e la porti volando a genti ignote
ne le lungi dal Mondo isole estreme,
o dove il Sol non giunge, o dove preme
le fiere il ghiaccio, e le contrade vote.
Che dove di Filippo il Nome impera,
e va col dì girando a paro a paro,
deve il Mondo goder tranquilla pace;
qual’è16 lungo il Sebeto17, ove si giace
l’armento a l’ombra, e ‘l Pastorello caro
presso a l’amata Safirena18 altera19.
16 Sic, ma a quel tempo era forma regolarmente in uso.
17 Antico fiume di Napoli. La sezione napoletana dell’Arcadia Romana (Sebezia) prese il nome da esso.
18 Safirena è il nome dell’autrice del componimento che chiude la raccolta; non credo, però, che sia il nome pastorale parziale di una poetessa dell’Arcadia e perché non è presente in nessun catalogo di questa accademia e perché in Rime scelte di poeti illustri de’ nostri tempi Rime scelte di poeti illustri de’ nostri tempi, op. cit., a p. 400 in un componimento di Biagio Maioli d’Avitabile si legge: Appressarsi vid’io dal lato monco/due Ninfe altere, Safirena, ed anco/Silvia, delle più belle, e più vezzose. Vedi anche la nota 20 di IV.
19 superba
IV
Presso a l’amata Safirena altera
cerca anco Agero20 pace, e intesse il serto
al gran Monarca Ibero21, ond’è, che ‘merto
maggior suo mostri, e la sua gloria intera.
Adorni il forte crin nuova maniera
di quercia, e alloro, che salito a l’erto
colle, ove per cammin dubbioso, e incerto
seco congiunse la gran donna fiera22.
Ond’è che ‘sacro olivo al capo augusto,
di perpetuo riposo i segni apporti,
e di feconda, e gloriosa prole23;
e così di trionfi e carco, e onusto,
dopo secoli molti a le sue sorti
cedendo no, ma vivo al ciel ne vole.
20 Dietro Agero si nasconde Biagio Maioli d’Avitabile , che pubblicò la raccolta, il cui nome pastorale, come s’è detto, era Agero (perché nativo di Agerola) Nonacride, fondatore della colonia Sebezia. Pubblicò Lettere apologetiche-teologico-morali scritte da un dottor napoletano a un letterato veneziano, Offray, Avignone, 1709. Un suo sonetto è in Rime e versi per le nozze degli Eccellentissimi Signori Giacomo Francesco Milano Franco d’Aragona, Principe di Ardore, ed Arrighetta Caracciolo de’ Principi di Santobuono, Ricciardo, Napoli, 1725, p. XXXIX.; un altro in Francesco Martello (a cura di) Laudi Mariane, Tipografia all’insegna dell’ancora, Napoli, p. 84. In rapporto a quanto detto nella precedente nota 18 si ha la conferma che Safirena sarebbe un nome di fantasia, non arcadico e, dunque non corrispondente ad una persona reale.
21 Filippo V di Spagna.
22 Maria Luisa di Savoia con cui Filippo V si era sposato nel 1701 in prime nozze.
23 Dalla coppia nacquero quattro figli (il primo, Luigi, il 25 agosto 1707 (la recita cui fa riferimento il titolo della raccolta era avvenuta il 2 maggio dell’anno precedente).
V
Cedendo no, ma vivo al ciel ne vole
dopo secoli molti il gran BORBONE,
e vincitor in fiera aspra tenzone,
scorra per quanto scopre, e gira il Sole.
Onde fia breve spazio l’ampia mole
per le sue glorie: e poche al paragone
del gran Nome saran l’alte corone
tutte, e quante pur darne il Mondo suole:
che maggior’è del gran FILIPPO il merto
emulator de l’Avo Re24, che Grande
poggiò sul colle faticoso, ed erto;
e giunse per sentier mai non impresso
col suo saper, con l’opre memorande,
ad altri, u’25 di salir non fu concesso.
24 Luigi XIV, di cui Filippo V era nipote.
25 dove
VI
Ad altri, u’ di salir non fu concesso,
fu Duce al gran NIPOTE26 il gran LUIGI27,
e segnando di lui gli alti vestigi28,
poggia su de la gloria un tempo istesso:
e con un marchio eternamente impresso,
a scorno del Danubio, e del Tamigi,
faranno i cuori tutti a’ lor piè ligi
per quanto mira il Sol lungi, e da presso.
Tornerà da per tutto il secol d’oro:
stillerà mele il bosco, e nutriranno
l’erbe fresche, a l’armento ora nocive.
Ed o qual de’ Pastor sarà il ristoro?
Qual sarà la mia bella? *29 e quai saranno
le Pastorelle ora ritrose, e schive? **
26 Filippo V
27 Luigi XIV
28 orme
29 Non riesco a comprendere la funzione di quest’asterisco e dei due successivi (che, fra l’altro, non compaiono nel verso iniziale del componimento successivo)
VII
Le Pastorelle ora ritrose, e schive
diverran tutte miti a’ lor Pastori,
e adorneranno co’ novelli fiori
le fronti sotto l’ombre a l’aure estive.
E pronta ogn’una al suon di dolci pive30
dirà l’istoria de’ passati amori;
spargendo a l’aria i suoi più cari ardori,
de’ fiumi innamorar farà le rive.
Benché tra duri affanni il forte Alnote31,
colpa d’empio destin, molto ha sofferto,
offre in tanto col cuor fido, e sincero,
bello vie più che mai quanto esser pote
d’olivo, quercia, lauro, e mirto il serto
tra gli aurei Gigli32 al gran Monarca Ibero33.
30 zampogne
31 Alnote Driodio era il nome pastorale dell’autore.
32 Vedi la nota 5 del componimento I.
33 Filippo V di Spagna.
VIII
Spirto gentil, che da celeste soglia
per sentiero di luce a noi scendesti,
cui sol di fregio, onde t’adorni, e vesti
non già d’incarco34 è la corporea spoglia.
Non t’incresca or, che lungo stame avvoglia35
per Te la Parca36, e l’abitar fra questi
confini, a l’ampio ingegno tuo molesti,
soffri anco a nostro pro37 con lieta voglia.
Ch’accio ti sia men grave, e no ‘l disdegne
diè il suo maschio fulgor Giove al tuo volto,
Marte alla man de la sua spada il pondo38:
così fornito di divine insegne
non Tu terrestre abitator, ma volto
fia39 per Te in nuovo Cielo il nostro Mondo.
34 peso
35 avvolga
36 In origine da sola, tutelava la nascita. Poi, sulla scorta delle Moire greche (Cloto, Lachesi ed Atropo, che, rispettivamente, filavano, misuravano e recidevano il filo della vita) divennero tre.
37 vantaggio
38 peso (latinismo, da pondus).
39 sarà
IX
Sebethe blandule, atque vos Sebethides
nymphae, et venusta collium cacumina,
quos alluit Thetis alma, Sirenum parens,
quis iste vos insuetus afflavit decor?
Ut nunc nitetis? Ut recens auctà acriùs
nunc dignitate, ac lumine ardetis novo?
Nempè ille vos invisit, à Gallia prius
Iberiam usque, et inde ab ipsa Iberià
ad nos reductus. Ipse vos, teneo probè,
collustrat, ipse nunc PHILIPPUS vos beat.
Utinam tuae illae, Urbs alma, Sirenes, quibus
alios morandi creditur canora vis
inesse, habenda si senum est dictis fides,
tam suave cantent, ille ut intellectum suae
iam postmodum incipiat pigere Hispaniae.
Neu forte probro id ille sibi verti putet,
ille, inquam, honori natus, atque gloriae
quem non voluptas frangat, illecebraque.
Hic namque virtus, atque deliciae simul
constant. Italiae proprium hoc nostrae est decus,
cui larga utrumque contulere sidera
mite solum, et acre ad inclyta ingenium. Haec domus
veraeque virtutis, voluptatumque; ut his
perfusa mens, non obruta, illi etiam vacet.
(Amato Sebeto e voi ninfe del Sebeto e vette leggiadre dei colli, che bagna la benigna Teti, genitrice delle Sirene, che cos’è questo inconsueto decoro che si è sparso su di voi? Come ora vi fate affidamento? Come da poco tempo ardete di una dignità ora alquanto fieramente accresciuta e di una nuova luce? Evidentemente vi ha visti lui riportato prima dalla Francia fino alla Spagna e poi a noi dalla stessa Spagna. Egli, ne sono giustamente convinto, vi onora, ora lo stesso Filippo vi rende felici. Alma città, voglia il cielo che quelle tue Sirene, nelle quali si crede, se bisogna dare fiducia alle parole degli antichi, che ci sia la forza canora di ammaliare gli altri, cantino tanto soavemente che egli subito dopo cominci a provare fastidio per il concetto di Spagna. E non per caso egli potrebbe pensare che ciò gli si rivolga a vergogna, egli, dico, nato per l’onore e la gloria, che non il piacere e le lusinghe potrebbero frantumare . Qui infatti ci sono nello stesso tempo la virtù e le gioie. Questo è l’onore proprio della nostra Italia, cui le stelle donarono l’una e l’altra cosa, il suolo mite e l’ingegno pronto a cose rinomate. Questa è la casa della vera virtù e dei piaceri, sicché la mente pervasa, non distrutta, da questi, ha tempo anche per quella)
X
Monarchia Hispana Galliam alloquitur
Misella Gallia, heus, quid hoc tibi accidit?
Quem tu edidisti, quemque virtutum omnium
lacte imbuisti, iamque suspiciens, tuà
maturiùs spe videras adolescere,
nobis repentè vindicavimus, tuum
in nos decus transtulimus. Ἅλλοι μὲν κάμον,
ὥναντο δ’ἅλλοι, dicimus proverbio.
En ille nunc adultus in sino tuo,
magnique confirmatus exemplis AVI,
germen PHILIPPUS inclytum à stirpe inclytà,
nostras decoraturus advenit plagas.
Sed si qua nostri te invidia pulsat, malam hanc
iam mitte curam. Quidquid est, aequi, ac boni
consulere praestat. An absque praemio hoc putas
abire tibi? Foedus meherclè inibimus,
quo nemo arctius, iam animos iuvat,
sociasque vires iungere. Ecquidnam additis
posthàc, amabò, impervium nobis erit?
Iam iam trucesque Mauri, et omnis Africae
nefanda pestis, Odrysiique, et quisquis est
quem nulla iuris sanctitas, nulla, aut fides,
Deùmve tangit religio, poenas luent,
timidaque nostro colla subiicient iugo.
Utinam quod auspicatus est olim Deus,
cum et mi PHILIPPUM, tibique LODOICUM dedit,
perficiat ipse, et iusta si vota haec probat,
concipere quae nos iussit, his ille annuat.
(La monarchia spagnola parla alla Francia
Misera Francia, che ti è successo? Colui a cui tu desti i natali40, che educasti col latte di tutte le virtù e già contemplante avevi visto troppo presto crescere con la tua speranza, lo abbiamo all’improvviso rivendicato a noi, abbiamo trasferito il tuo onore nel nostro. Alcuni si affaticano, altri ereditano41, diciamo con un proverbio. Ecco quegli ora adulto nel seno tuo e rafforzato dagli esempi dell’avo42, Filippo, germe famoso di stirpe famosa, è giunto alle nostre terre per portare onore. Ma, se qualche nostra invidia ti turba, manda via questa cattiva preoccupazione. Checché ci sia di equo e di buono conviene decidere. O ritieni opportuno per te star lontano da questo premio? Per Ercole, daremo inizio ad un patto con il quale nessuno ancora è capace di unire più strettamente gli animi e le forze alleate. Cosa mai, per favore, sarà impervio poi per noi dopo che ci saremo aggiunti? Ormai ormai i selvaggi Mauri ed ogni nefanda peste d’Africa e i Traci e chiunque c’è che non è toccato da alcuna santità del diritto o da nessuna fede o religione degli Dei, pagano le pene e sottomettono al nostro giogo i timidi colli. Voglia il cielo che ciò che un tempo Dio auspicò quando diede a me Filippo e a te Ludovico, lo mandi a compimento e se approva questi giusti desideri arrida a quelle cose che ci ordinò di pensare)
40 Filippo V era nato a Versailles.
41 Proverbio greco tramandatoci da Zenobio (grammatico del II secolo d. C.) tratto da raccolte più antiche perdute.
42 Luigi XIV
Un gruppo ancora più cospicuo è in Rime scelte di poeti illustri de’ nostri tempi, op. cit., pp. 238-251
XI
Altri di Mida43 l’or, di Creso44 i regni
abbia, e serva45 Fortuna alle sue voglie,
altri in campo guerriero auguste spoglie
tolga, d’immortal gloria eccelsi pegni.
Ad altro Mondo alcun drizzi i suoi legni47,
e per fregiar l’antico, il nuovo spoglie48,
di Socratiche carte altri s’invoglie49,
e ‘l vanto involi50 a’ più sublimi ingegni,
altri canti di Marte i pregi, e l’armi,
e del fiato migliore empia le trombe,
e strider faccia il luttuoso Sistro51.
Degni il mio plettro52 di più molli carmi
Amore, e lieta al gentil suon rimbombe53
di Focide54 la sponda, e del Caistro55.
43 Mitico re della Frigia, cui Dioniso aveva dato la capacità di trasformare in oro tutto quello che toccasse, compreso il cibo. Per non morire, chiese ed ottenne da Dioniso di perdere quel nefasto potere.
44 Re di Lidia famoso per la ricchezza.
44 sottoposta
47 Per metonimia: navi.
48 spogli
49 Può stare tanto per s’avvolga (parallelo all’avvoglia della nota 35; in tal caso vale per si lasci circondare dagli studi filosofici) oppure per s’invogli (si appassioni).
50 elevi
51 Strumento musicale dell’antico Egitto.
52 Per metonimia poesia.
53 rimbombi
54 Antica regione della Grecia; la sponda è quella del fiume Cefiso.
55 Fiume della Lidia.
XII
Le corna al Toro, ed al Lion i denti,
al Cavallo le zampe, il corso56 a’ Cervi,
a’ Pesci il nuoto diè Natura, e servi
fe57 del mobile Augello58 e l’aria, e venti,
che ale diegli a cangiar i luoghi algenti59,
e dove, o Sol, co’ dritti rai60 più fervi,
all’Uom non l’unghie dure, o forti nervi,
ma fe57 sproni d’onor caldi, e pungenti.
Alla Donna per lancia, e per iscudo
diè61 ‘l vago62 viso, che sì il Mondo apprezza.
Così son le sue sorti a ciascun fisse.
E ‘n saldo marmo sì rea legge scrisse:
il ferro, e ‘l foco, non che un petto ignudo,
vinca, chi armata sia d’alta bellezza.
56 la corsa
57 fece
58 uccello
59 freddi, latinismo da algentes.
60 raggi
61 diede
62 grazioso
XIII
Narri omai63 chi per prova intende Amore64,
qual’è65, come ci assale, e punge, e coce
quel suo dardo, che sì ratto, e veloce
entra per gli occhi, e si nasconde al core.
De’ sospir, dell’angoscie, e del dolore
dica, e del pianto, e d’amarezza atroce,
com’è ‘desio66, che qual 67 veneno68 nuoce,
se nell’Inferno sia pena maggiore.
Or’io bramo la vita, or di morire
son vago, or muto resto, ed ora sgrido
contro me stesso, e non incolpo altrui.
Scorrono tarde l’ore del martire,
e di godere un dì lieto diffido69,
perché, Donna, pietà non veggio70 in vui71.
63 ormai
64 chi per esperienza sa cos’è l’amore
65 Vedi la nota 16 di III.
66 desiderio; desio è forse dal latino *desedium, da desidia, (da desidere, che significa stare seduto, composto da de+sedere) che significa ozio, inoperosità, accostato per il significato a desiderium, che è da desiderare composto da de+siderare; questo secondo componente (che significa essere colpito da un malore o da una paralisi, cioè da un influsso maligno degli astri) è in comune con considerare ed è da sidus=astro. Nel latino medioevale, poi, anche assiderare (da ad+siderare), da cui la voce italiana. Riassumendo il rapporto semantico con sidus: in desiderare e considerare è prevalso il concetto di osservare gli astri per trarne auspici, in assiderare quello dell’influsso malefico.
67 come
68 veleno, dal latino venenum.
69 non spero
70 vedo
71 voi
XIV
Amor vidi volar nelle tue gote,
Madonna72, e nido far negli occhi tuoi;
né degna ti credei di star fra noi,
ma del più alto Ciel sull’auree rote73.
Un’immago di sé forse far pote74
l’alma75 natura, e l’ha ritratta poi,
bella in te, qual cristal de’ raggi suoi
imprime il Sol, qualora in lui percote.
Se a rimirar di te mi volgo il vago76
lume77, che con sua luce ogn’altro oscura,
non ha, credo Beltà forme più belle.
E se poi quel rigor, che avare stelle
posero ne’ tuoi sguardi, anche m’appago,
non ha, dico, Onestà legge più dura.
72 Composto da ma (riduzione di mia) e donna, che è dal latino domina(m), che significa signora, padrona, è l’appellativo generico della donna amata particolarmente caro al Petrarca.
73 Viene ripreso il concetto stilnovistico della donna angelo (in particolare e par che sia una cosa venuta 8da cielo in terra a miracol mostrare del famoso sonetto dantesco), con inversione del percorso cielo>terra).
74 può
75 che dà vita; dal latino àlere, che significa nutrire.
76 grazioso
77 sguardo
XV
Poiché in dura prigion di ferro grave
ebbe quel Grande 78 il suo nemico avvinto,
gittonne in mar la chiave, e certo il vinto,
già del suo mal nulla più teme, o pave79.
Tal mentr’io di catena aspra, e soave
sento legato il core, e di duol cinto,
perché non esca mai dal laberinto,
ad Amor, chi l’avea, ne diè la chiave;
ed ei gl’impose legge assai più dura,
di quante a’ suoi prigion’ 80 unqua81 prefisse,
sicché ogni amante per pietà ne pianse
e ‘l mezzo, e ‘l fin della mia vita oscura
nel saldo marmo d’una fronte scrisse
col suo dorato strale82, e poi lo franse.
78 Difficile l’identificazione con qualche personaggio famoso, per cui quel Grande potrebbe essere nenericamente riferito ad un detentore del potere.
79 prova spavento; latinismo (da pavere, che significa aver paura).
80 prigionieri
81 mai; latinismo da unquam.
82 freccia
XVI
Al Sig. Niccolò Amenta83
Quando lo spirto uman per gran tragitto
dall’alto suo principio84 in noi discese,
sue rare doti in numeri comprese
di celeste armonia, siccome è scritto.
Ma poiché alla ragione il suo diritto
sentiero il van desio85 rivolse, offese
tosto, e sconvolse il bell’ordine, e rese
delle potenze discordi il conflitto.
Ma sia fortuna, o sia pur’arte, o incanto,
o portata dal Ciel la nobil Cetra,
Amenta, solo è tuo, non d’altri il vanto,
il di cui suon quella pietate impetra86,
qual non sper’io da un duro cor, e intanto
coll’ordin primo ci solleva all’Etra87.
83 Niccolò Amenta (1659-1719), avvocato, autore di numerose commedie (La Gostanza, Il Forca, La Carlotta, Le gemelle, La Fiammetta, La Giustina, La fante, La Carlotta, La somiglianza), fu arcade col nome pastorale di Pisandro Antiniano. Due sonetti e un epigramma in distici elegiaci sono in Pompe funerali celebrate in Napoli per l’Eccellentissima Signora D. Caterina d’Aragona, Roselli, Napoli, 1697, pp. 197-199. Fu autore anche di Capitoli, s. n., Firenze, 1721; ricordo qui, a riprova degli stretti rapporti di alcuni personaggi tra loro, che alle pp. 126-129 c’è un componimento (in pratica una lettera in versi) da lui dedicato a Francesco Capece Zurlo (a quest’ultimo Donato Maria dedica il componimento n. XXXVII).
84 da Dio
85 Vedi la nota 16 di III.
86 implora
87 cielo; dal latino aethra(m), a sua volta dal greco αἴϑρα (leggi àithra), affine ad αἰϑήρ (leggi aithèr), da cui l’italiano etere, che significa aria.
Seguono cinque sonetti di tema amoroso:
XVII
Chiaro ruscello, ove la bianca mano
bagnò la bella fronte, ond’arso ho ‘l core,88
oh se temprar89 potessi in te l’ardore90,
per cui da morte vo91 poco lontano.
Ma rinfresco trovar io spero invano,
mentre al tuo dolce, e cristallino umore
arder sento nel cor foco maggiore,
che prima, e provo altro tormento strano.
Se dentro l’acque ancor foco ritrovo,
e ‘l foco l’aura accresce, onde respiro,
l’alma e qual mai più refrigerio attende?
Ma questo non è già miracol nuovo,
perché dovunque posa, e ovunque gira,
tutto Madonna92 del suo foco accende.
88 Riecheggia il celebre Chiare, fresche e dolci acque/ove le belle membra/pose colei che sola a me par donna/… (Petrarca, Canzoniere, 126).
89 mitigare
90 il fuoco d’amore
91 vado
92 Vedi la nota 72 di XIV.
XVIII
Con piacevole, vago, e bello aspetto,
dolci parole d’accortezza piene
son l’armi, con cui Amor contro me viene
spesso leggiadro, e fere93 in mezzo al petto.
Ond’ardo, e agghiaccio insieme, e giungo a stretto
varco di morte, e vivo pur mi tiene
la doglia94 no, ma, che va per le vene,
non so che di soave, e di diletto.95
Or timore m’assale, e spero, ed amo,
e ‘l corso all’alma del desio sospende96
Così della mia vita i giorni vanno.
Or piango, or taccio, e gridar’alto bramo97:
Donna, quei dardi, Amor, che da te prende,
questi, e mille altri effetti al cor mi fanno.
93 ferisce
94 dolore
95 da mettere in costruzione così: la doglia no, ma non so che di soave e di diletto che va per le vene.
96 e sospende per l’anima il corso del desiderio
97 Riecheggia l’or muto resto, ed ora sgrido di XIII.
XIX
Sappia, chi del mio stato ha maraviglia,
non son questi miracoli d’Amore,
che vivo io sembri (avendo entro arso il core)
nella fronte, nel volto, e nelle ciglia.
E chi perciò di amor si riconsiglia98,
sperando non perir tra tanto ardore,
vo99, che conosca, come suol di fuore
lo stato mio al vivo si assomiglia.
Che come suol dal Ciel fulmine ardente
cenere far cadendo ovunque tocchi,
qual pria ,lassando la sembianza esterna,
così riman la scorza, e quel lucente
raggio d’Amor, ch’esce di duo100 begli occhi,
e sol si strugge l’alma, ove s’interna.
98 riconvince
99 voglio
100 due; dal latino duo.
XX
Per vincer l’Onestà, che io tanto esalto,
ed aprir di sua rocca Amor l’entrata,
tre volte indarno101 della porta armata
percosse col suo strale102 il duro smalto.
Venne Pietà poi nel secondo assalto,
tutta del pianto mio molle, e bagnata;
ma perché le apra l’anima indurata,
non le val pianger forte, o gridar’alto.
Sicché lor vinti, io sol rimango assiso103
presso l’amato ostello104, e parto, e torno,
qual105 chi per via dubbiosa e tema, ed erri.
E invan nel mio pensier m’interno, e fiso106,
che, per entrare in sì dolce soggiorno,
è ancor chi batta, e non è chi disserri107.
101 invano
102 freccia
103 seduto, fermo
104 rifugio; è l’amata.
105 come
106 fisso, concludo
107 apra
XXI
O Rosignuol108, che tra quei verdi rami
spieghi i sospiri sì soavemente,
che l’acque fermi, e l’aure fai gir109 lente,
e a pianger teco il nostro mal ne chiami,
se110 l’aspra fiamma, ond’ardi, e quei legami,
onde forse sei preso, Amor rallente111,
né turbi il verno112con sua bruma113 algente114
quel lieto nido, ov’albergar più brami,
or che Madonna115 qui sospira, e geme
deh frena alquanto le amorose note,
e dal suo pianto altre dolcezze apprendi.
Sì vedrem poi per maraviglia insieme,
come meglio pietà destar si puote,
anche in rigido cor, de’ nostri incendi.
108 usignolo
109 andare, procedere
110 nel caso in cui
111 rallenti
112 inverno
113 nebbia
114 fredda
115 Vedi la nota 72 di XIV.
Il tre sonetti che seguono sono dedicati Al Signor Bartolomeo Ceva Grimaldi Duca di Telese.
Bartolomeo Ceva Grimaldi (1670-1707) fu arcade col nome pastorale di Clarisco Egireo; morì nel golfo del Leone per il naufragio di una nave inglese durante l’inseguimento di un vascello francese. Un suo componimento in esametri è in Pompe funerali celebrate in Napoli per l’Eccellentissima Signora D. Caterina d’Aragona, Roselli, Napoli, 1697, p. 259-261.
XXII
In questa selva, ove fuggì sbandita
ogni noia, ove solo albergo v’hanno
dolci Amor, dolci paci, e dolce fanno,
e più tranquilla nostra fragil vita,
teco gioir potessi, ed in romita116
parte teco sgombrar l’alma117 d’affanno,
e ristorarla dell’antico danno,
onde visse, e vivrà sempre pentita.
Di un lauro all’ombra, e non di quercia o d’elce
udirei poi, come al bel suon s’accorda
il canto tuo dell’Apollinea118 cetra.
La mia pianse al rigor di dura pietra:
ma al flebil suon trovandola più sorda
rotta a piè la gittai d’un’aspra selce119.
116 solitaria
117 anima
118 di Apollo; la cetra, insieme con l’arco e le frecce, è un suo attributo.
119 roccia
XXIII
Dura è la morte, e dopo lei mi pare
di mal gradito amore il colpo rio120;
pur non son, se tu volgi al viver mio
l’estreme noie, come amore, amare.
E chi tien fisi121 gli occhi, e può mirare
quel volto, onde in me il dardo, e ‘l colpo uscio,
e la candida man, che mi ferio122,
e le bellezze assai più che ‘l Sol chiare,
certo direbbe, è ben ragion, che morte
chiami ei sovente, e di costei si doglia,
che troppo a darle aita123 indugia, e tarda,
che di lei stando sulle avare porte,
non trova chi lo scacci, ed entro accoglia124;
tanto in tal pugna125 ogni difesa è tarda126.
120 crudele
121 fissi
122 ferì
123 aiuto
124 accolga
125 battaglia
126 lenta, tardiva
XXIV
Spesso col suo pungente acuto strale
mi sprona a gir127 sopra l’alpestre calle
Amor, che al basso oprar volger le spalle128
sforza129 chi vince, e vince ogn’un, che assale.
Non era la Beltà cosa mortale,
u’ il dardo raffinò, che mai non falle.130
Io vinto seguo; ei quasi da ima131 valle
mi scorse in suso132, e al pensier mio diè133 l’ale.
Ed ora stanco del cammin sì lungo
non torno indietro, anzi il tardar mi dole,
così caldo è lo spron, che ‘l fianco punge.
E quanto più par, che mi affretti, e vole134,
tanto dall’alta meta errando lunge
mi trovo sempre, e non so, se vi giungo.
127 andare
128 fuggire, arrendersi
129 costringe
130 ove il dardo, che mai non sbaglia, rese più fine; u’ è dal latino ubi; falle per falla.
131 profonda, nascosta
132 su; da susum, variante di sursum.
133 diede
134 voli
Ancora quattro sonetti sul tema dell’amore.
XXV
Ed ancor nuovo flutto al mar ti spigne135
o Nave senza vele, e senza sarte136?
Vacilla la ragione, e manca l’arte,
soffian per ogni lato aure maligne137.
Al Nocchiero il pallor ambe dipigne
le gote: rare stelle ha il Ciel consparte138,
onde il corso si guidi, e d’ogni parte
la procella139, e l’orror ne preme, e strigne140.
Tu sei sdruscita141, e ‘l mare entro ti bagna,
e l’ancora pur cede al cieco orgoglio,
che ti mena a perir fuor di speranza,
e più d’ogni soccorso ti scompagna142,
e ‘l porto, ove tu aspiri143, è un duro scoglio.
135 spinge
136 sartie
137 venti sfavorevoli
138 cosparse
139 tempesta
140 stringe
141 sdrucita, spaccata
142 separa, allontana
143 desideri giungere
XXVI
Or che più non mirate il vago144 viso,
occhi miei, il vago viso, il viso altero,
ove colui145, ch’ha del mio cor l’impero146,
piantò il suo trono, e vi si adora assiso,
frenate il pianto omai, poiché diviso
a parte a parte dentro il mio pensiero,
men bello il veggo no, ma più severo,
dolce nell’ira, or qual saria147 nel riso?
Ed or la rotta148 fe par, che rammenti149,
e150quel fatal per me funesto giorno,
quando già caddi in altri lacci151 avvinto.
Deh perché non finì152gli aspri lamenti,
che all’udir tai querele, a tanto scorno
poco mancò, che io non rimasi estinto.
144 grazioso
145 l’amore
146 dominio
147 sarebbe
148 rottura
149 ha fatto ugualmente che ricordi
150 anche
151 catene d’amore
152 pose fine a
XXVII153
Già mio dolce, ed amaro mio conforto,
occhi, che ‘l lungo e rio154 digiun pascete,
o fontane d’Amore, ove ascondete
quel rio152 veneno155, onde sarò alfin morto.
Che come suole Augello156 poco accorto
cader, cibo cercando, entro la rete,
mentre in voi bramo ore tranquille, e liete,
trovo lungo il penar, e ‘l piacer corto157.
Pur tal dolcezza in questo amaro io sento,
che da’ vostri bei rai158 nel cor mi piove,
che or godo del mio male, ed or mi pento.
Ma di quel, che altri scrisse, or mi rammento,
che, quando da principio il sommo Giove
creovvi, insieme unìo159 gioia, e tormento.
153 Vedi n. XXXIX
154 crudele
155 veleno; dal latino venenum
156 uccello
157 lungo il penar/il piacer corto: chiasmo
158 raggi; gli occhi.
159 unì
XXVIII
Spero dal tuo pennel nobil Pittore160
aver colei, che me fere161, e sovente
fugge, e seco ne porta audacemente
legata preda il tormentato core.
Via, mesci rose, e gigli, e dà colore
a fronte, a gote, a mento; ostro162 ridente
vivaci labbra esprima, e dolcemente
biancheggi il petto, ove risiede Amore.
Togli poi lo splendor di quella Stella
che gira163 il terzo Cielo, e poni a gli occhi
simile la pupilla, e questa, e quella.
D’oro il crin164, nero il ciglio, e in dubbio tocchi165
l’altro ferma ch’è dessa166. Ahi cruda, e bella
non fuggi, e più m’infiammi, e dardi scocchi.
160 Pittore immaginario al quale affida il compito di ritrarre la sua donna.
161 ferisce
162 porpora; ostro è dal latino ostrum, a sua volta dal greco greco ὄστρεον (leggi òstreon), che oltre al significato di ostrica, conchiglia aveva anche quello di porpora , perché essa veniva estratta da alcuni molluschi.
163 fa ruotare
164 biondi i capelli
165 in atteggiamento dubbioso tocchi
166 ferma com’è essa
Il sonetto che segue è dedicato Al Signor Giulio Cesare Cosma Nipote dell’Autore167
XXIX
Se quel desio168, con cui te stesso accendi
di far tuo nome eterno, e chiaro in rime,
e gir169 di Pindo170 sulle alpestri cime,
pel cui sentier già il passo affretti, e stendi,
durerà alquanto, finché etade171 ammendi172
alcun173 difetto con più sode lime174,
vedremti 175 col gran Tosco176 andar sublime
di par col volo, che pur’alto or prendi.
E allor le tigri in Pindo170 far177 pietose,
e romper potrai un sasso per dolore,
non che in Donna destar fiamme amorose.
Se impresso ivi vedrai ‘l mio dolce errore
su qualche tronco in rime aspre, e noiose,
bacia in mio nome l’esca178, ond’arso ho il core.
167 Difficile dire, oltretutto l’omonimia è sempre in agguato, se il dedicatario è colui che fu sindaco di Lecce negli anni 1681-1682.
168 Vedi la nota 66 di XIII.
169 andare
170 Monte della Grecia sacro ad Apollo ed alle Muse.
171 età; etade è latinismo da aetate(m).
Due sonetti del quale il primo sembra anticipare la concezione foscoliana di un’immortalità laica.
172 corregga
173 qualche
174 con un più solida revisione
175 ti vedremo
176 toscano; è il Petrarca.
177 fare, rendere.
178 la scintilla d’amore.
XXX
Quando dopo più secoli, se tanto
viver potrà del nome mio la gloria,
su nobil marmo leggerà l’istoria
alcuno del mio amor sì puro, e santo,
bagnerà forse di soave pianto
le gote, a sì dolente, e pia memoria.
E, o beato, dirà, per cui si gloria
Pindo179, e lieto risuona al tuo gran canto.
Forse e fia180 chi di dolce invidia tinto
dica, felice te, che in stil sì terso
vivi immortale di sì chiaro spirto181.
Della morte trionfi, e ‘l tempo hai vinto;
e intanto il sasso182 mio miri consperso183
di bianci184 fiori, e di soave mirto.
179 Vedi la nota 170 di XXIX
180 pure ci sarà
181 spirito; spirto è per sincope.
182 la tomba; metonimia.
183 cosparso
184 bianchi
XXXI185
Pietà, Signor, perdono al mio dolore,
onde tutt’ardo ,e al pregar mio dà loco186,
mira il mio pianto, odi i sospir, che infoco187
omai188 pentito del mio primo errore.
Di Musa giovanil mentito amore
(tu ben lo sai) fu sol trastullo, e gioco;
ma in vera fiamma presso un lento foco
poco mancò, che non ardesse il core.
Sulla tua Croce ecco il mio plettro189 appendo,
e intanto l’alma190 del suo pianto aspersa
si terge, e al vero Ben tutta si volta,
acciocché poi da quest’esilio uscendo,
dall’atro limo191, ove fu pria sommersa,
sen voli al suo Fattor192 libera, e sciolta.
185 Questo sonetto è presente anche in Tesoro cattolico. Scelta di opere antiche e moderne atte a sanar le piaghe religiose e politiche che affliggono l’odierna società, A spese della Società Editrice, Napoli, 1854, v. X, p. 91.
186 luogo
187 do alle fiamme
188 ormai
189 Per metonimia poesia.
190 anima
191 fango
192 creatore; Dio.
Il sonetto che segue è dedicato al Sig. Biagio Maioli de Avitabile in morte di Scipione Avitabile suo cugino. Biagio Maioli de Avitabile, come abbiamo visto, pubblicò a sue spese la raccolta in onore di Filippo V ed era arcade col nome pastorale di Agero Nonacride.
XXXII
Quando su lance193 d’oro i fati appese
di nostre vite la Giustizia eterna,
onde parte i momenti, e giù governa
quanto ad occhio mortal non è palese194,
Signor195 quei di Scipione a librar prese
sulla più alta region superna.
Con fisi occhi la Parca ivi s’interna196,
cui sol tanto mirar non si comprese197.
Di sua tenera età troppo era lieve198
il puro stame, onde accingeasi il fuso
di fil più lungo per far, che s’aggrave,
quando de’ suoi gran merti il pondo grave
si aggiunse, e piena di stupore in brieve
tremar vide la lance, e cader giuso.199
193 Piatti della bilancia; dal latino lance(m); non a caso bilancia è da un latino *bilancia(m), che è dal latino tardo bilance(m), composto da bis=due volte e lanx=piatto.
194 manifesto
195 Dio
196 Con occhi fissi qui la Parca s’introduce. Per Parca vedi la nota 36 di VIII.
197 per lei era incomprensibile guardare un sole così grande
198 leggero
199 il puro filo, per cui il fuso si accingeva a fare un filo più lungo per fare in modo che fosse più pesante, quando si aggiunse il notevole peso dei suoi (di Scipione) meriti e (la Parca) piena di stupore vide in breve oscillare un piatto e poi cadere giù
Questo sonetto è scritto in morte del proprio Padre.
XXXIII
O selve, o fonti, o fosco aer, che accendo
co’ miei sospiri, o Ninfe, a cui sol noto
fu ‘l cantar mio, troppo or me indarno200 scoto201
dal grave affanno, e me stesso riprendo202.
Oimè , Spirto gentil, che te seguendo203
manca al desio ‘l vigor, la lena al moto,
onde io già torno204, e più lasso205 il mio voto206
a te consacro, e la mia cetra appendo207.
Tu alla vita mortal me generasti,
e tu all’altra immortal208 miei dubbi passi
scorgevi, u’ men periglio il corso spezzi.208
Or tu sei gito innanti, e me lasciasti
timido, incerto infra dirupi, e sassi.
O vita infausta, e pur v’è chi t’apprezzi!
200 invano
201 scuoto
202 rimprovero
203 torno indietro
204 nel seguire te
205 stanco
206 la mia preghiera
207 e smetto di dedicarmi alla poesia
208 Tu mi generasti alla vita mortale e tu per l’altra immortale (quella del poeta)tenevi d’occhio i miei passi dubbiosi dove minor pericolo potesse spezzarne il corso
209 andato
Segue un Epitaffio per S. Giovanni di S. Facondo morto di veleno appostogli nel Sacro Calice.
XXXIV
Se chiedi, o Passeggier, di chi sia l’alma
spoglia, che miri in quest’urna compresa210,
è di Giovan, non che far morte offesa
ardì all’albergo di sì ben nata alma.211
Ma Dio chiamolla212, e disse: io questa palma
vo darti, andrem’insieme a questa impresa,
e partirem213 la preda infra noi presa;
mio sia lo spirto214,tua la mortal salma.
Stupì natura, e in breve coppa accolta
vide la vita in un giunta, e la morte,
e rise il Ciel del venturoso inganno.
La morte andò, ma la noia, l’affanno,
l’orror, l’angoscia, e ‘l resto di sua corte
dietro rimase in gran spavento involta215.
210 sepolta
211 è di Giovanni, perché morte osò fare offesa al corpo di un’anima così ben nata
212 la chiamò
213 divideremo
214 spirito; sincope.
215 avviluppata
Questo è per l’elezione del Sommo Pontefice Innocenzo XI216.
XXXV
Piangea la Chiesa, e in lutto vedovile
i dì traea con ansia, e con affanno,
e ‘l Lupo empio217, che veglia al comun danno,
cingea tutto d’insidie il Sacro Ovile.
Della maligna Luna anco218 il sottile
corno ingrossar tentava il fier Tiranno.
Dio scorgea il tutto, e dal superno scanno219
reggeva Ei sommo il nostro stato umile.
Sorga pur dunque l’Innocenza220, e Duce221
in mia vece ella al ver scorga222 le menti,
e ‘l Greco Imperio sia ligio al Latino223.
Sì disse e voci elle non fur224, ma accenti
di luce, e sì con note anco225 di luce
riverente a’ suoi piè scrisse il Destino.
216 Innocenzo XI fu papa dal 1676 al 1689.
217 il demonio
218 anche
219 dal regno dei cieli
220 Gioco di parola tra innocenzo e l’innocenza divinizzata (anche per questo con l’iniziale maiuscola).
221 guida
222 illumini, metta in condizione di scorgere
223 E la Chiesa orientale sia obbediente a quella occidentale
224 e quelle non furono parole
225 anche
Questo è dedicato a S. Orenzio primo. Protettore di Lecce.
XXXVI
O di grazia celeste ornata, e chiara
alma226, il cui forte, e impenetrabil zelo
spunta, e rintuzza alla vendetta il telo227
che l’offesa Giustizia a noi prepara,
già non invidio il Ciel, che a questa amara
prigion228 ti tolse: era tua patria il Cielo.
Ma quel, che a noi lasciasti, il tuo bel velo,
perché ne asconde229 ancor la terra avara?
O marmo230 ancora ignoto, ancor negletto231,
ma prezioso del ricco tesoro,
che sì il nostro desio sforza, ed accende,
deh se il riveli a noi, fregiar prometto
il nome tuo di quel verace alloro232,
cui 233 nembo234 unquanco235, né saetta offende.
226 anima
227 dardo; dal latino telu(m).
228 il corpo, la vita terrena
229 ci nasconde
230 sepoltura; metonimia
231 trascurato
232 vera gloria; alloro è metonimia.
233 che
234 nube minacciosa
235 mai
Quest’altro è dedicato al Sig. D. Francesco Capece Zurlo236
XXXVII
Ne’ suoi volumi eterni il gran Motore237
quando alle umane vite i fati scrisse,
agli Avi nostri alto valor prefisse,
o Francesco di lor Germe238 migliore.
Senno, e vole magnanimo d’onore
fur le sorti a ciascun segnate, e fisse;
e volle di tal’un nel cor si unisse
a quel di gloria caldo spron d’Amore.
Onde se per più secoli la bella
Partenope239 diè leggi240, e trionfante
rise, e di lauro241 ornò la sua corona,
lor fu sol vanto, e in te discese quella
Virtù242, che ora risplende in guise tante243.
E Amor per le sue vie me solo sprona.
236 Non mi è stato possibile definire il rapporto di parentela con Donato Maria, ma di Francesco Capece Zurlo un sonetto è in Pompe funerali celebrate in Napoli per l’Eccellentissima Signora D. Caterina d’Aragona, Roselli, Napoli, 1697, p. 153 e un altro in Componimenti recitati nell’Accademia a’ dì IV di Novembre, anno MDCXCVI ragunata nel Real Palagio in Napoli per la ricuperata salute di Carlo II, Parrino. Napoli, 1697, p. 101. Questo, poi, si legge in Giovanni Bernardino Tafuri, Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Mosca, Napoli, 1748, tomo II, p. 74: L’altra [accademia fondata a Napoli nel 1679] fu detta de’ ROZZI … fu per qualche tempo governata da D. Francesco Capece Zurlo Cavaliere stimatissimo per l’erudizione, e per la pratica delle cose del Mondo.
237 Dio
238 discendente
239 Napoli; era inevitabile che i “meridionali” lì facessero carriera.
240 fu la culla degli studi giuridici
241 gloria poetica, letteraria
242 Allusione alla sapienza giuridica di Francesco cui nel verso successivo Donato Maria contrappone la sua, che è poetica.
243 in tanti modi
Chiude la serie un sonetto Al Signor Cardinale Orsini Arcivescovo di Benevento244.
XXXVIII
Spiega, e spira, Signor, soavemente
oh qual vaghezza, oh qual gradito odore
santissima Virtù, quasi bel fiore
della tua ben purgata, e nobil mente.
Onde in rubella a Dio perfida gente245
maraviglia non sol, ma desta amore,
a cui l’alma ravviva246, e il grave errore
quella scote aveduta247, e omai 248 si pente.
Oh pur si avanzi sì, che lasci addietro
quella de’ tuoi grand’Avi, e pace apporte249
al Mondo, che dall’armi oppresso geme,
da cui Regnante sopra il Tron di Pietro
di riportarne avessi anch’io la sorte
al mio torto giustizia, e grazia insieme.
244 Vincenzo Maria Orsini (1649-1730), fu creato cardinale nel 1672, papa nel 1724 col nome di Benedetto XIII.
245 per cui in perfida gente ribelle a Dio
246 l’anima torna in vita
247 ravveduta
248 ormai
249 apporti
Per ultimo, a riprova della considerazione in cui era tenuto il nostro, un suo sonetto è in una pubblicazione francese: Raccolta di rime italiane, tomo II, Prault, Parigi, 1744, p. 77.
XXXIX
Esca mia dolce, ed amaro conforto,
occhi, che ‘l lungo e rio digiun pascete,
o fontane d’Amore, ove ascondete
quel rio veneno, onde sarò alfin morto.
Che come suole Augello poco accorto
cader, cibo cercando, entro la rete,
mentre in voi bramo ore tranquille, e liete,
trovo lungo il penar, e ‘l piacer corto,
Pur tal dolcezza in questo amaro io sento,
che da’ vostri bei rai nel cor mi piove,
che or godo del mio male, ed or mi pento.
Ma di quel, che altri scrisse, or mi rammento,
che, quando da principio il sommo Giove
creovvi, insieme unì gioia, e tormento.
È il n. XXVII con queste differenze; al primo verso Già mio dolce, ed amaro mio conforto e nell’ultimo unìo. Il testo del XXXIX, è quello già presente in Comentari del Canonico Giovanni Mario Crescimbeni custode d’Arcadia intorno alla sua istoria della volgar poesia, volume II, parte II, Basegio, Venezia, 1730, p. 263; esso dovrebbe essere quello definitivo soprattutto per l’immagine iniziale dell’esca mediata, come altre, dal Petrarca (Canzoniere, 37, 55, 90, 122, 165, 175. 181, 270 e 271).
(CONTINUA)
______
1 Giovanni Mario Crescimbeni, L’Arcadia, Antonio de’ Rossi, Roma, 1711, p. 365.
Per la prima parte (premessa)
http://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/08/gli-arcadi-di-terra-dotranto-premessa-1-x/
Per la seconda parte (Francesco Maria dell’Antoglietta di Taranto):
http://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/15/gli-arcadi-di-terra-dotranto-2-x-francesco-maria-dellantoglietta-di-taranto/
Per la terza parte (Tommaso Niccolò d’Aquino di Taranto)
http://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/23/gli-arcadi-di-terra-dotranto-3-x-tommaso-niccolo-daquino-di-taranto-1665-1721/
Per la quarta parte (Gaetano Romano Maffei di Grottaglie)
http://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/31/gli-arcadi-di-terra-dotranto-4-x-gaetano-romano-maffei-di-grottaglie/
Per la quinta parte (Tommaso Maria Ferrari (1647-1716) di Casalnuovo): http://www.fondazioneterradotranto.it/2019/08/16/gli-arcadi-di-terra-dotranto-5-x-tommaso-maria-ferrari-1647-1716-di-casalnuovo/
Per la sesta parte (Oronzo Guglielmo Arnò di Manduria, Giovanni Battista Gagliardo, Antonio Galeota e Francesco Carducci di Taranto) : http://www.fondazioneterradotranto.it/2019/08/26/gli-arcadi-di-terra-dotranto-6-x-oronzo-guglielmo-arno-di-manduria-giovanni-battista-gagliardo-antonio-galeota-e-francesco-carducci-di-taranto/
Per la settima parte (Antonio Caraccio di Nardò): http://www.fondazioneterradotranto.it/2019/09/17/gli-arcadi-di-terra-dotranto-7-x-antonio-caraccio-di-nardo/
#Alnote Driodio#Arcadi di Terra d'Otranto#Arcadia#Armando Polito#Biagio Maioli d'Avitabile#Donato Maria Capece Zurlo#Libri Di Puglia#Miscellanea#Paesi di Terra d’Otranto#Spigolature Salentine
1 note
·
View note
Photo
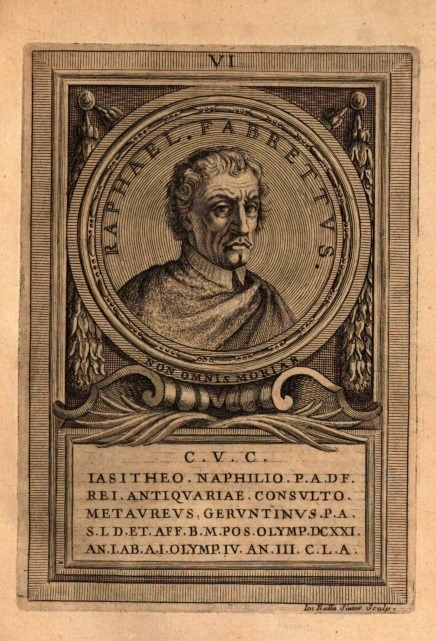
Nuovo post su https://is.gd/nMw4Nv
Gli Arcadi di Terra d'Otranto (4/x): Gaetano Romano Maffei di Grottaglie.
di Armando Polito
1697-1769 le date estreme della vita. Il suo nome pastorale era Onesso Boloneio, la forma più corrente; infatti è Onesso Bolonejo della colonia Mariana in Gennaro Ravizza, Notizie biografiche che riguardano gli uomini illustri della città di Chieti, Miranda, Napoli, 1830, p. 107; Onesso Bolimejo, sempre della colonia Mariana, in Gennaro Ravizza, Appendice alle notizie biografiche degli uomini illustri della città di Chieti, Tipografia Grandoniana, Chieti, 1834, p. 94). Al di là di queste oscillazioni, nulla sono in grado di dire circa l’origine di questo nome pastorale. Per quanto riguarda la colonia Mariana va ricordato che essa era stata fondata nella Religione dei Chierici Regolari delle Scuole Pie, cui il Maffei apparteneva, l’8 novembre 1703 col motto Hinc satur (Da qui sazio). di seguito lo stemma tratto dal frontespizio di Rime di Adalsio Metoneo pastore arcade della colonia Mariana, Stamperia di S. A. R., Firenze, 1738.
La produzione del Maffei, di carattere religioso e, prevalentemente, encomiastico, risulta imponente. Di seguito in ordine cronologico i titoli tratti dal volume citato del Ravizza (pp. 107-108) e, laddove è stato possibile reperirlo, qualche frontespizio.
Fasti antichi di Tarento, oggi Taranto. Sonetti del P. Gaetano di S. Margherita, grottagliese, cherico regolare delle Scuole pie, pastore arcade, consacrati all’illustrissimo signor D. Federico Valignani Marchese di Cepagatti, per S. M. C. C. presidente della Regia Camera di Napoli, fra gli Arcadi Nivalgo Aliarteo. In Chieti nella stamperia del Terzani, 17321
Componimenti poetici in occasione delle felicissime nozze di D. Pietro del Giudice, e D. Marianna Castiglione. Dedicati al merito del Marchese D. Saverio del Giudice P. A., e Vice Custode di detta colonia Tegea col nome di Olasco Panacheo. Chieti, per Ottavio Terzani, 1745
Componimenti poetici in occasione di prender l’abito Francescano nell’esemplarissimo Monistero di Santa Chiara di Lanciano la Signora D. Paola Ravizza col nome di Suor Maria Eugenia. In Chieti nella Stamperia del Terzani 1747
Componimenti poetici in applauso della professione solenne nel Monistero di Santa Chiara in Lanciano di Suor Maria Arcangela, già nel secolo Vittoria Guidotti. In Chieti per Ottavio Terzani 1747
Componimenti poetici in laude di F. Bernardo M. da Lanciano, Difinitore, Lettore Teologo, e Predicator Cappuccino. Dedicati al merito sovragrande del Sig. D. Paolo Minicucci. In Chieti MDCCLII. Nella Stamperia di P. Ferri
Caietani Romani a S. Margarita Cryptaliensis de clericis regularibus scholarum piarum carminum tomus primus. Teate. Ex typographia Petri Ferri, 17522
(Tomo I delle poesie di Gaetano Romano di S. Margherita da Grottaglie dei chierici regolari delle Scuole pie, Teate 1752 Dalla tipografia di Pietro Ferri) Teate era l’antico nome di Chieti.
Maria Assunta. Sonetti del P. Gaetano Romano di S. Margherita, Grottagliese, cherico regolare delle Scuole pie, all’Illustrissimo Signore D. Paolo Minicucci consacrati. In Chieti 1753, nella stamperia di Pietro Ferri3
Componimenti poetici fatti in lode di S. E. D. Raimondo di Sangro, Principe di S. Severo. Chieti, 1755, appresso Domenico Pachetti4
La virtù applaudita negli antichi Eroi Marrucini. Componimento Dramatico da cantarsi in occasione della solenne Accademia sul medesimo soggetto, rappresentato dagli studiosi delle Lettere umane nel Collegio de’ CC. Regolari delle Scuole Pie di Chieti. In Chieti MDCCLVIII
Relazione su la scoverta miracolosa, e tradizione antica della gloriosissima Vergine Maria delle Grazie, che si venera in Alanno, cui sono annesse le poetiche elucubrazioni del P. Gaetano Romano Maffei. In Chieti MDCCLXII
Componimenti poetici in morte di D. Giuseppe Aurelio di Gennaro, Regio Consigliere, e Lettore delle materie feudali ne’ studi pubblici di Napoli. Dedicati al Sig. D. Leopoldo Tutarini, Filologo, Pastore Arcade, Accademico Giureconsulto, ed Avvocato. In Chieti nella Stamperia del Pachetti, 17625
Componimenti poetici per l’esaltazione di D. Filippo Paini al trono vescovile di Valva, e Solmona. In Chieti, 17636
Opella in Anniversario pro fidelium animabus inexcogitabilem Purgatorii ignem patientibus, D. Jacobo Baroni Tiboni, V. I. Doctori, Patritio, Camerario, ac Theatinae Civitatis Principi dignissimo humillime dicata. Teate, MDCCLXVI, ex Typographia Dominici Pachetti7
Componimenti epitalamici per le felicissime nozze di D. Niccolò Barra Caracciolo, e D. Epifania Ramignani (nel Ravizza senza nome, senza luogo e senza data; in realtà, rispettivamente: Chieti, Pachetti e 1767)8
Il catalogo del Ravizza va integrato con i titoli che seguono.
Il Mose nel ritorno dall’Orebbe alla reggia di faraone. Oratorio composto dal padre Gaetano Romano Maffei di Santa Margherita cherico regolare delle scuole pie per cantarsi nella metropolitana dell’ill.ma citta di Chieti solennizzandovisi la festa del glorioso S. Giustino vescovo, cittadino e principal suo protettore nel giorno 11 di maggio. In Chieti : [s.n.], 17589
Grandezze del rosario di Maria opera del p. Gaetano Romano Maffei di S. Margherita chierico regolare delle Scuole Pie. In Chieti appresso Domenico Pachetti, 176810
Non desti meraviglia il fatto che tutte le opere del Maffei furono pubblicate a Chieti, dove egli visse ed operò per moltissimi anni. Non aleggia in esse ricordo della terra d’origine, fatta eccezione per la prima (Fasti antichi di Tarento). Non è un caso neppure che poche copie risultano conservate in biblioteche salentine (sottolineate nelle note 1-10).
Siamo giunti alla parte finale, forse l’unica, in fondo, originale di questo lavoro (ma vale per tutti gli altri della serie), cioè l’individuazione di componimenti sparsi in varie raccolte. Poteva andarmi peggio (come più in là si vedrà con altri autori) ma chi si accontenta gode.
Si tratta di tre sonetti inclusi in Componimenti poetici di vari autori per la promozione alla Sacra Porpora dell’Eminentissimo, e Reverendissimo Signor il Signor Cardinale Domenico Riviera seguita a 2 di Marzo del corrente anno, raccolti, e pubblicati per ordine dell’illustrissima Città dell’Aquila, Campana, Foligno, 1733, pp. 48-50. Li trascrivo aggiungendo in calce ad ognuno le mie consuete note esplicative.
Cinto allor, che fu d’ostro a il gran Riviera b,
fra l’Aterno s’accese, e fra ‘l Metauroc
lite d’onor; di chi di lor mai era
l’alta gloria novella ornata d’auro.
Da me, quegli d diceva, ei la primiera
origin trasse; è mio dunque il tesauro e.
Questof allor: Gli died’io la cunag altera,
è mia la gloria, e l’Indo il dice e ‘l Mauroh.
Giunto in quel punto al suol dall’auree porte
Giove, il gran Giove, i suoi begli occhi fisse,
e sul Riviera udio le liti insorte.
Gridò ridendo allor: Cessin le risse;
è comune tra Voi per bella sorte
tutto l’onor che l’ Cielo a lui prescrisse.
a Domenico Riviera (Urbino 1671- Roma 1752), nell’immagine che segue tratta da Effigies nomina et cognomina S.D.N. Innocentii PP. XI. et RR. DD., De Rossi, Roma, 1730, fu fatto cardinale da Clemente XII nel 1733.
Il Rivera fu socio dell’Arcadia col nome pastorale di Metaureo Geruntino (per Metaureo vedi le successive note c ed f.; per Geruntino il riferimento è al fiume Gerunte che scorreva presso la città di Elea secondo quanto si legge in Giovanni Mario Crescimbeni, L’Arcadia, Antonio de’ Rossi, Roma, 1711, p. 273). In un’adunanza dell’Arcadia il Riviera lesse, scritta in latino, la vita di Raffaele Fabretti (Urbino 1618-Roma 1700), famosissimo storico ed archeologo, che in seguito fu pubblicata in volgare da Giovanni Mario Crescimbeni (titolo: Vita di Raffaello Fabretti Urbinate detto Iasiteo Nafilio trasportata dal testo latino dell’Ab. Domenico Riviera da Urbino, detto Metauro Geruntino, nel nostro volgar toscano dal Can. Gio. Mario Crescimbeni Maceratese detto Alfesibeo Cario Custode Generale d’Arcadia) in Le vite degli arcadi illustri, I, Roma 1708, pp. 89-108, precedute dal ritratto del Fabretti che di seguito riproduco.
Il Riviera diede alle stampe De divo Joanne Evangelista oratio s Sanctissimum Dominum nostrum Innocentium duodecimum, Roma, Domenico Antonio Ercole, 1697 (era stato proprio Innocenzo XII a nominarlo prima coadiutore del Fabretti, poi suo successore nel 1700, nella custodia dell’archivio segreto); Per riconoscere lo stato del Reno, del Panaro, e del Pò, e l’accrescimento dei danni cagionati dal primo, Benacci, Bologna, 1719 e, sullo stesso tema, Alla santità di N.S. Clemente XI ed alla sagra Congregazione delle acque relazione, e voto di monsig. Domenico Riviera segretario della medesima, e visitatore appostolico l’anno 1716. Per riconoscere lo stato del Reno, del Panaro, e del Po, e l’accrescimento dei danni cagionati dal primo. Per la Congregazione delli 3 settembre 1717, Eredi del Benacci, Bologna, 1719; Sommario delle ragioni allegate nel Fatto/Dominicus Rivera Sacrae Congregationis aquarum secretarius, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1725; Resolutiones habitae a Sacra Congregatione aquarum in causa Bononien, seu Ferrarien. Aquarum Sper quatuor infrascriptis articulis inter interesse habentes ad dexteram fluminis Rheni in ejus parte inferiori Legationis Bononiae, et Civitatem Ferrariae, Principes Pios, & alios &cc. Die Ven. 24. Augusti 1725 / Dominicus Rivera sac. congregationis aquarum secretarius, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1725. Un suo contributo è in Nuova raccolta d’autori, che trattano del moto dell’acque, v. V, s. n., s. l., 1766.
b porpora cardinalizia. La voce è dal latino ostreu(m), trascrizione del greco ὄστρεον (leggi òstreon) che significava conchiglia e, per metonimia (la porpora era ricavata da alcuni molluschi, porpora.
c Aterno e Metauro sono i due maggiori fiumi, il primo dell’Abruzzo, il secondo delle Marche. A questo interesse per i fiumi non è estraneo quanto riporto alla fine della precedente nota a.
d L’Aterno. La famiglia Riviera era originaria de L’Aquila.
e Latinismo per tesoro.
f Il Metauro. Il futuro cardinale era nato ad Urbino.
g culla.
h L’affermano l’indiano e l’africano.
O fra gli Eroi più saggi Eroe migliore,
che sei di Storia, e di Poema degno,
gloria d’Aterno, e del Metauro onorea,
ed immortal di tutti due sostegno,
poiche te solo feo l’almo Fattore
Fenice altera nel divino ingegnob,
onde in te chiudi, e poi diffondi fuore
quanto contien delle virtudi il Regno,
la bell’almac Real del gran Clemented
cinger ti volle d’ostroe, e d’oro il Crine
per degno premio di sì eccelsa mente.
E al tuo mertof le glorie almeg latine
convengon sì, che in mirar l’ostro ardente
mira ciascun le tue virtù divine.
a Vedi le note c, d ed f del precedente componimento.
b poiché il creatore che dà vita (Dio) rese te solo superba Fenice (l’araba fenice era un mitico uccello che risorgeva dalle sue ceneri).
c anima. Da notare il gioco di parola tra questo sostantivo, che è da anima con dissimilazione (àlima) e caduta della vocale postonica e il precedente aggettivo almo, che, invece, è dal latino almu(m), che significa nutriente, che dà la vita, a sua volta da àlere, che significa alimentare.
d Clemente XII.
e Vedi la nota b del precedente componimento.
f Forma sincopata per merito.
g benefiche; si completa il gioco di parola di cui s’è detto alla nota c.
Và di Savoia a veder lieto i Figli,
disse Clemente al suo Riviera un giornoa,
Eroe fra lor vedrai d’alti consigli
famoso in guerra e di Pietade adorno.
Egli è il gran Duce Eugenio. Intanto digli,
che qualor di sue glorie il bel ritorno
da lui la Fede aspetta, omai si appigli
a quei pensier, che fagli fregio intorno.
Chinò il Riviera il ciglio a tai parole;
e d’ampie Idee già pieno alto Messaggio
partì dalla Romana augusta Mole.
Qual poi si fosse in compier con vantaggio
di Santa Fe sì belle cause, e sole,
chiedilo al Mondo, e ti dirà: Fu saggio.
a Allude alla missione diplomatica presso Eugenio di Savoia che Clemente XII gli aveva affidato nel 1707, sulla quale vedi Francesco Maria Ottieri, Istoria delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in Italia per la successione alla Monarchia delle Spagne dall’anno 1696 all’anno 1725, tomo IV, Stamperia di Pallade, Roma, 1754, pp. 295-300.
(CONTINUA)
Per la prima parte (Premessa):
http://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/08/gli-arcadi-di-terra-dotranto-premessa-1-x/
Per la seconda parte (Francesco Maria dell’Antoglietta di Taranto):
http://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/15/gli-arcadi-di-terra-dotranto-2-x-francesco-maria-dellantoglietta-di-taranto/
Per la terza parte (Tommaso Niccolò d’Aquino di Taranto):
http://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/23/gli-arcadi-di-terra-dotranto-3-x-tommaso-niccolo-daquino-di-taranto-1665-1721/
_______________
1 Una copia presso la Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi de L’Aquila, una presso la Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi di Bari, una presso la Biblioteca civica don Vincenzo Angelilli di Gioia del Colle (BA), una presso la Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo di Brindisi, una presso la Biblioteca comunale Francesco Trinchera senior di Ostuni (BR), una presso la Biblioteca comunale di Gallipoli (LE), due presso la Biblioteca provinciale Nicola Bernardini di Lecce, una presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, due presso la Biblioteca della Società napoletana di storia patria di Napoli, una presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, una presso la Biblioteca comunale Marco Gatti di Manduria, una presso la Biblioteca S. Francesco di Sava (TA), una presso la Biblioteca civica Pietro Acclavio di Taranto, una presso la Biblioteca diocesana Beata Lucia Broccadelli, sede centrale, di Narni (TR).
2 Una copia presso la Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi de L’Aquila, una presso la Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi di Bari, una mutila presso la Biblioteca diocesana A. Sanfelice di Nardò (LE), una presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli.
3 Una copia presso la Biblioteca Calasanziana di Campi Salentina (LE), una presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, una presso la Biblioteca della Società napoletana di storia patria di Napoli, una presso la Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo.
4 Una copia presso la Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi de L’Aquila.
5 Una copia presso la Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi de L’Aquila, una presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, una presso la Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo.
6 Una copia presso la Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi de L’Aquila.
7 Una copia presso la Biblioteca diocesana di Ripatransone (AP), una presso la Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi de L’Aquila.
8 Una copia presso la Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi de L’Aquila.
9 Una copia presso la Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi de L’Aquila.
10 Una copia presso la Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi de L’Aquila, una presso la Biblioteca nazionale Sagarriga-Visconti di Bari.
#Arcadi di Terra d'Otranto#Arcadia#Armando Polito#Gaetano di S. Margherita#Gaetano Romano Maffei#Metaureo Geruntino#Nivalgo Aliarteo#Raffaele Fabretti#Libri Di Puglia#Miscellanea#Spigolature Salentine
0 notes
Text
“Quante volte è dovuta andare a letto con Beckett per avere questo scoop?”. Deirdre Bair, la biografa del grande Samuel che ha tenuto a bada orde di accademici
A metà del libro, Parisian Lives: Samuel Beckett, Simone de Beauvoir and Me, A memoir (Atlantic Books, 2020) la biografa statunitense, Deirdre Bair, confessa il suo crimine. Per anni ha provato a mettere le mani sulle lettere che Samuel Beckett inviava a Thomas MacGreevy sicura di trovarci il bandolo della matassa, il motivo che aveva allontanato il drammaturgo irlandese dalla sua terra natia per condurlo in Francia. Con riluttanza, i nipoti di MacGreevy le permisero di leggere le lettere sotto rigide condizioni. In quella domenica invernale, non appena si sedette di fronte alla macchina da scrivere in casa loro, mentre udiva la famiglia del poeta pranzare nella stanza accanto, Bair sapeva di dover correre contro il tempo: le poche ore concessegli dalle sorelle, non le sarebbero mai bastate per trascrivere tutta la corrispondenza di cui necessitava. “Quel pomeriggio ho fatto l’unica scelta disonesta di tutta la mia carriera” ammette Bair. Con nonchalance, l’americana si infilò una piccola selezione di lettere nella borsetta per portarsele nella stanza d’hotel in cui alloggiava.
“Mentre lavora, il biografo”, scrive Janet Malcolm, “è come un ladro professionista: irrompe in una casa, fruga nei cassetti in cui crede ci possano essere soldi e preziosi, per poi allontanarsi trionfante con la refurtiva”. Il suo libro, The Silent Woman: Sylvia Plath & Ted Hughes (riedito da Granta nel 2020) accusa i lettori di biografie di essere colpevoli di “voyerismo e indiscrezione” almeno quanto gli autori stessi: entrambi, e insieme, sgattaiolano in punta di piedi lungo il corridoio per spiare dal buco della serratura. Infatti, le sostanziose borse di studio in letteratura biografica non sono altro che una fulgida patina di rispettabilità, che scontorna la curiosità più morbosa.
*
Il giorno successivo, Deidre Bair reinserì le lettere di MacGreevy nella collezione senza alcun segno di usura. Tuttavia, la sua ammissione è rivelatoria, poiché ci mostra come – da esperta reporter quale era – fosse pronta a tutto pur di scovare lo scoop. E uno scoop ha avuto. Quando, nel 1978, Samuel Beckett: A Biography vene pubblicato [in Italia è tradotto per Garzanti nel 1990, ndr], suscitò clamore e mandò in confusione molti accademici in doppiopetto. Gli studenti di Beckett si accalcarono per scrivere recensioni irrisorie che ne evidenziassero imprecisioni e lacune. Ciononostante, per quanto alcune di quelle critiche fossero lecite, il vero peccato di Deirdre Bair fu quello di essere una sconosciuta, e donna per giunta, che aveva scritto il libro su Beckett, che né professori né accademici avrebbe mai osato scrivere.
Nel 1970 Deirdre Bair aveva scelto di intrecciare la propria vita a quella di Beckett con la stessa leggerezza con cui avrebbe scelto cosa mangiare dal menu di un ristorante. Aveva passato i precedenti dieci anni a lavorare come reporter, mentre aiutava il marito a concludere un corso postlaurea e cresceva i loro due figli. Quando ebbe la possibilità di frequentare un corso annuale di letteratura presso la Columbia University, colse la palla al balzo, pensando che l’avrebbe aiutata nella sua carriera da giornalista. Scelse Beckett come oggetto di tesi solamente perché il suo nome era in cima all’ordinata lista di scrittori organizzata per ordine alfabetico, che lei stessa aveva stilato per l’occasione. Il suo tutor la ammonì: se avesse scelto di scrivere della vita di Beckett, come stava pianificando, non avrebbe mai ottenuto né un PhD, né un incarico accademico. “Non avrai una borsa di studio: è solo una biografia,” le disse.
Ma Bair “riconobbe il brivido che si prova quando si trova la storia giusta” e decise di contattare Beckett stesso per chiedergli il permesso di scrivere la sua biografia. “Noiosa e priva di interessi” le rispose una settimana più tardi riferendosi alla propria vita; “vi sono professori che ne sanno più di me” aggiunse poi. Infine, scarabocchiata, quasi l’avesse pensata in un secondo momento, una straordinaria frase senza alcun segno di cesura: “qualsiasi informazione biografica in mio possesso è a tua disposizione se verrai a Parigi ti incontrerò”.
*
Deirdre sarebbe partita per Parigi nel novembre del ’71 e le prospettive non potevano essere più rosee: un cospicuo rimborso spese per il viaggio, un operoso agente letterario e la possibilità di convincere un editore. Ma tutto ciò non durò a lungo, ovviamente. Un amico newyorchese di Beckett, lo scrittore John Kobler, le rifilò due enormi bottiglie di whiskey Bushmill per il collega irlandese. Solo più tardi scoprì che a Beckett nemmeno piaceva il Bushmill, e che quindi aveva faticato invano per farle entrare nella valigia. Tuttavia, lo sgradito regalo era solo il presagio dei fraintendimenti e dei rischi nei quali Deirdre si sarebbe invischiata e che l’avrebbero inghiottita per i successivi sette anni.
“Non ti aiuterò – e non ti sarò d’intralcio”, le disse Becket al loro primo incontro. “La mia famiglia e i miei amici ti assisteranno; i miei nemici ti troveranno presto”. Bair, però, non si aspettava che amici e nemici di Beckett fossero tanto difficili da distinguere fra loro e, che nei sette anni occorsi per fare le opportune ricerche e ultimare il libro, il suo soggetto sarebbe stato fino a quel punto elusivo. Nonostante l’impareggiabile disponibilità che lo scrittore dimostrava, nel presentarle il suo cerchio di frequentazioni, e nel lasciarla libera di chiedere qualunque cosa volesse; Beckett spesso spariva da Parigi in modo alquanto misterioso, senza lasciare alcun recapito, durante le settimane in cui lei lo raggiungeva dall’America per proseguire il lavoro. Quando invece si palesava, Beckett imponeva rigide regole. Niente registrazioni, niente appunti. Bair doveva scriversi le domande in anticipo, memorizzarle attentamente e, dopo averlo incontrato, precipitarsi nella sua stanza d’albergo per buttare giù qualche disordinato appunto. “Quando intuiva ch’io stessi per scoprire qualcosa, s’irrigidiva”, rammenta Bair, “si arrovellava nei propri discorsi; li riempiva di commenti personali e si mostrava sprezzante”.
*
Deirdre sospettava che Beckett non la prendesse seriamente. Un giorno, divertito dalla situazione, Con Leventhal – un amico dello scrittore – le rivelò di una volta in cui Beckett si era riferito a lei come “la donna dai capelli rigati” alludendo alle mèches che Deirdre si faceva dal parrucchiere. Le ricordò dell’ordinario sessismo di cui era vittima nei suoi giorni in redazione, quando si supponeva che una “ragazza reporter” dovesse scrivere di “cucina, vestiti, club di bridge e circoli sociali” piuttosto che di cronaca vera. Ma Bair non si era arresa allora e non si sarebbe certo arresa nemmeno in questa nuova fase della sua carriera. La sua determinazione venne ripagata. “La mia parola è la mia promessa”, le disse e lei gli credette. Bair aveva il sospetto che anche Beckett fosse curioso di vedere come lo avrebbe dipinto mentre era ancora vivo.
Le esperienze con la maggior parte degli amici di Beckett furono tutt’altro che felici. Bair si sorbì tutte le “derisorie maldicenze” che venivano fuori quando litigavano su chi appartenesse o meno al circolino degli eletti. Dovette comprare una marea di scotch a George Reavey a New York, in cambio di briciole biografiche sullo scrittore (“un incubo che andò avanti durante i sette anni di scrittura del libro”). In quasi ogni pagina di Parisian Lives, si può trovare una vena di ripicca o una traccia del rancore a lungo serbato da parte dell’autrice. “Ero l’unica in grado di riconoscere i ritratti che faceva di certi personaggi noti a Dublino”, scrisse di quando leggeva l’opera di Beckett, ma le memorie dei suoi soggiorni a Dublino per cercare la verità non erano affatto piacevoli. “Ho passato serate interminabili seduta sullo sgabello di un pub nel tentativo di tenermi alla larga da innumerevoli poeti, attori, sceneggiatori, giornalisti o professori irlandesi e ubriachi”. È un peccato che la generosità e la gentilezza di Seamus e Marie Heaney, e di altri che ne mostrarono nei suoi confronti, venga fuori solo lateralmente.
*
Parisian Lives arde nella irreprensibile ira di Bair nei confronti dei comportamenti sessisti che l’hanno perseguitata mentre seguiva Beckett e negli anni successivi. Alla pubblicazione del libro nel 1978, la frustrazione provata dai critici statunitensi, nei confronti di una scrittrice in grado di affrontare un soggetto letterario così importante, venne fuori. Richard Elmann, sulla The New York Review of Books, si chiese come Beckett avesse potuto permettere a una totale sconosciuta di scrivere della sua vita. “La domanda è interessante quanto qualsiasi altro tema proposto nel libro, e la sua risposta non è difficile da intuire”. Le sue insinuazioni non erano più complesse di quelle articolate dal giornalista che chiese a Bair: “Quante volte è dovuta andare a letto con Beckett per avere questo scoop?”. I recensori britannici furono più corretti e alternarono elogi per il lavoro di Deirdre a critiche legittime sulla biografia. Inaspettatamente, Bair non menziona alcun critico irlandese, se non Brian Fallon, che nel The Irish Times scrisse in occasione della ristampa del ’81: “Le parti migliori sono probabilmente quelle che parlano della vita di Beckett in Francia, del suo impegno nella Resistenza (per il quale venne decorato) e quelle che descrivono le circostanze in cui è riuscito a scrivere e produrre Aspettando Godot, mettendo fine a decenni di ombre e difficoltà. Le conoscenze di Ms. Bair in merito alla letteratura irlandese degli anni ’30 e ’40 sono molto meno interessanti e costellate di seccanti scivoloni e abbagli. Per esempio, viene citata un’opera di Sean O’Casey chiamata I Sogni di Padre Ned, mentre il nome di battesimo di Con’ Cremin diventa Constantine invece di Cornelius; viene citato il fantomatico bando su Joyce in Irlanda etc.”.
*
Aver scritto della vita di Beckett, prima e dopo la pubblicazione, è stato sfibrante per Deirdre Bair, ma fra i lividi e le ferite di battaglia, la biografa ricorda alcuni momenti edificanti. Dopo sette anni di duro lavoro, appena prima della messa in stampa del libro, le venne comunicato che doveva ottenere il benestare di Beckett per ogni singola citazione da lettere personali e manoscritti inediti. Esausta, gli scrisse per spiegare la situazione, e chiese a Beckett di apporre le proprie iniziali accanto a ogni citazione che avrebbe voluto inserire nel libro; si trattava di ventitré pagine di citazioni. Una settimana dopo giunse la risposta dell’irlandese. Aveva firmato ogni citazione eccetto una: il poema che aveva scritto da scolaro della Portora Royal School a dodici anni: “mostra meglio la tua diligenza nella ricerca, che la mia evoluzione come scrittore” le spiegò con sagacia. Dopo tutti gli ostacoli superati e le ostilità incontrate in quegli anni, capire che Beckett era davvero un uomo di parola, commosse profondamente Bair. “Nella mia carriera ho incontrato molte persone di parola”, scrive, “ma nessuno ha mai pareggiato l’integrità mostrata da Samuel Beckett. Per lui la parola era veramente una promessa”.
*
Il successo di Samuel Beckett: A Biography fu la ricompensa di Bair. I lettori si ammassarono nelle librerie per averne una copia, le venne conferito il National Book Award nel ’81. Un editore le offrì un contratto per scrivere di chiunque avesse voluto, convinto che Deirdre potesse “tener testa a qualsiasi irlandese, compresa Virginia Woolf”. Lei giurò di aver chiuso con le biografie, ma poco dopo tornò sui suoi passi. Nel 1986 pubblicò Simone de Beauvoir: A Biography, e da allora ha scritto una mezza dozzina di altre biografie; tutte accolte ottimamente dalla critica. Carl Jung, Anaïs Nin, Saul Steinberg e Al Capone furono i suoi soggetti e anche la sua carriera accademica decollò. Tuttavia, come ci racconta nell’introduzione di Parisian Lives, dopo così tanti libri e così tanti anni, tutto ciò che interessava al pubblico erano comunque i due scrittori “di Parigi”, Beckett e de Beauvoir, che cordialmente si detestavano. Ovunque andasse e di chiunque Bair parlasse, tutti le chiedevano di loro due e sempre con la stessa domanda. “Ma com’erano veramente?”.
*
Così, a quasi cinquant’anni dalla prima volta in cui guardato nei celesti “occhi da gabbiano” di Beckett nella hall di quell’hotel parigino, Deidre Bair ha risposto alla domanda che tiene svegli i ficcanaso, mettendosi al centro della scena. Nell’introduzione di Parisian Lives descrive il libro come “un curioso ibrido: si tratta di bio-memorie”, in cui parla di sé stessa come una biografa quando incontra Beckett e de Beauvoir. La sua vita è proiettata attraverso il prisma dei suoi soggetti più noti ed è quindi particolarmente significativa la sua morte – occorsa nel 2020, all’età di 84 anni – a stretto giro dalla nomina al Premio Pulitzer di questo suo ultimo libro. Parisian Lives, non doveva essere la sua ultima opera; infatti, Deirdre Bair stava già lavorando su un altro progetto, una biografia di T.S. Eliot, quando è deceduta. Tuttavia, così, questo libro chiude nel modo più preciso il ciclo della sua relazione “a vita” con Beckett e de Beauvoir, descrivendo il suo modo scomodo e trasgressivo di inseguire le vite degli altri.
In fin dei conti, Parisian Lives non parla di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato nella biografia, né vuole raccontare i crimini che si commettono nel nome di questo genere. Il vero soggetto è il prezzo che una donna ha dovuto pagare per avere successo nella vita professionale che si è scelta. Dopo le tante avversità incontrate nello scrivere di Samuel Beckett, Bair riporta le parole dell’artista franco-americana, Louise Bourgeois, che le hanno dato il coraggio per continuare a scrivere biografie: “Nell’arte, non c’è posto per una donna, fino a quando non avrà provato e riprovato che non si lascerà spazzare via”.
Ann Kennedy Smith
*L’articolo è stato pubblicato in origine su “Dublin Review of Books” come “The Hard Life”; la traduzione è di Giacomo Zamagni
L'articolo “Quante volte è dovuta andare a letto con Beckett per avere questo scoop?”. Deirdre Bair, la biografa del grande Samuel che ha tenuto a bada orde di accademici proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2VnOl1y
0 notes
Text
Arthur Rimbaud, anima disperata, abbraccia la folle avventuriera Isabelle Eberhardt in Africa… Discorso su “Il tempo degli assassini” di Henry Miller
In questo tempo che tutti chiamano “sospeso”, dove non c’è tempo per la primavera né per le lacrime né per i defunti, spesso si fanno cose che di solito si rimandano, dicendo “un giorno o l’altro lo faccio”. Ecco, all’inizio di questa terribile pandemia quel giorno è arrivato, ma non credevo che sistemare la libreria di casa fosse una così lunga operazione. Dovevo essere in Africa per le mie solite missioni in un ospedale della Tanzania, e invece dal 9 marzo sono recluso in casa come altri 3 miliardi di persone nel mondo. Devo dire che sono “volati” i giorni e le settimane: da quasi due mesi sono alle prese con la libreria e non ho ancora finito. Infatti a ogni piè sospinto faccio una sosta, perché scorgo libri che avevo scordato anche di aver letto e con grande piacere mi soffermo su qualche volume in particolare, come “Il tempo degli assassini”, saggio su Arthur Rimbaud che ho riletto ora molto volentieri (del resto qualcuno ha detto che la Letteratura e i Classici vanno sempre riletti), scritto da Henry Miller per il centenario della nascita del poeta (1854) e pubblicato in Italia nel 1966 da Sugarco a cura di Giacomo Debenedetti, tra i maggiori interpreti della letteratura italiana del XX secolo. “Voici le temps des Assassins” (Ecco il tempo degli Assassini) è il rintocco che chiude Mattinata d’ebbrezza nelle Illuminazioni di Rimbaud, e da lì proviene il titolo, con una polivalenza di significati, della quale Rimbaud è solo in parte responsabile.
*
A pagina 64 mi sono imbattuto in una cancellazione fatta da me a matita nel 1976, dieci anni dopo la pubblicazione, con delle notule da cui è scaturito il presente scritto, nel punto in cui si dice che Rimbaud fu una delle anime più disperate che abbiano mai percorso la terra. È vero che cedette per logoramento, ma non prima di aver battuto ogni via sbagliata… Ecco, avevo cancellato il termine sbagliata scrivendo a fianco “non è vero”. Non so che cosa intendessi allora con questa negazione così perentoria, certo è che la frase veniva lasciata monca ma non privata del senso più forte e cioè “non prima di aver battuto ogni via”. Tutto mi fa credere che Rimbaud avesse percorso ogni strada pur di arrivare al fondo delle cose e andando ben oltre il concetto di “via possibile”. L’accezione “sbagliata” significava per me forse attribuire a quelle vie il senso di non legittimamente percorribili e quindi non idonee all’esperienza del bene, ma c’era comunque qualcosa, come una musica lontana, distante una voce, quasi un tocco impercettibile che chiamava oltre la parola, oltre la realtà, almeno quella di pura percezione. E fin lì mi sono spinto attraverso i testi e l’esperienza della vita, imboccando a volte anche la parola “sbagliata” o l’esperienza illegittima. E ho capito che si può essere fuorilegge, ma non necessariamente diventare banditi, così come nel caso di Rimbaud il “veggente”, che divenne termine di paragone anche nell’esperienza successiva a quella letteraria, cioè a quella africana a me molto cara.
*
Una lezione di vita e di poesia che sonda le diverse anime del sentire, sperimenta, scende negli abissi della letteratura e dell’esistenza: sia nel Le bateau ivre sia nelle Illuminazioni se ne ha ampia conferma. Una natura che in qualche modo mi era famigliare nel tempo della gioventù ma che rimane per sempre o forse lo è per tutti i giovani che identificano la loro ribellione, il loro disagio, la propria urgenza creativa nella parola poetica, scoprendo poi che nella vita “vera” si rimpiange molto quel tempo indimenticabile. Come per Miller, che non si è mai fatto mancare nulla in fatto di “stranezze”, Rimbaud è sempre stato anche per me una presenza adescante che si aggirava per casa coi suoi libri, ma io non l’avevo mai degnato d’uno sguardo, se non quello per la mirabolante scia luminosa delle numerose vite che aveva lasciato nelle menti di noi “poeti” in erba. Già pensavamo alla scrittura come a una colpa piuttosto che a un merito e anch’io ero convinto allora di essere indesiderato, di non servire per nulla alla società e al mondo. Avevo una fretta di esistere intrusiva e a volte insopportabile. Allora presi la laurea in Medicina, andai a bottega in varie parti del mondo e finii in Africa, tornando in Italia vivo e risanato. Esattamente dieci anni dopo aver letto quel libro che per primo mi aveva parlato di Rimbaud in Africa (si legga Carlo Zaghi, Guida editori 1993). Da lì il mio grande interesse per il suo daimon, che mi ha sempre seguito nei vagabondaggi ormai più che trentennali in Africa. E in Etiopia, a Shashamane, sepolto in una cella francescana a fare il medico missionario, ho letto un libro su Isabelle Eberhardt, e dai suoi testi ritrovati e salvati da un capitano francese dal fango della sua casa è emersa una storia davvero incredibile. Vi chiederete che cosa c’entra questo con il saggio Il tempo degli assassini di Henry Miller (potete trovarlo anche nelle raffinatissime edizioni SE). Aspettate e vedrete.
*
Isabelle è stata un’esploratrice e scrittrice svizzera di origini russe, figlia di una nobildonna di San Pietroburgo vedova di un alto ufficiale dello zar, Pavel Karlovitch de Moerder, e di padre ignoto. Una vita davvero romanzesca quella di Isabelle Eberhardt, sul crinale tra XIX e XX secolo. Una vita breve, eppure gremita di audaci esperienze: la parabola di una giovane donna nata a Ginevra, madre certa, padre incerto, scrittrice e giornalista irrequieta, innamorata del Maghreb e della cultura islamica, che attraversa il Nord Africa travestita da cavaliere arabo (con lo pseudonimo di Mahmoud Saadi) per potersi addentrare in territori inaccessibili, interdetti a visitatrici europee. S’innamora dell’ufficiale arabo Slimène Ehnni e con lui si unisce a una confraternita sufi, vivendo in povertà. Nomade tra i nomadi, Isabelle fa del deserto la sua casa. Espulsa dal Paese, ripara a Marsiglia, sposa Slimène e come cittadina francese ritorna in Algeria. Si stabilisce ai margini del deserto e, pur essendo sposata, non smette di indossare abiti maschili e di condurre tormentati vagabondaggi tra i nomadi; beve alcool con i legionari, fuma hashish e va a letto con chi le piace. A venticinque anni soffre di malaria, forse anche di sifilide, ma resta una donna fiera, lucida e dall’intensa vita spirituale. Amica di sceicchi e di sapienti sufi, ma anche di ufficiali dell’esercito coloniale francese, sospettata di spionaggio da una parte e dall’altra, Isabelle abbraccia la fede musulmana e vive emozionanti avventure tra esplorazioni, immersioni nelle comunità locali, scontri con i ribelli, infuocate vicende amorose. Fino a una morte assurda, a soli ventisette anni, nel 1904, vittima di un’improvvisa inondazione in Algeria, ad Aïn-Sefra: annegata per l’esondazione di un piccolo el oued, incredibilmente in pieno deserto del Sahara. Sotto la melma del fiume il capitano francese, di cui dicevo sopra, salvò i suoi scritti.
Qualche fantasista della biografia, una svizzera francese molto vicina alle Ardenne, ha indicato la madre della Eberhardt come l’ultimo amore di Rimbaud, la madre, che, amica del poeta francese, pare l’abbia spedita in Africa a cercare un’altra vita e a fare esperienza. E magari a cercare il suo vero padre, Arthur… Ma in quel concetto di “esperienza” che mi è molto caro, le lettere di Rimbaud che vennero da lontano, cioè dall’Abissinia di allora e indirizzate alla propria madre e alla sorella, trovavano quel senso profondo dal fatto di frequentare ogni via. In alcune note biografiche che si somigliano sia in Rimbaud che in Miller, e a questo punto anche nella Eberhardt, rinvengo la stessa fame di avventura e insaziabile curiosità nei desideri senza limiti, con lo stesso coraggio, la stessa tenacia e una sorta di autoflagellazione che portò il poeta “maledetto” a non scrivere più nulla e a rifugiarsi nell’ascetismo e, paradossalmente, nell’esperienza della vita. In situazioni a volte tragiche e pericolose come quelle del contrabbando di schiavi e della vendita d’armi. Con Miller una differenza: mentre per il poeta francese la letteratura venne prima della vita e dell’esperienza, per Miller fu esattamente il contrario, cioè prima visse e fece esperienza della vita, poi si dedicò alla letteratura. Infatti pubblicò il suo primo libro all’età di quarantatré anni, mentre Rimbaud a venti aveva già scritto tutto, eccetto quanto contenuto nel famoso baule nero venduto chissà dove nella folle corsa attraverso le piste polverose d’Africa, per raggiungere l’ospedale di Parigi. Purtroppo non abbiamo nessun documento del linguaggio delirante a cui si abbandonava sul letto dell’ospedale.
*
C’è un’altra possibilità per vivere la letteratura: scriverla mentre la si vive. Rimbaud questo non lo fa. Forse nelle carte irrimediabilmente perdute si poteva trovare qualcosa della sua esperienza africana, della quale non restano che testimonianze rare o sbiadite fotografie pagate oggi a peso d’oro. Ah, se Rimbaud lo sapesse! Oggi non avrebbe più la pena di quei 40.000 franchi che doveva accumulare per vivere felice, viaggiando per le sue tormentate vie della Terra. Ma questo è solo pia illusione, perché i franchi diventeranno 50.000 e così via. E allora che cos’è che a un tipo simile rende tanto difficile accettare il mondo così com’è? Certo, se avesse saputo che una copia autografa di Saison en Enfer sarebbe stata battuta all’asta per più di un milione di euro dei giorni nostri…ma così è.
Per quanto nel saggio Miller definisca il poeta il “suicida vivente” e per quanto sia stata studiata in lungo e in largo, la vita di Arthur Rimbaud rimane un mistero esattamente come il suo genio. Immolarsi in un’esistenza piena di insidie e tormenti al punto da rendere irriconoscibile, lui, opera splendida del creato, che fanciullezza sublime, miracolosa pubertà… spirito beffardo e motteggiatore impassibile, come ebbe a definirlo Paul Verlaine, sono gli eponimi di un genio di rara sapienza. Infatti la sua attività creatrice si può liquidare in pochi anni, cioè tra il 1869 e il 1873, quando un anonimo editore di Bruxelles dell’Alliance typographique (M. J. Poot et Compagnie) in Rue aux Choux pubblicò l’opera poi marchiata come di poeta maudit, maledetto, cioè Una stagione all’inferno, del cui lancio l’autore se ne infischiò bellamente, perché aveva altro da fare.
*
Una scrittura poetica potente e ironica, dono alto e supremo alla storia della poesia universale, magnifica testimonianza dell’Intelligenza, prova fiera e francese… affermazione incontestabile di questo immortale regno dello Spirito, dell’Anima e del cuore umano: la Grazia e la Forza… sempre secondo le affermazioni di Paul Verlaine. La mia giornata è fatta. Lascio l’Europa. L’aria marina brucerà i miei polmoni, i climi perduti mi conceranno. Così scriveva quasi come un commiato sulla sua Saison en enfer, dove l’uomo Rimbaud smette i panni del poeta, per indossare quelli dell’uomo “libero”, dell’avventuriero in Africa, del mercante di schiavi e di fucili, dell’uomo che ha scelto di vivere non soggetto alle pastoie legittime della burocrazia francese, libero da tutto, ma non da se stesso. E uno si salva se abdica a questo, ma è illusoria libertà, perché la libertà è una prerogativa per l’io rinnegato, senza costrizioni. E questa non è libertà, perché uno che vive una vita così come lui l’ha vissuta non può esaurire tutte le aspettative richieste, scrive Henry Miller, scrittore inquieto e anche lui “maledetto” e geniale. È una speciale condizione che procura il diritto di sollevare obiezioni, di tirarsi in disparte se necessario, perché non tiene conto delle differenze degli altri ma solo delle proprie. Non lo aiuterà questo né la sua poesia gli farà trovare un legame stabile e una comunione con tutto il genere umano. Si rimane separati per sempre, isolati per sempre. La madre austera e severa, il padre fuggitivo e inesistente avranno un ruolo centrale nella sofferenza di tutta la vita di Arthur Rimbaud, non solo perché i genitori, e l’epoca del resto, pretendevano che egli soffrisse, ma egli soffrirà perché è tutto lo spirito dell’uomo a trovarsi in difficoltà, e soffrirà come può patire un seme destinato a cadere su un terreno sterile. Era nato seme e rimase seme per sempre.
Il corpo che cede nell’ultimo atto di vita, allorché non è che un moncone immobile, come lo chiama, non è cosa di cui sbarazzarsi con un ghigno scettico.
*
Rimbaud era l’incarnazione del ribelle. Occorrevano tutte le varietà di degradazione e di umiliazione conosciute, serviva ogni tipo di strappo per spezzare la volontà caparbia ch’era la pervietà delle sue misteriose sorgenti. Egli fu perverso, è vero, intrattabile, ferreo e duro fino all’ultimissimo momento, quando non c’era più speranza, ma il maledetto si fa prima veggente e poi credente. E si racconta che il prete che somministrò a Rimbaud l’estrema unzione pare abbia detto a Isabella, la sorella: “Vostro fratello ha la fede, figliola mia, anzi io non ho mai visto una fede così grande”. Ed Henry Miller aggiunge che ci si trovava davanti a una fede delle anime più disperate che abbiano mai avuto sete di vita. E se mi permettete un’azione di rimando, vi dirò che ho visto molte analogie con la vita di Cristo e il suo Calvario. E nessuna diversità fra Isabelle Eberhardt e Rimbaud, soprattutto se confrontiamo le loro esperienze tra Harar e l’Ogaden, dove forse, ci piace pensarlo, i due si erano incontrati e magari abbracciati da qualche parte in quelle pietrose solitudini del deserto. E solo per misurare non tanto una parentela di sangue, ma un anelito straordinario, questo sì, nella ricerca della libertà più assoluta. Se riflettete un attimo, vi accorgerete che le due vite (ma anche quella di Miller) per forma e contenuto coincidono con la rivoluzione che fecero nel loro contesto sociale.
Rimbaud fu il nome e la sfera del sovvertimento non solo del linguaggio poetico ma di un nuovo pensiero di etica e costume svincolato dai cliché morali dell’epoca. Esattamente come nel caso dell’inquieta scrittrice russa, anche se con finalità ovviamente diverse ma non contrarie. Arthur Rimbaud era ricco di spirito e anche i suoi avversari, angeli del “male”, lo reclamano, quando si accorgono che la sua poesia è una quanto mai dotta rivelazione divina. Ma attenzione! Bisogna considerare l’affermazione non con il piglio ecclesiastico o teologico, bensì con quell’afflato che innalza il pensiero contro le pastoie fabbricate dall’uomo su misticismo e religione, che lo solleva sopra le leggi, i codici, le convenzioni, le superstizioni umane, elevando un canto supremo e degno dell’universo che è quello della Parola, la stessa che l’Onnipotente usò per trasformare in carne il verbo. Fu custode del sangue più segreto, asciugò le lacrime agli angeli del bene e del male, consegnando alla storia un tesoro che nessun poeta ebbe mai a donarci negli ultimi secoli, perché i segni e i simboli adoperati sono una delle prove più certe che il linguaggio è un mezzo per mettersi in rapporto con l’ineffabile e l’imperscrutabile. E non appena i simboli diventano comunicabili a tutti i livelli perdono la loro portata ed efficacia.
Ha ragione Miller quando sostiene che chiedere al poeta che parli il linguaggio dell’uomo della strada è come pretendere che un profeta chiarisca le sue predizioni.
*
Pensate per esempio quanto “veggenti” furono le sue parole, quando Rimbaud si scaraventò contro l’amico Delahaye che sosteneva l’indubitabile superiorità dei conquistatori germanici: “Idioti! Dietro le stridule trombe e i melensi tamburi torneranno al loro paese a mangiar salsicce… Gli toccherà di trangugiare tutte le porcate della gloria. Vedo già la amministrazione di ferro e di pazzia che incasermerà la società tedesca…”. Pensate con quale precisione annunciò prima l’armamento dei tedeschi e poi l’avvento del nazismo e la sua sconfitta. Tenebre e luce sono il suo credo, al punto da essere conteso, con pari diritto, da ambo le parti. Questa è la sua gloria, ripeto…Quello che si mise sotto i piedi fu il mondo della morte vivente, il falso mondo della cultura e della civiltà. Spogliò lo spirito di tutti i vani ornamenti che sostengono l’uomo moderno. Il faut être absolument moderne! La battaglia spirituale è violenta quanto la battaglia degli uomini, ma la visione della giustizia è il piacere esclusivo di Dio. Dice Miller aggiungendo, è implicito che la nostra è una falsa modernità, la nostra è una battaglia non aspra o eroica come quella che combatterono i santi perché loro erano gagliardi e gli eremiti artisti, oramai fuori moda, purtroppo. Solo un uomo che sapeva valutare la disciplina, quella che si sforza di elevare la vita all’altezza dell’arte, poteva esaltare in tal modo i santi.
E non c’è modernità più di questa vera profezia, se la riferiamo a oggi, dove il tutto celebra la propria omologazione senza più mistero e dove le cassandre si sono rese verità esiziali contro le quali il potere, in mano ai soliti idioti, si fa luogo e misura della distruzione di clima e ambiente. E dove la poesia è ancora relegata al suo “rigor mortis”, ma non ha ancora esalato il suo ultimo respiro. Solo un virus, il COVID19, che senza eserciti e più piccolo migliaia di volte di un millimetro ha paralizzato il mondo antropocentrico, ci ha fatto profondamente riflettere su quali sono le “vie” e quali le “vie sbagliate”. E Rimbaud, quasi a confermare il suo genio, si rivela veggente assoluto, l’Absolument è il nostro respiro. I poeti, come fratelli, uniscano il loro, per intonare un grido alto nell’universo e nella storia, la nostra, prima che diventi la bara di tutte le creature. Absolument moderne, assolutamente moderno, importante che sia con la poesia, quella vera. Ecco quello che lui, come me, ha trovato in Africa, e da quelle parti, su quelle strade polverose, alita il suo spirito.
Dino Azzalin
(febbraio 1976-aprile 2020)
*In copertina: Arthur Rimbaud ad Harar, nel 1883
L'articolo Arthur Rimbaud, anima disperata, abbraccia la folle avventuriera Isabelle Eberhardt in Africa… Discorso su “Il tempo degli assassini” di Henry Miller proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2VR3VlG
0 notes
Text
“Se mi fosse concesso di gettare un solo grido verso Dio, sarebbe questo: Io voglio essere VERA”: sulle lettere di Katherine Mansfield
Un dettaglio non è dettato dal caso. Nel 1944, per Frassinelli, Cristina Campo, come Vittoria Guerrini, firma la traduzione di Una tazza di tè, antologia di racconti di Katherine Mansfield. La Campo ha 21 anni, è nata pochi mesi dopo la morte di Katherine, nello stesso anno, il 1923. Proprio quell’anno, ci informa un biografo, la Campo “scrive la sua prima poesia”. La poesia s’intitola Passo d’addio, ed è la prima – custode del titolo – delle undici poesie che la Campo pubblicherà nel 1956, per ‘All’insegna del Pesce d’Oro’, memorabile marchio Scheiwiller. “E mentre indugia tiepida la rosa/ l’amara bacca già stilla il sapore/ dei sorridenti addii”, è l’ultima terzina della poesia, tutelata da una epigrafe tratta dai ‘quartetti’ di Thomas S. Eliot – utile, credo, come spettro e passepartout per comprendere i racconti della Mansfield.
*
In Vita breve di Katherine Mansfield (già Rizzoli 1980, ora Adelphi), Pietro Citati tende a fare della scrittrice un tozzo di cristallo. “Tutti coloro che conobbero Katherine Mansfield negli anni della sua breve vita, ebbero l’impressione di scorgere una creatura più delicata degli altri esseri umani: una ceramica d’Oriente, che le onde dell’oceano avevano trascinato sulle rive dei nostri mari”. Credo, piuttosto, che sia un grido vetrificato, la verifica di un urlo, KM. Insomma, è una che rompe le consuetudini familiari e il canone degli affetti, che ha foga di vita, si affoga nel criterio del corpo. Nel 1909, l’anno prima aveva lasciato la Nuova Zelanda per Londra, KM se la fa con un violinista, poi sposa un maestro di canto – in funereo abito nero – da cui scappa, la prima notte di nozze, senza darsi. Incinta, la madre la sbatte in Baviera per evitare scandali e la disereda – lei abortisce spontaneamente, legge Anton Cechov e soprattutto conosce il di lui traduttore, un polacco sagace, con cui ha una storia. Insomma, Katherine è sfrenata, è un bicchiere di vetro lanciato in faccia. Se è una ceramica, vuole farsi spaccare.
*
Eppure, Mansfield – il cognome autentico è Beauchamp – sembra alloggiare nella mansuetudine, analogia in leggerezza. Piuttosto, probabilmente, è la cifra alchemica della sua scrittura: “Katherine Mansfield scrive con mani lievi: accenna, allude, sceglie con grazia gli aggettivi. È volutamente vaga – uno degli aggettivi prediletti della scrittrice neozelandese – perché preferisce che il significato rimanga sospeso, per così dire, aleggi impalpabile sulle cose”, scrive in una bella Nota alle traduzioni Franca Cavagnoli, che ha curato per Mondadori Tutti i racconti di KM (2006). Delle cose non abbiamo certezza di senso, ma di assalto.
*
Le lettere di KM hanno altezza impari, da paragonare – se piacciono i paragoni – a quelle di Emily Dickinson, della Woolf – che invidiava con turbe KM. Dicono che la sua vita sia consustanziale all’opera: d’altronde, di ogni grande scrittore possiamo dire che la carne si è fatta verbo. In uno dei racconti più belli, Alla Baia: “Ma quando Beryl si soffermò a osservare il bush, le parve che fosse triste. ‘Siamo alberi silenziosi che la notte stendono verso l’alto i propri rami per domandare supplichevoli qualcosa che nemmeno noi sappiamo’, disse il bush afflitto. È vero che quando si è soli e si pensa alla vita ci si intristisce sempre. L’eccitazione e tutto il resto improvvisamente ti abbandonano ed è come se, nel silenzio, qualcuno ti chiamasse e tu udissi il tuo nome per la prima volta. ‘Beryl!’”. C’è anche questo desiderio: essere chiamati per la prima volta, udire per la prima volta il proprio nome.
*
Dal luglio di un secolo fa vengono queste parole. “O Vita – misteriosa vita – che cosa sei tu? Forster dice: un gioco. Io sento ad un tratto come se da tutti quei libri venisse un clamore di voci – sì, i libri parlano – specialmente i poeti. Come sono belli i salici – come sono belli – come piove il sole su di essi – le minuscole foglie si muovono come pesciolini. Oh sole, risplendi per sempre! Mi sento un po’ ebbra – mi sento come un insetto caduto nel cuore d’una magnolia”. Nel 1919 KM è rotta dalla tubercolosi, in settembre andrà a Ospedaletti, sulla Riviera ligure. Ci sono stato spesso. A Bordighera, il comune che lo bordeggia, i miei nonni affittavano una casa, in estate, lì è morto mio padre, ho fatto l’amore, la prima volta. Che siano scritte per noi, ora, quelle parole, se ora possiamo finalmente capire KM, espulsa dal secolo, le sue esplosioni di vetro.
*
Che belle le lettere, mi dice Francesca Serragnoli – un poeta, finalmente! – perché tutto, lì, inizia e si conclude, senza replica, in una sfera, un mondo. In uno spazio autonomo e proprio, dico io, dove si attua l’attesa e l’indagine non è cosa pensa?, ma pensami!, in una Camelot della mente – e dunque, della carne.
*
Ristampate da Elliot nel 2016, le Lettere della Mansfield dicono un tratto – e il tormento – dell’editoria nostra. Le ho nell’edizione prima, del 1943, Mondadori, per ‘I quaderni della Medusa’, collana, leggo, che si occupa di “opere biografiche, critiche, libri di viaggio, di memorie ecc.” dei “grandi scrittori di fama universale”, stampati dall’editore “in traduzioni accuratissime come sempre, dovute all’ingegno e alla cura di egregi scrittori nostri”. Quindi: le Pagine di viaggio di D.H. Lawrence, i Ricordi di Lev Tolstoj, la biografia di Erasmo di Stefan Zweig. La ‘quarta’ è accattivante: “La fama di Katherine Mansfield, l’eccezionale scrittrice neozelandese, morta il 9 gennaio 1923 ad Avon, poco più che trentenne, anziché appannarsi va facendosi col tempo sempre più splendente e vasta; e l’influenza dell’arte sua si fa sentire continuamente, in profondità, nelle opere più elette della moderna letteratura narrativa. Sarà dunque accolto col massimo favore questo volume di ‘Lettere’ scelte e tradotte da una delle più delicate e originali scrittrici italiane, Milli Dandolo”. Su Emilia ‘Milly’ Dandolo, pubblicata con agio da Garzanti, Mondadori, Rizzoli, Treves, potremmo sbriciolare le consuete parole sulla vanità della fama: resistono ancora le sue traduzioni di Peter Pan e di Samuel Pepys.
*
“Ci sono lettere e memorie di scrittori tanto diverse dalla loro opera d’artisti, che spesso deludono o disorientano. Katherine è un personaggio delle sue novelle: e queste lettere sembrano ‘inventate’, per la meravigliosa capacità dell’artista che inventa la verità, o che trasforma la propria verità in un miracolo d’arte”, scrive la Dandolo. In effetti, è proprio quando scrive di sé, della sua vita, che lo scrittore inventa, si crea, dando viso agli eventi, sgambate al giorno. (d.b.)
***
A Lady Ottoline Morrell
Sabato pomeriggio, luglio 1919
Piove e io mi sento sola, fredda, abbandonata. Pregate per me. Conosco molto bene questo senso di dissolvimento, di vita incorporea: l’ho provato in quest’ultima settimana. Ero a letto, ridotta uno straccio, e piangevo e il pianto mi faceva tossire e l’estate era finita… Credo fermamente che sia venuto il tempo per una “parola nuova”, ma credo che non sarà facile dirla. La gente non ha ancora esaminato a fondo l’incantevole mezzo della prosa. È ancora una terra inesplorata – lo sento così profondamente.
*
A Dorothy Brett
luglio 1919
O Vita – misteriosa vita – che cosa sei tu? Forster dice: un gioco. Io sento ad un tratto come se da tutti quei libri venisse un clamore di voci – sì, i libri parlano – specialmente i poeti. Come sono belli i salici – come sono belli – come piove il sole su di essi – le minuscole foglie si muovono come pesciolini. Oh sole, risplendi per sempre! Mi sento un po’ ebbra – mi sento come un insetto caduto nel cuore d’una magnolia.
*
A William Gerhardi
21 novembre 1921
Sapete, ve lo dico in confidenza, io non sarò per molto tempo ‘di moda’. Mi si scoprirà; tutti saranno disgustati, rabbrividiranno di sgomento. Mi piacciono tante cose terribilmente fuori moda – e la gente. Mi piace sedere sulle soglie delle porte, chiacchierare con la vecchia che porta le mele cotogne, andare in gita nelle piccole vetture traballanti, ascoltare la musica dei giardini pubblici nelle sere d’estate, parlare ai capitani dei piccoli battelli malandati, a gente d’ogni genere in poti d’ogni genere. Ma che fatale periodo ho cominciato! Continua per sempre. Davvero, occorrerebbe un’intera vita per finirlo…
Vedete, non sono un’aristocratica; le colazioni domenicali e le complicate conversazioni sul problema sessuale e quel languore che è così importante e quello spirito che è ancora più importante – vedete, io fuggo tutte queste cose. Io sono innamorata della vita, terribilmente… Sì, vivo in Svizzera perché sono tisica. Ma non sono inferma. La tisi non mi appartiene. È solo un orribile cane vagante che mi perseguita da quattr’anni, e così io cerco di perderlo tra queste montagne. Ma immobilizzata per sempre – oh no!
*
Ad Arnold Gibbons
13 luglio 1922
…L’importante è scrivere – trovare se stessi perdendo se stessi. (Non c’è verità più profonda). Non so davvero se in questo mondo – fatto com’è fatto – il dolore sia assolutamente necessario. Ma non vedo che noi possiamo giungere alla conoscenza e all’amore se non attraverso il dolore. Ciò pare troppo definito, espresso così poveramente – se parlassi, potrei fare delle riserve… Ma devo credere nel dolore.
*
A John Middleton Murray
26 dicembre 1922
…Vedi, la domanda è sempre la stessa: Chi sono io? E fin che non si è trovato la risposta, io non vedo come si possa governare se stessi. C’è un ‘io’? bisogna essere persuasi di questo prima di sapere come bisogna sicuramente comportarsi. E io non credo nemmeno per un momento che questi problemi possano essere risolti solo col cervello. È questa vita del cervello, questa vita intellettuale a prezzo di tutto il resto che ci ha condotti in questa situazione. Come può aiutarci ad uscirne? Non vedo speranza di salvezza, se non si impara a vivere secondo le nostre emozioni e i nostri istinti, mantenendo tutto in equilibrio.
Vedi, se mi fosse concesso di gettare un solo grido verso Dio, sarebbe questo: Io voglio essere VERA. Fin che non sarò così, non vedo come potrò non essere sempre alla mercé della vecchia Eva in tutte le sue manifestazioni… Per il momento so veramente, veramente, che tutte le cose una dopo l’altra mi sono state tolte, ma che non sono annientata – e che spero – e più che sperare – credo. Mi è difficile spiegarmi… Tutto passerà come un sogno, con irrisorie consolazioni…
Katherine Mansfield
L'articolo “Se mi fosse concesso di gettare un solo grido verso Dio, sarebbe questo: Io voglio essere VERA”: sulle lettere di Katherine Mansfield proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2JR1Q4h
0 notes
Text
Benjamin Tammuz compie 100 anni. Lui è il Minotauro, l’enigmatico Kurtz che si aggira nel labirinto della letteratura
Minotauro deve morire – e chi ha contratto affetto per lui muore in eccesso d’afflizione. Tra il Minotauro e l’agnello sacrificale non c’è larga distanza: Minotauro non è il mostro a cui vengono offerti giovani vergini per placare la fame inusuale – e la lussuria – piuttosto, è il condannato a morte. Il labirinto è il sicario, la ghigliottina.
*
Non è irrilevante la sottigliezza degli dèi nell’arte del vendicare. Minosse è figlio di Europa e di Zeus in forma di toro; Poseidone, per punire l’orgoglio di Minosse, fa innamorare sua moglie, Pasifae, del toro. Dalla loro unione nasce Minotauro: a conti fatti, immagine enigmatica e gemella di Minosse. Pur sempre una donna che si unisce alla bestia. Labirinto come si sa è ricalcato sul palazzo di Minosse, a Cnosso, fitto di corridoi dalle brusche curve, di spirali. La sfida di mostruosità tra Minotauro e Minosse non c’è; non sarà un caso che Minosse è posto come giudice delle anime – e che l’inferno dantesco abbia affinità logistiche con labirinto. Sa srotolare in prato il labirinto che è l’uomo.
*
Le cifre in cui si colloca la vita di Benjamin Tammuz reclamano un ordine. Nato 100 anni fa, l’11 luglio del 1919 in Unione Sovietica, muore trent’anni fa, a Gerusalemme, il 19 luglio del 1989. Un rigore cristallino spira nella data di nascita e di morte di Tammuz – sono certo che modellando la cabbala delle cifre di nascita e morte si possa dar ragione di una esistenza, ditemi superstizioso giocatore di dadi –, che contrasta con i dati assai scarsi intorno alla sua vita. Una nota – di pallida brevità – pubblicata sul New York Times avverte: “autore israeliano di origine russa, scultore e sostenitore della convivenza tra arabi ed ebrei, è morto di cancro, aveva 70 anni”. Ignoravo che fosse scultore. Negli anni Cinquanta Tammuz ha studiato alla Sorbona, a Parigi, “ha partecipato a molte mostre collettive, una sua opera, dedicata ai piloti israeliani, è visibile presso il parco dell’Indipendenza di Tel Aviv”. A leggere il ‘coccodrillo’ parrebbe un artista, mentre è uno degli scrittori più folgoranti del cinquantennio. Almeno. Per quel libro.
*
Non ho trovato interviste di Tammuz. Alcune note biografiche lo ricordano come giornalista – per il giornale Haaretz – altre ricordano il suo ufficio culturale presso l’ambasciata israeliana a Londra (è stato anche scrittore ‘residente’ a Oxford), altre ancora segnalano il suo impegno politico e artistico nel gruppo dei cosiddetti Cananei. Su Tammuz, insomma, ci sono poche notizie, per lo più difformi, eppure è uno degli scrittori israeliani contemporanei di maggior talento. In Italia, i suoi libri sono pubblicati dalle Edizioni E/O. Li ho letti. Il frutteto e Requiem per Naaman sono romanzi ben costruiti, delicati e arsi. Poco più che interessanti. Il minotauro è un romanzo perfetto.
*
Bejamin Tammuz sembra una sorta di Kurtz, è inafferrabile quanto l’Aleksandr Abramov del suo capolavoro. Il minotauro (tornato in edizione E/0 nella collana ‘Le Cicogne’), in effetti, è una sorta di Cuore di tenebra: entrambi i romanzi sono focalizzati su un ‘mostro’ – Kurtz nel caso di Conrad, l’ineffabile agente segreto innamorato arcangelicamente della ragazzina, Thea, nel libro di Tammuz – c’è un labirinto – l’Africa oscura, le oscurità occidentali; in entrambi: le sinuosità del cuore umano – e hanno una costruzione romanzesca impeccabile. Tutta la vicenda, letta attraverso un conturbante scambio di lettere, è narrata da Tammuz nelle prime trenta pagine del primo capitolo, L’agente segreto. La stessa vicenda, poi, è vista dagli occhi delle vittime e del mostro. Che dall’amore scaturisca la morte è un pensiero comune, ma che un amore mai consumato, neppure in favore d’occhi, chieda il sacrificio di innocenti è una tormentata mostruosità.
*
Diverse sono le versioni moderne del mito di Minotauro: quasi tutte riabilitano la mostruosità in un difetto di sguardo umano, spesso il mostro si abbandona alla morte con carezzevole resa, di solito si mesce il mito greco a quello favoloso de “La Bella e la Bestia”, in ogni variante, anche cinematografica. Da Cesare Pavese a Borges – che capisce che il ‘mostro’ è “la casa”, cioè il labirinto – da Marguerite Yourcenar a Friedrich Dürrenmatt, il Novecento è costellato di Minotauri. Spesso ci si dimentica che la bellezza, alla greca, è unione tra armonia del corpo umano e bestialità, Dioniso che cavalca la tigre, le Baccanti che s’imbestiano, Eracle travestito da leone, gli dèi che prendono figura di belve seducenti. Tra uomo e bestia non c’è l’anatomica e automatica distinzione che assegniamo, cervellotici, ora. Minotauro è bello perché spaventoso, unione perfetta tra uomo e bestia – è bello perché è nascosto, come il dio nel tempio – le spire del labirinto come le volute del fumo d’incenso. Con efficacia narrativa Tammuz ha creato un romanzo dalla struttura labirintica, con uno straordinario Minotauro: dell’agente segreto non scopriamo il volto – che gli viene rifatto e contraffatto – ma la sconvolgente capacità seduttiva. Thea è innamorata di un enigma – non sa chi le scrive, chi è così ferocemente innamorato di lei, con una dedizione tanto accurata – e di una crudeltà.
*
All’epoca – pubblicato in Israele nel 1980, tradotto in inglese l’anno dopo – Il minotauro colpisce l’attenzione di Graham Greene, che ne parla come del “miglior romanzo dell’anno”. Nitidezza formale, glaciale ferocia, la filiazione di Kafka – “avrei voluto Kafka per amico; e credo, nella mia grande stupidità, che avrebbe acconsentito. Aveva un’enorme clemenza; amava gli uomini e avvicinava anche i pazzi. Avrei avuto buone speranze” – sorprendono. Qualche anno fa, in virtù di riedizione, Maureen Corrigan lo elogia sul Washington Post. Cannando un po’ il tiro: sentendo odore di ‘ninfetta’ – l’agente segreto scopre Thea su un autobus, ha una moglie, due figlie, “E io ho quarantun anni, e lei all’incirca diciassette. Ventiquattro anni” – il recensore cita Nabokov. Il concetto è contrario, però: qui più si ama più ci si allontana. Minotauro è come dio: non consuma l’atto, protegge. Imprigiona. Non mi avrai, ma sei mia – non avrai altri che me, l’immagine che hai di me.
*
Il cuore è qui: “In nessun modo potremo essere quello a cui eravamo destinati. Riunirci sarà impossibile. Il motivo è semplice, banale e umiliante, ma non voglio parlarne, perché se lo facessi, sapresti che ho paura e allora dubiteresti del mio amore. Ecco, ho già detto troppo. Ti amo, Thea. Se c’è un Dio ci farà incontrare lì dove ti ho sognata o immaginata per la prima volta, prima che tu nascessi. Se Lui non farà questo per noi, vuol dire che non è Dio, o che non esiste affatto, o che è solo un ufficio: efficiente ma indifferente”.
*
Il labirinto è la Storia, tesa a svelarsi fino alla scoperta di Dio, Minotauro infinito. Possiamo essere Arianna, e attendere che il mostro si faccia uomo – o rischiare in Teseo, perché di tutti è il sogno di decapitare il dio. In terra d’Israele labirintico è il libro.
*
Che colpa ha avuto Minotauro, che cosa gli si imputa, perché non sfamarlo dandogli in sposa la sorella?
*
In una versione del mito, Minotauro è un bambino quando lo gettano nelle fauci di labirinto. Cresce e trova il modo di scrivere lettere in alfabeti mai visti ad Arianna, l’amata sorellastra di cui solo sa l’odore. Infine, lei sceglie le vie contorte di labirinto, si unisce a Minotauro, e mettono casa, dove i muri sanno di foresta. Sia onore a Tammuz, ha scritto uno dei libri segreti e magnetici – si può preferire il mistero alla stabilità, si può morire per un amare senza carne, perché letale è immaginare. (d.b.)
L'articolo Benjamin Tammuz compie 100 anni. Lui è il Minotauro, l’enigmatico Kurtz che si aggira nel labirinto della letteratura proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2NHGiv2
0 notes
Text
Ho perso la testa per questo libro (che ritorna tra noi!): “Il minotauro” dell’enigmatico Benjamin Tammuz
Le note biografiche lo scarnificano – c’è poco da sapere, in effetti – piuttosto, ricordo lo shock dovuto all’opera – devastante – mi chiesi, sollevando occhi inceneriti, e questo da dove viene?
*
Viene da Israele, Benjamin Tammuz, nato da ebrei russi, in Unione Sovetica, un secolo fa (nel 1919), trapiantato in Palestina dall’età di cinque anni, scuole a Tel Aviv, studi alla Sorbona, il tic per l’arte – è pittore, scultore – la pratica come giornalista presso Haaretz, le gite colte a Londra – dal 1979 al 1984 è scrittore residente all’Università di Oxford. Muore nel 1989.
*
Di shock simili ne ricordo un paio. Pedro Paramo di Juan Rulfo e Il mondo estremo di Christoph Ransmayr. Intendo: sono libri da cui, pregiudizialmente, ti attendi un lago e in cui scopri, navigandoli, un oceano. Il minotauro fa lo stesso effetto. Un effetto, devo dire, subdolo: al principio, desiderai esserne l’autore. Poi, cominciai a comprarne una sfilza di copie – per rileggerlo, per regalarlo. Ora non ne ho più.
*
Non fui l’unico a essere sorpreso. Il libro, pubblicato nel 1980, fu giudicato semplicemente geniale da Graham Greene. I giornalisti non sapevano che pesci prendere. David Quammen, sul New York Times, scrisse che Il minotauro “è uno strano solitario romanzo di amore e spionaggio, sulle attese e i compromessi di cui gli uomini si cingono… molto simile a ciò che fa William Faulkner in L’urlo e il furore e Lawrence Durrell nel ‘Quartetto di Alessandria’”; l’onesto recensore della Kirkus Review, negli stessi giorni, era l’estate del 1981, rimarca gli “echi da Franz Kafka e Joseph Conrad”; Maureen Corrigan, l’altro ieri (era il 2013), dal soglio del Washington Post, legge la riedizione del Minotauro e gli pare una mostruosità che sta tra Lolita – “alcune pagine le avrebbe potute scrivere Humbert Humbert” – e Il grande Gatsby. Una fiera di giganti – Faulkner, Durrell, Kafka, Conrad, Nabokov, Fitzgerald – per arginare lo stupore. Io ci vedo Kafka, ovvio. E una struttura narrativa che è come un cappio al collo.
*
Il romanzo è questo. Un uomo – anzi, “un tale” –, che “era un agente segreto”, ha quarantuno anni, vede una ragazza, che ne ha “all’incirca diciassette”, in un autobus e la riconosce: è lei, che si chiama Thea, la donna del suo destino. “L’ho vista d’un tratto sedersi davanti a me sull’autobus. Non ho avuto alcuna difficoltà a riconoscerla”. Il tale, allora, comincia a scrivere delle lettere a Thea – che non lo ha riconosciuto – e a determinarne – spiandola, talento di professione – l’esistenza. Thea è lusingata e imbronciata (“non è carino lasciare le cose in sospeso come fa lei”). Lui è determinato, letale, romantico (“Ti sto togliendo le scarpe e sto baciando le dita dei tuoi piedi. Le conosco, così come conosco ogni linea del tuo corpo. Non irritarti, non aver compassione. Non avevo mai conosciuto la felicità finché non ti ho incontrata”). Nel libro, scritto con stupita freddezza, con suprema indifferenza, scopriamo l’infanzia del “tale”, veniamo a sapere che, dopo alcune rovinose missioni spionistiche, ha dovuto modificare i tratti del suo viso – irriconosciuto, irriconoscibile –, assistiamo alla fine dei vaporosi amanti di Thea.
*
Il romanzo pare perfetto. Il lettore è recluso nell’hangar di due solitudini, che mai verranno in contatto. Il rapporto tra i due è così sacro che il disvelamento sarebbe assassino. Soprattutto, spiamo – dacché i guardoni siamo noi, estasiati dalle lettere di questo amante misterioso – l’esito di un amore del tutto mentale: un uomo è fulminato dal viso di una donna – che non si accorge di lui – e decide che è lei e nessun altra. D’altronde, l’amore è così: disciplina, ossessione, spreco. Si ama solo l’irraggiungibile. Per amare bisogna essere un romanziere, consapevoli che i sentimenti sono giungla, sbandata di tigri.
*
Di certo. Il buono e il cattivo del Minotauro, romanzo che ha la nitidezza degli assoluti, è che è come se Tammuz ti mettesse una benda in gola. Prima ti fa godere – infine ti soffoca. La prima volta mi ha sorpreso, la seconda mi ha stordito – ho voluto studiarne l’involuta, volumetrica tecnica narrativa – la terza mi ha sfiancato. Ora Il minotauro torna in libreria, nella collana ‘Le Cicogne’ delle Edizioni e/o (pp.176, euro 11,90), che raduna i piccoli classici della casa editrice. Spinto dall’entusiasmo per Tammuz, ho letto un paio di altri suoi romanzi, Requiem per Naaman e Il frutteto. Buoni romanzi, per carità – del tutto incomparabili a Il minotauro.
*
Lui è Benjamin Tammuz (1919-1989): “Il minotauro” è pubblico nel 1980, l’anno dopo esce in UK, con Graham Greene entusiasta
Nello scarno ‘coccodrillo’, pubblicato il 21 luglio 1989, il New York Times ricorda che Tammuz, “morto di cancro, a 70 anni”, tra i massimi scrittori israeliani contemporanei, “è stato uno dei leader del movimento Canaanita, che ha cercato di costruire una nuova nazione ebraica, in opposizione al giudaismo, per aggirare il conflitto con gli arabi. Il movimento non ha mai ottenuto alcun supporto da Israele ed è sostanzialmente riconosciuto per il ruolo importante nell’aver trasformato l’ebraico biblico in un linguaggio moderno”. Secondo Ron Kuzar (Hebrew and Zionism, New York, 2001), alcuni membri del movimento facevano parte delle falangi paramilitari sioniste Irgun e Lehi. Probabilmente anche da questo retroterra proviene il “tale” del Minotauro.
*
Resta il titolo: chi è il Minotauro? Il “tale” dei servizi, innamorato dell’amore impossibile, impassibile nell’esercizio della sua professione, fino alla fine, crudele, viene da dire. Ma si è mai visto un Minotauro che scrive lettere d’amore? Minotauro – il ‘mostruoso’ – è l’innocenza di Thea, speculo, io. Il labirinto è l’esistenza, che dietro l’angolo ci fa sommuovere con risposte inattese – labirinto nel labirinto nel labirinto, è la vita umana. Il “tale”, in fondo, credendosi Teseo, è preda compiaciuta dell’innocente – del suo sogno di innocenza.
*
Comunque rivolti il cervello, Il minotauro di Benjamin Tammuz è un romanzo bellissimo. Quasi decisivo. (d.b.)
L'articolo Ho perso la testa per questo libro (che ritorna tra noi!): “Il minotauro” dell’enigmatico Benjamin Tammuz proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2EcqKL3
0 notes