#corpo come metafora
Explore tagged Tumblr posts
Text
“Nel condominio di carne” di Valerio Magrelli: Un Viaggio Autobiologico tra Corpo e Psiche, Recensione di Alessandria today
Un’intima esplorazione del corpo umano, tra letteratura e scienza, in una narrazione originale e viscerale
Un’intima esplorazione del corpo umano, tra letteratura e scienza, in una narrazione originale e viscerale “Nel condominio di carne” è un’opera unica nel panorama letterario, in cui Valerio Magrelli esplora il proprio corpo come un “condominio��� abitato da innumerevoli entità e memorie. Questo libro rappresenta un viaggio interiore tra anatomia e introspezione, in cui l’autore si racconta…
#Alessandria today#anatomia e memoria#anatomia interiore#autobiografia fisica#autobiologia#Ballard#corpo come metafora#corpo umano#corpo umano come diario#Cronenberg#diario anatomico#Einaudi Editore#Einaudi Stile Libero#esplorazione del sé#filosofia del corpo#Francis Bacon#Google News#identità e corpo#immagini poetiche#introspezione e scienza#Introspezione Profonda#introspezione psicologica#italianewsmedia.com#LETTERATURA CONTEMPORANEA#letteratura d’avanguardia#letteratura e medicina#letteratura e scienza#letteratura italiana#memorie corporee#narrativa italiana
0 notes
Text
iperbole
Inoculare sacri terrori nel corpo sociale – che è ormai un irriconoscibile corpaccione – è l’imperativo categorico di ogni potere. Lo è da sempre, si sa. Senonché non serve più che tale orrorifica istillazione avvenga secondo un piano preordinato e verticale. Il corpaccione di cui sopra se lo produce e se lo inocula da sé, volontariamente ed orizzontalmente, senza che alcun medico luminare glielo ordini. Dosi sempre più massicce di paure sempre più impalpabili e spesso posticce. Allo scopo anything goes: lo spread o i Maya, il gelo siberiano o la crisi finanziaria, il nucleare iraniano o una qualche influenza con una qualche misteriosa sigla, nonché immancabili capri espiatori vari & eventuali – meglio ancora una pozione magica ottenuta mescolando tutti questi ingredienti a casaccio. Magari da iniettare subito in rete, da far circolare capillarmente e da interiorizzare per bene, ganglio dopo ganglio, creando l’illusione che tutto si sia fatto da sé. E d’altra parte è vero che si è fatto da sé. Autorealizzazione di paure autoindotte. Si ottiene inoltre il risultato di innalzare di un altro grado la soglia immunitaria, dimenticando che vaccinarsi contro ogni cosa comporta il rischio di vaccinarsi contro la vita stessa e il suo fluire – in definitiva contro se stessi. Come succede con le malattie autoimmuni. Se qualcuno pensa che ci possa essere una cura per l’iperbole sociale che ho provato a descrivere servendomi di un’iperbole linguistica (o, se si preferisce, di una serie di biometafore, peraltro prodotti sociali a loro volta) – la risposta è no. E ne dubito perché siamo ormai al capezzale del paziente; e significherebbe inoculare l’ennesima sostanza in un corpo esausto – un vero e proprio accanimento terapeutico con avvitamento ipertossico. Meglio forse far fuori il corpaccione e sbarazzarsi del cadavere; aspettare che marcisca e magari provare a usarlo come concime nell’attesa che cresca qualcos’altro. Oppure uscire addirittura dalla metafora. Fuor di metafora, come si suol dire.
-La botte di Diogene
24 notes
·
View notes
Text
Il comunismo cosmico di Franco Piperno - Jacobin Italia
Il comunismo cosmico di Franco Piperno - Jacobin Italia https://search.app/77gv63Re1jyNniS48

Il comunismo cosmico di Franco Piperno
Giuliano Santoro
15 Gennaio 2025
Dalla terribile bellezza del lungo Sessantotto al municipalismo, sempre osservando e raccontando le stelle: addio a Franco Piperno
Nella mia infanzia, al nome di Franco Piperno associavo una specie di brigante- licantropo. Mio padre mi portava ad Arcavacata, nel campus dell’Università della Calabria, a vedere «i lupi di Piperno». Cominciavamo a girare attorno alla rete al di là della quale vivevano i lupi. Mio padre certe volte prendeva un bastone e lo batteva sulla recinzione, perché venissero fuori e li potessimo vedere. Una volta uscirono fuori dagli arbusti all’improvviso, come accade nei film di paura quando la colonna sonora accompagna la tensione fino a farla esplodere. Grosso spavento e poi grosse risate. Chissà se quel Piperno, che Andrea Pazienza disegnava coi peli lunghi che uscivano dalle orecchie (appunto, un licantropo), ci guardava dal suo nascondiglio, con cappello a falde larghe, mantello e stivali.
Ma perché, poi, se ne stava rintanato? Quale sceriffo gli dava la caccia e quale reato gli veniva imputato? Mio padre non me lo spiegava e io non glielo chiedevo. Uno si immaginava questo signore che si era dato alla macchia, ma che allevava a distanza addirittura dei lupi. Venne fuori un altro indizio sulla licantropia del Pip. Proprio lui, «quello dei lupi» era anche solito uscire di notte e guardare le stelle.
Siccome la vita è fatta di cerchi che si chiudono e di anni che ritornano, a vent’anni dal mio primo incontro coi lupi finalmente chiesi a Pip quale fosse la loro storia. «Me li regalò un mio amico del dipartimento di ecologia dell’Università della Calabria che si occupava di lupi e di falchi – ha raccontato Pip – Li allevai amorevolmente, li allattai, li seguii, li filmai. Quei cuccioli mostravano un rapporto con la vita e con la violenza senza nessuna sbavatura e ridondanza. Era una dimostrazione di essenzialità. Sembravano chirurghi, quando azzannavano i conigli vivi». Ma perché li tenevi rinchiusi, Pip? «Volevo loro molto bene. Ne ero affascinato, ma ero costretto a tenerli in quel recinto. Altrimenti avrebbero azzannato le pecore dei contadini e quindi sarebbero stati uccisi. La natura aveva fornito loro un’autonomia totale, ma erano finiti per benevolenza umana in un recinto». In tutto ciò, Pip riconosceva la metafora della sua generazione: «Mi parlavano di quanto accadeva a molti dei miei compagni ed amici e un po’ anche a me stesso. Penso in particolare a mia moglie Fiora, che era stata condannata a dieci anni di galera per associazione sovversiva». Come finì? «Per otto mesi non mi staccai da quei lupi. Poi ricevetti anche io un mandato di cattura e non mi parve il caso di scappare con due lupi, era troppo complicato. Allora il rettore dell’università li accolse in quel grande recinto del campus di Arcavacata».
La storia dei lupi, della loro autonomia e della loro selvaggia potenza costrette dentro una prigione dimostra che Franco Piperno, scomparso a Cosenza il 13 gennaio 2025 a 82 anni, conosceva bene l’arte della retorica e della seduzione linguistica, usava gli aggettivi e gli avverbi da consumato spadaccino della discussione. Come un lupo coltivava l’agguato. Come quando ci spiegava che nel Sessantotto si era smesso di investire sul futuro e si era scelto di giocare tutto sul presente. Era stato il movimento statunitense, diceva Piperno, che «aveva indicato la possibilità di sostituire alla lotta per la presa del potere la sperimentazione collettiva di una diversa vita civile, basata sulla produzione autonoma di relazioni comunitarie, capaci di far posto al corpo, cioè alla sensualità e al piacere». Precisava: «Questo è un punto decisivo perché è come praticare l’esodo, dove esodo non significa più, come gli antichi ebrei, andare via dall’Egitto per raggiungere la terra promessa; piuttosto lasciare emergere un diverso Egitto dal suo stato di latenza».
Piperno dalla Calabria si era spostato, da studente, a Pisa e poi a Roma. Cacciato dal Pci per «frazionismo», era stato tra i fondatori di Potere operaio, con Toni Negri, Oreste Scalzone, Sergio Bologna, Mario Dalmaviva e tanti altri. Era una delle organizzazioni che si formarono nel contesto del lungo Sessantotto italiano ma anche la prima ad autosciogliersi, nel 1973. «Toni dice che eravamo una specie di strana massoneria – mi raccontò una volta, col consueto sarcasmo – Era difficile entrare ma una volta che eri dentro tolleravamo qualsiasi follia». Si differenziava da alcuni suoi compagni di strada che si sono formati alla formidabile scuola della «nefasta utopia» dell’operaismo politico, come la chiamava sarcasticamente Franco Berardi Bifo in un saggio di qualche anno fa. Non cercava nessuna centralità lì dove è più alto lo sviluppo capitalistico. Ma manteneva una caratteristica dello stile operaista, che lo preserva da qualsiasi forma di teorizzazione prescrittiva e lagnosa. La si riconosceva quando affermava che il comunismo, inteso come abolizione della riduzione della forza-lavoro a merce, non bisogna costruirlo magari armati di buone intenzioni e libretti rossi. Esso è già in atto. La potenza della cooperazione sociale è già, qui ed ora, più forte della solitudine del capitalismo. Bisognerebbe prenderne atto, dunque, e per questo vivere meglio. «La festa sessantottina è ritrovare l’interezza dell’essere – scriveva ancora Pip – dove nulla eccede o esclude, per essere completamente sé stessi, occorre fondarsi con gli altri nel tutto; come quando nel carnevale si è donne uomini animali, tutti insieme ebbri fino al punto che l’orgia appare sulla soglia, come assolutamente possibile».
Negli anni del ritorno in Calabria, dopo l’esilio in Canada e Francia a seguito della persecuzione giudiziaria che dal 7 aprile del 1979 in poi colpì lui e tanti suoi compagni e compagne, si occupò di Sud, del rapporto tra sviluppo e ricchezza sociale, della critica del tempo lineare del capitale. Prese la cattedra di fisica della materia e promosse, a Cosenza, la nascita dell’emittente comunitaria Radio Ciroma e lanciò in tempi non sospetti, ben prima dell’epoca di Porto Alegre e della democrazia partecipativa su base locale, la suggestione del municipalismo: «Potere alle città, potenza ai cittadini». Un piccolo aneddoto per dire della capacità di stare nelle cose del mondo. Erano i primi anni Novanta quando, ospite di una tribuna elettorale per esporre il programma della lista civica comunale che aveva messo insieme ai suoi, impiegò il tempo che gli era concesso per tessere l’elogio del locale collettivo di studenti medi che si dedicava alla crescita comune e al mutuo appoggio invece che per chiedere esplicitamente voti. Il dettaglio sta nel fatto che quegli adolescenti (mea culpa: quando si è così giovani si ha il diritto di essere estremisti) impegnavano parte del loro tempo anche a criticarlo duramente, imputandogli una qualche deviazione da chissà quale ortodossia rivoluzionaria. Chapeau, Franco.
Divenne, sempre a Cosenza, per due volte assessore «al planetario» e al traffico. Ruolo che interpretò invogliando gli agenti della polizia locale ad applicare con rigore il codice della strada per dissuadere i suoi concittadini dall’uso dell’automobile anche per i piccoli tratti. E uno dei suoi vecchi compagni infilò una battuta fulminante: «Finalmente Franco è davvero a capo di una banda armata». La sua nomina ad amministratore la si deve a Giacomo Mancini, segretario socialista prima di Craxi e ministro che concluse nella sua Cosenza la sua carriera politica. E che in nome del garantismo aveva difeso Piperno e tutti gli autonomi imputati. C’è una scena che rivela cosa rappresentasse Mancini all’epoca della grande repressione. Il 9 marzo del 1985 la polizia aveva ucciso a Trieste il militante dell’autonomia Pietro Pedro Greco, sparandogli addosso con la scusa che aveva scambiato un ombrello per un fucile. I funerali di Pedro si tennero nel suo paese d’origine, un villaggetto della provincia di Reggio Calabria. Bisogna immaginare che clima ci fosse: pochissimi compagni, affranti e braccati, con le bandiere rosse nel paesaggio lugubre della temperie degli anni Ottanta. A un certo punto davanti alla chiesa si fermò un’automobile e ne scese il leader socialista. Era l’unico personaggio politico a partecipare alle esequie e chiedere giustizia per quella morte.
Le analisi di Piperno di questa fase mettevano insieme l’osservazione filosofica e antropologica delle forme di vita meridiane con la strabiliante capacità affabulatoria di quando raccontava il cielo. Chiunque abbia avuto la fortuna di fare un’uscita notturna nei boschi con lui per assistere allo Spettacolo cosmico che metteva in scena spiegando le stelle, non può dimenticare il modo in cui teneva insieme nozioni astronomiche, narrazioni mitologiche, considerazioni esistenziali, divagazioni politiche. Era un modo di mettere in pratica la convinzione che le diverse materie erano fatte per essere mescolate, messe a confronto, intrecciate e che non esisteva la neutralità del metodo scientifico. Questo doveva essere il senso dell’università, sosteneva Piperno: un luogo in cui tutti i saperi si incontrano, oltre la gabbia delle discipline.
Quando, nel 1978, le Brigate rosse rapirono Aldo Moro, Piperno era già tornato in Calabria, a insegnare Fisica della materia all’università. Capì che la morte del presidente della Democrazia cristiana sarebbe stata un disastro per tutti i soggetti in campo e si adoperò per salvargli la vita, approfittando anche del fatto che nel frattempo alcune sue vecchie conoscenze del Potere operaio romano avevano scelto di entrare nelle Brigate rosse. Gli rimase appiccicata una formula, quella che invitava a coniugare la «geometrica potenza» di via Fani con la «terribile bellezza» degli scontri di piazza del 12 marzo del 1977 a Roma. Era un modo per dire che ogni forma di scontro, anche la più radicale, non avrebbe dovuto prescindere dalla dimensione di massa. Ma la formula, che lui stesso avrebbe definito dannunziana, passò per l’esaltazione del terrorismo. Sempre alla Commissione parlamentare d’indagine sul terrorismo, Piperno disse senza mezzi termini ciò che pensava di quella vicenda e dei motivi che lo spinsero a immischiarsi nell’affaire: «Le Br erano davvero convinte che si potesse interrogare Moro e scoprire i legami con gli Stati uniti – affermò – C’era un livello di analfabetismo politico nel gruppo dirigente delle Br che faceva paura e che peraltro secondo me traduceva la situazione ingarbugliata del paese».
Accanto a saggi pensosi e a scritti densi (molti dei quali raccolti negli ultimi tempi dalla rivista online Machina), Piperno era abilissimo nel motto di spirito, nella risposta ironica lapidaria e dalla logica stringente, maneggiava paradossi che ti mettevano con le spalle al muro. A un interlocutore che in un programma televisivo gli rinfacciava di aver esaltato l’uso della violenza, replicò trasecolato ricordando con una metafora iperbolica il contesto della «piccola guerra civile italiana» degli anni Settanta: «Mi chiede se la violenza è giusta? È come se mi chiedesse se cacare è bello. Cacare non è giusto, è inevitabile». In un’altra occasione, venne accusato di aver favorito coi suoi amici sessantottardi la pratica del libero amore, contro la famiglia tradizionale: «Noi non costringevamo nessuno – replicò Pip, sinceramente sgomento – Se uno voleva essere libero poteva farlo, ma non era obbligato. Con noi a volte c’erano anche preti e suore, nessuno li costringeva al libero amore».
Una vita talmente piena, colma di tentativi, errori, sconfitte avventurose ed esperienze irripetibili, viene riassunta dalle cronache con formule giudiziarie e immaginette pigre e precostituite. Delle quali Piperno era consapevole. Anzi, ci giocava. Una decina di anni fa mi trovai con Franco a Torino, per un dibattito al quale avremmo dovuto partecipare. A un certo punto entrammo in una piccola rosticceria di fronte a Palazzo Nuovo per mangiare un boccone. Venne fuori che anche la signora che ci serviva al bancone era di origini calabresi. Allora attaccammo discorso. Lei era evidentemente sedotta dal suo eloquio elegante. (C’era un vezzo, non solo di Franco devo dire, che portava a mescolare il linguaggio di tutti i giorni a parole d’altri tempi: gendarme per dire poliziotto, malfattore per dire bandito, querulo per dire piagnone e così via). «Ma sa che non si sente molto che lei è di giù? Che mestiere fa?», gli disse la locandiera. Lui rispose con gli occhi di ghiaccio che ridevano, l’inconfondibile erre arrotata e i peli che gli uscivano dalle orecchie ben pettinati: «Dev’esserhe che sono stato in prhigione».
* Giuliano Santoro, giornalista, lavora al manifesto.
# Franco Piperno
# fondatore e dirigente di Potere operaio 1968
#università della Calabria / professore di fisica
# esilio in Francia e Canada
Brillante e raffinato intellettuale, rivoluzionario alla luce del sole ( citazione da "Il Manifesto), mai contraddittorio. Uomo profondamente legato alla sua terra di origine : la Calabria.
13 /1/2025 C' è luna piena e Venere e le stelle.. Buon viaggio. 🌹💫💫💫
16 notes
·
View notes
Text
Lei sa che l’eccitazione sessuale può smuovere anche una montagna con la stessa facilità con cui, una volta saziata, lascia franare i massi. E non importa se, nella caduta, i massi possono spaccarti la testa. Per gli uomini, dopo che l’eccitazione è esplosa come lava di un vulcano, tutto finisce o, per continuare la metafora, si raffredda e si arresta. Mentre lo stesso desiderio incandescente nel corpo di una donna si deposita come semente e cresce fino a trasformarsi in vera e propria brama di possesso. Poi, tiepido, cullato sotto la pelle e nel cuore della donna, il desiderio – lo stesso desiderio poco prima condiviso – si rassegna a rimanere solo come un uccello che cova le proprie uova in uno stato di nostalgico rapimento.
Marcela Serrano - L’ albergo delle donne tristi
Ph Roger Rossell
25 notes
·
View notes
Text

Kintsugi la filosofia giapponese come...
"Il Kintsugi non è solo una tecnica di restauro, ma ha un forte valore simbolico. Rappresenta la metafora delle fratture, delle crisi e dei cambiamenti che l’individuo può trovarsi ad affrontare durante la vita.
L’idea alla base è che dall’imperfezione e da una ferita possa nascere una forma ancora maggiore di perfezione estetica e interiore. La particolarità di questa pratica risiede nel fatto che il vaso non viene riparato nascondendo le crepe, ma anzi queste vengono sottolineate attraverso l’oro."
Le ferite del corpo e dell'anima sono curabili e sono guaribili se le viviamo con l'avere fiducia in questo oro, che è balsamo e consapevolezza della forza interiore che ognuno di noi ha.
52 notes
·
View notes
Text

Era un venerdì notte e Betty se ne stava lì in piedi su quel marciapiede inghiottito dal buio. I suoi piedi sembravano incollati all’asfalto mentre il suo sguardo era perso esattamente come lei. Tutti intorno si muovevano freneticamente, tutto scorreva all’impazzata ma non lei. Lei era lì e ci sarebbe rimasta fino la fine. Nel suo sguardo si specchiava una luce che mai avrebbe pensato di conoscere in questo modo. La luce delle fiamme. Le fiamme feroci, quelle che più di tutto bruciano la vita di chi le incontra. No, non è una metafora. Betty stava guardando il fuoco crescere sempre di più. Indomabile, affamato, come il brivido di piacere che le stava attraversando il corpo.

Da piccola era solita giocare con le candele, pucciare le dita nella cera fusa, chiudere gli occhi e respirare il profumo di un fiammifero spento… quante ne ha combinate… ha di sicuro rischiato di mandare a fuoco almeno una volta la casa dei suoi genitori. Il fuoco la terrorizzava da sempre eppure trovava così divertente e affascinante il modo in cui è in grado di mangiarsi in un attimo qualsiasi cosa.
Così, quel venerdì pomeriggio, quando seppe che l’uomo che amava profondamente da quattro anni e che lei credeva mai sarebbe stato capace di farle del male, in realtà l’aveva tradita… Betty si sentì esplodere dentro. No, non sentì il cuore spezzarsi, forse quello era rotto da tanti anni. Sentì più un calore insopportabile divampare dentro di lei.
Aveva pianto per un po’ poi era salita sulla sua macchina, si era recata a casa del suo ragazzo e… semplicemente le aveva dato fuoco.
Aveva deciso che non sarebbe uscita dalla vita di quell’uomo silenziosamente come ci era entrata. No, voleva uno spettacolo pirotecnico. E lì, su quel marciapiede, in prima fila, il suo dolore faceva a pugni con la sua più grande e appagante vendetta
Silvia Stoyanova
2 notes
·
View notes
Photo


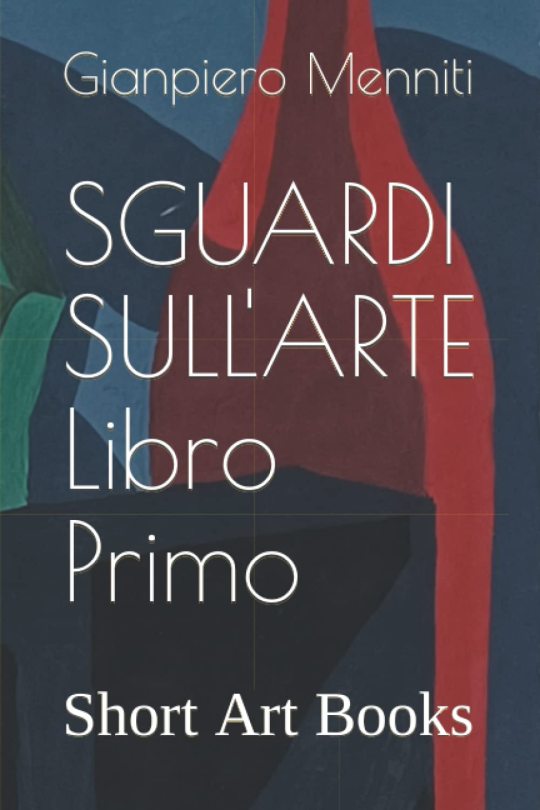
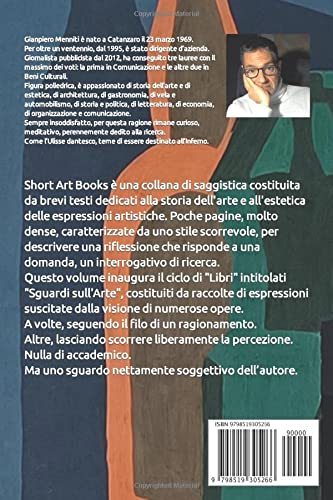
Da: SGUARDI SULL’ARTE LIBRO PRIMO - di Gianpiero Menniti
L'UOMO GRECO E L'UOMO CRISTIANO
La tragedia di Sofocle narra del figlio che in apparenza infrange due tabù: uccide il padre e giace con la madre. Ma Edipo non è colpevole: l'origine della vicenda è nel misfatto di Laio, il re che teme il pronunciamento dell'oracolo e decide di assassinare il figlio. Il padre è l'assassino. Edipo è la vittima. Laio è dunque colui che non accetta la metafora della morte come passaggio del testimone al figlio. Non accetta la decadenza del corpo. Non accetta di trasmettere la sua eredità, l'Io che si scioglie nella figura del figlio. Non accetta la condizione che la natura impone per se stessa, per le sue finalità di vita senza scopo. La vita che necessariamente è morte. Così, Laio si ribella, infrange l'ordine e apre le porte al caos. Edipo è la vittima. Inconsapevole, rifiuta il nuovo ordine imposto dagli eventi, non segue la regola dell'equilibrio, nella scia dell'ignota ma presente e angosciosa eredità paterna. Nella sua sfrontata ricerca di verità si condensa la tragedia indicibile, struggente, insanabile. Egli è il figlio che si affaccia al mondo attratto dal suo disvelamento, dalla fiducia nella conoscenza. Anche lui senza misura. Anche lui epigono del caos. La tradizione cristiana ripensa il ruolo del padre, ma non entro "l'aretè", necessità di natura e accoglimento del destino di mortale. L'uomo cristiano coltiva la speranza della salvezza dalla morte e sposta l'asse della verità dall'ordine di natura all'ordine divino. Il Dio non è caos ma è padre. Il Dio non è solo onnipotenza ma è divenuto amore. E Amore vince sulla Natura fino a sovvertirne il corso, fino a superarne la muta indifferenza attraverso il Verbo che è coscienza e ricerca. Ecco che il padre accetta la sentenza di morte del figlio:
«Il più giovane disse al padre: "Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta."» (Luca, 15,12).
Nel mondo ebraico l'eredità chiesta prima della scomparsa del genitore equivaleva ad un delitto, rappresentava il desiderio di sopprimere il padre stesso. Ed era punibile con la sentenza capitale. Ma il padre divide l'eredità e lascia andare il figlio: riconosce che il desiderio della sua morte è nel figlio anelito di libertà, estrema pulsione di conoscenza, inclinazione naturale alla vita che divora la vita. Non si vendica, non si lascia cadere nell'impulso contrastante e sceglie la speranza, confida nella salvezza. E nel ritorno. Quando la speranza si avvera e l'ordine naturale dei sentimenti ancestrali è sovvertito, vinto, sconfitto, il padre cancella il passato (il passato è peccato, il presente è redenzione, il futuro è salvezza) e riabbraccia il figlio ritrovato. La Natura rimane in agguato: l'altro figlio osserva e recrimina e rimprovera:
«Egli si adirò e non volle entrare; allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: "Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando; a me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici; ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato" » (Luca, 15, 28, 29, 30).
Ma è qui che la parabola evangelica tocca il suo culmine, spesso misconosciuto:
«Il padre gli disse: "Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è stato ritrovato."» (Luca, 15, 31, 32).
Il padre, sublimazione dell'Amore, salva anche lui, anche l'altro figlio incapace fino a quel momento di comprendere l'ordine di Dio, il figlio rimasto entro l'ordine di Natura che reclama la vendetta. Ma lo salva davvero? Rembrandt lo pone nella scena, a destra, solenne e torvo di rancore. In severo contrasto con l'espressione di disperata compassione che sorge nell'abbraccio tra il padre e il figlio ritrovato. Chagall lo esclude, ponendolo di spalle e accostandogli una figura ferina di risentimento, in basso a destra. Mentre lascia al centro del mondo che accorre l'atto d'amore del padre, approdo finale ed ascesa nel superamento dell'impeto.
- Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 - 1669): "Ritorno del figliol prodigo", 1661/1669, Ermitage, San Pietroburgo
- Marc Chagall (1887 - 1985): "Il ritorno del figliol prodigo", 1975, Museo nazionale messaggio biblico Marc Chagall, Nizza
- In copertina: Maria Casalanguida, "Bottiglie e cubetto", 1975, collezione privata
#thegianpieromennitipolis#arte#arte moderna#arte contemporanea#rembrandt#marc chagall#maria casalanguida
26 notes
·
View notes
Text
Quando alla fine dell'estate dovevo rimettere i piedi nelle scarpe, era finita la libertà. Non solo per metafora, perché le libertà procedono dal basso verso l'alto, ma per evidenza: il contatto con la libertà iniziava dalla pianta scalza sul selciato dell'isola d'Ischia, sull'aspro degli scogli. Era l'inspessimento dell'epidermide che diventava buccia. Poi toccava al resto del corpo arrossarsi, far bolle sulla schiena, da bucare con l'ago. Era la mutazione estiva, caduta la pelle di carta velina della città, spuntava l'altra, compatta, colore di carruba, coi peluzzi gialli.
Da adulto ho iniziato a portare sandali per gran parte dell'anno, anche in inverno. Poi ho smesso. Dopo la domanda premurosa e centesima: "Non hai freddo ai piedi?", ho dovuto arrendermi. Quando vado in città o sono in viaggio metto le scarpe chiuse, ma sento i piedi scontenti. Sono abituati a stare all'aria, hanno una loro temperatura indipendente.
Stare sotto al sole è abituale per i mediterranei, ma non resisto a mettermi sdraiato. Cammino lungo le rive, nuoto, scalo qualche scoglio, poi mi copro. Ho dei punti bruciati della pelle sui quali spalmo una protezione, non sul resto del corpo. Mi tengo il sole addosso, pure il sale, una seconda pelle.
Nelle pagine del libro sacro Kohèlet/Ecclesiaste si ripete a cadenza di affanno: "tàhat hashèmesh", sotto il sole. Non è quello delle vacanze, ma quello che pesa sulla schiena piegata dei braccianti. È la più potente, schiacciante forza della natura.
Ho conosciuto questo sole, che sovrasta chi non può mettersi all'ombra. Per questo amo quella degli alberi e continuo a piantarli. Vedo la loro crescita, il tronco che espande il diametro, la chioma che allarga a ombrello il suo riparo in terra.
I pescatori d'Ischia non scherzavano con la forza del sole. Nicola, quello che mi ha insegnato a pescare, portava il basco a bordo, i pantaloni blu rimboccati al ginocchio e una canottiera bianca che non toglieva mai. A lui e agli altri non importava niente l'uniformità dell'abbronzatura.
Borges ha scritto un eroico elogio dell'ombra, quella della sua cecità. Io posso lodare la circonferenza protettiva dei rami di un albero. Durante le mietiture in Africa vicino all'Equatore, in mezzo ai trent'anni, ricordo il sole che calava rapido a terra alle sei di sera e rispuntava alle sei del mattino. Abituato alle oscillazioni di orario del Mediterraneo, chiamavo con la marca di un orologio svizzero quel saliscendi puntuale.
Appena tramontato uscivano in volo fitte schiere di pipistrelli. Volavano basso, sfioravano. I loro scatti vicini di alta pressione mi ricordavano le sforbiciate leggere di un barbiere. A mezzogiorno il sole era così a piombo sulla terra che i corpi non facevano ombra. Buffo camminare in piena luce e non trascinarsela dietro. Non ho dimestichezza con la parola anima, ma con la sua controfigura, l'ombra, con lei sì. Mi gira intorno, mi tiene compagnia meglio di un cane, anche di sera a lume di lampadina, di camino acceso. Non si fa accarezzare.
Quando scalo una parete al sole sento il suo fiato sul collo, sul dorso delle mani. È contatto fisico, non solamente luce. Se mi batte dritto davanti, faccio schermo con il palmo sugli occhi, non uso occhiali di protezione. Come i piedi, anche gli occhi sono fatti per stare alla luce.
" 'O sole nun è ddoro": così inizia una poesia di Rocco Galdieri. Non è d'oro, invece è geografia, per chi è del Mediterraneo. La sua irradiazione feconda la terra, e noi di questo mare mangiamo e beviamo il sole e i suoi derivati.
Erri De Luca, Il sole
8 notes
·
View notes
Text

Nei giorni scorsi ho assistito a una prova aperta di The Garden, il nuovo lavoro di Gaetano Palermo, con Sara Bertolucci e Luca Gallio, che quest’anno è stato selezionato per la quarta edizione di ERetici_le strade dei teatri, il progetto di accoglienza, sostegno e accompagnamento critico, ideato e curato dal Centro di Residenza dell’Emilia Romagna.
In scena una black box ospita al suo interno un unico fermo immagine che solo alla fine si smaterializza lasciando lo spazio vuoto. Una donna, vestita con una sottoveste rosso mattone, è riversa a terra sul fondo destro del palcoscenico e lì resterà immobile, mossa solo da un respiro lento e profondo.
La dimensione immaginifica e di spaesamento che si crea per lo spettatore è dettata dalla drammaturgia sonora, che ad ogni cambio di brano amplia l’immaginario in nuove visioni, e dall’impianto luminoso, che resta statico dopo una prima accensione a lampi di neon. Per rifarci al titolo ci troviamo davanti a una natura morta, che fa però permeare di vita quell’immagine statica in ogni attimo che passa.
Fotografia o cinema? Teatro o dj set? Installazione o durational performance? O tutto questo insieme? L’impianto del lavoro è decisamente teatrale: come si diceva in principio, c’è una scena nera che si illumina quasi cinematograficamente per restare così, con la stessa tonalità di colore e luce, fino alla fine. Poi c’è la drammaturgia sonora che è ciò che da movimento a un’immagine altrimenti immobile e fa sì che lo spettatore proceda nella giustapposizione di immaginari e di significati.
Il dispositivo che il collettivo artistico mette in opera viene così definito da un crash mediale che fa collasse il cinema nel teatro, il teatro nel dj set, la fotografia nell’installazione e così via. Questo meccanismo inoltre sembra operare su quel piano di reinvenzione del medium di cui parla Rosalind Krauss (2005): facendo collassare sulla scena molteplici media il collettivo porta lo spettatore dentro il processo stesso, rendendo percettibile, grazie alla ripetizione all’infinito della stessa immagine, la finzione della rappresentazione e il funzionamento dell’immaginazione.
La mente così vaga tra le immagini della memoria: da un’apparizione lynchiana a una classica vittima del cinema di Hitchcock, da un corpo collassato durante un rave party al corpo a terra di Babbo Natale nella clip de La Verità di Brunori sas, dai corpi della cronaca nera a quello di Aylan riverso sulla spiaggia greca e così via, continuamente si creano e distruggono immagini nella mente di chi guarda.
In questa pratica mediante la quale si crea un ibrido, per restare anche nella metafora naturale, che incrocia più media, si assiste a una sorta di Iconoclash (Latour, 2005): accade allora che chi guarda si ritrova in una sorta di terra di mezzo, di indecisione dove non sa l’esatto ruolo di un’immagine, di un azione perché, nel caso di The Garden, questo si modifica non appena viene assimilato dell’occhio di chi guarda; e su questa scena ciò che accade è proprio questo: lo spettatore è messo davanti ad un’immagine iconica che cambia costantemente di significato e senso, passando dal sentimento del tragico a quello del comico fino a dissolversi svanendo ironicamente, rompendo il quadro della rappresentazione.
Una delle caratteristiche fondamentali delle immagini è, sempre per Bruno Latour, la loro capacità di scatenare passioni ed è proprio su questo meccanismo che sembra lavorare il collettivo guidato da Palermo che a settembre presenterà al pubblico una prova aperta di questo lavoro presso la Corte Ospitale di Rubiera dove si chiuderà il progetto ERetici.
*****************************************************
*Krauss, R. (2005). Reinventare il medium. Cinque saggi sull'arte d'oggi, a cura di Grazioli E., Mondadori, Milano.
* Latour, B. (2002). What is iconoclash? Or is there a world beyond the image wars. Iconoclash: Beyond the image wars in science, religion, and art, 14-37.
3 notes
·
View notes
Text
l'Eterno e il Tempo

Uno sguardo sul futuro non può prescindere da una riflessione sul tempo. Nella Grecia antica, ad esempio, ci sono tre figure che rappresentano il tempo:
una è Aion, l’eone, il tempo eterno;
l’altra è Chronos, il tempo che scorre, misurato, che divora l’esistenza.
e poi c’è il Kairos, l’opportunità.
Aiòn, "tempo" in greco antico connesso etimologicamente con l’avverbio aèi "sempre”. Un tempo inteso come eternità, come "sempre essente", distinto dal tempo "chrònos" e dal tempo "kairòs".
Rappresentato nelle fonti antiche, letterarie e iconografiche, come un fanciullo o un ragazzo, con il cerchio dello zodiaco (o un serpente) avvolto intorno al corpo. Eraclito scrive: "Aiòn è un bambino che gioca con le tessere di una scacchiera: di un bambino è il regno del mondo". Con Aiòn si allude alla vita come durata, nelle intermittenze e anacronie dell’esistenza personale. Si tratta di una distinzione in parte assimilabile a quella introdotta da Henri Bergson tra tempo della fisica, quantitativo e calcolabile, e durata, dimensione della coscienza irriducibile a qualsiasi logica sommativa e lineare.
Chrònos "tempo" in greco antico inteso come successione di istanti, di ore, di giorni, tempo che rovina e distrugge.
Già nelle fonti letterarie e iconografiche ellenistiche gli attributi mortiferi e distruttivi del tempo-chronos, vengono confusi con gli attributi del dio Kronos, che nel mito divora i suoi figli, ma viene poi ingannato ed evirato dal figlio Zeus. In particolare l’attributo del falcetto, strumento della mietitura e metafora della ciclica rinascita delle messi, passa dalla divinità sincretica Saturno-Kronos al Tempo-Chronos, la cui iconografia andrà sempre più identificandosi con quella della Morte. Kaìros in greco significa "momento opportuno". Questa parola si riferisce al tempo e in special modo intende al "momento fra", cioè quel determinato periodo di tempo in cui interverrà qualcosa che cambierà lo stato attuale delle cose. Si può tradurre come momento propizio, opportunità.
Da notare che su una delle colonne di Delfi, i sette sapienti avevano fatto incidere la massima “kairòn gnôthi" riconosci il momento giusto. Kairos, l’Opportunità, viene interpretato come un fanciullo alato con i capelli lunghi caduti sulle spalle davanti, ma calvo dietro, come a dire che quando il momento favorevole è passato, esso non può essere preso all’ultimo istante per i capelli. Che ora è? Che anno è? L’orologio e il calendario indicano un tempo che ci domina. Egli è Chronos, che ci dà una cifra convenzionale, senza comunicazione con le leggi della natura.
Ma se ci chiediamo: -Che cosa avviene?- ci interroghiamo e scopriamo se è " il tempo opportuno " dei rapporti continui, seppure inavvertiti dalla maggioranza degli uomini, che intercorrono tra il microcosmo e il macrocosmo. Kairos è un tempo rivelatore, ci svela il senso, l’importanza dell’ora che volge, ci suggerisce il mistero della reazione a catena che collega le cause agli effetti, il prima al dopo, che immette l’uomo nel cosmo ed il cosmo nell’uomo, ci rende consapevoli del fatto che tutto è interconnesso. Nel tempo di Kaìros occorre essere aperti per poter cogliere un momento di rottura che precipita la possibilità di mettere in atto ciò che si è preparato. Sta a noi lavorare per cogliere quell'attimo. Carpe diem, direbbe Orazio. Lo stesso fa la cuoca, se sa cogliere l'attimo in cui i suoi piatti, nel forno, son cotti a puntino; lo stesso fa chi governa una barca, se vira al momento opportuno e nel senso giusto e alza o ammaina le vele, lo stesso il pilota che deve sapere quali comandi e in che momento usarli per decollare sollevarsi accelerare, atterrare; l'atleta, se a tempo debito e con la dovuta forza lancia il disco, scocca la freccia, incalza o molla l'avversario, lo stesso il medico, se dosa il farmaco e il punto e la profondità dell'incisione che va praticando.
E il politico che deve conoscere quali provvedimenti faranno il bene del Paese in quel momento storico- economico; l’insegnante che sa quali saperi al momento opportuno e quali competenze sviluppare nel discente con una progettazione adeguata e misurata sull’allievo. Non per caso la più bella immagine di Kairòs, l'istante topico, l'occasione, o l'attimo fortunato, trovata a Traù, nell'attuale Croazia, era forse posta all'ingresso d'uno stadio. Il bassorilievo raffigura un giovane con le ali ai piedi, recante in mano una bilancia posta in equilibrio su un rasoio e, soprattutto, con un gran ciuffo di capelli sulla fronte, ma la nuca rasata. Se sarà passato oltre non sarà più possibile afferrarlo. Sta a noi prevenirne i movimenti e la fuga, sta a noi, in una serie di attimi, scovare, cogliere, afferrare quell'unico frammento di tempo in cui saremo a tempo perfetto con l'armonia cosmica. Comprendere, agire ed operare bene, godere, essere felici: sforzarci e faticare per tutto questo e poi, con semplicità e facilità inattese, riuscire ed uscire dal tempo, dall'indifferenza infinita e divorante di Chrònos, guadagnare, sia pur solo per quell'attimo, il tempo adatto a noi, nella perfezione di ciò che la nostra natura poteva compiere e che di fatto ha saputo compiere.
Così Rainer Maria Rilke dice dell Kairòs greco antico: “E a un tratto, in questo faticoso nessun dove, a un tratto, / l'indicibile punto, dove quel ch'era sempre troppo poco, / inconcepibilmente si trasmuta, salta / in un troppo, vuoto. Dove il conto a tante poste / si chiude senza numeri”.
Dentro un Chrònos infinito e inesorabile, un Kairòs unico, capace dunque, se colto opportunamente, di renderci, per quell'attimo e per sempre, eterni.
-C. D'Eramo
10 notes
·
View notes
Text
I Tarocchi dei Videogiochi
Per secoli i tarocchi hanno avuto uno spazio importante negli strumenti di divinazione e per tutti questi secoli sono rimasti con una codifica ben definita su come vanno rappresentati e su come devono essere fatti fino all’arrivo dei tarocchi moderni.
Dal loro arrivo, per fortuna o per sfortuna, i tarocchi hanno ottenuto ogni forma e dimensione possibile, per seguire i desideri dell’artista dietro allo specifico mazzo svincolandosi dal essere solo un oggetto divinatorio.
Da allora i tarocchi sono diventati un modo per permettere agli artisti di mostrare la loro capacità artistica e il loro stile con un tema standard e codificato. Questo ha permesso di ottenere dei mazzi di tarocchi moderni, che non sono solo tarocchi-strumento di divinazione ma anche un “Esercizio di stile” per l’artista, che può vedere come sfida e quindi affrontare col suo stile e le sue atmosfere.
ARCKADE, i tarocchi dei videogiochi
Arckade sono i tarocchi del gamer, e Ckibe, la artista che ha realizzato le grafiche dei tarocchi, ci ha messo anima e corpo per farle.
Ovviamente visto che siamo nel XXII secolo abbiamo anche un bellissimo documentario sul tutto il processo creativo del mazzo dei tarocchi, dal concept ai dettagli e le citazioni.
Cosa mi ha colpito
Come giocatore io non gioco tutto il gioco sempre. Delle volte non lo finisco, lo lascio la. Ma se un gioco mi piace e mi prende lo finisco e lo esploro in modo pesante, pertugi inclusi.
Questo mi ha portato a passare un paio di ore a fissare le carte e analizzare tutti i dettagli e mi sono innamorato di alcuni dettagli sulle carte.
Gli arcani minori
Solitamente gli arcani minori sono la parte “noiosa” di un mazzo di tarocchi: lo stesso seme, ripetuto un numero di volte pari a quanto dice il nome della carta (4 di bastoni sono 4 bastoni sulla carta) a meno di non essere una delle figure di quel seme, nel qual caso c’è la figura e il seme della carta.
In questo caso però non è il solito copia-incolla dei semi ma c’è uno studio dietro.

Ogni uno dei quattro semi (monete, bastoni, spade e coppe) è stato realizzato attraverso l’utilizzo di oggetti dei videogiochi.
Per esempio sulle carte del seme delle monete è possibile trovare sia le monete di SuperMario che gli anelli di Sonic (valuta del gioco di Sonic). Questo viene portato all’estremo nelle carte delle coppe dove potete trovare una delle pozioni dei giochi Pokemon su scaffale affianco a tutte le altre.
Gli arcani maggiori
Personalmente sono stato sorpreso dagli arcani maggiori.
Io mi aspettavo che ogni arcano maggiore avesse un gioco come tema della carta e che altri giochi apparissero come dettagli invece non accade cosi.
Ogni arcano maggiore è un genere o un tipo di giochi specifico, con i loro topos rappresentati e con una serie di citazioni e riferimenti studiati molto bene (spiegato molto bene nel documentario linkato più in altro) che rendono gli arcani maggiori più vicine a una pagina di “Dov’è Waldo” che a un tarocco tradizionale.
Ovviamente il genere del gioco che è stato utilizzato per ogni singolo arcano �� legato all’arcano maggiore in qualche modo.

Nello specifico caso del Diavolo, che rappresenta sia il lato oscuro della psiche, che gli impulsi più bassi, ha come tema i gioco Bullett-Hell (Inferno di proiettili).
Mi piacerebbe dire che è una metafora di come nei giochi rappresentati nella carta si sta facendo riferimento a scelte morali che hanno poi portato a questa battaglia (si veda Undertail e Cuphead che hanno i combattimenti presenti nella carta solo dopo aver fatto delle scelte nel gioco) ma l’autrice Ckibe ammette nel documentario che il riferimento è Diavolo->Inferno->Hell->BulletHell semplice semplice.
Personalmente questo lo vedo come un plus di questo set di tarocchi, che li rendono tarocchi moderni e riescono a sdoganarsi rispetto alle solite figure e a prendere una propria identità coerente e coesa dall’inizio alla fine del mazzo.
Se questo mazzo di tarocchi ti interessa e vuoi prenderteli anche per te puoi seguire il link referral qui sotto e aiutare il sito con il tuo acquisto.
Grazie comunque
ARCKADE: I tarocchi dei videogiochi di Ckibe
Link con referral per l'acquisto
Acquista qui
L'articolo I Tarocchi dei Videogiochi proviene da Digital Tea Room.
0 notes
Text

Nosferatu, storia di un abuser sconfitto.
Il rapporto tra Orlok e Ellen in Nosferatu può apparire, a una lettura più superficiale, come una danza tra predatore e preda, ma c’è tanto altro di cui parlare. È una rappresentazione cruda e stratificata di un ciclo di abuso che si consuma nel buio della dipendenza e del potere. E non è un caso che l’iconografia del vampiro, da sempre, si sposi perfettamente con la metafora dell’abuser: manipolativo, insidioso, capace di controllare e soggiogare la sua vittima fino a privarla di ogni autonomia.
E, al di là di questo caso specifico, il vampiro è spesso utilizzato come mezzo per rappresentare il conflitto tra il femminile e il maschile. In Carmilla di Joseph Sheridan Le Fanu, la vampira protagonista incarna un femminile non conforme, legato al desiderio e alla libertà, che destabilizza il mondo patriarcale intorno a lei. Dracula stesso, di Bram Stoker, dà una forma a molte delle ansie vittoriane sul potere sessuale delle donne. Ma ci sono anche esempi ben più contemporanei: in Una dote di Sangue, di Saint T. Gibson, il vampiro che trasforma Constanta e la rende sua moglie è affascinante, seducente, ma anche soffocante, distruttivo e oppressivo. L’atto di ribellione della protagonista è una fuga, ma soprattutto un atto di autodeterminazione. In Guida al trattamento per vampiri per casalinghe di Hendrix, il vampiro è un predatore, sì, ma soprattutto simbolo del marciume di una società sessista, classista e razzista.
Tornando a noi. Ellen, al centro di questa dinamica, è tutt’altro che una vittima passiva. La sua vulnerabilità iniziale non ne definisce il destino, ma piuttosto prepara il terreno per un atto finale di resistenza assoluta. Ed è un atto che prima passa, dolorosamente, dal riconoscimento della propria posizione nel sistema del potere, per poi sfidarlo dall’interno. Il sacrificio di Ellen non è una semplice resa al male; è la demolizione del ciclo tossico che il vampiro rappresenta, un’interruzione brutale e definitiva di una relazione che, altrimenti, si perpetuerebbe all’infinito. Nel suo gesto, Ellen reclama il potere che le è stato tolto, ribaltando la narrativa patriarcale del “salvatore” per diventare essa stessa l’eroina della propria storia.
La teorica femminista Silvia Federici parla di questo genere di sacrifici proprio nel suo Calibano e la strega: Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria: qui lei sottolinea come il sacrificio femminile sia spesso visto come un prezzo inevitabile per sovvertire il potere. Ellen abbraccia quel prezzo, ma lo trasforma: non è una martire, ma una distruttrice. Non salva solo se stessa, ma rompe il sistema, annientando il vampiro nella sua stessa vulnerabilità. Un atto di sovversione, quando consapevolmente intrapreso per interrompere un sistema oppressivo.
Ellen non si limita a sopravvivere al vampiro: lo distrugge, trasformandolo da abuser onnipotente a una reliquia del passato. E nel farlo, si erge come un simbolo eterno della capacità di ribellarsi e riscrivere la propria storia, anche nei momenti più oscuri. Laddove gli uomini della sua vita avrebbero voluto risolvere il problema a picconate e palettate, lei attinge al suo innato potere femminile, al suo essere “incantatrice” - e così la chiama Orlok stesso -, alla forza femminile magica e occulta che da sempre ci dicono di reprimere.
#witchcore#dark#witchcraft#horror#nosferatu#eggers#vampire#a dowry of blood#dracula#vampiro#female rage#feminism
1 note
·
View note
Text
Se solo ripenso a toccare determinate cose o a bere un goccio di alcool mi viene l’ ansia, mi sento male e vado in paranoia, al punto che mi sembra davvero di aver fatto un’ altra nottata in certe condizioni, quando in realtà non è successo e magari sono stata nel letto a leggere
È come se mi fossi traumatizzata da sola con tutto quello che ho fatto e vissuto in due anni, e quando mi partono i pensieri ossessivi su questa cosa e si ripresentano scene di determinati momenti, inizio a sentirmi male, mi sento pietrificata dall’ansia e nell’ angoscia, e non so come liberarmi da quella morsa che mi stringe il petto
Ci sono giornate in cui nella mia mentre riprendono forma quelle quattro pareti gialle, la strana pala appoggiata in un angolo, il tavolo consumato di legno scuro, e pochi metri più in là quel letto sfatto, sporco, che separava il nostro altare della distruzione da quel bagno freddo e angusto
La bottiglietta sempre sul tavolo o nelle mani di qualcuno, l’ odore del bicarbonato, dell’ ammoniaca , di tutte le sostanze chimiche che impregnavano l’ aria e si sedimentavano, tiro dopo tiro, nei miei polmoni agonizzanti, mentre quello strano formicolio e quel calore si diffondevano lentamente in tutto il corpo
Ho visto da vicino la violenza, lo sporco, la mania, lo schifo più totale e inimmaginabile. Ho visto persone vendere telefoni, madri disperate che andavano a cercare i loro figli trentenni in casa di estranei alle 6 del mattino, bugie su bugie, vendite e svendite di se stessi per avere tra le mani quella piccola pietra bianca che ti fa sentire benissimo per due minuti esatti e che poi ti lascia da schifo per tutto il tempo rimanente, con le paranoie, un’ ansia ineguagliabile, i sensi di colpa, la totale incapacità di empatizzare col mondo intorno a te, perché in quel momento desideri soltanto fumare, non vedi altro, non senti altro, e il tuo cervello non può pensare ad altro se non al momento in cui sará inebriato di nuovo quell’ estasi di due, tre, massimo cinque minuti. E poi così per il resto delle giornate che seguono, in un circolo pressoché infinito di dissoluzione
“ Princess”, così mi chiamavano, e non so neanche perché
La cosa che mi mette più i brividi è pensare alle persone che mi chiedevano continuamente di fare questo “kiss”, e io sì, certo, forza, perché no.
E quindi questi individui facevano a gara per farmi fumare il crack, per accendermi la bottiglietta mentre loro la tenevano in mano e io mi ci attaccavo, forse cosciente della chiara metafora sessuale che ci fosse dietro
Ma a me andava bene così e non mi interessava di essere vista come la puttana della situazione, anzi
Fino a che c’ ero dentro, ero troppo inerme per ribellarmi o reagire alla cosa, ed ero troppo corrotta per capire quanto la cosa in sè fosse allucinante
Come ero troppo inerme quando a una certa, dopo aver speso quasi tutto il mio stipendio in una notte, mi buttavo in quel letto schifoso, mi giravo e mi accovacciavo su me stessa , pregando Dio che qualcuno prima o poi si accorgesse della mia situazione e mi salvasse. Non mi importava che sarebbe venuto tutto fuori. Io volevo solo che qualcuno mi aiutasse e piangevo gridi silenziosi, stretta in mezzo a due, a volte tre persone
Quel pazzo schifoso cominciava a toccarmi e a strusciarsi dietro di me, e io reagivo a parole ma non riuscivo comunque ad alzarmi da quel letto e andarmene, perché mi sentivo così miserabile e schifosa da credere di dover vivere pure quelle cose, in quel momento.
E poi uno, due giorni dopo, stessa storia
A volte mi sembra quasi che quel periodo sia stato l’ esito finale di un qualcosa che aveva già preso piede dentro di me , e che poi si è dissolto nella strada piu tragica e orrenda che potesse esserci
La rabbia, questo voler sopprimere sempre tutto e tutti intorno a me soffocando la luce, le nevrosi da controllo, il non voler riconoscere le piccole cose genuine che possiamo trovare nella vita e fare di tutto per tenerle a distanza e per tenere se stessi a distanza dall’ amore e dal calore umano
Ecco, il crack, e in generale la cocaina, fanno questo: diventi insensibile a tutto. Chiudi le porte, per così dire. Esisti solo tu. Per quanto puoi diventare loquace, le altre persone e il resto del mondo sono solo un contorno. Ma un contorno che si sbiadisce sempre di più, mentre i mostri nella tua testa si ingigantiscono fino a diventare sempre più reali e ti inghiottiscono, lasciando letteralmente solo le scheletro e qualche chilo di carne consumata attaccato al corpo.
E io credo che la mia dipendenza sia stata l’ esito finale di tutte queste cose che già da anni albergavano in qualche parte remota del mio inconscio: sono dovuta passare attraverso l’ inferno per disconoscerlo. È come se fossi andata ad amplificare delle cose che avevano già preso piede tempo prima nel mio essere ( noncuranza, egoismo, prepotenza) per potermi poi ricongiungere alle mie parti più intime e in profondità
Tutto quello che ho vissuto, non solo con il crack e la cocaina, mi ha portata inesorabilmente a volermi salvare e ad ascoltare la vocina di qualcuno che ho soppresso dentro di me 22 anni fa
E alla fine forse mi ha salvata proprio quella bambina che piangeva da sola la notte, strozzando le urla con il cuscino, per non farsi sentire da nessuno
Mi sono ritrovata a parlare di “ silenzio “ in questi giorni, e non posso fare altro che pensare a come questa parola abbia in realtà caratterizzato tutta la mia vita
Ho dovuto sempre soffrire nel silenzio ma anche gioire nel silenzio, perché ogni tipo di entusiasmo mi veniva sempre stroncato sul nascere, facendomi sentire sbagliata per le cose che provavo( ma io ero solo una bambina, come potevo rendermi conto?)
Un po’ come quando provavo a raccontare a mia nonna o a mio padre quello che mi stava succedendo in casa e mi veniva detto che non c’ era nulla di male, che non dovevo prenderla così. Poi a distanza di due ore mi ritrovavo ad 8 anni a pulire il vomito da alcool lasciato da altre persone e a rinfilarmi nel letto pregando che la notte si portasse via tutto, ogni cosa, mentre i miei occhi e il mio cuore piangevano disperati
La mia mente ha sempre circoscritto queste cose ad episodi isolati o comunque di breve durata, ma oggi so che non è così e che in realtà hanno coperto un arco temporale di quasi otto anni, protraendosi per tutto questo tempo
E oggi che è come se fossi un’ altra persona ( ma comunque sempre il frutto di una concatenazione di cose ed eventi che sono parte di me e che costituiscono il mio essere) , sto tornando alle cose che amavo di più da piccola, pure sentendomi da sola nell’ amarle, e senza vergognarmi più o sentirmi in difetto per questo
Non c’è niente di male nel mostrare la propria vulnerabilità e a volte mi chiedo cosa abbiano vissuto nel profondo le persone che mi sono vicine , per arrivare ad essere così
Mi sembra tutto estremamente nuovo ma da una parte, nonostante io sappia vivere in questa mia solitudine e alla fine ci abbia vissuto tutta una vita, a volte mi manca condividere qualcosa con qualcuno
Ma nel senso più puro e genuino che possa esistere
Non so, a volte mi manca un abbraccio la sera, e nel profondo sento la mancanza di dare a qualcuno questo calore e questo amore che sento , e che per ora rimane solo dentro di me
A volte è così forte questa cosa che l’ avverto come una cosa fisica, una sorte di fame d’ amore, anche se detta così sembra quasi una fame distruttiva
Avendo vissuto pure alimentata da quel tipo di fame, però, so che tutto quello che sento ora non ha a che vedere con quel tipo di fame lì, ma è invece un canto dolce, più tiepido ma comunque caldo, che non si specchia più in un abisso di catrame che inghiotte tutto
Solo che sto tenendo tutto per me, perché anche quando ogni tanto torno a fare volontariato sì, l’ attività riflette un po’ il tipo di amore che sento dentro di me e che mi piacerebbe trasmettere anche ad altri, ma ormai non è più esattamente questo
A volte avrei proprio bisogno di intimità, dell’ intimità di un abbraccio ( ma non quello di un’ anziana, nonostante possa comunque riempirmi di gioia e darmi tante cose belle ) ma quello di qualcuno che potrebbe essermi più vicino, anche in senso più fisico
Solo che appunto avendo vissuto anche tantissima violenza, abusi, manipolazioni ( tutto fatto e subito, in una duplicità disarmante) ho come fatto terra bruciata durante tutto questo periodo brutto, e solo adesso sto riniziando a rapportami agli altri e a non autosolarmi
Solo che appunto, vissuta ormai questa fase di autoisolamento ,mi sto realmente concedendo di vivere, e mi rendo conto che alla fine l’ essere umano è fatto per amare e che questa è l’ unica cosa reale e che ci lega tutti, e mai come adesso ne ho sentito questo “ bisogno”, questo desiderio, questa voglia di darlo ad un’ altra persona e di accettarlo e riceverlo a mia volta, con tutto il suo calore
Il fatto che mi ritrovi da sola ad avere tutti questi pensieri mi sembra quasi il risultato inequivocabile di tutto il male che ho fatto e che mi sono fatta, con tantissime cose e persone, quasi come se questi fossero i risultati tragicomici e grotteschi dell’ egocentrismo e della fame distruttiva e autodistruttiva che ho alimentato in tutti questi anni. Ma so che è il modo con cui il mio cervello ha processato per tanti anni i sensi di colpa, e ora non lascio che questa sensazione prenda il sopravvento
Non so se se le stelle cadenti fanno rumore quando attraversano il cielo
0 notes
Text

Il Mito di Er è un racconto filosofico narrato da Platone alla fine del decimo libro della Repubblica. È una delle più celebri esposizioni platoniche sull'immortalità dell'anima e sulla giustizia divina. Questo mito non è da intendersi come un resoconto storico, ma come una metafora per illustrare temi morali e filosofici.
Trama del Mito di Er
Er, un guerriero di origine panfilia, muore in battaglia. Dopo dodici giorni, il suo corpo, miracolosamente preservato dalla decomposizione, viene ritrovato e portato sul rogo funebre. Poco prima della cremazione, Er si risveglia e racconta ciò che ha visto nell’aldilà.
1. Viaggio nell’aldilà
Er riferisce di essere giunto in un luogo misterioso dove le anime si radunano. Qui, due aperture conducono verso il cielo e due verso il sottosuolo.
Le anime dei giusti ascendono al cielo per essere premiate, mentre quelle dei malvagi scendono sotto terra per essere punite.
Dopo mille anni, le anime tornano per scegliere una nuova vita sulla Terra.
2. La scelta delle vite
Le anime, riunite in una grande pianura, hanno la possibilità di scegliere una nuova vita da un assortimento di destini prestabiliti, rappresentati da modelli (o "sorti").
La scelta è determinata dall’esperienza acquisita durante le vite precedenti e dalla loro saggezza. Questo processo sottolinea la libertà individuale e la responsabilità morale.
3. Il Fuso di Ananke
Er osserva il fuso della Necessità (Ananke), un'immensa struttura cosmica che governa il destino e il movimento dei cieli.
Le Moire, figlie di Ananke (Cloto, Lachesi e Atropo), regolano la vita e il destino: Cloto assiste alla scelta delle vite, Lachesi assegna i destini e Atropo rende il destino immutabile.
4. Il Ritorno alla vita
Dopo aver scelto, le anime attraversano il fiume Lete (il fiume dell’oblio), bevendo per dimenticare le loro vite precedenti. Tuttavia, alcune anime bevono più di altre e dimenticano più profondamente.
Infine, le anime si reincarnano nei corpi scelti e tornano nel mondo fisico.
Significato del Mito di Er
Il racconto simboleggia l’importanza della giustizia e della virtù. Alcuni temi centrali includono:
Immortalità dell'anima: L'anima non perisce con il corpo e affronta conseguenze in base alle sue azioni.
Responsabilità individuale: La scelta della vita futura sottolinea il libero arbitrio.
Ciclicità dell’esistenza: La reincarnazione è un processo continuo, legato alla purificazione dell'anima.
Il mito di Er serve come monito per vivere una vita giusta e virtuosa, poiché le scelte morali hanno conseguenze eterne.
#Mito di Er#platone#racconto filosofico#guerriero#vite precedenti#myth of er#philosophical tale#past lives#book#kintsugi
0 notes
Text

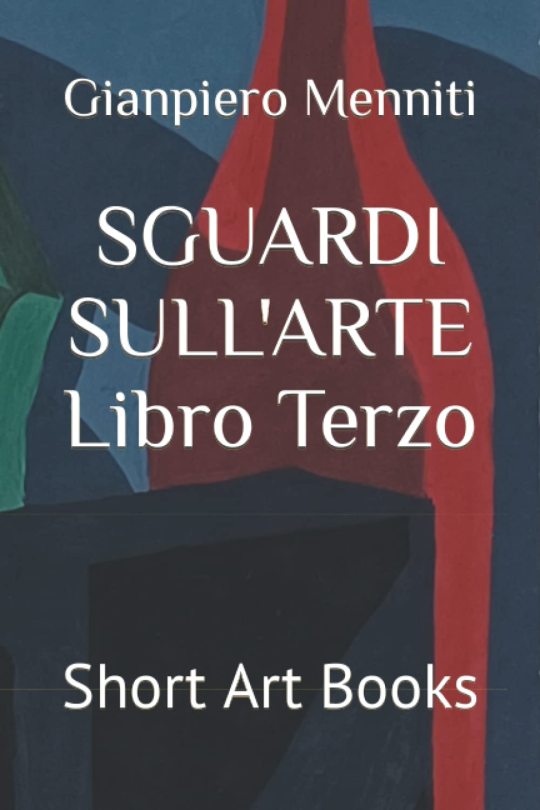
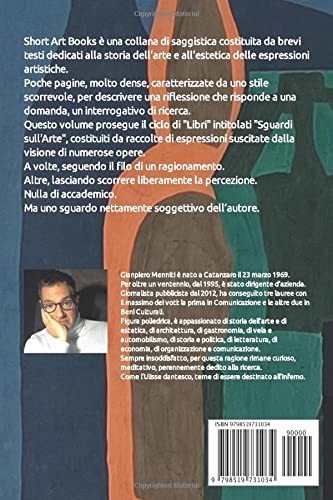
Da: SGUARDI SULL'ARTE LIBRO TERZO - di Gianpiero Menniti
L'IDEA IMPRECISA
La suggestione dell'idea come espressione della razionalità, come codice che fornisce identità comune alla comunità degli esseri umani, è molto antica. Il pensiero occidentale è debitore a Platone il quale seppe cogliere nel concetto di "anima" l'incontrovertibile della verità che viene in luce, in opposizione alla doxa delle sensazioni e delle espressioni soggettive: nell'anima, entità invisibile ma generatrice del pensiero, l'idea è "ἀλήθεια", svelamento, uscita dall'oblio, chiarezza, evidenza. Si comprende quale valore abbia la relazione tra luce e tenebre, non solo come metafora dell'incessante ricerca del significato: è la luce la condizione della "forma", del fenomeno, dell'apparire, del reale. "Ιδέαι" sono dunque le entità eterne costitutive della realtà, ne rappresentano l'essenza. Eppure, fuori dalle espressioni matematiche, dei numeri e delle forme geometriche, le idee circolano se fanno storia: si affermano qualora divengano una narrazione condivisa. Se con sant'Agostino l'anima platonica entra a pieno titolo nella dimensione teologica di una religione dei "corpi" - senza il concetto di corpo è impossibile capire il cristianesimo - il riflesso dell'idealismo primigenio che si porta dietro, induce a ritenere la razionalità delle idee il marchio della loro autenticità, del loro ancoraggio saldo alla verità. Così, il pensiero occidentale, da Platone in avanti, ha proseguito nel solco dell'idea come atto generativo, della creazione che ha un'origine rispetto al nulla. Il buio è il nulla. La luce è il primo atto. «In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte.» - Genesi, capitolo primo - Dunque, l'occidente crede nell'essere e nel nulla, nella creazione e nel significato. Ma l'occidente cristiano. Non quello greco. Che non a caso, dimenticando la lezione di Parmenide, ha espresso, magistralmente, l'inquietudine di trovarsi di fronte al baratro del "nulla" nella tragedia. Ecco perché noi siamo cristiani e non più greci: abbiamo risolto la terribile percezione di un'assenza del significato, nella fede in un atto di creazione che ogni essente ha tratto dalle tenebre. Non importa che quest'idea sia imprecisa, non trovi fondamento in un'evidenza: l'idea stessa del rimedio alla morte nel nulla, per quanto inesplicabile, indefinibile, inconsistente sul piano materiale, ha conquistato il mondo e costituito la sua direzione storica. Ecco perché Nietzsche definì questa concezione il "colpo di genio del cristianesimo". Idea imprecisa quanto contraddittoria: Dio non è luce, ma è ciò che non può essere mai svelato. Altrimenti, Dio diverrebbe un concetto, una "cosa" come le altre cose del mondo. Per questa ragione, l'occidente designa il malefico con il termine "Lucifero", colui che porta la luce, colui che vuole svelare, colui che vuole "reificare" il Dio creatore. Idea imprecisa, dunque. Perché la perfezione dell'idea possiede qualcosa di luciferino, in sé. Mentre il dubbio e la ricerca, contengono una tensione vitale che spesso si dimentica o volutamente si tralascia. L'esperienza del viaggio ha più valore della meta. Presunta. Forse inutile.
- Gaetano Previati (1852-1920): "La creazione della luce" - 1913 circa, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma - In copertina: Maria Casalanguida, "Bottiglie e cubetto" 1975, collezione privata
13 notes
·
View notes
Text
Smile 2: un sequel che segue gli spunti horror del primo capitolo

Naomi Scott è la nuova protagonista della saga horror diretta da Parker Finn, che continua pedissequamente la storia del primo film di successo. Al cinema.
Gli horror d'intrattenimento sono tornati alla ribalta negli ultimi anni (o forse non se ne sono mai andati) e ogni tanto spicca qualche titolo che fa prepotentemente parlare di sé. Come Smile, la pellicola del 2022 con Sosie Bacon diretta da Parken Finn e basata sul suo omonimo corto di due anni prima.

Il punto in comune tra i due film
L'attrice interpretava una terapeuta che diventava l'ultima vittima di una sorta di parassita demoniaco che passava di ospite in ospite costringendolo ad uccidere, oppure uccidersi davanti ad un'altra persona a cui passare il morbo, entro sette giorni. Il finale era fortemente aperto con la giovane donna che si sacrificava in nome dell'ex fidanzato Joel, col volto di Kyle Gallner, che funge da ponte in Smile 2.
Smile 2: di nuovo nella tana del lupo

La carismatica protagonista del sequel
Sono passati sei giorni dal precedente capitolo, quindi manca poco alla scadenza soprannaturale al centro della storia. La regia di Parker Finn ci porta in medias res dentro questa catena di eventi apparentemente senza fine e arriviamo alla nuova protagonista femminile, la popostar Skye Riley, interpretata questa volta da Naomi Scott, perfetta per il ruolo e per reggere un intero film. La cantante è in lenta risalita dopo un terribile declino fatto di dipendenza da droghe e alcol che ha portato ad un brutto incidente nella sua vita. L'incontro con un vecchio amico, Lewis (Lukas Gage), la fa entrare nella pericolosa orbita di quella maledizione apparentemente infinita, lasciando perplessi la determinata madre-agente (Rosemarie DeWitt), l'ex migliore amica (Dylan Gelula) il timido assistente (Miles Gutierrez-Riley) e il produttore musicale (Raúl Castillo) che pensa solo al profitto.
Un sequel di cui c'era davvero bisogno?

Un'inquietante scena della pellicola
Parker Finn, nel bene e nel male, segue il processo creativo del capitolo inaugurale di questa saga potenzialmente infinita. Partiamo ancora da una buona idea e uno sviluppo interessante, che trasferisce dalla psicologia alla musica il core del racconto. Si instaura così una metafora della fama come qualcosa che ti fagocita e ti risputa fuori lasciandoti inerme e confuso, incapace di prendere decisioni sane e salutari per il futuro della tua vita. La regia passa dalla camera a mano a dei mini-piani sequenza con maestria e anche una buona dose di tensione narrativa, coadiuvata dall'utilizzo di jump scare che, per una volta, fanno davvero saltare sulla sedia e sono ben inseriti all'interno del tessuto narrativo.

Le bellissime coreografie del film
Anche l'estetica, complice la professione della protagonista, è estremamente curata e intrigante, utilizzando colori accesi e luci al neon per raccontare un orrore che si sviluppa da dentro e attraverso i movimenti del corpo, con coreografie meta-narrative. Dopo queste interessanti premesse, che potevano comunque distinguerlo nella massa di horror oramai proposti quasi con l'algoritmo e soprattutto uno dietro l'altro in sala, arriva il taglio con l'accetta (per restare in tema) del buon lavoro fatto, proprio come in Smile, e proprio nel gran finale.
Un terzo atto che rovina il film

Skye perde il controllo
Senza spoilerare nulla, vi dico invece che chiudere in modo anche interessante questa saga, pur avendo a disposizione dei pretesti narrativi che sembrano portare a quel tipo di epilogo, Smile 2 preferisce concludersi in una sorta di labirinto mentale della protagonista che non comprende più cosa sia reale e cosa no - e di conseguenza anche noi spettatori: non in maniera affascinante o accattivante, bensì ridondante e stancante arrivati a quel punto. Non solo: il messaggio finale, del potere della musica che da curativa diventa tossica, sia dal punto di vista dei fan e del fandom sia da chi sta dietro il microfono e deve affrontare il peso del successo, si perde e porta ad un epilogo che apre ad un ulteriore prosieguo della storia. Un vero peccato.
Conclusioni
In conclusione viene da chiedersi l’effettiva utilità di un film come Smile 2 dato che prende tanto il buono quanto il brutto dal capitolo inaugurale riproponendo lo stesso schema narrativo: un interessante punto di partenza e uno sviluppo semi-originale, che in questo caso riflette sulle conseguenze tossiche della fama e sul potere curativo della musica al contrario, per arrivare ad un terzo atto che manda tutto all’aria lasciando aperta la porta all’ennesimo sequel di una catena che non sembra non potersi spezzare, proprio come quella soprannaturale del film.
👍🏻
Naomi Scott, perfetta e carismatica come protagonista.
I jump scare ben assestati.
Una regia che crea tensione e un’estetica affascinante.
La nuova tematica affrontata…
👎🏻
…che però si perde dentro una struttura narrativa fotocopia del primo Smile.
I personaggi secondari sono davvero poco approfonditi.
Il finale annulla quello che di buono ha fatto il film fino a quel momento.
#smile#smile 2 movie#smile 2 2024#smile 2022#naomi scott#recensione film#recensione#review#movie review
1 note
·
View note