#Centro Studi Cura e Comunità
Explore tagged Tumblr posts
Text
Festival delle Medical Humanities: Un Viaggio tra Narrazione, Ascolto e Arti Visive Applicate alla Salute. Il Festival si svolge dal 15 al 20 ottobre con eventi online e incontri in presenza ad Alessandria
La quinta edizione del Festival delle Medical Humanities "Iconografia della Salute" ha preso il via il 15 ottobre 2024 ad Alessandria.
La quinta edizione del Festival delle Medical Humanities “Iconografia della Salute” ha preso il via il 15 ottobre 2024 ad Alessandria. Quest’anno il festival è dedicato al tema “Parola e relazione” e prevede un ricco programma di eventi tra presentazioni di libri, conferenze, tavole rotonde e mostre. La manifestazione si propone di esplorare l’interazione tra narrazione, ascolto e arti visive nel…
#Accademia del Paziente Esperto#Alessandria#Alessio Pini Prato.#arte nella cura#arti visive#ascolto e medicina#Centro Nazionale Malattie Rare#Centro Studi Cura e Comunità#cura e relazione#EUPATI#Eventi ad Alessandria#eventi online#Festival 2024#Festival delle Medical Humanities#Giuseppe Opocher#Graphic Medicine#Iconografia della Salute#Istituto Superiore di Sanità#laboratori sulla salute#Malati di Letteratura#manifestazione interdisciplinare#Mariateresa Dacquino#Medicina Narrativa#Musicoterapia#narrazione e salute#oncologia innovativa#professionalità sanitaria#resistenza al Parkinson#salute e cultura#Sandro Spinsanti
1 note
·
View note
Text
Lambert Maguire, a cura di Fabio Folgheraiter, Il lavoro sociale di rete. L'operatore sociale come mobilizzatore e coordinatore delle risorse informali della comunità, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 1989. Indice del libro

View On WordPress
0 notes
Text
Favara, XVI Edizione della Festa della Legalità. Ecco il programma dal 3 al 12 Maggio 2024

Dal 3 al 12 maggio 2024, si svolge a Favara la XVI Edizione della "Festa della Legalità", voluta e coordinata da Gaetano Scorsone. Ecco il programma degli appuntamenti in cartellone: Venerdì 3 maggio Ore 09.30, il Liceo Statale “M. L. King” in collaborazione con il Centro Studi “A. Russello”, presenta il Convegno: La Grande Sete di… Giustizia, Aula “C. Marrone”. Saluti: Dirigente Scolastico Prof.ssa Mirella Vella; Antonio Palumbo (Sindaco di Favara); Dott.ssa Maria Buffa (Dirigente USR Sicilia); Dott. Gaetano Scorsone (Coordinatore Festa della Legalità). Interventi: -Prof. Salvatore Ferlita (Università Kore, Presidente Centro Studi “A. Russello”); -Dott. Salvatore Cardinale (Magistrato a riposo); -Dott. Antonio Liotta (Editore, Vice Sindaco di Favara); -Prof. Calogero Sorce (Docente Liceo “M. L. King”); -Letture di Sara Chianetta (Vice Presidente Centro Studi “A. Russello”); -Interventi artistici a cura del Gruppo Teatro “I Ragazzi del King” diretto dalla Prof.ssa Arianna Vassallo. Modera la Professoressa Giada Attanasio (“Docente Liceo M.L.King”). Domenica 5 maggio Ore 08.30, l’A.I.D.O. Gruppo Comunale Favara “N. Papa–S. Urso”, il C.A.M.E. dei Templi di Favara e la Chiesa Madre presentano l’evento: Memoria, Gratitudine, Preghiere: percorsi di legalità di una comunità in cammino. Programma: - Ore 08.30-09.15: Afflusso delle auto e moto d’epoca e dei partecipanti presso il “Saracen Bar” di Via Capitano Callea n. 119; - Ore 09.30: Inizio percorso della memoria con l’omaggio a Stefano Pompeo presso il Cimitero di Piana Traversa (deposizione composizione floreale, lettura profilo, preghiera); a seguire visita alla Stele del Beato Giudice Rosario Angelo Livatino – sp3 -, fermata in Via Padre Pino Puglisi e in Corso Vittorio Veneto (scaletta) per ricordare rispettivamente il Beato Pino Puglisi, Gaetano Guarino e Stefano Pompeo; - ore 11.30: Santa Messa in Chiesa Madre, celebrata dall’Arciprete don Nino Gulli. Al termine, consegna del IV Trofeo “Gaetano Tuzzolino/Gaetano Parello” alla Tenenza dei Carabinieri di Favara da parte del C.A.M.E. dei Templi. Lunedì 6 maggio Ore 10.30, l’A.N.F.F.A.S., l’I.I.S.S. “E. Fermi” e la Pro Loco “Castello” presentano il workshop inclusivo per il rispetto dei Beni Comuni: Insieme si può, presso la sede dell’A.N.F.F.A.S. di Via E. Berlinguer n.23 di Favara. Interventi a cura di persone con disabilità dell’Associazione ospite e degli Alunni dell’I.I.S.S. “E. Fermi”. Martedì 7 maggio Ore 09.30, l’I. C. “A. Camilleri” e l’Associazione “Favara per il Futuro” presentano In classe con Livatino, plesso “Mendola-Vaccaro”. Interventi di Autorità locali ed esponenti dell’Università Kore di Enna. Ore 11.00, l’I. C. “G. Guarino” con la partecipazione degli studenti dell’I.P.S.S.E.O.A. “G.Ambrosini”, in una dimensione di continuità e orientamento, presenta lo spettacolo teatrale Voli di colombe, ali di farfalle, dedicato a bambini vittime innocenti della mafia. 0re 16.30, l’I. C. “Falcone Borsellino” presenta lo spettacolo La classe dei banchi vuoti, tratto dall’omonimo libro di Don Luigi Ciotti, con il coordinamento degli insegnanti Maria Cristina Marrella e Francesco Brutto. Mercoledì 8 maggio Ore 09.30, l’I. C. “V. Brancati” presenta il Convegno La lotta per la legalità, la giustizia e la libertà. L’ultimo discorso di Giacomo Matteotti, presso il Castello Chiaramonte di Favara. Saluti: -Prof.ssa Carmelina Broccia, Dirigente Scolastico; -Antonio Palumbo, Sindaco del Comune di Favara; -Dott.ssa Miriam Mignemi, Presidente del Consiglio Comunale; -Dott.ssa Etta Milioto, Presidente Commissione Pari Opportunità; Interventi: -Dott. Paolo Cilona, giornalista e scrittore; -Francesco Curaba, già Dirigente Scolastico; Intermezzi musicali a cura dell’orchestra dell’Istituto. Letture e approfondimenti: -Prof.ssa Giuseppina Mira, poetessa; -Alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado. Coordina la Prof.ssa Ombretta Canu, docente I. C. “V.Brancati”. Ore 15.00, l’Associazione Culturale Unitre visita la Casa Circondariale “P. Di Lorenzo” (Petrusa) per presentare Conciliazione e Tradizioni popolari, momento di intrattenimento con poesie, canzoni, recitazioni, letture, sketch di vita vissuta, barzellette, serenate e altro ancora al fine favorire un positivo afflato di spontanea inclusione, di umana condivisione e di pari dignità. Oltre ad una rappresentanza dell’Unitre è prevista la presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Favara, Dott.ssa Miriam Mignemi. Ore 19.30, presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano, Veglia di Preghiera per la Pace e la Legalità, aperta a tutta la comunità cittadina. Giovedì 9 maggio Ore 20.30, la Compagnia Teatrale “Arcobaleno” e il Comune di Favara presentano: Anime, tratto da Anime che si chiamano di Antonella Morreale, Castello Chiaramonte. Regia di Antonella Morreale e Franco Sodano. Musiche di Franco Sodano e Gigi Finestrella. Musici: The Angels e Myriam Russello. Venerdì 10 maggio MANIFESTAZIONE FINALE Ore 09.30, inizio afflusso delle rappresentanze scolastiche e associative, degli ospiti, delle Autorità e della cittadinanza, in Piazza don Giustino per prepararsi alla Marcia della Legalità. Ore 10.00, partenza del corteo da Piazza don Giustino in direzione Piazza Cavour, attraversando Via Roma, Via Vittorio Emanuele, Via Cesare Battisti. Ore 10.30, Piazza Cavour: deposizione Corona di fiori al Monumento ai Caduti delle Guerre e alle Vittime innocenti della mafia; saluti delle Autorità; scopertura e presentazione della maxi tela dedicata all’Esercito Italiano -Istituzione Madrina della manifestazione - con l’intervento del Maestro Vincenzo Patti; consegna del 6° Trofeo “Salvatore Cucchiara” al Vigile del Fuoco Antonio Lattuca; passaggio dello Stendardo della Legalità dall’Unitre Empedocle all’Istituto Studi e Ricerca "Calogero Marrone”. La consueta iniziativa Pane, Olio e… Legalità offrirà la possibilità di gustare il buon pane favarese, donato dai Maestri Panificatori cittadini e arricchito dalla qualità dell’olio frutto della nostra terra. Il gustoso assaggio sarà accompagnato da pensieri sulla Legalità che gli studenti delle Scuole cittadine, insieme ai loro familiari, hanno appositamente preparato. A curare l’organizzazione e la distribuzione gli Allievi dell’I.P.S.S.E.O.A.“G. Ambrosini”. Saluti finali Read the full article
0 notes
Text
"Il 41° Congresso di Cardiologia, promuovere la salute del cuore attraverso la conoscenza, la cura e la prevenzione"
di Riccardo Rescio
Il Congresso di Cardiologia "Conoscere e Curare il Cuore" rappresenta un appuntamento imprescindibile per la comunità medica e cardiologica internazionale.
Questo importante evento, in programma dal 29 febbraio al 3 marzo 2024 nella prestigiosa location della Fortezza da Basso, celebra la sua 41ª edizione sotto l'egida del Centro per la Lotta contro l'Infarto Fondazione Onlus.
Da oltre quarant'anni, il Congresso si distingue come un faro di conoscenza nel panorama cardiologico, offrendo un'ampia panoramica sugli ultimi progressi nella diagnosi e trattamento delle malattie cardiovascolari.
Grazie alle ricerche in biologia molecolare, studi sperimentali, fisiopatologia, indagini epidemiologiche e studi clinici, gli esperti presenti potranno approfondire le tematiche più attuali e condividere le migliori pratiche per promuovere la salute del cuore.
Anche questa edizione, diviene catalizzatore di idee e innovazioni nel settore cardiologico, offrendo ai partecipanti l'opportunità unica di scambiare conoscenze, esperienze e scoperte scientifiche.
La prevenzione delle malattie cardiache riveste un ruolo centrale in questo contesto, poiché investire in stili di vita salutari, effettuare controlli regolari e sensibilizzare sull'importanza di ridurre i fattori di rischio come il fumo, l'obesità, il diabete e l'ipertensione rappresenta il fondamento per preservare la salute del cuore e ridurre l'impatto delle patologie cardiovascolari sulla popolazione mondiale.
Firenze 1° marzo 2024
Centro per la Lotta contro l'Infarto
0 notes
Text
Per contribuire ai necessari lavori di restauro della Chiesa romana, venerdì 8 dicembre (festa dell’Immacolata Concezione), la Sala concerti della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, ospiterà, con inizio alle ore 17,00, un concerto di musica classica eseguito dal “Can Roig Ensemble di Barcellona” composto dai professori della scuola municipale di musica “Can Roig i Torres” Mario Bugliari (Viola), Maria Teresa Folqué (Chitarra), Carles Franco (Violino), Medeya Kalantàrava (Violino), Elisabetta Renzi (Violoncello) e Isabel Suoto (Flauto traverso). Il nome del gruppo “Can Roig Ensemble” proviene dall’edificio modernista in cui ha sede la scuola, ubicato nel centro storico di Santa Coloma de Gramenet municipio dell’area metropolitana di Barcellona, che, oltre all’ordinaria attività pedagogica, promuove progetti didattici di carattere sociale per dinamizzare l’ascolto e la pratica della musica nei diversi centri educativi del municipio. L’idea di organizzare dei concerti (ad ingresso gratuito) per sostenere mediante offerte i restauri della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, di cui è Rettore Mons. Marco Frisina e resi possibili dall’ospitalità della Comunità del Monastero delle Benedettine di Santa Cecilia in Urbe, di cui è Abbadessa Maria Giovanna Valenziano, è “nata” nel 2015. Anche ciò che verrà raccolto in occasione del concerto dell’8 dicembre è finalizzato ai restauri, ed in specifico ai restauri dei materiali lignei. L’edificio antichissimo, che sorge sui resti della domus romana dove visse Santa Cecilia, ha una stratificazione nei secoli, dal Paleocristiano al Romanico, dal Gotico al Liberty. Sempre minata dall’umidità, a causa della vicinanza del Tevere, la Basilica ed i suoi arredi hanno bisogno di continua sorveglianza e di continui interventi di restauro. Di qui la necessità di un aiuto concreto. La Basilica è patrimonio dello Stato Italiano, affidato alla cura delle Benedettine, da sempre vigili custodi delle memorie di arte e di fede. Anche nell’ottica di valorizzare tale patrimonio, il Monastero, negli anni, ha attivato tre scuole-laboratorio, aperte a tutti, senza limiti di età né requisiti di partenza. La scuola “Cantantibus Organis”, nata con l’intento di fare esperienza dell’ars celebrandi in ambito monastico, gode del Patrocinio dell’Ufficio Liturgico della Diocesi di Roma e dell’Aiscgre, Associazione Internazionale Studi Canto Gregoriano e si avvale della collaborazione dell’“Academia Latinitati Fovendae”. Il suo nome richiama Santa Cecilia, martire della prima comunità cristiana di Roma, di cui il Monastero conserva la memoria. Tra gli insegnanti: sr. Dolores Aguirre ccv, Luigi Pastoressa, Nico De Mico, Mons. Giuseppe Liberto. La scuola “Petali e Pennelli” per l’acquisizione delle tecniche dell’acquerello botanico. Insegnante Aurora Tazza. Il “Laboratorio per la conservazione, manutenzione e recupero dei beni - memoria delle attività del Monastero”. Insegnante Daniela Caporali Viggiani. Il programma del concerto sarà caratterizzato dalla varietà timbrica dei vari insiemi: undici valzer di Franz Schubert arrangiati per flauto e chitarra da Th. Pinschof e Jochen Schubert; il quartetto per flauto, chitarra, viola e violoncello scritto da Schubert nel 1814 sulla base del trio Notturno op.20 per flauto, viola e chitarra di Vaclav Thomas Matiegka virtuoso della chitarra e compositore di successo nei circoli amatoriali di musica di Vienna; il trio incompiuto in si minore D471 per violino, viola e violoncello di Franz Schubert, scritto negli anni 1816-17 quando ancora spensieratamente scriveva per le frequenti serate cameristiche celebrate in compagnia degli amici; il quintetto in re maggiore G448 di Luigi Boccherini per due violini, viola, violoncello e chitarra ricco di sonorità “spagnoleggianti” che l’ambiente di Madrid gli ispirava. Di fatto il compositore visse a Madrid dal 1768 fino alla morte nel 1804, prestando il suo servizio come compositore di corte all’Infante Luigi
fratello del re Carlo III di Borbone dedicandosi soprattutto alla produzione da camera con opere di tutti i generi, tra cui ben 125 quintetti. In occasione del concerto, la Reverenda Madre aprirà la Cripta della Basilica e, al termine della visita, si potrà verificare il progresso dei restauri dei materiali lignei del Monastero, eseguiti dal “Laboratorio per la conservazione, manutenzione e recupero dei beni - memoria delle attività del Monastero” con la guida della restauratrice Daniela Caporali Viggiani. Anche questa iniziativa è sostenuta dal Maestro Claudio Giuliani, dalla Coop. Sociale “Apriti Sesamo”, dall’Associazione “Ghibli” nella persona di Giulia Romano, e dall’Associazione “Palatinum”.
0 notes
Text
La coscienza del luogo
appunti sul tragitto #3
Alberto Magnaghi è architetto, urbanista e Professore emerito di Pianificazione Territoriale presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, dove ha fondato il Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti, laboratorio di ricerca che raggruppa docenti, ricercatori, collaboratori, laureati, laureandi, dottori, dottorandi e studenti in forme mobili di discussione e di lavoro comune.[1] I suoi studi sul territorio lo hanno portato alla fondazione della Scuola Territorialista italiana, approccio contemporaneo alla pianificazione e al design urbani e regionali oggi condivisi dai cosiddetti Territorialisti, teorici e studiosi impegnati nella formulazione di nuovi modelli per affrontare il problema ecologico, che condividono una critica alla nozione tradizionale di sviluppo sostenibile e concentrano l’attenzione sulla necessità di un ritorno a una prospettiva locale. Nell’analisi storica dello sviluppo del concetto di territorio, alla ricerca delle cause e delle condizioni che hanno generato l’ odierna crisi ecologica, Magnaghi spiega come prima dell’avvento della modernità meccanizzata il territorio fosse individuabile come “l’ambiente dell’uomo”, un terzo elemento prodotto dalla co-presenza e co-evoluzione della natura insieme agli insediamenti umani.
Nel libro Il principio territoriale, il teorico analizza come la situazione di distacco degli abitanti dal proprio territorio caratteristica della modernità sia sintomo di una più generale trasformazione di questi in lavoratori, clienti e consumatori atomizzati, messa in atto e perpetuata negli anni dai sistemi socio-economici e tecno-finanziari globali.[2] La società capitalistica moderna, basata sull’avanzata tecnico-scientifica e fatta di reti globali e realtà dislocate ha strutturato una nuova concezione di territorio come sito inanimato, semplice spazio vuoto su cui adagiare i meccanismi della civiltà delle macchine. La civilizzazione moderna ha preteso di svilupparsi a prescindere dall’ambiente naturale, interrompendo il processo di co-evoluzione tra uomo e natura per instaurare una dinamica di dominio e controllo del primo sulla seconda.

Quello che è il risultato di un processo di stratificazione lungo tutta la storia, denso di saperi, conoscenze e memorie è stato quindi concettualmente svuotato e strumentalizzato ai fini produttivi. In questo modo, con l’abbandono del concetto di territorio come ambiente di cui l’uomo è parte, l’azione sulla natura è stata rivolta al dominio e al controllo e ha generato enormi danni per entrambe le parti coinvolte: l’ambiente e l’umanità. Constatato che il sistema in cui abbiamo investito e su cui pensavamo di poter fare affidamento non è sostenibile e ha inoltre fallito nella promessa di un miglioramento del lavoro e della vita per tutti, si rende evidente la necessità di nuove forme di progettazione e organizzazione, in grado di rimettere al centro i bisogni dell’ecosistema territorio ripartendo dai valori base della comunità. Risanare il rapporto tra abitanti e spazi abitati significa recuperare i saperi contestuali del vivere e riconoscere le identità dei luoghi, espresse nei loro paesaggi. In quest’ottica si rende necessaria anche una nuova narrazione degli stessi abitanti contemporanei che devono diventare costruttori dei patrimoni locali attraverso il recupero del rapporto con il territorio, in senso individuale e comunitario. Questo è possibile attraverso un cambio di prospettiva, per cui gli abitanti tornino ad avere cura del territorio e ad impegnarsi quotidianamente nel rapporto con esso, considerando il luogo come bene patrimoniale comune.
La struttura capitalistica della società e la conseguente disgregazione delle forme di solidarietà sociale e di classe hanno generato da tempo risposte oppositive, nella forma di mobilitazioni globali contro le azioni dannose e in favore di modalità più consapevoli di progresso. La globalizzazione ha fatto inevitabilmente riemergere la dimensione locale, in cui si attivano modalità di mutuo soccorso e la crescita di coscienza del luogo collettiva e individuale. Lo studioso riconosce l’esistenza in Italia di varie forme di organizzazione sociale basate sulla partecipazione, sulla valorizzazione attiva del patrimonio territoriale realizzata attraverso la collaborazione:
La produzione sociale del territorio e del paesaggio, attraverso la partecipazione collettiva alla produzione di un patrimonio vivente deve promuovere un processo che sappia sottrarre il patrimonio storico e paesaggistico alla sua funzione museale e mercantile verso una sua riappropriazione e qualificazione attiva come bene comune per l’elevazione della qualità della vita, dell’ambiente e dei paesaggi contemporanei.
A questo fine diventa fondamentale che gli abitanti dei territori riprendano consapevolezza di saperi, identità, culture accumulate nei tempi lunghi della storia e si ridefiniscano attraverso l’appropriazione di questa mole di conoscenze, costruendo una propria “coscienza del luogo”. Ed è a mio parere in questo snodo che si evidenzia la rilevanza del contributo che l’arte contemporanea può fornire all’interno di un più ampio progetto di riterritorializzazione. Attraverso le pratiche partecipative non convenzionali, le forme di residenza artistica context specific e le altre varie forme che la progettualità artistica assume oggi, si apre la possibilità di creare situazioni specifiche per gli abitanti dei singoli territori e costruire spazi di prossimità, in cui riattivare le relazioni e generare reti dal basso. Il ritorno al territorio si concretizza in un contro-esodo verso le zone marginali, rimaste escluse dai processi di agglomerazione urbana.
[1] http://www.lapei.it/
[2] Alberto Magnaghi, Il principio territoriale, Bollati Boringhieri, 2020
#arte contemporanea#pratiche territoriali#alberto magnaghi#villa d'ogna#territorio#coscienza del luogo#contemporaneo
1 note
·
View note
Text
Armonie in Amicizia: Musica ed Emozioni al Day Hospital Onco-Ematologico di Alessandria
Il 14 novembre 2024, il Coro Unitre Alessandria si esibisce presso l’Ospedale Civile di Alessandria per regalare un momento di serenità a pazienti e famiglie.
Il 14 novembre 2024, il Coro Unitre Alessandria si esibisce presso l’Ospedale Civile di Alessandria per regalare un momento di serenità a pazienti e famiglie. Il Day Hospital Onco-Ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria ospiterà, il 14 novembre 2024 alle ore 17, l’evento musicale “Armonie in Amicizia – Quattro passi tra musica ed emozioni”. Questo speciale concerto, che…
#Alessandria cultura#Alessandria eventi#Alessandria today#AOU Alessandria#Armonie in Amicizia#assistenza oncologica#benessere pazienti#benessere psicofisico#BIOS Donne Operate al Seno#Centro Studi Medical Humanities#coinvolgimento comunità#comunità ospedaliera#concerto benefico#concerto per pazienti#Coro Unitre Alessandria#Cultura Alessandria#cura attraverso la musica#DAIRI#Day Hospital Onco-Ematologico Alessandria#donazione pianoforte#Elia Fumagalli#eventi benefici#evento ospedaliero#famiglia Taulino#Google News#italianewsmedia.com#Monica Elias#musica e salute#musica in ospedale#musica terapeutica
0 notes
Text
Mario Giacomelli: Figure/Ground
da https://www.getty.edu (trad. G.Millozzi)
--- Nato in povertà, in gran parte autodidatta, Mario Giacomelli è diventato uno dei più importanti fotografi italiani. Dopo aver acquistato la sua prima macchina fotografica nel 1953, ha iniziato a creare ritratti "umanistici" di persone colte nei loro ambienti naturali e astrazioni drammatiche di paesaggi. Ha continuato a fotografare nella sua città natale, Senigallia sulla costa adriatica italiana, ma non solo, per quasi cinquant'anni. Rese in bianco e nero ad alto contrasto, le sue fotografie sono spesso grintose e crude, sempre intensamente personali.
Questa interessante mostra a Los Angeles (USA) presso il Centro della Fondazione Getty è dedicata alla memoria di Daniel Greenberg (1941-2021) ed è stata possibile grazie alla donazione da lui fatta insieme a Susan Steinhauser.
----------------
Mario Giacomelli (1925-2000) è unanimemente considerato come uno dei più importanti fotografi italiani del XX secolo. Nato in povertà, ha vissuto tutta la sua vita a Senigallia, una città sulla costa adriatica italiana, nelle Marche. Dopo aver perso suo padre all'età di nove anni ed aver completato ad undici la scuola elementare, ha fatto l'apprendista tipografo e lo stampatore, iniziando da autodidatta a dipingere e a scrivere poesie. Con i soldi donati da un anziano dell’ospizio dove la madre lavorava, aprì una sua tipografia, attività che gli ha assicurato la stabilità finanziaria per tutta la vita. Il suo impegno con la fotografia è iniziato poco dopo, profuso la domenica, quando il negozio era chiuso.
Dopo aver acquistato la sua prima macchina fotografica nel 1953, Giacomelli ottenne rapidamente numerosi riconoscimenti per la cruda espressività delle sue immagini, che echeggiavano molte dei temi del cinema neorealista del dopoguerra e della letteratura esistenzialista, con i loro interessi sulle condizioni della vita quotidiana e della gente comune come pensiero, individuale ed affettivo. La sua preferenza per la pellicola con grana grossa e per la carta da stampa ad alto contrasto lo ha portato a creare composizioni audaci e geometriche con neri profondi e bianchi luminosi. Focalizzando più frequentemente la sua macchina fotografica sulle persone, i paesaggi e le marine delle Marche, Giacomelli ha trascorso diversi anni ad esplorare la sua personale idea fotografica, ampliandola e reinterpretandola, o riproponendo un'immagine realizzata per una serie per includerla in un'altra. Dando inoltre alle sue opere titoli derivati dalla poesia, trasformò soggetti familiari in meditazioni su temi esistenziali, il tempo, la memoria e sul senso dell'esistenza stessa.
LA FORMAZIONE DI GIACOMELLI
Da giovane Giacomelli prestò per un breve periodo servizio nell'esercito italiano durante la II Guerra Mondiale. La sua pratica fotografica mostra l'influenza di due approcci prevalenti nella fotografia europea del dopoguerra: l' "umanesimo", che è spesso associato al fotogiornalismo, e l'espressione artistica come mezzo per esplorare la psiche interiore, derivata dalla teoria della fotografia soggettiva avanzata dal tedesco Otto Steinert (1915-1978). In Italia, questi approcci hanno trovato le loro rispettive controparti nei circoli fotografici "La Gondola", fondato a Venezia nel 1948, e "La Bussola", nato a Milano nel 1947. Giacomelli, da fotografo autodidatta, ha scambiato idee e conoscenze con i membri di entrambi i club. Fu anche cofondatore del circolo "Misa", una sezione locale de "La Bussola" che prese il nome dal fiume che scorre a Senigallia.
Le persone ed i luoghi di Senigallia sono motivi ricorrenti nell'opera di Giacomelli. Oltre a rivelare il suo interesse per le diverse comunità della sua città natale - dalle fotografie di una famiglia rom ai bambini che si divertono sulla spiaggia - dimostrando la sua capacità di combinare impulsi umanistici ed espressivi. Giacomelli sin da giovane capì come la grana grossa, il movimento e l'alto contrasto potevano fare di più che fornire semplicemente una sensazione di astrazione in quanto accrescevano anche il potere emotivo delle immagini.
I PRIMI LAVORI (1956–60)
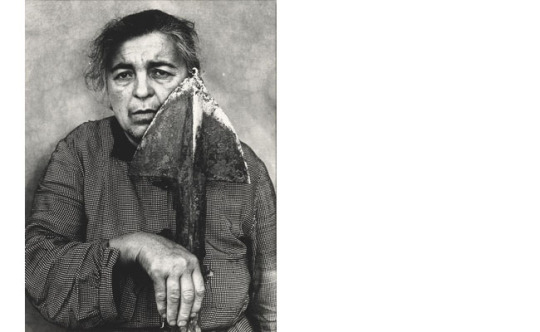
Mia madre 1956, stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
Nel 1955 Giacomelli acquistò la fotocamera Kobell di seconda mano con obiettivo Voigtländer che avrebbe impiegato per il resto della sua carriera. In seguito la descrisse come qualcosa che era stato "rattolato", ossia tenuto insieme con del nastro adesivo e che perdeva sempre parti! Realizzata dai produttori milanesi Boniforti & Ballerio, la fotocamera utilizzava rullini 120 per produrre negativi 6 x 9 cm e dandogli la possibilità di usarla con obiettivi intercambiabili ed un flash sincronizzato. Per Giacomelli non era un dispositivo per registrare la realtà, ma un mezzo di espressione personale. La sua prima collaborazione con membri di club fotografici locali e nazionali e la sua sperimentazione con l'illuminazione naturale e artificiale, esposizioni multiple e altre tecniche con questa nuova macchina fotografica ed in camera oscura hanno presto portato a quella raffinatezza di un linguaggio visivo unico che lo contraddistingue.
Tra le prime fotografie di Giacomelli ci sono ritratti di familiari e amici: l'immagine di sua madre che tiene in mano una vanga è una delle sue più significative. Ha anche scattato fotografie di nature morte e studi di figura nella sua casa e nel giardino; i nudi esposti in mostra ritraggono il fotografo e sua moglie, Anna. Relativamente convenzionali nella composizione, queste opere illustrano come Giacomelli abbia imparato il suo mestiere, fornendo anche la misura in cui il suo soggetto è stato suggerito dalle persone e dai luoghi a lui più vicini.
OSPIZIO | VERRÀ’ LA MORTE E AVRÀ I TUOI OCCHI (1954–83)

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, n. 97 , 1966; stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
La prima opera che Giacomelli espose in serie fu Ospizio. Raffigura i residenti della casa per anziani di Senigallia, dove sua madre lavorava come lavandaia, che ha visitato per diversi anni prima di iniziare a fotografarvi. Realizzate con il flash, le immagini che ne risultano sono caratterizzate da uno studio inflessibile di individui che vivono i loro ultimi giorni. In seguito si riferirà a queste come le sue fotografie più vere e dirette perché riflettevano la sua stessa paura di invecchiare.
Giacomelli ha continuato questa serie per quasi tre decenni, ribattezzandola nel 1966 Verrà la morte e avrà i tuoi occhi come il titolo di una raccolta di poesie dello scrittore Cesare Pavese (1908-1950). Nel portfolio pubblicato nel 1981 ha intensificato le qualità inquietanti del declino e dell'isolamento mentale e fisico ingrandendo piccole porzioni dei suoi negativi e stampando su carta accartocciata anziché piatta.
"Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dalla mattina alla sera, insonne".
—Tradotto da Geoffrey Brock, 2002
LOURDES (1957 e 1966)

Lourdes, 1957, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
In contrasto con Ospizio / Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, la serie Lourdes descrive persone che vivono con malattie, ferite o disabilità che sono alla ricerca di una guarigione miracolosa. Giacomelli ricevette l'incarico di fotografare in questo luogo di pellegrinaggio cattolico nel sud della Francia nel 1957. Fortemente addolorato da ciò che vide, usò solo pochi rullini, restituì la somma che gli era stata anticipata e per un po’ di tempo non mostrò a nessuno le immagini scattate. Si recò poi di nuovo a Lourdes nel 1966, con la moglie e il secondo figlio. Questa volta era alla ricerca di una cura, per il loro figlio, che aveva perso la capacità di parlare a seguito di un incidente.
Lourdes è l'unica serie realizzata da Giacomelli fuori dall'Italia, anche se gli è stato attribuito un gruppo di fotografie realizzate in Etiopia (1974) ed un altro in India (1976). Giacomelli acquistò macchine fotografiche e pellicole per due persone che stavano programmando un viaggio in questi paesi, ed entrambi hanno tratto spunti e suggerimenti da precedenti discussioni con lui quando fotografarono nelle rispettive località. Giacomelli in seguito fece delle stampe dai negativi e firmò il suo nome su alcuni di essi, riconoscendo così la sua collaborazione.
PUGLIA (1958)
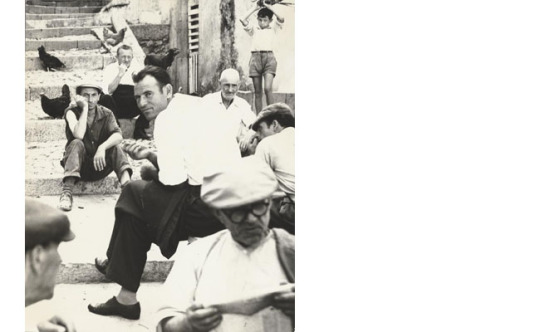
Puglia , 1958; stampato 1960, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
Giacomelli gestiva la sua tipografia, la Tipografia Marchigiana, nel centro di Senigallia. Un’attività di successo che divenne ben presto un luogo di ritrovo per fotografi, artisti e critici, il cui indirizzo stampato lo ritroviamo sul verso di tutte le sue fotografie. Nei suoi primi anni, l'attività occupava la maggior parte del tempo di Giacomelli, lasciandogli solo la domenica per le sue escursioni fotografiche. Così esplorava più spesso la vicina sua città, le sue spiagge e la campagna circostante nelle Marche, solo di tanto in tanto viaggiava anche più lontano.
Per questa serie, realizzata in Puglia, la provincia più a sud-est d'Italia (il “tacco dello stivale”), dovette fare un viaggio di circa 480 chilometri. Lì ha concentrato la sua attenzione sull'interazione di più generazioni di cittadini che si riuniscono tranquillamente sullo sfondo della tipica architettura semplice e imbiancata delle città collinari come Rodi Garganico, Peschici, Vico del Gargano e Monte Sant'Angelo. Queste immagini ci forniscono un'idea della capacità di Giacomelli di coinvolgere i suoi soggetti, sottolineando anche il fondamentale impulso umanistico nel suo lavoro.
SCANNO (1957-1959)

Scanno, n. 52 , 1957-1959; stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
A seguito della sua continua osservazione dei residenti dell'ospizio di Senigallia, le fotografie, che Giacomelli ha realizzato durante i viaggi a Scanno nel 1957 e nel 1959, dimostrano ulteriormente la sua capacità di descrivere le persone in un determinato tempo e luogo. In questo paese situato nell'Appennino dell'Italia centrale, a circa 430 chilometri a sud di Senigallia, Giacomelli incontrò uomini e donne che svolgevano le loro faccende quotidiane o si radunavano in piazza, drappeggiati in abiti o mantelli scuri, con il capo coperto di cappelli o sciarpe. Anche quando si radunano, i soggetti sembrano isolati o persi nei propri pensieri. Sia a fuoco nitido, che sfocato dal movimento, l'individuo, che accidentalmente guarda direttamente nella sua macchina fotografica, suggerisce un senso di mistero o furtività. Giacomelli ha usato, per fotografarli, una bassa velocità dell'otturatore e una ridotta profondità di campo.
GIOVANI SACERDOTI | NON HO MANI CHE MI ACCAREZZANO IL VOLTO (1961–63)
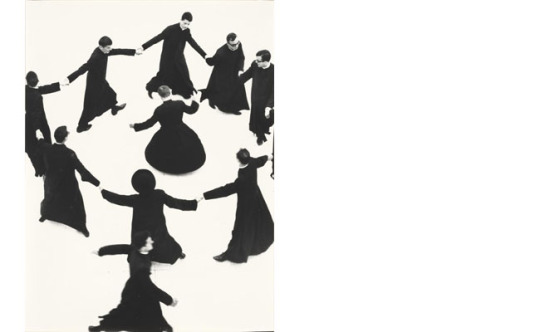
Giovani sacerdoti, n. 74, 1961–63; stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
Tra le immagini più memorabili di Giacomelli ci sono quelle dei pretini (giovani sacerdoti) del seminario di Senigallia, che ha catturato mentre giocano nella neve o si rilassano nel cortile. Ancora una volta accoppiando le forme particolari di figure vestite di nero (questa volta, seminaristi in tonaca) su uno sfondo bianco (ambienti innevati o assolati), queste fotografie suggeriscono uno stato d'animo più spensierato di quanto non sia evidente in altre serie. Sebbene sembrino coreografie impostate, sono invece il risultato della sfrenata giovialità dei preti mentre corrono, lanciano palle di neve o giocano a girotondo, unite alla lungimiranza di Giacomelli di lasciare che le scene si svolgessero naturalmente, mentre le riprendeva dal tetto.
Dopo aver conquistato la fiducia dei seminaristi, Giacomelli iniziò ad interagire con loro, ma questa interazione si interruppe bruscamente quando propose ai giovani dei sigari in cambio di alcune fotografie che intendeva presentare a un concorso sul tema del fumo. Il rettore del seminario, scandalizzato dalla proposta, gli negò ulteriori accessi. Giacomelli in seguito diede a questa serie il titolo Non ho mani che mi accarezzano il volto, traendo le parole dai primi due versi di una poesia di padre David Maria Turoldo (1916-1992) dedicata ai giovani che abbracciano solitaria vita religiosa. Questo titolo conferisce intensità ai momenti di esuberanza e cameratismo che accompagnano le intense ore di studio in seminario.
I PRIMI PAESAGGI (1954–60)
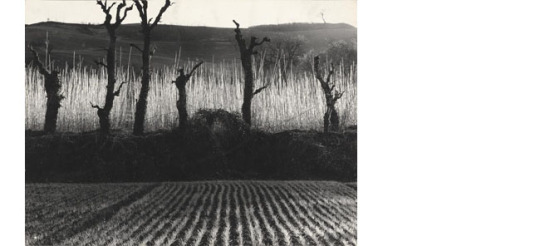
Paesaggio: Fiamme sul campo , 1954; stampato 1980, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
La regione italiana delle Marche è caratterizzata da dolci colline, piccole fattorie e frazioni, tra i primi soggetti fotografati da Giacomelli. Come per i suoi ritratti e gli studi di figure di questo periodo, le composizioni dei suoi primi paesaggi sono abbastanza convenzionali, con elementi in primo piano al centro e sullo sfondo, altri organizzati attorno alla linea dell'orizzonte chiaramente distinguibile. Tuttavia, man mano che affinava la propria tecnica, Giacomelli si posizionava spesso in cima a una collina puntando la macchina fotografica verso il basso o alla base di essa puntandola verso l'alto, eliminando così l'orizzonte e creando un disorientante assieme di forme geometriche. Il suo particolare sviluppo del negativo, l'uso di carta da stampa ad alto contrasto e le manipolazioni in camera oscura hanno ulteriormente migliorato le qualità grafiche distintive delle sue immagini. Non era raro per lui incidere forme sui suoi negativi per aggiungere drammatici contrappunti.
Negli anni Giacomelli è tornato più volte in alcuni siti, documentandoli durante le diverse stagioni e rotazioni di colture. In seguito avrebbe incorporato fotografie realizzate per uno scopo in una serie che aveva altre ambizioni iniziali, in particolare quella di fungere da commento sulla capacità sia degli eventi naturali sia degli interventi umani di cambiare le caratteristiche della terra.
LA BUONA TERRA (1964-1966)
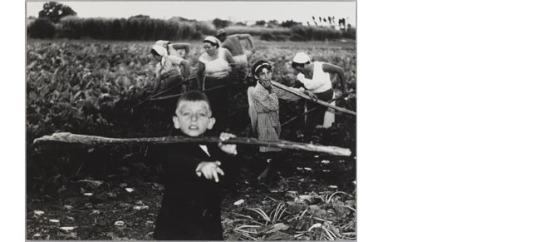
La buona terra, 1964-1966: stampato anni '70, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
Per questa serie, Giacomelli ha seguito le vicende di una famiglia di contadini per diversi anni mentre conducevano la loro vita quotidiana nelle campagne intorno a Senigallia, seminando e raccogliendo colture e curando il bestiame. Una volta ottenuta la loro fiducia, ha iniziato a realizzare fotografie che sottolineassero la natura ciclica della loro esistenza, includendo sia l'intreccio di più generazioni sia l'intreccio di compiti e responsabilità quotidiane, con momenti di svago e riposo. La buona terra racconta una storia di resilienza, autosufficienza e continuità.
L'ultima di queste immagini è simboleggiata dal motivo ricorrente degli imponenti pagliai che fanno da sfondo al lavoro, al gioco e alla celebrazione del matrimonio di una giovane coppia.
Periodicamente Giacomelli chiedeva alla famiglia, con la quale intratteneva un'amicizia al di là di questo progetto, di utilizzare il proprio trattore per arare precise sagome nei campi incolti. Le immagini risultanti, che costituiscono la base della sua serie Consapevolezza della natura, affrontano la questione degli interventi dell'uomo sul paesaggio. Alcuni esempi sono in mostra parte finale del percorso.
METAMORFOSI DEL TERRITORIO (1958-1980)
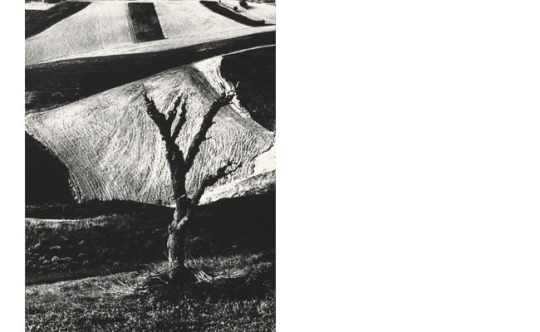
Metamorfosi della terra, n. 5 , 1971; stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
Le fotografie raccolte sotto il titolo Metamorfosi della Terra sono state realizzate nell'arco di circa due decenni nelle campagne senigalliesi. Senza una linea dell'orizzonte per ancorarli, sono disorientanti, richiedendo allo spettatore di fare affidamento su una casa o un albero solitario come punto focale. L'ambiguità prospettica abbonda: Giacomelli ha scattato le fotografie da un punto di vista elevato o abbassato? Ha tenuto la telecamera parallela o perpendicolare al terreno? Questa confusione è il risultato dell'intrinseca "verticalità" della regione collinare marchigiana, o Giacomelli si è affidato alla manipolazione in camera oscura (come la stampa su fogli di carta fotografica inclinati diagonalmente) per creare configurazioni ad angolo retto di forme che altrimenti dovrebbero retrocedere nella distanza ad un determinato punto, seguendo i principi della prospettiva?
Queste ambiguità sono ulteriormente intensificate dall'intenzione di Giacomelli di affrontare con questo lavoro le questioni di abbandono e perdita ecologica. Profondamente in sintonia con la geografia rurale e le pratiche agricole marchigiane, diffida delle conseguenze che hanno accompagnato il passaggio dai secolari sistemi di frazionamento e rotazione delle colture ai moderni metodi di meccanizzazione e concimazione che sovraccaricano il terreno mantenendolo in costante uso. La serie è quella del lamento.
CONSAPEVOLEZZA DELLA NATURA (1976-1980)

Consapevolezza della natura, n. 38 , 1977-1978; stampato 1981, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
Le fotografie di questa serie sono tra le più iconiche di Giacomelli, notevoli per la loro astrazione grafica e grintosa, che ha ottenuto grazie ad una prospettiva aerea e utilizzando pellicole scadute per esasperare il contrasto tra bianco e nero. Trovando una poetica reciprocità nel ritrarre una terra in “triste devastazione” con una pellicola “morta”, Giacomelli ha percepito queste immagini come un mezzo per resuscitare la sua amata campagna marchigiana e dotarla di un diverso tipo di bellezza. I campi arati pulsano con un'intensità ritmica che è assente dalle immagini precedenti, in parte perché ha chiesto che alcuni di questi solchi fossero incisi appositamente nella terra (come già anticipato, dalla famiglia di contadini che ha descritto in La buona terra). Un timbro sul verso di ogni stampa descrive ulteriormente la serie come “l'opera dell'uomo e il mio intervento (i segni, la materia, la casualità, ecc.) registrati come documento prima di perdersi nelle relative pieghe del tempo”. Le immagini risuonano concettualmente con la Land Art o Earth Art, un movimento artistico attivo alla fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, in cui gli artisti usavano il paesaggio per creare sculture e forme d'arte site-specific. Come era sua abitudine, Giacomelli ha incorporato fotografie di serie precedenti, che potrebbero essere state fatte da una collina vicina o che non includevano i suoi interventi.
LAVORI SUCCESSIVI (anni '80)
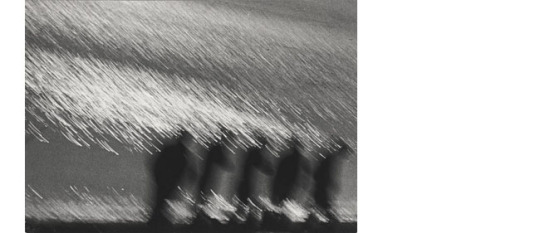
Le mie Marche, anni '70-'80, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
Giacomelli ha concepito molte delle sue serie come sequenze che raccontano storie di individui in un determinato tempo e luogo. Ha intervallato ritratti e paesaggi, ma ha anche unito questi generi in doppie esposizioni o sperimentando tempi di posa lunghi e muovendo la fotocamera durante l'esposizione per sfocare le linee tra la figura e lo sfondo. E ancora una volta, ha spesso riproposto un'immagine realizzata per una serie in un'altra serie, rafforzando il senso di fluidità che collega tutto il suo lavoro. Molte di queste sequenze sono state ispirate da poesie, non nel tentativo di illustrarle, ma per creare narrazioni parallele.
Sebbene le fotografie in questa sezione derivino da serie diverse, ne condividono il senso nell'impostazione, nella posizione o nell'atmosfera. Più facilmente classificabili come paesaggi, segnano un notevole passaggio dalla precedente posizione di Giacomelli di criticare il lento degrado della terra a quella che invece pone le basi per una contemplazione più metafisica dell'interconnessione tra spazio, tempo ed essere. La maggior parte è stata realizzata negli anni Ottanta, quando Giacomelli rifletteva sulla perdita della madre (morta nel 1986), sulla sua crescente reputazione internazionale come fotografo e sulla propria mortalità.
IL MARE DELLE MIE STORIE (1983-1987)

Il mare delle mie storie, 1983–87, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
Giacomelli ha annotato che il mare a cui si fa riferimento nel titolo di questa serie era quello della sua infanzia, l'Adriatico, ma in realtà era anche il mare di tutta la sua vita. Ha realizzato le sue prime fotografie lungo la costa di Senigallia dopo aver acquistato una macchina fotografica nel 1953. Circa trent'anni dopo, la curiosità su come una prospettiva aerea potesse trasformare l'aspetto delle persone lo ha portato a ricorrere ad un amico che possedeva un aeroplano per farlo volare sopra le spiagge della regione. Le composizioni risultanti creano motivi astratti sulla sabbia, generati dalle forme e dalle ombre di bagnanti, di sedie a sdraio, d'ombrelloni e di barche.
VORREI RACCONTARE QUESTO RICORDO (2000)

Vorrei raccontare questo ricordo, 2000, Mario Giacomelli, stampa alla gelatina sali d'argento. Il J. Paul Getty Museum, dono di Daniel Greenberg e Susan Steinhauser. Riprodotto per gentile concessione di Mario Giacomelli Archive © Rita e Simone Giacomelli
Il titolo poetico di questa serie riflette lo stato d'animo sempre più pensieroso dell'ultimo lavoro di Giacomelli. Di tanto in tanto intravediamo il fotografo stesso mentre si occupa di uno strano assortimento di oggetti di scena, tra cui cani e uccelli di peluche, un manichino e una maschera. Il suo brusco ritaglio, la leggera sovraesposizione per invertire i valori tonali e la pittura o il graffio di aree sul negativo introducono elementi dell'assurdo o del surreale come mezzi per affrontare l'inevitabilità della propria mortalità. La serie, una delle sue ultime, è una meditazione sulla malinconia, la perdita e il passare inesorabiole del tempo.
RIFLESSIONI SU GIACOMELLI
Giacomelli muore nel novembre 2000 dopo una lunga malattia. Aveva continuato a lavorare su diverse serie fotografiche fino ai suoi ultimi giorni, con il commovente titolo Vorrei raccontare questo ricordo attestando fino alla fine il suo temperamento profondamente introspettivo. Dai suoi inizi poco promettenti come ragazzo povero e poco istruito, Giacomelli ha reindirizzato il corso della sua vita, mantenendo un'attività di stampa di successo che gli forniva sicurezza finanziaria e dedicandosi alle arti come personale mezzo di espressione. Sebbene fosse autodidatta in poesia, pittura e fotografia, è stato con quest'ultimo mezzo che ha creato un senso di continuità e fluidità per tutta la sua vita. Ha ottenuto riconoscimenti internazionali come uno dei fotografi più importanti d'Italia nonostante abbia realizzato la maggior parte delle sue fotografie nella sua città natale, Senigallia e nelle vicine Marche.
“Naturalmente [la fotografia] non può creare, né esprimere tutto ciò che vogliamo esprimere. Ma può essere una testimonianza del nostro passaggio sulla terra, come un quaderno…
...Per me ogni foto rappresenta un momento, come respirare. Chi può dire che il respiro di prima sia più importante di quello dopo? Sono continui e si susseguono finché tutto si ferma. Quante volte abbiamo respirato stanotte? Potresti dire che un respiro è più bello degli altri? Ma la loro somma costituisce un'esistenza”.
—Mario Giacomelli, 1987
LA COLLEZIONE GIACOMELLI
Tra il 2016 e il 2020, i collezionisti di Los Angeles Daniel Greenberg e Susan Steinhauser hanno donato 109 fotografie di Mario Giacomelli al J. Paul Getty Museum. La loro collezione copre ampie aree della produzione di Giacomelli, da alcune delle sue prime immagini a quelle realizzate negli ultimi anni della sua vita. Attingendo dalle loro donazioni, questa mostra è concepita non come una retrospettiva completa, ma come un'opportunità per considerare la visione dei collezionisti nell'assemblare questi fondi in un periodo di vent'anni, facendo comprendere quelle che percepivano come le preoccupazioni chiave della pratica di Giacomelli: la gente e il paesaggio, così come la gente nel paesaggio – il rapporto “figure/ground” del sottotitolo della mostra.
Il Getty Museum è riconoscente anche all'Archivio Mario Giacomelli, con sede a Senigallia, Sassoferrato e Latina, per l'assistenza nella conferma di titoli e date. Nel corso della sua carriera Giacomelli è tornato alle singole immagini, ripensandole e rielaborandole per serie successive, complicando spesso il compito di assegnare titoli o date definitivi. Grazie anche a Stephan Brigidi dei Bristol Workshops in Photography per aver fornito informazioni sui portfolio dell'artista del 1981, La gente e Paesaggio. Le stampe dei portfolio sono dislocate nei quattro percorsi della mostra e presentate in cornici più leggere ed in misura più grande.
---Tutte le immagini in mostra: link
------------------------
Mario Giacomelli: Figure / ground
29 giugno-10 ottobre 2021
Getty Center
1200 Getty Center Drive, Los Angeles, CA 90049 ' +13104407300
Orario: 10.00 – 17.00, chiuso il lunedì
1 note
·
View note
Text
Come posso contattare le biblioteche bergamasche che non fanno parte della RBBG?
Nella provincia di Bergamo ci sono molte biblioteche non collegate alla Rete bibliotecaria bergamasca con cataloghi ricchi e utili.
Sistema bibliotecario urbano [Bergamo CITTÀ] Il Sistema Urbano di Bergamo è costituito dalle otto biblioteche di pubblica lettura della città di Bergamo e dal centro di catalogazione.
CATALOGO BIBLIOTECHE CITTA' DI BERGAMO
Biblioteca civica "Angelo Mai"
Biblioteca centrale "Antonio Tiraboschi"
Biblioteche rionali Biblioteca Ambiveri - Biblioteca Caversazzi - Biblioteca Gavazzeni - Biblioteca Colognola - Biblioteca Pelandi - Biblioteca Loreto - Biblioteca Valtesse
ALTRE BIBLIOTECHE IN CITTA’
Biblioteca dell'Accademia Carrara via San Tomaso, 53 - 24121 Bergamo - Tel. 035/270272 - [email protected]
Biblioteca del Museo di Scienze Naturali "E.Caffi" piazza Cittadella, 3 - 24129 Bergamo - Tel 035286050 [comprende il Centro di riferimento per l'educazione ambientale - via Reich, 49-51 - 24020 Torre Boldone] - Tel. 035-399464 035-399614
Biblioteca Musicale "Gaetano Donizetti" via Arena, 9 - 24129 Bergamo - Tel 035233781 - [email protected]
Biblioteca del Museo Archeologico piazza Cittadella, 9 - 24129 Bergamo - Tel. 035242839
Biblioteca del Museo storico di Bergamo Piazza Mercato del Fieno, 6/a - 24129 Bergamo - tel.035247116 - [email protected]
Biblioteca Fondazione "Serughetti-La Porta" viale Papa Giovanni XXIII, scala d - 24121 Bergamo - tel 035-219230 - [email protected]
Biblioteca Centro Servizi Bottega del Volontariato della provincia di Bergamo via Longuelo, 83 - 24129 Bergamo Tel. 035/234723 - [email protected]
Biblioteca dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo - Tel: 035-4213318
Biblioteca dell'Archivio di Stato di Bergamo via Fratelli Bronzetti, 24-26-30 - 24124 Bergamo - tel. 035/233131- [email protected]
Biblioteca della Fondazione "Adriano Bernareggi" via Pignolo, 76 - 24121 Bergamo - tel. 035-248772 - [email protected]
Biblioteca "Di Vittorio" - CGIL Via Garibaldi, 3/E - 24122 Bergamo - Tel. 035-3594350 - [email protected]
Biblioteca del Clero di S. Alessandro in Colonna presso Biblioteca Mons. Giacomo Maria Radini Tedeschi - Istituto diocesano Preti del S. Cuore via Garibaldi, 10 - 24122 Bergamo - tel. 035/270657 - [email protected]
Biblioteca "Girolamo Zanchi" del Centro culturale protestante Bergamo via T. Tasso, 55 - 24121 Bergamo - tel. 340 16 95 685 - [email protected]
Biblioteca dell'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea (ISREC) via T. Tasso, 4 - 24121 Bergamo - tel. 035-238849 - [email protected]
Ateneo di scienze lettere ed arti (già Accademia degli eccitati) - Biblioteca via Torquato Tasso, 4 - 24121 Bergamo - Tel. e fax 035.247.490 - [email protected]
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Centro Documentazione scientifica Piazza OMS 1 -Piano: 0 - Civico: 55 - Torre 7 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267.3701- [email protected]
Camera di Commercio Largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo - Tel. 035.422.5243 - [email protected]
Celim Bergamo, Organizzazione del Volontariato Internazionale Cristiano - Centro Documentazione via Conventino, 8 - 24125 Bergamo - [email protected]
Fondazione Alasca Lab80 Archivi dell’audiovisivo via Pignolo, 123 - 24121 Bergamo - Tel. 035 344246 - [email protected]
Centro Studi, Osservatorio Politiche Sociali - CSD Via Fratelli Calvi 10, Palazzina B - 24122 Bergamo - Tel.035387656 - [email protected]
CISL - Biblioteca "Giuliano Zonca" via Giovanni Carnovali, 88/A - 24126 Bergamo - Tel. 035.324.759 - [email protected]
Biblioteca Seminario Vescovile "Giovanni XXIII" via Arena, 11 - 24129 Bergamo - Tel. 035.286.221/252 - [email protected]
Unione Italiana Ciechi - Biblioteca non vedenti via Torquato Tasso, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.399.980 - [email protected]
Servizi bibliotecari dell'Università di Bergamo Le tre biblioteche dell'Università di Bergamo sono i punti di servizio del sistema bibliotecario di Ateneo che contempla una biblioteca umanistica, la biblioteca di Economia e Giurisprudenza e la biblioteca di Ingegneria.
Mediateca provinciale Via Angelo Goisis 96/B - 24124 Bergamo - Tel. 035 320828 - [email protected]
Brembate di Sopra Fondazione Famiglia Legler Via Legler 14 -24030 - tel 035 4371563
Camerata Cornello Biblioteca del Museo dei Tasso e della storia postale via Cornello, 22 - 24010 Camerata Cornello Tel. 0345 43479 [email protected]
Dalmine Biblioteca della Fondazione Dalmine piazza Caduti del 6 luglio 1944, 1 - 24044 Dalmine - Tel. 035 5603418 - [email protected]
Museo del Presepio Via XXV Aprile, 179 - tel 035 563383
Gandino Biblioteca parrocchiale di S. Maria Assunta Via Bettera, 14 - 24024 Gandino BG - Tel 035/745425 - [email protected]
Lovere Biblioteca dell'Accademia di Belle Arti "Tadini" Piazza Garibaldi, 5 - 24065 Lovere - tel. 035 962780 - [email protected]
Romano di Lombardia Biblioteca parrocchiale - Museo d'arte e cultura sacra vicolo Chiuso, 22 - 24058 Romano di Lombardia - tel 0363-910633 - [email protected]
Altri cataloghi
Beni Culturali Diocesi di Bergamo La storia e la cultura bergamasca attraverso gli oggetti prodotti nel corso dei secoli dalle comunità cristiane del territorio. L'archivio contiene i beni culturali mobili ecclesiastici di tutto il territorio della Diocesi di Bergamo ed è costituito da oltre 270.000 schede e circa 280.000 immagini digitali.
Sistema bibliotecario della Regione Lombardia Il Polo regionale lombardo vede la partecipazione di 82 biblioteche di varia titolarità e 3 sistemi bibliotecari urbani con oltre 500 postazioni di lavoro collegate e numerose postazioni a disposizione del pubblico. L’OPAC del Polo regionale lombardo SBN comprende materiale antico, moderno e musica, e, in misura per ora ancora limitata, collegamenti a risorse digitali.
Biblioteca Digitale della Lombardia La sezione consente l'accesso a un primo nucleo di documenti inerenti territorio, storia e arte della Lombardia. I documenti disponibili appartengono al patrimonio librario di cinque istituzioni: Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo, Biblioteca Civica Centrale di Monza, Biblioteca Civica Ricottiana di Voghera, Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda e Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia.
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale Il Catalogo SBN è la rete delle biblioteche italiane promossa dal MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), dalle Regioni e dalle Università, e coordinata dall'ICCU. Vi aderiscono attualmente biblioteche statali, di enti locali, universitarie, di istituzioni pubbliche e private, operanti in diversi settori disciplinari (oltre 5.600 a giugno 2015). Le biblioteche che partecipano a SBN sono raggruppate in Poli locali.
Catalogo dei periodici italiani Il sito del Catalogo Italiano dei Periodici ACNP è un progetto che ha avuto origine negli anni '70 su iniziativa dell’ISRDS-CNR per realizzare un Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (da qui la sigla ACNP). Dal 1988 il Centro Inter-Bibliotecario (dal 2011 Area Sistemi Dipartimentali e Documentali) dell'Università di Bologna cura, in collaborazione con il CNR, le procedure gestionali on-line e l'OPAC del catalogo.
Catalogo Libro Parlato Lions Il sito del "Libro parlato Lions" è un servizio totalmente gratuito che - da oltre trent'anni - mette a disposizione di tutti i suoi utenti la propria "AUDIOBIBLIOTECA" interamente costituita da libri registrati da "viva voce"; un "service" della grande tradizione dei Lions, i "cavalieri della luce per i non vedenti", come li ha denominati la cieca Helen Keller alla Convention Internazionale dell'Associazione Lions del 1925. Possono essere utenti tutti coloro che non possono leggere autonomamente: ciechi, ipovedenti, persone anziane con difficoltà di lettura, disabili fisici e psichici, pazienti ospedalizzati, dislessici.
1 note
·
View note
Photo

Comunicato stampa del 13/09/2020
IN PROVINCIA DI ENNA RINASCE LA FIAMMA TRICOLORE
La Comunità militante di Barrafranca, che nei mesi scorsi ha dato vita al Centro Studi “Praesidium”, attivo sul territorio con varie azioni di denuncia sui molti disservizi comunali, sulla difesa e cura del verde pubblico, diffusione di locandine in ricordo del giudice Paolo Borsellino e altre iniziative, unitamente ai rappresentanti di Leonforte, Aidone, Calascibetta, Villarosa, (presto altri con cui siamo in contatto si aggiungeranno), annuncia l’adesione al Movimento Sociale – Fiamma Tricolore, già concordata con il segretario regionale Mario Settineri e con il segretario nazionale Attilio Carelli. Per molti di noi che hanno militato e provengono dalla storia gloriosa del Movimento Sociale Italiano e dalla Fiamma Tricolore fondata da Pino Rauti dopo il tradimento e l’abiura di Fiuggi, si tratta di un ritorno nella nostra casa politica di sempre. Tempo addietro fummo costretti a compiere altre scelte, sempre comunque in linea con i nostri ideali, per contrasti politici con l’allora segretario Luca Romagnoli, poi finito in Fratelli d’Italia. Per fortuna, la classe dirigente della Fiamma ha saputo mantenere salde le radici difendendo la propria identità di unico soggetto politico legittimato come erede del Movimento Sociale Italiano di Almirante e Rauti e un progetto autenticamente alternativo basato sul trinomio Identità-Sovranità-Socialità.Da oggi anche in provincia di Enna rinasce la Fiamma Tricolore: Avamposto di libertà contro la dittatura del pensiero unico e del politicamente corretto; Presidio di difesa della nostra cultura e identità nazionale; Alternativa sociale e nazionalpopolare per la rinascita della Patria.Nelle prossime settimane comunicheremo la data per l’inaugurazione della sede provinciale alla presenza dei massimi dirigenti del Movimento.
Centro Studi Praesidium – Ufficio stampa
0 notes
Link
Esistono due tipi di contenuto a sfondo razzista nelle curve del tifo organizzato. Una forma larvata di micronazionalismo, anzi una sorta di localismo aggressivo, si manifesta un po’ ovunque, negli stadi calcio, per effetto della vocazione territorialista che si annida in ogni tifoseria. Questa attitudine è riflesso di una componente originaria. Non ci sarebbero stati ultrà, senza appartenenza ai luoghi, alle città, agli spazi eletti a presidio di tali aggregati giovanili. È una vocazione che può sfociare in comportamenti e messaggi apertamente xenofobi, ma non è detto che ciò debba avvenire sempre. Al contrario, in molti stadi italiani come in altri contesti europei, dove per diverse ragioni il bagaglio simbolico delle singole tifoserie si è orientato verso l’antirazzismo militante e la componente identitaria ha interiorizzato tale scelta di campo, la rivendicazione dell’odio razziale è stata bandita. Esiste però un altro tipo di razzismo negli stadi. Ed è quello veicolato da militanti e organizzazioni di estrema destra, molto abili nel portare all’esasperazione una tendenza di per sé costitutiva di ogni aggregato ultrà: l’individuazione del nemico. Queste organizzazioni incontrano condizioni favorevoli. La maggior parte dei frequentatori di una gradinata presenta infatti un carattere verginale nella padronanza del lessico politico; soprattutto nei primi anni assorbe parole d’ordine e miti basati sulla semplicità del messaggio. D’altronde i gruppi della destra radicale autonoma trovano terreno favorevole non solo nella predisposizione delle curve a “farsi patria”, ma anche nel sistema poliziesco strutturatosi intorno al panorama del tifo organizzato negli ultimi decenni, che ha sterilizzato la componente solidaristica presente in diversi contesti curvaioli, accentuandone le pratiche paramilitari. A deviare l’immaginario verso la causa xenofoba contribuiscono i media mainstream che per semplificazione comunicativa, e spesso per esigenze di bottega, comprimono le categorie simboliche del razzismo e dell’ultrà, le appiattiscono rendendole omogenee e complementari. C’era una volta Verona “La cultura della nostra terra contro l’idiozia delle vostre menti. Verona prima solo nell’eroina”. Il compianto ultrà Ettore Covello andava orgoglioso di questo striscione esposto a suo tempo in un Cosenza-Verona in risposta alle provocazioni neonazi degli ultrà scaligeri nella gara di andata. Nella sua tesi di laurea specialistica mai discussa, perché la morte prematura ne ha troncato sogni e prospettive, Covello individua il sostrato xenofobo nei rituali del pallone e rileva il carattere multidirezionale della discriminazione razziale dentro e intorno al football: “È spesso motivo di comportamenti violenti all’interno di una medesima tifoseria, infatti vi sono casi di insulti razzisti tra gli stessi tifosi di una squadra. Sono diverse le testimonianze di tifosi neri e meticci che dichiarano di essere stati insultati sugli spalti da altri tifosi, e ciò fa sì che la loro presenza sugli spalti sia molto limitata”. Questa casistica di eventi perlopiù spontanei, in qualche modo connaturati al gioco del calcio sin dalle sue origini, è testimoniata da un’ampia letteratura. In “Compagni di stadio” Solange Cavalcante ricorda le pesanti restrizioni per il tesseramento dei giocatori neri che in Brasile e altrove furono attuate per tutta la prima metà del ‘900: “Più tardi – un più tardi che si fece attendere fino agli anni Cinquanta – dirigenti e leghe dovettero cominciare ad aprire le porte dei club ai neri, non potendoli più lasciare fuori a guardare. Nonostante ciò, per ora la porta aperta dei club sarebbe stata solo quella secondaria, quella della servitù. Accettarono i giocatori neri e meticci, ma a patto che non accedessero ai club per gli stessi percorsi dei bianchi, che usassero retine e si stirassero i capelli, schiarendosi la pelle del volto con la polvere di riso”. Dal canto suo, Ettore Covello evidenzia quanto sia labile il confine tra spontaneità e propaganda studiata a tavolino. A partire dagli anni novanta, numerose sono state le iniziative di chiara finalità politica, che i gruppi egemoni di alcune delle principali curve italiane hanno prodotto per innestare un razzismo consapevole e schierato nella messaggistica differenzialista che nei linguaggi del calcio non è mai mancata, a tutti i livelli, persino istituzionali, nel passato recente come in quello remoto. Si pensi solo alle infelici esternazioni omofobe e antisemite del presidente della FIGC, Carlo Tavecchio. “Nel 1983/84 a Verona si sentirono i primi “Buuh” razzisti nei confronti di Cerezo, – scrive Covello – e nel 1996 si tentò di comprare un giocatore di colore, l’olandese dalla pelle scura Ferrer, ma dalla curva, in occasione del derby con il Chievo, appesero un fantoccio tinto di nero con una corda al collo e addosso la scritta “Negro go away”; dietro, un paio di ultrà gialloblu, indossarono il cappuccio del Ku-Klux-Klan. Inoltre esposero uno striscione in dialetto veronese che recitava: “Il negro ve l’hanno regalato, dategli lo stadio da pulire”, e sui muri della città avevano scritto “Meglio in C che un giocatore negro”. Verona diviene così, sin dagli anni novanta, laboratorio di un neonazismo futbolisticoriproducibile, alla portata del supporter spontaneo e sprovveduto, non assimilabile al militante dell’estrema destra. Il razzismo attecchisce nell’iconografia della tifoseria gialloblu, entra a far parte del suo codice costituente, assume la portata di tratto peculiare della volontà di insubordinazione che permea una comunità ultrà e la distingue dal restante contesto della tifoseria d’appartenenza. Dick Hebdige, fondamentale studioso degli stili di vita giovanili conflittuali e delle pratiche di insorgenza spontanee non riconducibili alle forme della politica militante, spiega che “la risposta sottoculturale non è semplice affermazione né rifiuto, né sfruttamento commerciale e neppure ribellione sincera. Non è semplice resistenza a un ordine esteriore né esplicito conformismo alla cultura familiare. È, sia una dichiarazione di indipendenza, di alterità, di intenzione estranea che un rifiuto dell’anonimato, della condizione subordinata. È un’insubordinazione. Allo stesso tempo è anche una conferma della condizione di sottomissione, una dichiarazione di impotenza”. Nei suoi studi, Hebdige sottolinea la tendenza innata delle sottoculture ad assorbire i feticci della società dei consumi, plasmandoli e riadattandoli in una sorta di bricolage semiologico. Ma – per dirla con Roland Barthes – emerge anche la loro ineluttabile propensione a lasciarsi assorbire e mitizzare, a farsi comprare per essere rivendute. Significative le celebrazioni per i 40 anni del punk, che in questi giorni attraversano le accademie e le istituzioni museali deputate al consenso. Dunque nella saldatura tra insubordinazione e xenofobia è custodita la risposta alla domanda: Come prolifera il razzismo negli stadi? In un contesto come il recinto del calcio sociale, imperniato sull’istinto, sui messaggi a bassa frequenza o comunque su un’autoimposta limitazione della capacità critica, quando non trova una corrente culturale avversa che si affermi in modo conflittuale, pratichi l’uso della forza e imponga un autocontrollo nel campo della simbologia politica, la discriminazione razziale e quella di genere attecchiscono con maggiore facilità. Il luogo comune che attribuisce solo alla cultura di destra l’attitudine alla violenza e al comunitarismo, assimila l’identità ultrà al neofascismo, trascurando quanto tali componenti siano presenti anche nei movimenti sociali della sinistra antagonista. Che alla violenza non attribuiscono un primato, ma si riservano di esercitarla. Narciso ultrà Nel mito di Narciso il protagonista si innamora della propria immagine specchiata nell’acqua, al punto da caderci dentro e morire annegato. È un formidabile esempio di oggettivazione del soggetto vivente. Lo specchio liquido fotografa, immortala, restituisce il ritratto. Si tramuta esso stesso in Narciso, lo rimpiazza fino al punto che lui ci si tuffa dentro e rinuncia al proprio essere. Avviene un fenomeno analogo nei gruppi ultrà. Lo specchio infatti è costituito dai media e dall’immagine che costruiscono di ogni singola tifoseria. Gli ultrà reagiscono facendo propria la fotografia fornita dai mezzi d’informazione, rivendicando i tratti e gli aggettivi che nei loro confronti sono adoperati, spesso in senso dispregiativo. I social network amplificano questa tendenza, in quanto vettori di un’altra determinante componente del narcisismo: l’autocontemplazione. Le curve abitate dagli ultrà assorbono e capovolgono. Sono piene di stendardi che clonano le formule retoriche della vulgata mediatica: “Sparuta minoranza”, “Opposta fazione”, “Cani sciolti”. Ciò avviene non solo nella simbologia, ma anche nelle pratiche e negli slogan. Accadde a Firenze, nel periodo dei mondiali di Italia ’90. Un gruppo di commercianti del centro storico assoldò delle ronde per liberarele strade dagli ambulanti nordafricani. Ci furono delle spedizioni punitive notturne, alcuni migranti finirono in ospedale. Sui media trovò ampio risalto il caso di una città come Firenze, dalle tradizioni democratiche, turbata da tali gravi episodi. Dalla curva Fiesole, da sempre di impostazione sinistroide, si alzarono cori come “Chi non salta è marocchino”. È chiaro che il processo di assimilazione e insubordinazione aveva spinto una parte della tifoseria viola a specchiarsi nella stigmatizzazione che i media producevano nei confronti della loro città, fino a identificarsi con quelle accuse. Quale fascismo Decisivo diventa allora comprendere quale sia l’intensità della retorica fascista che può trovare spazio tra gli ultrà. Anzitutto va ribadito che ad imporsi nell’iconografia e nella prassi, in alcuni contesti curvaioli, non è il cosiddetto fascismo in livrea. Nel suo “Nazi-rock. Pop music e destra radicale”, Valerio Marchi spiega che già tra gli anni sessanta e settanta si afferma una nuova figura di giovane fascista: “Si caratterizza per una matrice sociale più variegata rispetto al ‘modello sanbabilino’ e per una dimensione culturale che tende ad appaiare alle coordinate storiche dei nazional-rivoluzionari tutta una serie di temi, di stili e di atteggiamenti, di ‘nuovi consumi’ mutuati dalla Sinistra. Alla consueta predisposizione all’atto violento, alla lugubre esaltazione della guerra e della morte, ai residui di nostalgismo inizia ad affiancarsi un senso di autocritica sulle commistioni del proprio ambiente con settori deviati dello Stato e, con essa, una messa in discussione di alcuni valori tradizionali e del proprio quotidiano modo d’essere”. È proprio questo tipo di neofascismo ad attecchire nelle curve. Ed è lo stadio Olimpico di Roma a fungere da laboratorio. Tutta una serie di messaggi confezionati con notevole acume politico e spiccata conoscenza della comunicazione di massa, hanno favorito lo slittamento delle forme ancestrali della xenofobia presente nel football verso qualcosa di più concreto. Sarebbero tanti gli episodi da esporre. Molti anni fa, nella stagione 1988/89, la fanzine degli ultrà laziali, “Mr. Enrich”, proponeva in copertina l’immagine derisoria di due giornalisti che affannosamente corrono verso la sala stampa di uno stadio di calcio. Ribaltando contro di loro uno slogan molto in voga ai danni degli ultrà, “Calmati! È solo un gioco”, li disegnava in abiti tipici e presunti tratti somatici ebraici, a saldare l’odio contro la categoria giornalistica al rancore antisemita. “I giornalisti sono insolenti e cinici come gli ebrei”, sembrava voler dire la vignetta del magazine biancoazzurro. Gli effetti semantici sulla mente di un giovane ultrà laziale, lettore abituale della fanzine e sprovvisto di strumenti culturali per decodificare il messaggio, sono immaginabili. Ai propri calciatori che sfilavano sotto la Nord con una frase inneggiante all’antirazzismo, già un paio di decenni or sono i laziali rispondevano con uno striscione eloquente: “I vostri miliardi per le nostre borgate”. Chiara l’associazione del degrado dei quartieri popolari alla denuncia urlata dell’invadenza degli stranieri. Da terreno esclusivo di un proletariato solidale e geneticamente comunista, le periferie si trasformano così in sede privilegiata di una destra sociale radicale e radicata. E lo striscione esposto, sempre in quel periodo storico, nel derby contro la Roma: “Ieri rossi, oggi bianchi, ma di nero solo Aldair” stuzzicava la Sud nell’orgoglio neofascista, poco tempo dopo la sua conversione in territorio nero, conseguente alla cacciata del CUCS. Per capire in che misura tale propaganda abbia contribuito a innervare una mentalità xenofoba persino nei luoghi meno inclini a recepirla, è prezioso un libro di Giuliano Santoro, “Al palo della morte”, che con la questione degli ultrà non ha legami diretti. Il racconto ricostruisce il contesto in cui maturò l’omicidio del pakistano Shahzad, avvenuto nel 2014 a Roma nel quartiere Tor Pignattara. “Ci diceva che non era come noi, che non era una spia come noi, che noi siamo dei comunisti di merda e delle zecche e che saremmo dovuti tornare ai Parioli”, riferiscono i testimoni del delitto a proposito delle urla minacciose lanciate contro di loro da una delle persone coinvolte nell’assassinio a sfondo razziale. Nella mentalità borgatara, i Parioli non sono più dunque la zona franca dei romani ricchissimi, ma un nido di comunisti. Quando ad ammazzare è un “ultrà” La morte di Emmanuel Chidi Namdi, il nigeriano ucciso nella scorsa estate a Fermo dal 39enne Amedeo Mancini, segna il culmine nella distorsione funzionale attuata dai media mainstream in questo Paese. Sin dal primo istante, Mancini è anzitutto un “ultrà della Fermana, dunque un fascista”. La seconda identità è conseguenza della prima e comunque diventa un particolare marginale. La maggior parte delle testate giornalistiche ha deciso che l’assassino, in quanto ultrà, è intrinsecamente razzista. Che Mancini fosse un ultrà della Fermana, è indiscutibile. Il problema sorge quando il legame tra la sua militanza in curva diventa inscindibile dalle sue convinzioni razziste. In taluni casi, il tono è addirittura indulgente. Scrive Il Resto del Carlino: “Intorno ad Amedeo Mancini, l’ultrà della Fermana Calcio che nella tragica e controversa lite di Fermo ha sferrato un cazzotto al profugo nigeriano Emmanuel (poi morto per la ferita alla testa susseguente alla caduta), ci sono la direttrice del carcere di massima sicurezza di Ascoli…”. Dunque la lite è “controversa”, e comunque è stato sferrato solo un “cazzotto”. Povero ragazzo – viene quasi da pensare leggendo le cronache di quei giorni –, in fondo la sua xenofobia è soltanto un istinto difensivo maturato in tanti anni di stadio. Ma può guarire. Sì, è vero, ha colpito Emmanuel dopo aver dato della “scimmia” alla compagna della vittima, però si sa che questi ragazzi usano la forza più per gioco che per cattiveria. Se ha sbagliato, è perché fa l’ultrà. E tutti gli ultrà sono un po’ razzisti, sebbene spesso manifestino questa “attitudine” in senso goliardico. “Fascista” e “violento” diventano due connotati accessori e inevitabili dell’identità curvaiola. E per i media “Ragazzi carichi di passione” son pure quelli che seguono la nazionale di calcio. Peccato che ogni tanto si lascino andare a saluti romani e slogan antisemiti. Del resto sono “estremisti”. Sì, va bene, sono “di destra”. Ma secondo il rapporto periodico di polizia sui gruppi ultrà, nella black list bisogna inserire anche tanti gruppi “di estrema sinistra”, come quelli che sulle gradinate hanno aderito alla campagna “Welcome Refugees”, esponendo striscioni di benvenuto ai migranti. Così il vecchio teorema degli “opposti estremismi”, sempre utile per giustificare la legislazione d’emergenza, torna in voga e appiattisce linguaggi e appartenenze. Sesto tempo La violenza xenofoba è dunque quella più riproducibile e al contempo la meno rischiosa da praticare. Basta individuare un nemico debole e aggredirlo per ottenere legittimazione e rispetto nel gruppo dei pari. Pratiche e linguaggi razzisti negli stadi hanno attecchito sul sostrato preesistente. Tuttavia, c’è una via d’uscita? La risposta forse può arrivare dal restante panorama ultrà europeo che essendo anagraficamente posteriore quindi periferico rispetto a quello italiano, può conservare dei tratti distintivi utili alla comprensione di certe dinamiche. È noto che nella maggior parte dei casi, i gruppi dell’est europeo aderiscono ai movimenti nazionalisti in ascesa nei rispettivi Paesi. L’argomento meriterebbe una trattazione specifica e adeguata. Eppure in altri contesti, come la Germania e l’Inghilterra, esistono tifoserie schierate apertamente in senso antirazzista. In Italia la risposta al quesito “Che fare?” è custodita in un possibile diverso modo di inquadrare il municipalismo conflittuale. Fino a quando l’appartenenza a un territorio sarà considerata campo esclusivo delle destre, tutto l’armamentario simbolico futbolistico slitterà verso l’identitarismo delle “patrie locali”. Ma recuperando la lezione di tanti movimenti che nella difesa dei propri luoghi e dei beni comuni, esercitano la forza fisica e la ragione contro le multinazionali e i poteri costituiti posti a tutela dei loro interessi, è possibile inoculare degli anticorpi culturali in ciò che resta delle curve degli stadi di calcio. Il solidarismo e la contaminazione con le altre etnie possono e devono diventare motivo d’orgoglio anche nei linguaggi degli ultrà. Un vecchio slogan antixenofobia dei Cosenza Supporters recitava: “Per il pallone è indifferente CHI lo calcia”. Claudio Dionesalvi “Nuova Rivista Letteraria”, Alegre, novembre 2016 da Inviato da nessuno
2 notes
·
View notes
Text
Ladri di occhi: una triplice alleanza che ruba la vista a settecento milioni di occhi nel mondo – uno screening tra i parlamentari costituito gruppo interparlamentare

(di Nicola Simonetti) Killer sono tre malattie irreversibili (glaucoma, retinopatia diabetica, maculopatie) che una prevenzione basata su visite annuali specialistiche, non invasive, avrebbe potuto evitare. Così non è neanche in Italia dove, su iniziativa dell’Agenzia Internaz. Prevenzione Cecità- Italia onlus, è stato effettuato screening oculistico tra i parlamentari riscontrando “tra quelli che si sono sottoposti agli esami – ha commentato il Dott. Marco Verolino, responsabile oculistica Ospedali Riuniti Area Vesuviana – ASL Napoli 3 Sud, che dell’indagine è stato il coordinatore – che il 65 per cento non esegue una visita oculistica completa di fondo oculare con regolarità una volta l’anno e che il 35 per cento ha eseguito un esame del fondo oculare solo a seguito di disturbi visivi. Se si considera ha proseguito – che, in questo caso, si tratta di un segmento di persone che, per diverse ragioni, dovrebbe essere particolarmente avvertite, possiamo comprendere quanto ancora resti da fare in materia di prevenzione”(ItalianHealth Policy Brief (IHPB).CEIS-Università di Roma Tor Vergata). Una premessa – questa – alla costituzione dell’Intergruppo parlamentare. “Occorre agire con determinazione intervenendo anche – ha detto l’on. Paolo Russo, presidente dell’Intergruppo parlamentare ed egli stesso oculista – sul piano legislativo e la risposta può venire solo dal fatto di promuovere l’adozione di scelte di politica sanitaria che rendano possibili nuovi modelli gestionali - sistematici e strutturali - che consentano di affrontare questo specifico ambito sanitario secondo le indicazioni e i suggerimenti della comunità scientifica internazionale. Considerando che nel nostro Paese abbiamo potenzialità e competenze scientifico-tecnologiche non comuni, che vanno comunque messe a sistema in modo sinergico – ha proseguito – non intervenire sarebbe una grave colpa”. Gli ambiti nei quali l’Intergruppo opererà sono essenzialmente quattro: promozione di politiche sanitarie che pongano la tutela della vista e la prevenzione delle patologie oculari al centro dell’agenda sanitaria del Paese; varo di iniziative di carattere legislativo e politico in grado di sollecitare Governo e Regioni verso l’adozione di provvedimenti che possano garantire a tutti i cittadini e su tutto il territorio una miglior prevenzione e una miglior cura delle patologie oculari, nonché l’accesso ai servizi di riabilitazione visiva; creazione di favorevoli condizioni per una più ampia adozione delle attività di screening atte a conseguire un miglioramento dei livelli di assistenza e una riduzione dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale; dare impulso ad iniziative di standardizzazione e centralizzazione dei dati clinici che consentano di ottimizzare conoscenze e sinergie tra le diverse strutture sanitarie del Paese. Organismo di consulenza tecnica dell’Intergruppo Parlamentare sarà la stessa Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia onlus,che è già fortemente impegnata in numerose iniziative di sensibilizzazione e che, al di là di quanto già fatto presso Camera e Senato, si appresta a varare altri progetti su scala nazionale con il supporto della rivista di politica sanitaria ItalianHealth Policy Brief (IHPB). "La prevenzione – ha detto, alla conferenza tenuta a Roma - l’avv. Giuseppe Castronovo, presidente di IAPB Italia onlus – è un dovere di ogni persona: tra l’altro consente di evitare molte malattie oculari e notevoli sofferenze, oltre che un aggravio importante di spesa pubblica. Per questo i cittadini devono recarsi periodicamente dall'oculista e portarci i propri figli. Come diceva Leonardo da Vinci la vista è il signore dei sensi. Per questo non dobbiamo mai trascurarla: solo così potremo avere sempre luce nella vita". L’affermarsi di nuovi e più efficaci paradigmi gestionali per le patologie ottico-retiniche potrebbe produrre salutari contributi alla sostenibilità della spesa sanitaria. A titolo di esempio, basterà ricordare che, secondo uno studio prospettico elaborato nel 2017 dal CEIS (Centre for Economic and International Studies-Università di Roma Tor Vergata), la retinopatia diabetica, in assenza di un miglioramento del quadro assistenziale, genererà un aumento della spesa sanitaria di 4,2 miliardi di euro nel periodo 2015-2030. “La ricerca è impegnata su vari fronti e qualche risultato lo ha già dato – ha sottolineato il Prof. Filippo Cruciani, referente scientifico di IAPB Italia onlus – ma ciò su cui bisogna soprattutto puntare è la prevenzione sia primaria che secondaria. Primaria – ha proseguito – vuol dire sostanzialmente stile di vita mentre la secondaria consiste nella diagnosi precoce, quando la malattia è ancora allo stato asintomatico; purtroppo l’attitudine alla prevenzione è ancora molto bassa nel nostro Paese”. Le tre malattie sotto osservazione: Il GLAUCOMA, prima causa di cecità irreversibile al mondo: colpisce 55 milioni di persone, mentre 25 milioni hanno già perso le proprie capacità visive per causa sua (un milione sono in terapia ed altrettanti, in Italia, sono a rischio ma lo ignorano). “Si tratta di epidemia 3.0, una malattia della seconda e terza età' che, nel 2020 – è previsto - interesserà 80 milioni di persone nel mondo. Il glaucoma aggredisce il nervo ottico e può portare a cecità ed è – dice l'Associazione italiana per lo studio del glaucoma - nuova minaccia, silenziosa nei riguardi della popolazione mondiale. La cura del glaucoma è molto costosa e incide già notevolmente sulla spesa sanitaria nazionale che, in prospettiva, verrà ulteriormente gravata dai costi socio-assistenziali di sostegno a una fetta così ampia di popolazione che non sarà più auto-sufficiente perché priva della vista”. Una malattia subdola che, nella forma cronica non dà neanche sintomi mentre una pressione oculare troppo elevata sta danneggiando “silenziosamente” la visione. Primo avviso sono piccole “macchie” scure (scotomi) alla periferia del campo visivo (quello che si può vedere senza muovere il capo) che si restringe via via fino raggiungere una visione a cannocchiale (“tubulare”) e, in casi peggiori, l’oscurità completa. Se non curata in tempo, la forma porta senza scampo a perdita della funzione visiva. Obiettivo da raggiungere, quindi: individuare subito i casi di glaucoma ignorati: sono mezzo milione in Italia; quando i colpiti se ne accorgeranno almeno il 40% della propria capacità visiva sarà già perduta. La prevalenza della malattia aumenta con l'età e, molte volte, si presenta prima dei 40 anni. A questa età e, comunque, quando compaiano i primi segni di presbiopia (visione sfocata da vicino) o ci sia familiarità, è necessario sottoporsi a controllo oculistico che comprenda la misurazione della pressione oculare. Ma solo il 21% degli italiani ha eseguito un controllo della vista negli ultimi 5 anni. La RETINOPATIA DIABETICA: Sei italiani su cento soffrono di diabete ma in tre su 10 di loro la malattia ha, in qualche modo, interessato anche la retina (un’ “estensione” del cervello il cui tessuto nervoso capta e trasmette, al centro, gli stimoli visivi) e, in carenza di terapia ed adeguamento di regole si vita, in prospettiva, la danneggerà irreparabilmente quale risultato di danni accumulati nel tempo a carico dei piccoli vasi sanguigni della retina. Interessa 42 milioni e 1/2 di persone nel mondo ed è prima causa di cecità in età lavorativa e, se il diabete tipo 1 è diagnosticato dopo i 30 anni, essa è del 20%; dopo 5 anni di malattia del 40-50%, dopo 10 anni e di oltre 90% dopo 20 anni. I danni alla retina sono evitabili controllando il diabete. Verificare anche la pressione arteriosa nel diabetico tipo 2 riduce il rischio di malattia micro-vascolare del 37%, il tasso di progressione della retinopatia diabetica del 34% e il rischio di peggioramento dell’acuità visiva del 47%. Questa patologia, se non migliorerà il quadro assistenziale, farà aumentare la spesa sanitaria di 4,2 miliardi di euro nel 2015-2030 (univ. Tor Vergata Roma). MACULOPATIE: Interessano 200 milioni di persone nel mondo; un milione in Italia. Tra le acquisite, più diffusa la degenerazione maculare (AMD) legata all’età; negli over 55 è principale causa di cecità legale nel mondo occidentale. Due le forme di AMD: la secca (atrofica) ad evoluzione lenta e meno aggressiva per la quale non c’è terapia specifica, e la umida (essudativa), a volta evoluzione della prima. Pertanto, vanno seguite insorgenza ed evoluzione della patologia retinica. La umida, meno comune, ma più aggressiva, ad evoluzione più rapida, presenta nuovi vasi sanguigni retinici nella macula (centro della retina). Ogni maculopatia va diagnosticata presto (necessarie visite periodiche) onde ricorrere ad iniezioni intravitreali di anti-VEGF (contro, cioè, i fattori di crescita coinvolti nell’angiogenesi, formazione di nuovi vasi sanguigni che invadono la retina). Read the full article
0 notes
Text
«In Veneto le mafie ormai si sono infiltrate ovunque e l’hanno fatto a piccoli passi, entrando nelle case come amici disposti ad aiutare economicamente gli imprenditori o le amministrazioni locali».
Non ha dubbi Maurizio Dianese, giornalista e autore di articoli, inchieste e libri sulla Mala del Brenta e la malavita nel Nordest, che con i colleghi Gianni Belloni, Antonio Massariolo e Roberta Polese ha dato vita al Centro di documentazione e d’inchiesta sulle criminalità organizzate del Veneto (Cidv) inaugurato lo scorso 17 febbraio a Dolo. «Il caso del comune di Zimella – spiega – dimostra in modo evidente che sono dappertutto. Un piccolo paesino nel Veronese di poche migliaia di abitanti dove la Dia di Venezia ha smantellato una 'ndrina che era così forte da essersi staccata dalla “casa madre” calabrese e aver acquisito una propria autonomia d’azione».
Dal racconto di Dianese emerge che le mafie si sono spartite il territorio veneto insediando verso Verona, nella zona del lago di Garda, tre organizzazioni ‘ndranghetiste; più a sud la ‘ndrangheta e la mafia; nella zona orientale la Camorra e in particolare il clan dei Casalesi mentre a Venezia hanno messo radici ‘ndrangheta e mafia palermitana. «Qui da noi – prosegue – hanno avuto gioco facile perché non eravamo culturalmente preparati al fenomeno. Io stesso quando dieci anni fa studiavo la situazione di Eraclea, se non avessi parlato con il magistrato Nicola Gratteri, non avrei capito che per trovare le infiltrazioni mafiose occorre tenere d’occhio le ditte che sponsorizzano squadre di calcio e feste patronali. E, infatti, scoprii che Luciano Donadio, capo locale del clan dei Casalesi, sponsorizzava la squadra di calcio del Ponte Crepaldo di Eraclea e la festa del patrono e stava proponendo, all’allora sindaco Giorgio Talon, di mettere gratis le luminarie di Natale».
Un obiettivo chiaro, quello delle mafie in Veneto: entrare nella vita quotidiana dei cittadini per carpirne la fiducia presentandosi come brave persone. «Donadio – prosegue – sul Ponte Crepaldo ha investo 50 mila euro, una cifra enorme per una piccola squadra, ma nessuno si è preoccupato di verificare la provenienza di quel denaro. Così un capo clan è entrato di diritto tra le persone che contano della comunità di Eraclea».
Mentre ai tempi della Mala del Brenta tutti sapevano chi era Felice Maniero e gli stavano alla larga, oggi le mafie sono parte della nostra vita tanto che si arriva al punto che all’indomani degli arresti di Eraclea i cittadini avviano una raccolta firme in difesa del sindaco Mirco Mestre, ritenendo impensabile che una persona che è parte integrante della comunità potesse essere un malavitoso. E questo è esattamente quello che avviene da sempre nel sud Italia.
Di fronte a questa situazione la repressione, se pur indispensabile, è solo la cura per l’oggi, il vaccino per il domani è dato dallo studio dei fenomeni malavitosi e dalla formazione dei cittadini che devono imparare a riconoscere per tempo tutti i campanelli d’allarme, «perché – spiega Dianese – anche un piano regolatore può invitare al malaffare. Pensiamo a Jesolo: nel momento in cui prevedi nuova edificazione in una fase di crisi economica, quando gli imprenditori locali non possono investire, stai incoraggiando l’arrivo di capitali sporchi. Gli studi fatti dall’Università di Padova lo dicono chiaramente: in Veneto lavorano 400 imprese di media e grossa dimensione che sono infiltrate dalle mafie».
Eppure nonostante da molto tempo se ne parli, si lancino allarmi e si spieghi il fenomeno, ancora non ci poniamo le giuste domande e ripetiamo sempre gli stessi errori. «Recentemente – prosegue il giornalista – ad Abano Terme una famiglia russa ha comprato tre alberghi ma nessuno è andato a controllare da dove arrivano i soldi perché persiste la cultura veneta del “basta che ci siano i soldi”. Invece oggi i grossi investimenti delle mafie sono fatti proprio nel settore turistico. E poiché il Veneto è una delle principali mete turistiche italiane, è indispensabile vigilare».
[...]
Il Veneto della lega e della legalità.
22 notes
·
View notes
Text
Dal Trentino a spasso nella provincia di Caserta
Da mercoledì 20 febbraio a venerdì 22 febbraio gli studenti dell’Istituto d’Istruzione “Marie Curie” Pergine Valsugana (Trento) si sono affidati a Nero e non solo! Onlus circolo dell’Arci per fare un viaggio breve ma intenso in Terra di Lavoro. Mercoledì mattina siamo stati alla Casa delle associazioni presso la cioccolatteria Dulcis in Fundo gestita dalla cooperativa Davar in un bene confiscato alla Camorra a Casal di Principe. Lì Tina Borzacchiello la responsabile ci ha raccontato come la cooperativa è impegnata a realizzare l’inserimento lavorativo di persone disagiate e come questo abbia determinato un’importante occasione educativa, riabilitativa, di socializzazione ma anche luogo di abilità relazionali, tecniche e professionali. Qui ci ha raggiunto Gianni Allucci di Agrorinasce la società che gestisce per alcuni comuni della zona i beni confiscati. Intorno a mezzogiorno Tina ci ha accompagnato nella chiesa di San Nicola di Bari dove è stato assassinato don Peppe Diana il 19 marzo del 1994. Lì abbiamo incontrato Augusto di Meo, testimone di giustizia nel processo contro gli assassini di Don Peppe Diana. De Meo ha visto l’assassino di don Peppe, suo fraterno amico, e non ha avuto un attimo di esitazione a denunciare l’accaduto e a riconoscerlo. In chiesa era presente anche il parroco che arrivò dopo la morte di don Peppe per aiutare la comunità a riprendersi e che è tuttora reggente. Questi era di Giugliano e per non spaventare la famiglia disse che sarebbe rimasto pochi mesi. Invece oggi sono quasi 25 anni. Anni in cui i cambiamenti si vedono, anche se resta molto da fare. A pranzo siamo andati in un ristorante Nuova Cucina Organizzata, un'altra esperienza di riuso sociale dei beni confiscati. Qui i ragazzi hanno potuto gustare i prodotti del territorio e l’immancabile pizza. Nel pomeriggio siamo andati in un’associazione “La forza del silenzio” che gestisce beni confiscati per la cura e l’inserimento dei ragazzi e degli adulti Autistici. Questa associazione ha due laboratori, uno di stampa di oggetti e t-shirt e un altro alimentare specifico per i celiaci. Il responsabile, un poliziotto, ci ha spiegato la sua storia personale ( ha 2 figli autistici) e quella dell’associazione. Esperienza nata 10 anni fa, insieme ad altri genitori, per dare una risposta concreta a questi bambini che nulla avevano dal territorio e dalla società. Hanno avuto in gestione due beni confiscati, entrambi di “Sandokan” Schiavone e ci ha raccontato le difficoltà di operare su un territorio di forte impatto criminale, ma soprattutto nelle abitazioni della camorra.

Giovedì alle 7,00 siamo partiti alla volta di Castel Volturno per andare a far visita al Caseificio della coooperativa “Le Terre di Don Peppe Diana”. I soci con grande determinazione hanno perseguito l’impegno a dar vita ad un caseificio con produzione di prodotti caseari, rifornendosi da allevamenti del territorio controllati nell’ottica della giustizia e legalità. Abbiamo assistito alle varie fasi della produzione della mozzarella, assaggiando il prodotto appena lavorato. La cooperativa gestisce anche terreni confiscati ed è in procinto di realizzare un’attività agricola proprio su questi. Dopo ci siamo diretti a Santa Maria la Fossa dove abbiamo visitato i terreni confiscati assegnati all’associazione Nero e non solo! e parlato di questo progetto, già in essere da un paio di anni, ovvero l’allevamento di Elicicultura. Inoltre questo si è coniugato con l’impiego di un bracciante agricolo titolare di protezione sussidiaria che dopo aver fatto un percorso nello SPRAR si S.Maria C.V. e seguito un apprendistato presso le Maestranze Edili è stato assunto dall’associazione per svolgere il lavoro con le lumache. Siamo andati quindi a pranzo presso una casa dove si realizza il progetto SPRAR gestito dalla cooperativa Solidarci. Dopo pranzo abbiamo incontrato il sindaco di Santa Maria la Fossa il dott. Antonio Papa che ci ha parlato dell’importanza dei beni confiscati per lo sviluppo del territorio. Il sindaco ci ha portato presso il centro documentale intitolato a Pio La Torre. Qui c’è l’impianto di gassificazione per trattare i reflui delle bufale, gli animali che producono il latte da cui si produce la famosa mozzarella.

Venerdì mattina ci siamo incontrati presso l’Anfiteatro Flavio di santa maria Capua Vetere e dopo una visita nella storia, ci siamo diretti al Museo Campano. Alle 12,00 presso la libreria Spartaco si è svolto un incontro con Angelo Ferrillo, presidente dell’Arci Caserta, sui temi dell’accoglienza e della protezione internazionale. Subito dopo si è tornati all’Anfiteatro e si è pranzato da Amico Bio dove a fare le pizze per gli studenti c’è un beneficiario del progetto Sprar che, dopo aver fatto un corso di formazione e poi un tirocinio, è stato infine assunto come pizzaiolo. Alle 16,00 ci siamo spostati nella Sede di Nero e non solo! O.n.l.u.s. a Caserta dove abbiamo incontrato il professore dell’Università degli Studi del Molise Gianni Cerchia che ci ha illustrato l’origine storica delle organizzazioni criminali e della camorra in particolare, parlandoci dell’intreccio tra economia, politica e camorra.

Gli studenti hanno visitato martedì Napoli, nelle sere a seguire hanno visto Caserta, Caserta Vecchia e San Leucio. Il sabato hanno visitato la Reggia di Caserta.
0 notes
Text
Mostra fotografica ”… tutti giovani sui vent’anni…” - 1915 – 1918.
A cent’anni dalla Prima Guerra Mondiale, esistono documenti, pubblici e privati, che ne conservano la memoria. Sono quelli che ci consentono di rivivere un periodo altrimenti sconosciuto a noi contemporanei. In occasione del ciclo delle celebrazioni nazionali, il MuDiF - Museo didattico della fotografia -, nell’ambito delle proprie attività istituzionali per la valorizzazione del patrimonio fotografico storico regionale, presenta, dal 27 gennaio al 25 febbraio 2017, a Sarno (Sa), presso la prestigiosa Villa Lanzara-del Balzo, la Mostra fotografica e documentale dal titolo “…tutti giovani sui vent’anni…”. L’iniziativa si svolge in collaborazione con i Comuni di Sarno e di Montesano sulla Marcellana, con il Patrocinio dell’Esercito Italiano, della Regione Campania, della Provincia di Salerno e dell’Università degli Studi di Salerno. Seguendo le indicazioni del Comitato Interministeriale per le celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, sono state raccolte le fonti documentarie locali inerenti la partecipazione alla Grande Guerra di concittadini - fotografie, scritti, lettere, cartoline, libri, oggetti, filmati e testimonianze –, attivando specifici processi partecipativi e di conoscenza, soprattutto tra gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le Associazioni, gli Enti territoriali e i singoli cittadini, per raccontarne attraverso la storia e le storie dei nostri soldati e delle loro famiglie l’impatto umano, affettivo, sociale ed economico. Una raccolta di documenti che, di fatto, è il recupero della storia familiare e personale, costola della Grande Storia di cui è parte e che vuole valorizzare l’enorme contributo in vite umane dei giovani militari provenienti dal Sud. Il Progetto, che ha ottenuto il Patrocinio della struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affiderà alla Mostra il ruolo – condiviso con gli Enti Istituzionali e le scuole del territorio – di presentare i materiali documentari e fotografici raccolti riguardanti il periodo che va dal 1915 al 1918. Il percorso espositivo sarà diviso in più sezioni tematiche. Ci saranno immagini dei fanti che, prima della partenza per il fronte, spedivano ai propri cari; foto di soldati impegnati in attività giornaliere, scattate a ridosso della prima linea, riproduzioni di cartelle cliniche di militi ricoverati per disturbo post traumatico da combattimento. Di grande interesse sarà, inoltre, una sezione dedicata alla stampa locale del tempo e una dedicata al capitano di cavalleria del Regio Esercito Raffaele Libroia, Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla cui memoria è dedicata la storica caserma nocerina, sede del Battaglione Trasmissioni “Vulture” dell’Esercito Italiano. Un segmento racconterà anche “all’altra trincea”: immagini di militari austriaci, uomini dalla divisa diversa che hanno vissuto la stessa tragedia dei nostri soldati. Il Progetto prevede, dopo la giornata inaugurale, i seguenti incontri di approfondimento: “La Grande Guerra raccontata a cura di Giuseppe Palmisciano, docente della Pontificia Università Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Tommaso d’Aquino “Gli scemi di guerra”, a cura di Giuseppina Salomone, presidente del Centro Ricerche sulla Psichiatria e le Scienze Sociali, ASL Sa1 – “L’utilizzo della fotografia durante la Grande Guerra” a cura di Rosario Petrosino, direttore del Museo Didattico della Fotografia. Si tratterà di un’operazione culturale di grande interesse e valenza per le comunità territoriali, che focalizzerà anche la funzione di amalgama fra le popolazioni svolta dalla condivisione della vita in trincea. Mai come allora, militari provenienti dalle varie aree del Paese hanno avuto l’occasione di sentirsi parte di un unico Paese e accomunati dai medesimi ideali.
Informazioni di servizio: Per le scuole o per gruppi di almeno dieci persone è possibile prenotare una visita guidata alla mostra telefonando al nr. 081 517 9573 dal martedì al giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e al nr. 3385789010.
1 note
·
View note
Text
Il bene e il male davanti al semaforo
Passare con il rosso di notte? È uno dei tanti quesiti che pongono un tema universale. Di questo si occupa la nuova disciplina: l'obiettivo non è guarire l'individuo ma offrirgli una prospettiva diversa - di Federico Capitoni, Robinson la Repubblica.

Ils vont 📷 Treno Regionale Roma-Fabriano, ottobre 2017
L'associazione della filosofia alla parola "pratica" ancora sorprende molti, abituati a pensare che la madre di tutte le discipline riguardi la pura speculazione, l'accademia e — nel peggiore dei casi — un mondo teorico, ideale, che non trova alcuna applicazione nella realtà. Quando si parla di pratiche filosofiche è dunque naturale essere pronti a spiegare cosa si intende, non solo in termini concettuali, ma anche professionali, visto che quello del filosofo pratico, per quanto ancora poco diffuso, è un mestiere a tutti gli effetti.
Le pratiche filosofiche sono molteplici, ma possono dividersi in due grandi tronconi: quelle individuali e quelle collettive. Nel primo caso si parla prevalentemente di consulenza filosofica, un dialogo tra un consultante (colui il quale espone un suo problema) e un consulente (il filosofo) che ha l'obiettivo di fare luce sulla questione, senza intenzioni risolutive. Può considerarsi una pratica alternativa, ma non affine, alla psicoterapia, sebbene non vengano messi in campo strumenti o modelli psicologici e non si miri alla soluzione del problema, ma soltanto a escogitare nuovi punti di vista per guardarlo e affrontarlo. Non c'è alcuno scopo terapeutico e non esiste la figura del paziente (tanto meno del malato). Se c'è invece un riferimento filosofico, esso non è una scuola, ma una modalità: quella socratica delle continue interrogazioni e messa in discussione di ogni proposizione. Cogliere in fallo logico l'interlocutore spesso tradisce un suo errato posizionamento rispetto alla questione.
Lo stesso approccio socratico, argomentativo, è alla base anche delle pratiche collettive, un mondo più ampio, fatto di tante attività — caffè filosofici, Philosophy for Children, Philosophy for Community, dialoghi in stile filosofico — tutte accomunate però dal medesimo processo, controllato — non diretto! — dal filosofo professionista che assume il ruolo di facilitatore. Normalmente disposti in circolo, per eliminare ogni gerarchia e per fare in modo che lo spazio vuoto creato al centro sia il luogo neutro delle argomentazioni, i partecipanti — facilitatore incluso — iniziano un dialogo che normalmente scaturisce dalla lettura di un testo non filosofico. Più raramente il tema è già deciso prima di iniziare il dibattito, si preferisce utilizzare un testo perché è interessante anche il processo grazie al quale si arriva all'argomento. I partecipanti fanno osservazioni non sul testo, bensì a partire da questo, il che consente di vedere come in un brano, che pure possiede una tematica centrale, la comunità possa individuare un argomento laterale o non palesemente emergente. E ciò mostra l'inevitabile collegamento di temi anche apparentemente lontani. Il testo serve dunque a scatenare, accendere, la riflessione, che prende corpo attraverso la libera circolazione delle opinioni.
Quel che c'è di filosofico sono la pratica dialettica, l'argomentazione e un processo di astrazione che esercita la mente: si parte sempre da casi particolari per arrivare all'universalizzazione del concetto, per quanto il tempo (raramente si superano le due ore) lo consenta. Nessuno, quando si comincia, lo sa, ma è esattamente quello che succede: è naturale che dall'esperienza di vita del singolo, se sia il caso o meno di passare col semaforo rosso anche alle tre di notte quando non c'è nessuno (e magari neanche le telecamere che controllano, cosa che fa spesso la differenza), si giunga a una riflessione più generale prima sulle regole e poi sul rapporto bene/ male. Se il dialogo naviga da solo, il facilitatore quasi non interviene; è chiamato invece a rilanciare il dialogo e a spostare l'asse su cui il pensiero si è disposto se la discussione si arena.
La pratica non è soltanto nel processo dialogico, ma anche nel coinvolgimento esistenziale. Il tema deve essere sentito, la filosofia diventa pratica se ci riguarda. Se nella consulenza ancora resiste un dualismo (il consultante va dal filosofo e non sa di fare filosofia), nelle pratiche collettive, il partecipante diventa subito filosofo egli stesso, anche perché può affrontare una questione che lo concerne senza però che per lui costituisca un problema da risolvere e che lo fa soffrire. Così si può parlare di giustizia, di identità, di regole, di creatività: parole dalle quali sviscerare i contenuti e le manifestazioni nella vita di tutti i giorni. Nulla impedisce di alzare il livello, se il facilitatore lo ritiene opportuno. Nel caso di una discussione sul rapporto tra egoismo e altruismo, per esempio, normalmente vi sono due opposte fazioni: chi crede nell'altruismo vero, assoluto, e chi pensa che questo si fondi comunque sull'egoismo (impossibilità del dono puro: il dare procura comunque soddisfazione e contentezza). Si possono introdurre allora gli ultimi risultati delle ricerche neuroscientifiche secondo cui quello che chiamiamo egoismo non è altro che uno strumento biologico umano per la salvaguardia della specie e di cui siamo naturalmente dotati. Altrimenti dovremmo sentirci in colpa ogni volta che troviamo parcheggio, dacché lo abbiamo sottratto a chi arriva un secondo dopo di noi... E se ognuno cedesse il parcheggio all'altro, quel posto rimarrebbe sempre libero.
Questo filosofare concerne appunto la vita e non ha alcuna ambizione di addivenire a una qualche verità. E benché viga un atteggiamento logico, non c'è una guerra tra tesi opposte, se ne accettano anche di mediane; non esiste la formale polarizzazione di A e B e il tertium, una volta tanto, è possibile. Chi ha voluto argomentare sulla necessità del vaccino obbligatorio dicendo che chi non si vaccina è un pericolo per gli altri, si è ovviamente visto rispondere, logicamente, che chi è vaccinato è protetto, mentre chi non lo è la pensa esattamente come "l'untore"; dunque l'argomentazione cade. Ma poi la realtà ci dice che ci sono bambini che si vorrebbe vaccinare ma che appartengono a una piccola percentuale di individui clinicamente non vaccinabili e si conviene che l'eccezione va tutelata. Eccezione che in un sistema rigorosamente logico non dovrebbe esistere. La filosofia esce così dall'università e entra nell'esistenza di ognuno. Ciò che conta sono le “buone ragioni”, purché sempre argomentate, più che la logica infallibile. E soprattutto che si pensi e si parli non per sentito dire, per studi o per dogmi di pensiero, bensì con la propria testa. È anche il motivo per cui gli incontri funzionano meglio se svolti tra non studiosi: quelli finirebbero altrimenti per citare le teorie dei grandi pensatori e il dialogo assumerebbe le fattezze del convegno universitario.
Invece l'attività, allenamento del pensiero, trova grande successo tra i normali cittadini, nelle scuole, nelle aziende e anche nelle carceri (un libro di recente uscita per Mursia, Filosofia dentro, racconta di esperienze nei penitenziari), cioè tra persone che senza saperlo sollevano i grandi temi della storia della filosofia: una volta, parlando di pregiudizio, è stato detto da un bambino di undici anni che "per non avere pregiudizio bisognerebbe disporre di un giudizio ‘puro', senza un'idea che lo precede", che è esattamente la questione fenomenologica di Cartesio prima e di Husserl poi.
I partecipanti colgono altresì con gioia anche l'aspetto comunitario e sociale degli incontri. La maggior parte di loro confessano che le occasioni per confrontarsi civilmente e mantenere una conversazione a un livello che non sia quello superficiale della chiacchiera sono normalmente scarse. E che si torna a casa stimolati, magari — e per fortuna — con meno certezze, ma con un processo di riflessione ormai innescato che non può far altro che alimentare ulteriori ragionamenti e dialoghi: il motore filosofico è partito.
La filosofia diventa cura, ma non intesa come terapia, bensì come cura di sé, palestra per la mente. Per prendersi cura di sé si può andare a pilates, al cinema, in gelateria e - perché no? - a un dialogo filosofico.
#filosofia#robinson#larepubblica#consulenza filosofica#vita#pratica filosofica#cura di sè#psicoterapia#terapia#dialogo#facilitatore#ragionamento#comunità
0 notes