Text
Capitolo 33 - Spazio d'immagine
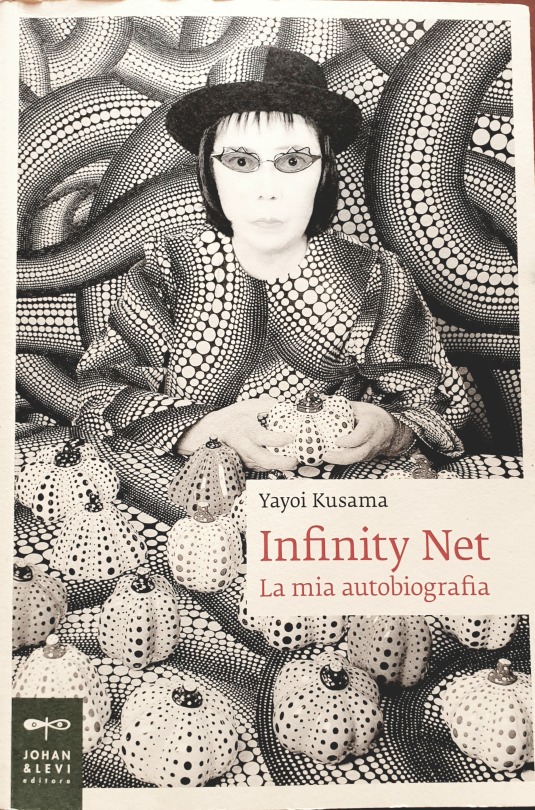
Nel 2001 in occasione della prima edizione di Yohokohama Triennale, oggi alla sua ottava edizione, Yayoi Kusama partecipa con due opere che vogliono essere il suo personale omaggio al nuovo inizio dell’arte contemporanea in Giappone e all’inizio del XXI secolo. Per la prima opera, ospitata al chiuso nella sala del Pacifico Yokohama, Kusama riveste di specchi un’intera stanza, al soffitto appende delle sfere riflettenti e infine ricopre anche il pavimento di sfere specchiate, di modo che
“Chi entrava vedeva la propria immagine riflessa in millecinquecento sfere, e riusciva a percepire l’infinito mutamento di prospettiva generato dai propri movimenti, in un’esperienza di repetitive vision.” (Y. Kusama)
Intitola l’opera Endless Narcissus Show.
Nella seconda opera, questa volta all’aperto, le sfere riflettenti sono duemila, hanno un diametro di 30 centimetri, sono di acciaio inossidabile e bagnate galleggiano in una sezione del canale lungo la passeggiata che collega la stazione ferroviaria Sakuragicho all’area portuale di Shinko. Assecondando il flusso delle onde e i loro movimenti, le duemila sfere riflettono per gli spettatori il profilo delle nuvole, il bagliore intermittente della luce, le geometrie del porto. Il titolo dell’opera è Narcissus Sea e l’artista così ne descrive l’effetto
“Le infinite palle a specchio si avvicinavano e poi si allontanavano, tornavano ogni volta a mutare il loro aspetto in risposta al movimento continuo e senza posa del canale. Emettevano suoni delicati, ora un ticchettio, ora un cicalio. Era una visione stupefacente: creature enigmatiche che si moltiplicavano nell’acqua.”

Da una stanza tutta per sé del primo trentennio del Novecento siamo passati a una stanza tutta piena di sé del nuovo Millennio, dove con un movimento spontaneo e naturale gli individui della società liquida di Z. Bauman del XX secolo, seguendo il flusso della corrente senza sosta, si sono riversati nel narcisismo senza fine di Kusama e degli individui del XXI secolo.
Le esperienze di repetitive vision affollano i nostri schermi e le immagini che più si ripetono sono autoritratti estemporanei e giornalieri di persone comuni e di personaggi famosi. I selfie si diffondono nei primi anni del Duemila, arrivano con l’uso delle fotocamere digitali, che permettono di duplicare un’immagine all’infinito e l’uso delle piattaforme social, con le quali è possibile condividere e diffondere la propria immagine infinitamente.
La prima piattaforma che permetteva di pubblicare il proprio autoritratto fu MySpace, la piattaforma offriva uno spazio di presentazione di sé stessi e un modo di affermarsi fu proprio occupare lo spazio della galleria fotografica, non con le proprie opere ma inserendovi i propri selfie, prendere il proprio spazio significava fare mostra e negozio di sé stessi.
La parola selfie viene dall’Inglese ed ha la stessa radice del termine selfish che definisce chi non tiene in considerazione gli altri e i loro bisogni, chi è o si comporta da egoista. Non voglio né insinuare né affermare che chi si faccia dei selfie sia egoista o per forza narcisista. Amo ricevere i selfie delle persone che mi sono care, amo vedere i loro volti, leggere sulle loro espressioni come stanno e penso che sia una meravigliosa opportunità quella di comunicare usando la propria immagine ma ritengo comunque significativo porre l’attenzione sulla diffusa abitudine di ritrarre sé stessi e su quanto sia diventata necessaria sia a livello individuale sia a livello sociale.
Un tempo chi voleva rintracciarci aveva bisogno di conoscere il nostro indirizzo di posta fisico o il nostro numero di telefono fisso, adesso basta che digiti il nostro nome su una qualsiasi App social per trovarci subito dopo, sorridenti sulla foto del nostro profilo. Mentre prima bisognava recarsi all’indirizzo e suonare il citofono per raggiungerci o telefonarci per parlare con noi, adesso raggiungerci significa accedere ai nostri contenuti social, conoscerci significa guardare le nostre foto e leggere i nostri slogan.
Facebook è stata la prima piattaforma social completamente basata sull’identità degli iscritti, tanto da avere la parola Face nel proprio nome, per essere riconosciuti e connettersi alla propria comunità di seguaci bisognava metterci la faccia. In Facebook, come anche in altri social, Instagram incluso, l’uso dei selfie è indispensabile per il successo di un account e di recente alcune aziende, alla vecchia lettera di presentazione preferiscono l’invio di un video di pochi minuti, in cui i candidati che aspirano a ricoprire la posizione offerta, si presentano rispondendo alla domanda: perché saresti la persona giusta per questo lavoro?
Presentarsi è mostrarsi seguendo i dettami del marketing, applicando correttamente armocromia e make-up fotografico, post editing grafico per rendere fotogenico qualsiasi volto e la grammatica degli slogan vincenti.

Gli individui del secolo scorso con relazioni e identità fluide, senza legami duraturi, senza passato e senza progetti gettati nel futuro, immersi nell’eterno scorrere del presente sono confluiti in una società di individui che si autodefiniscono sul dire non sul fare, sull’apparire non sull’essere, sul presentarsi non sull’essere riconosciuti dalla comunità di riferimento in base alle opere compiute. Una società di individui che occupano posti di potere decisionale fondamentali per la comunità, che occupano spazi pubblici con l’opportunità di influenzare il pensiero di molte persone, che occupano spazi educativi e culturali con la responsabilità di formare le nuove generazioni, che occupano spazi di influenza, occupano questi spazi non per il riconoscimento dovuto alle loro opere, perché in possesso di quelle competenze che li rendono i candidati migliori per quel determinato ufficio o servizio, ma perché capaci di presentarsi e abili nell’uso del linguaggio del successo, perché come le palle a specchio di Kusama sono capaci di mutare, pur restando uguali, in risposta al movimento senza posa del canale.
Individui che fondano la loro narrazione sull’essersi fatti da soli, sull’aver raggiunto il successo partendo dal basso e non scoraggiandosi mai, sempre fissi sulla meta, pronti a tutto per raggiungere i propri obiettivi, perseverando sempre. Siamo pieni di narrazioni di individui che non devono ringraziare nessuno per la loro ricchezza e il loro successo, incapaci di riconoscere l’aiuto ricevuto, individui che si appropriano delle intuizioni o delle scoperte di altri e di altre senza darvi il giusto riconoscimento, individui che si presentano come eroi solitari, con capacità straordinarie e una visione del mondo non comune, ostinati nel loro desiderio di realizzare i propri sogni, disposti a tutto per farlo e soprattutto vincenti, vincenti su tutto e tutti.
Questi individui sono come le sfere di Kusama, pianeti solitari che nella perfezione della loro forma sono impermeabili a qualsiasi cosa provenga dall’esterno, assumono i contorni del mondo esterno senza subire cambiamenti, s’identificano con i movimenti della corrente senza esserne trascinati, riflettono l’immagine dell’altro da sé senza esserne tuttavia trasformati, così pericolosamente dissociati da abusare segretamente di quelle stesse donne che pubblicamente, e nella vita virtuale, esaltano difendendone i diritti.
Sfere di acciaio inossidabile sorde alle sollecitazioni del mondo esterno come a quelle del loro mondo interiore, unità compatte con una separazione netta tra dentro e fuori, continuamente fluttuanti tra verità e menzogna, tra bene e male, acrobati equilibristi dell’ Endless Narcissus Show.
A Est di Roma, 28 agosto 2023 h 2:04 p. m.
#LOVEINTblog#stalking online#violenza#abuso#potere#resistenza#Yayoi Kusama#cyberstalking#identificazione#Narciso#Endless Narcissus Show#mito#sorveglianza#Selfie#verità#Narcissus Sea#ossessione#inviolabilità della persona#empatia#riflesso#individualismo#arte#Facebook#Istagram#libertà#privacy#azione
1 note
·
View note
Text
Capitolo 32 - Il narcisista

Sono passati poco più di due mesi dalla pubblicazione dell’ultimo capitolo di questo blog, nonostante le mie intenzioni fossero di concludere questa denuncia in forma di racconto entro l’estate, sono accaduti degli eventi che mi hanno turbato così tanto, non solo da non poterne scrivere, ma da rendermi incapace di scrivere qualsiasi altra cosa fino ad oggi. Gli eventi sono legati a questo violento stalking che subisco da anni e anche se qualcuno mi ha consigliato di tacere per il momento, di non attirare ulteriormente l’attenzione, penso che sia proprio questo il momento necessario per scrivere e per continuare a raccontare, per non smettere di riflettere e far riflettere, per non implodere in questo inevitabile senso di impotenza.
C’eravamo lasciati con Cotta, il fanatico amico di Ovidio che violenta Eco e nella conclusione del capitolo, alludevo al fatto che la violenza di Cotta su Eco nascesse proprio dalla conoscenza che questo ha del valore della fanciulla. Cotta è l’unico a sapere che Eco non è una selvaggia così stupida che può solo limitarsi a ripetere le frasi che le vengono rivolte dagli altri, incapace di pronunciare un suo personale discorso, ed è anche l’unico che può rimanere affascinato dalla sua cultura essendo stato, non solo un amico di Ovidio, ma un fan dello scrittore, un seguace così invasato da spingersi ad un auto esilio per ritrovare le orme dell’amico e i resti dello scrittore. In un luogo desolato come Tomi, ai limiti della dignità umana, Cotta è l’unico che può comprendere la straordinarietà di Eco ed è proprio per questo che la violenta, vuole possederla ma sa di non esserne all’altezza, sa di non avere le capacità e le doti necessarie per avere da Eco quello che le prenderà comunque con la violenza.
Questa estate le notizie di femminicidi e stupri di donne non sono mai mancate, la violenza di genere è diventata un fatto quotidiano nel nostro Paese e come sempre succede con ciò che si ripete spesso, nessuno fa più caso all’orrore che gli cammina affianco. L’orrore è quotidiano e lascia ormai indifferenti, nella frazione di un fotogramma i nostri telegiornali passano dalla guerra a scene di vacanze, di lidi balneari e di interviste ad italiani in Albania dove il mare è splendido e il divertimento è per tutte le tasche.
Quando ogni giorno consumiamo i pasti davanti a un telegiornale che trasmette notizie di guerra, morte e distruzione senza che ci passi l’appetito, come possiamo poi indignarci per una donna che muore ammazzata, per una ragazza che viene drogata e poi stuprata?
Io invece vorrei soffermarmi a riflettere con voi, pensare insieme a quale tipo di uomo possa essere capace di drogare una donna per fare sesso con lei, quale tipo di uomo sia capace di stuprare una donna mentre è incapace di esercitare la sua volontà, invitarvi a chiedervi quale tipo di uomo sia capace di godere abusando di una donna che si trova in uno stato di simil morte, con un corpo che non reagisce. Come mai è diventato così frequente? Come mai gli abusatori, che restano spesso impuniti, sembrano delle così brave persone?
Questa volta invece di rimandare come di consuetudine la risposta ai successivi capitoli rispondo subito che il solo tipo di uomo capace di fare questo è un narcisista patologico, uno che usa gli altri come oggetti per il suo piacere, che considera gli altri solo degli strumenti del suo godimento e del suo successo, è lo stesso uomo che sarebbe impotente, proprio in senso letterale, davanti a quella stessa donna se lei fosse cosciente e consapevole.
“L’uomo mostra una entusiastica inclinazione per donne da lui profondamente stimate, che però non lo eccitano al rapporto amoroso, ed è potente nei soli riguardi di altre donne che non «ama», per le quali ha poca stima o che addirittura disprezza.” (Sigmund Freud in Psicologia delle masse e analisi dell’Io)

Il narcisista è qualcuno che non ha completato lo sviluppo psichico maturando, ma è rimasto fissato, è bloccato in una fase ben precisa di questo sviluppo senza riuscire ad andare avanti; incapace di attraversare e superare il momento edipico, il narcisista continua a vivere nella rivalsa di quel momento.
Nell’abuso sessuale con l’uso di droghe, la donna vittima diventa arrendevole, sottomessa, incapace di senso critico nei confronti della situazione, le è impedita ogni iniziativa personale, la sua coscienza è annullata, stordita, il senso di realtà compromesso a tal punto da percepire la situazione come se fosse un sogno che al mattino si dimentica.
Gli ultimi eventi di cronaca hanno visto uomini abusare in questo modo di donne, agendo in coppia con altri uomini oppure riprendendo la violenza con il proprio smartphone per poi condividere in rete il video. Ogni persona sana moralmente giudicherà questa azione, la sua brutalità e la trivialità dell’abuso, inspiegabile ma per ogni buon psicoanalista è direttamente collegabile a qualcosa che è andato storto durante la fase edipica.

L’uomo che droga una donna e dopo ne abusa insieme all’amico, è un uomo che è rimasto bloccato alle ferite della maturazione edipica, quando il bambino deve accettare di non poter sposare e possedere la madre, deve accettare che il padre non è un rivale da eliminare e cominciare a dirige la sua energia libidica, il suo investimento amoroso al di fuori dei familiari, rivolgendosi al mondo sociale esterno.
Un ragazzo, un uomo che abusa di una donna dopo averla drogata è qualcuno che non riesce a godere senza ripetere la scena edipica: possedere la madre-oggetto mentre il padre-rivale guarda e accetta la sconfitta. Chi abusa in questo modo di una donna è qualcuno incapace di godere di un rapporto reciproco perché ha bisogno, per raggiungere il piacere, dello sguardo di un altro uomo, della fantasia della sua celebrazione vittoriosa davanti a un rivale che viene finalmente sconfitto. È la messa in scena di un trauma che ha condotto a una deviazione, esitata in un comportamento violento e criminale. Un padre troppo autoritario, aggressivo verbalmente, fisicamente o psicologicamente nei confronti di una madre sottomessa e un figlio ricettacolo dei dolori della madre, rifugio per questa, depositario delle sue confidenze intime e designato a riscattarla da questa immeritata sofferenza.
Un figlio che la saprà amare e la salverà, un eroe! Questo stesso figlio negli anni continua ad assistere alla sottomissione della madre a un padre che non stima, con il quale però s’identifica perché la madre, che è l’oggetto del suo amore, continua ad amarlo. Le scene di violenza si susseguono accompagnate sempre da quelle di sottomissione. Il bambino a questo punto non capisce più cosa sta succedendo e per difendersi da tutta questa angoscia, si ritira in sé stesso, regredisce alla fase di narcisismo originario in cui la sua psiche e il suo corpo erano principio ed esito del piacere, la madre era percepita come un oggetto buono dispensatore di cure e amore, indistinta da sé stesso, che al primo richiamo esaudiva i suoi desideri in una perfetta simbiosi. Il suo Io ritorna allora ad essere il punto di partenza e quello di arrivo di ogni evento, gli altri diventano solo oggetti del suo piacere e le relazioni sono solo strumenti per accrescere l’immagine ideale di sé. Un esilio dalla realtà assoluto in cui non esiste coscienza morale, autocritica o assunzione di responsabilità, esiste solo il piacere dell’Io. Un esilio in cui l’altro è vissuto come oggetto d’amore da possedere o come rivale sul quale vincere privandolo dei suoi tesori.
Un narcisista è l’eroe di una madre, passivamente aggressiva, docilmente sottomessa a un padre violento, che ha trasformato il figlio in un dio nel quale non ha saputo confidare e che non è stata capace di amare. Il narcisista, a differenza di altre persone che come lui sono cresciute in famiglie disfunzionali e violente, che hanno cercato di riconoscere gli eventi accaduti, hanno provato a dare un nome alla violenza subita, hanno fatto il lavoro necessario a rimarginare le ferite, per essere in grado di allontanarsi da quel passato evolvendo psicologicamente, è qualcuno che ha deciso di prendersi tutto quello che vuole, di prenderselo come rivalsa ai suoi dolori, come vincita che conferma il suo potere, o con l’insensibile naturalezza di chi per allontanare un cane che intralcia il suo passo gli dà un calcio sul muso.

È proprio il narcisista il tipo di uomo che può provare piacere nell’abusare una donna drogata, incosciente e inconsapevolmente sottomessa, mentre un altro uomo o una fotocamera lo guardano. Chi considera la donna un oggetto, chi la svaluta, chi si sente minacciato dalla sua intelligenza, chi si relaziona solo con gli altri uomini e solo in termini di competizione e di potere è il tipo di uomo che può abusare di una donna dopo averla resa inerme.
Chiunque con uno sviluppo psichico e morale sano sa che fare l’amore o godere di una sessualità libera è come danzare insieme, che se un uomo per godere ha bisogno di umiliare, picchiare, sottomettere, comandare e veder soffrire una donna, siamo decisamente lontani dall’amore libero e spaventosamente vicini alla malattia mentale.
Uno sviluppo psichico normale non è uno sviluppo in cui non vi siano stati eventi critici, esperienze negative o traumatiche, uno sviluppo psichico normale è quello che procede confrontandosi con questi eventi per progredire, attraversando il dolore che hanno recato, elaborando un significato per non restare imbrigliati nella rete dei traumi. Lo sviluppo psichico procede tutta la vita e in ogni fase di essa tende al mantenimento della salute mentale e morale della persona. Una persona sana psichicamente e moralmente è incapace di considerare un altro uomo, una donna, un bambino o un animale solo e soltanto un oggetto del proprio piacere.
Gela, 16 agosto 2023 h 12:00 a. m.
#LOVEINTblog#stalking online#violenza#abuso#potere#resistenza#Eco#cyberstalking#identificazione#Narciso#Edipo#mito#sorveglianza#SigmundFreud#verità#ComplessodiEdipo#ossessione#inviolabilità della persona#empatia#Ovidio#Metamorfosi#Christoph Ransmayr#Il mondo estremo#droga#libertà#privacy#azione
1 note
·
View note
Text
Capitolo 31 - Il sonno della coscienza genera mostri

“… intorno a lui fu consultato il vate profetico per sapere se avrebbe visto i lunghi giorni di una matura vecchiaia: «Se non si conoscerà» egli disse. La profezia dell’augure a lungo sembrò menzognera, ma la confermarono la fine, gli avvenimenti, nonché il genere di morte e la singolarità della follia.”
Metamorfosi di Ovidio
Il lui della citazione è Narciso e come ci racconta Ovidio, era un giovane di straordinaria bellezza che dopo essersi specchiato nelle acque di un lago, s’innamora follemente della sua immagine riflessa e nel tentativo di afferrarla cade in acqua e muore annegato. La singolarità della follia è quella di amare sé stesso più di qualsiasi altro essere al mondo e come da profezia, la morte avviene nel momento in cui si conosce, si vede per la prima volta.
Il mito di Narciso è tra i più conosciuti della mitologia greca e tra i più utilizzati in psicologia come in letteratura per raccontare individui insensibili e manipolatori o descrivere società basate sull’egotismo e l’apparenza.
In Introduzione al narcisismo (1914), Sigmund Freud definisce narcisismo originario un particolare stadio dello sviluppo psichico durante il quale il bambino, o la bambina, basta a sé stesso, nel senso che il suo corpo è il punto di partenza e di arrivo delle pulsioni e del piacere. È quel momento in cui dipendiamo completamente dall’accudimento materno, il momento in cui ogni nostra necessità viene soddisfatta senza che sia necessario far nulla fuorché piangere, è il momento in cui la simbiosi con chi ci accudisce è assoluta, non siamo capaci di distinguere ciò che è io da ciò che è il corpo dell’adulto che ci accudisce. Abbiamo fame, sete, vogliamo dormire, essere coccolati oppure vogliamo giocare o essere cambiati e senza nessun altro sforzo che sia quello di agitarci scompostamente e piangere, otteniamo ciò che desideriamo, quello di cui abbiamo bisogno. Nel momento di massima dipendenza siamo quasi come degli dei, otteniamo pronta soddisfazione senza la necessità di affidare alle parole la nostra richiesta e solo con il movimento.
Crescere comporta però ripetere continuamente l’esperienza dell’essere incapaci, da soli, di soddisfare le nostre necessità, di essere fisicamente e psicologicamente inadatti a rispondere alle richieste dell’ambiente; crescendo ci scontriamo con i limiti che l’educazione pone al soddisfacimento del nostro piacere e con la frustrazione che deriva dai divieti morali e civili che la nostra società impone. Questo è il momento edipico, un momento fondamentale secondo Freud nello sviluppo psichico normale e in quello patologico dell’essere umano e per spiegarlo prende a prestito un altro mito di origine greca, quello di Edipo.
Questa volta a consultare l’indovino Tiresia sono il re Laio e sua moglie Giocasta, al quale pongono la stessa domanda che i genitori di Narciso posero all’augure: il loro primogenito vivrà sereno e abbastanza a lungo da godersi la vecchiaia? Sì, il bambino vivrà a lungo, abbastanza da invecchiare ma sarà causa di morte per il padre, è la risposta del veggente. I genitori sconvolti dalla profezia, decidono di uccidere il bambino, ma non essendo capaci di farlo affidano il neonato a un cacciatore, chiedendogli di abbandonarlo nel bosco così che muoia di fame e di freddo. Il cacciatore compassionevole non esegue però l’ordine del re, salva il bambino affidandolo alle cure di altri due genitori regali, senza figli, che lo accolgono con immensa gioia.
Una volta cresciuto, Edipo per dimostrare il suo valore di uomo e di futuro re, si mette in marcia, esercito a seguito, con l’intenzione di conquistarsi un proprio regno. Durante il cammino giunge dinnanzi ad una strettoia, all’altro capo della quale c’è Laio con il suo esercito in marcia. Nessuno dei due sa chi sia l’altro, ma entrambi sanno che il diritto di passaggio spetta a Laio in quanto re e in quanto anziano. Come sappiamo Edipo freme dalla voglia di mostrare le sue doti virili e i suoi talenti da guerriero così, invece di cedere il passo a Laio in rispetto alle leggi e agli dei, comanda al suo esercito di attaccare per imporre il suo diritto di passare per primo. Sarà proprio la sua spada ad uccidere il padre. Edipo trionfante e inconsapevole conquista il regno di Laio, sposa la madre e dall’unione dei due nascono ben quattro figli. Dei miti greci e delle leggende la cosa che più mi piace è che la verità anche se giace nascosta per anni e anni, trova sempre il modo di manifestarsi e una volta nota a tutti, la giustizia segue implacabile. Edipo venuto a conoscenza dell’orrida verità, si accecherà con le sue stesse mani e si costringerà a una vita in esilio vagando per strade sconosciute coperto di stracci.
Freud utilizza il mito di Edipo per spiegare un passaggio fondamentale della maturazione psichica durante il quale l’Io smette di trovare godimento in sé stesso e si rivolge all’ambiente, cerca di soddisfare i suoi bisogni nella relazione con i genitori, uno dei quali diventa l’oggetto del suo amore, l’altro diventa oggetto d’identificazione e d’imitazione, una sorta di ideale. Il primo atto costitutivo dell’Io come Essere in relazione con è una scelta d’amore e contemporaneamente è il desiderio di voler essere come quel modello in grado di possedere l’oggetto amato.
Il processo di identificazione è alla base del complesso edipico, il bambino s’identifica con l’oggetto amato che vuole per sé e con il quale non ammette distanza o separazione, ma s’identifica anche con il rivale in amore, l’altro genitore al quale vuole somigliare, che imita e che vorrebbe sostituire. L’identificazione è il primo legame emotivo che istauriamo con un’altra persona perché sia nell’innamoramento che nell’ammirazione tendiamo a emulare il comportamento delle persone amate e ammirate, in Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921) Freud dice che a volte l’Io copia la persona amata a volte quella non amata (quella ammirata) e che l’identificazione è immedesimazione, la stessa che utilizziamo per comprendere l’Io estraneo di altre persone, la stessa che sta alla base dell’empatia. L’Io dunque crea un legame emotivo identificandosi con il soggetto che ammira e dunque con ciò che vorrebbe essere oppure con l’oggetto e dunque con ciò che vorrebbe avere.
Il legame emotivo che si istaura mediante l’identificazione è ambivalente, tende all’avvicinamento e alla tenerezza con l’altro con cui ci si identifica ma allo stesso tempo tende all’allontanamento e a cercare di separarsi da questo. Le forme di relazione basate sull’identificazione sono forme primordiali di relazione, l’altro è vissuto come un oggetto, come qualcosa che si vuole avere interamente, o in parte appropriandosi dei suoi attributi, in questo aspetto predatorio e aggressivo risiede l’ambivalenza del legame.
Narciso vuole afferrarsi ed Edipo non vuole solo diventare re, vuole essere re come Laio, vuole il suo regno, il suo esercito e la sua regina.
“[L’identificazione] Si comporta come una propaggine della prima fase orale dell’organizzazione libidica nella quale l’oggetto bramato e apprezzato veniva incorporato durante il pasto e perciò distrutto in quanto tale. Come è noto il cannibale rimane fermo a tale stadio; egli ama i nemici che mangia e non mangia se non quelli che in qualche modo può amare.”
Tre saggi sulla teoria sessuale (1905)
È sempre Freud a parlare e sembra far eco al poeta che dal carcere di Reading canta:
“Troppo poco si ama, o troppo a lungo;
C’è chi vende l’amore e chi lo compra,
Chi commette il delitto lacrimando
E chi senza un sospiro:
Poiché ogni uomo uccide ciò che ama,
Ma non per questo ogni uomo muore.”

Infatti a morire sono solo le donne che vengono divorate da uomini che amano solo sé stessi. I dati circolati dopo la morte di Giulia Tramontano, la giovane donna incita di sette mesi uccisa dal suo compagno, dicevano che in Italia 3 donne al giorno sono vittime di violenza e l’85% di loro muore uccisa da compagni, mariti, padri e figli, proprio da quegli uomini che le amano di quel tipo d’amore che le considera soltanto oggetti utili al loro nutrimento e al loro piacere. Ecco che tipo di amore è quello di ogni uomo che uccide ciò che ama, lo stesso tipo di amore in nome del quale chi mi stalkerizza giustificava la sua azione abusante nei miei confronti. In questi anni mi sono chiesta come potesse una persona, che mi ossessionava con la sua presenza sempre lì dov’ero io ad ascoltare ogni mio respiro, a guardare ogni mia azione, sempre pronto a sottolineare i miei gesti, gli eventi della mia vita con poesie d’amore, canzoni, articoli, sempre lì a ripetere le mie parole, i miei argomenti, a imitare i miei gesti, i miei modi di dire, che a ogni mio tentativo di liberarmi da questa sorveglianza globale rispondeva che sarebbe rimasto per sempre perché mi amava troppo, come può questo uomo non aver mai nemmeno tentato, di avere una relazione normale con me? Non aver mai cercato d’incontrarmi o di parlarmi per comunicare, non soltanto per ripetermi come un’eco infinita. In linea con Freud ritengo che la risposta stia proprio nella fame smodata e insaziabile dell’oralità, e nella violenza dell’identificazione come esporrò nel prossimo capitolo.
Adesso, dopo aver parlato di uomini, di miti e di parole ripetute, mi piacerebbe concludere con la storia di un personaggio femminile Eco, la ninfa ripetente, così come l’ho trovata nel libro di Christoph Ransmayr, Il mondo estremo.
La storia è ambientata agli estremi confini del mondo conosciuto, nella città di Tomi, sul Mar Nero, dove Ovidio fu esiliato e dove morì. Il protagonista è Cotta, amico del poeta, che aveva assistito al suo ultimo discorso pubblico a Roma prima dell’esilio. Cotta si reca nella città selvaggia perché vuole rintracciare le ultime tracce di Ovidio e delle Metamorfosi, muovendosi in un mondo in cui il mito si trasfigura in realtà. In questo romanzo Eco è una donna straniera, povera e sola, dalla pelle così chiara e delicata che se si espone al sole inizia a squamarsi e a decomporsi, per questo vive in una caverna in cima alla montagna. Eco è capace di discorrere di molte cose, sa molto e ha vissuto a servizio di Ovidio fino alla morte di quest’ultimo, ma a Tomi generalmente quando le rivolgono la parola si limita a ripetere le ultime parole di chi le ha parlato. Essendo una straniera, povera e donna, gli uomini della città ferrigna, si presentano di notte nella sua caverna e portando polli, stoffe, grano o farina pretendono di accoppiarsi con lei, lei per sopportare quei momenti, rimane in silenzio e immagina di trovarsi a passeggiare per sentieri di montagna. Cotta è l’unico a sapere che Eco non ripete soltanto parole, ma parla in modo tale da fargli venire il sospetto che Ovidio stesso possa aver scritto le Metamorfosi ripetendo le storie ascoltate dalla donna. Nonostante questo, o forse proprio per questo, anche Cotta la violenta.
Roma, 12 giugno 2023 h 9.33 a. m. – 15 giugno 2023 h 3.05 p. m.
#loveintblog#LOVEINTblog#stalking online#violenza#abuso#potere#resistenza#Eco#cyberstalking#identificazione#Narciso#Edipo#mito#sorveglianza#SigmundFreud#verità#ComplessodiEdipo#ossessione#inviolabilità della persona#empatia#Ovidio#Metamorfosi#Christoph Ransmayr#Il mondo estremo#Oscar Wilde#libertà#privacy#azione#Ballata del carcere di Reading
3 notes
·
View notes
Text
Capitolo 30 – In Copertina

Erano gli ultimi anni del secolo scorso, era di domenica pomeriggio, mia sorella ed io ritornavamo a casa dopo essere state al cinema e ci fermammo a guardare un mucchio di libri ammassati sulle tavole di una bancarella. Eravamo adolescenti allora e vivevamo a Gela, dove oltre la biblioteca, c’era soltanto una cartoleria che su ordinazione ti permetteva di acquistare i libri richiesti, non avevamo una libreria dove poter girare e prendere un libro tra le mani, iniziare a leggerlo e scegliere tra classici e contemporanei, tra poesia e romanzi, tra i saggi. Imbattersi in una bancarella di libri era per noi quindi, una gioia simile a quella che avevamo da bambine, vedendone una di caramelle e zucchero filato.
Mia sorella comprò La critica della Ragion Pura di Kant ed io trovai Psicopatologia della vita quotidiana di Freud. Qualche anno dopo ci saremmo ritrovate a Roma, lei a studiare Filosofia io Psicologia, con l’abitudine di conciliare cinema e libreria quando volevamo trascorrere una domenica tranquilla insieme.
Fu quel libro di Freud a farmi capire che da grande avrei voluto diventare una psicologa. Sapevo poche cose di me e mi conoscevo poco a diciotto anni, ma ero certa che qualunque cosa avessi fatto, se avessi amato farla non mi sarei mai stancata, né scoraggiata di fronte agli ostacoli che inevitabilmente s’incontrano quando s’inizia a realizzare il proprio progetto lavorativo. Entrare nel mondo del lavoro per me, non poteva significare principalmente entrare nel mercato, non mi chiedevo quanto volessi guadagnare, ma cosa potessi fare per sentirmi gratificata dal mio lavoro.

Allora come oggi, considero il denaro nel suo valore strumentale, quello di servire a soddisfare le nostre necessità e dove eccede ad ampliare le nostre possibilità. Non so fare denaro, so guadagnarlo con la mia professionalità perché ho proprio scelto di stare al mondo, mettendomi a servizio dei miei simili con le mie competenze, le mie conoscenze e la mia umanità. Non riuscirei a vendere niente a nessuno e non m’interessa nemmeno imparare come si fa.

Scrivere, disegnare e fotografare sono quello che faccio per nutrire la mia vita, sia abitando comodamente la mia solitudine sia potendone condividere il processo con altri. Quando ancora a Valencia provai la strada della fotografia, mi resi conto che non riuscivo a provare nessun piacere nel fotografare secondo un tema dettato da altri, anche se non mi era impossibile. Partecipai ad alcuni contest organizzati dalla scuola che avevo frequentato, una di queste volte la mia foto fu inserita in una mostra collettiva e fu anche acquistata. Il titolo della mostra era Ponte en Portada, che tradotto significa mettiti in copertina, i fotografi dovevano integrare loro stessi nella copertina di un qualsiasi stampato. Fu divertente, ma anche quando dovetti farlo per lavoro, mi accorsi che non mi sentivo a mio agio a dover fotografare secondo richiesta. Nella scrittura come nella fotografia, in ogni forma di espressione che scelgo ho bisogno di sentirmi libera, di sceglierne la misura, la forma, il contenuto, il materiale, ho bisogno di sapere di essere sola o al contrario di essere insieme a, ho bisogno di poter essere io a decidere se quello che ho scritto, disegnato, fotografato è qualcosa che vorrò mostrare oppure no. Potermi esprimere in libertà e con questa consapevolezza è il mio diritto ad essere lasciata in pace, il mio diritto a stare bene, il mio diritto di essere nelle condizioni di lavorare bene, amare bene, vivere felice. Non essere spiata, impedire che i dettagli della mia vita privata vengano usati da altri per le proprie pubblicazioni, non ha a che vedere soltanto con il furto di una proprietà intellettuale, ha principalmente a che vedere con l’inviolabilità della mia persona, con la salute che è il fondamento di tale inviolabilità e con la possibilità di percepirmi libera di realizzare il mio progetto di vita.

Una volta riacquistato un adeguato benessere psicofisico, mi resi conto di non voler cambiare vita, che l’unico lavoro che davvero volessi fare era il mio, la psicologa e che dopo questa brusca interruzione, ero pronta a riprendere. Ero finalmente uscita dal burn-out.
Quando l’impiegato del Ministero dell’Istruzione di Valencia mi disse che per la validazione dei titoli professionali sarebbe passato almeno un altro anno, decisi che fosse arrivato il tempo di andare via. Ero rimasta ferma due anni e aspettarne un altro non avrebbe avuto senso, così tornai in Italia con l’intenzione di riprendere a lavorare, continuare a formarmi e approfondire il tema del trauma psichico.
Trascorsi l’estate del 2019 in Sicilia a casa di mia madre mentre pianificavo il mio prossimo futuro. Prima di lasciare Valencia avevo creato una serie fotografica genere collage, nella quale provavo a dare forma all’abuso che avevo vissuto, mettevo insieme in forma di immagini i temi che oggi tratto in questi capitoli. Usavo anche allora i libri, le loro copertine e i loro titoli, lasciando una traccia che mi ha permesso oggi di annodare i fili di qualcosa che a quel tempo era incomprensibile. Creai un account su Instagram che chiamai @passeggeridellinfinito dove postai la mia serie e qualche altra fotografia. Ancora non sapevo tutto quello che so oggi sulle piattaforme di social, pensavo che fosse una finestra dalla quale poter esprimere il mio punto di vista, denunciare quello che mi era accaduto e che consideravo oramai passato. Come ho avuto modo di scrivere già, non era così.

Quell’estate fu molto difficile, finii al pronto soccorso per una colica renale, ricordo di aver provato un dolore fisico indicibile e di aver perso dieci giorni di mare. Mia madre ed io nei giorni precedenti il mio incidente di salute, discutemmo in maniera molto accesa mentre ci trovavamo a mare. Non avevo, come d’abitudine, nessun dispositivo con me, ma quando tornai a casa Instagram era di nuovo pieno di post su madri e figlie che litigano, su rapporti familiari disfunzionali, su testimonianze e quanto altro potesse riferirsi a quel particolare momento della mia vita privata, che ancora oggi ricordo con dispiacere.
Un paio di anni dopo scoprirò che Oloferne, in uno dei suoi interventi televisivi parlando dell’importanza della privacy e della tutela dei nostri dati personali, citando anche le rivelazioni di Snowden dice,
riporto a memoria ma penso mi scuserete se per amor di precisione non vado a ricercare il video e mi espongo ancora a quella vista,
“il furto dei nostri dati non ha a che fare con la privacy nel senso di qualcuno che ascolta mentre mia madre mi dice Stronzo…”
A settembre, tramite amazon.com avevo acquistato il libro di Snowden e quello di Greenvald, ma ho aspettato le vacanze di natale del 2019/20 per leggerli entrambi. Il video di Oloferne è di novembre 2019.
Non aveva mai nemmeno per un secondo smesso di spiarmi, di ascoltarmi, di guardarmi, di ripetermi, di pensarmi, ero diventata per lui il suo lavoro.
Roma 1 maggio 2023 h: 14.36 p. m.
#LOVEINTblog#stalking online#Italia#abuso#potere#resistenza#hacker#cyberstalking#misoginia#diritto alla pace#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#lavoro#ossessione#inviolabilità della persona#empatia#privacy
1 note
·
View note
Text
Capitolo 29 – Il male della sorveglianza (II parte)
Era il 1890 quando il giudice Louis Brandeis definiva il diritto alla privacy, il diritto di essere lasciati in pace in quanto fondamento dell’inviolabilità della persona, ed era il 2013 quando G. Greenvald raccoglieva la testimonianza di E. Snowden e The Guardian pubblicava i documenti che dimostravano come il governo degli Stati Uniti, in barba a ogni diritto inalienabile e ignorando la Costituzione, aveva messo in atto il più organizzato e potente sistema di sorveglianza di massa.
È 2023 adesso e ci sono io che ho vissuto, e vivo, sulla mia pelle gli effetti di una sorveglianza perpetua, non da parte del governo che ha creato l’architettura informatica in grado di consentire questa sorveglianza, ma da parte di un uomo in grado di accedere a tali strumenti, in possesso delle capacità per sfruttarli e con l’accanita intenzione di usarli contro di me.
“Con l’abolizione della sfera privata, si perdono vari aspetti di solito associati alla qualità della vita. Come molti di noi sanno per esperienza, la privacy permette una liberazione dalle costrizioni. A tutti è capitato di adottare un certo comportamento credendosi soli – ballare, confessare qualcosa, esplorare la propria sessualità, esprimere idee non ancora collaudate – per poi accorgersi con vergogna di essere stati visti da altri. Solo quando ci sappiamo al riparo da occhi indiscreti ci sentiamo realmente liberi di sperimentare, di testare i nostri limiti, di esplorare nuovi modi di vivere e di pensare, di essere noi stessi.”
È sempre Greenvald a parlare e continua affermando che la privacy è indispensabile per la libertà e la felicità umana poiché è in essa che germogliano la creatività, il dissenso e la sfida all’ortodossia. L’autore cita alcuni esperimenti effettuati per indagare gli effetti psicologici e sociali sulle persone che sapevano di essere osservate, dimostrando quanto la sorveglianza di massa sia per sua natura intrinsecamente repressiva e capace di annichilire il comportamento di chi vi è sopposto.
In uno degli esperimenti citati, P. Zimbardo chiede ai soggetti di esprimersi a favore o contro la legalizzazione della marjuana. Il campione è suddiviso in due gruppi, ad un gruppo viene detto però, che quello che diranno verrà condiviso con le Forze dell’Ordine a solo scopo di ricerca. I risultati mostrano una percentuale nettamente a sfavore della legalizzazione della marjuana nel gruppo che sapeva che la polizia avrebbe conosciuto le loro risposte.
In un altro esperimento i soggetti acconsentivano ad essere osservati in tutti gli ambienti della propria abitazione, tranne in bagno e in camera da letto, per una settimana. Non soltanto fu difficile trovare persone che accettassero di sottoporsi allo studio, ma chi vi partecipò dopo appena poco tempo, si sentì a disagio a compiere azioni, compiute senza nessun problema prima, come assumere farmaci o stare nudi sotto la doccia. L’essere osservati caricava d’importanza anche atti precedentemente considerati privi di importanza.
In un altro degli esperimenti riportanti in No place to hide, i ricercatori avevano dotato i componenti di gruppi familiari di localizzatori, in modo da potersi tenere sotto controllo tutto il tempo, e ognuno era veramente sempre sotto controllo. Quando un familiare voleva vedere dove si trovasse l’altro, accedeva al dispositivo per vedere la localizzazione e contemporaneamente al familiare cercato, arrivava la notifica di chi lo aveva cercato. Inoltre ognuno poteva disattivare il dispositivo in qualunque momento e questo veniva comunicato a tutti gli altri. Ogni volta che si usava il dispositivo si riceveva poi un questionario, vi si chiedeva perché lo avesse usato e come si sentiva dopo aver localizzato il familiare. I soggetti risposero che, anche quando non stavano facendo nulla di male, né avevano intenzione di farlo, si sentivano in ansia, quasi colpevoli di non saper giustificare cose normali come scegliere un percorso piuttosto che quello abituale per andare a lavoro. Inoltre, anche quando decidevano di sottrarsi alla localizzazione spegnendo il dispositivo, si sentivano a disagio a doverne giustificare il motivo.
A nemmeno 10 anni di distanza dalla pubblicazione del libro di Greenvald, esistono App per la sicurezza familiare che consentono proprio di geolocalizzare tutti i dispositivi inseriti tra i familiari ed esistono genitori che la usano.

Le persone che sanno di essere osservate cambiano radicalmente comportamento, tendono a esprimersi il meno possibile, a isolarsi, a diffidare di chiunque, a dimostrare la loro innocenza, ad aderire all’ordine sociale stabilito e a non deviare dalle regole comunemente accettate; le loro possibilità di scelta e di azione sono estremamente ridotte, non riescono ad opporsi e a dissentire, vivono costantemente in uno stato di ansia, di vergogna e di paralisi emotiva.
Fra tutte le ricerche alle quali mi sono dedicata in tutti questi anni per capire cosa stava accadendo, a cominciare dalle rivelazioni di E. Snowden fino ad imparare ad installare Linux sul mio pc, è soltanto nel libro di Gleen Greenvald che ho avuto il coraggio di leggere la letteratura scientifica riguardante gli effetti psicologici sulla sorveglianza di massa e quelli sulla manipolazione online del comportamento. Non sono ancora riuscita ad avventurarmi in questa parte della storia. Mi sono bastati quelli citati nel suo libro per sentirmi ancora una volta di fronte a qualcosa di più grande di me, qualcosa d’inconcepibile, qualcosa di spaventoso. Lessi, infatti, il libro di Snowden e quello di Greenvald all’inizio del 2020 e mi ci sono voluti tre anni per accettare di essere anche io dentro la storia che raccontavano, di essere io uno di quei soggetti.

Chi sorvegliava me era ben attento a farmi sapere che nulla sfuggiva al suo sguardo, dentro e fuori casa, nel web come nel mondo reale, che era impossibile sottrarsi al suo controllo e poco a poco, mi convinsi che non ci fosse realmente nulla da fare. Accadeva che mentre passeggiassi con Paco chiacchierassi con qualcuno che a sua volta portava a spasso il suo cane. Non avevo il telefono con me durante quelle conversazioni casuali e non scambiavo il mio numero con quella persona, erano giusto chiacchiere come si fanno nella vita quotidiana normale. Poi arrivata a casa qualcosa di quella conversazione, il nome della persona, qualcosa che avevo detto, il suggerimento di visitare qualche posto particolarmente bello di Valencia, erano tra le notifiche sul mio telefono, in un post di Oloferne, erano un suggerimento con una notifica di YouTube.
Ogni dettaglio della mia vita era sempre continuamente visto, sottolineato e riportato. YouTube proponeva video sulla maniera di farsi il bidet il giorno dopo che cambiando casa, ne trovai una con un bagno sempre senza finestre ma con il bidet. Ancora, mi suggeriva video su particolari maniere di usare il bagno, di dormire, di fare le pulizie, abitudini che riconoscevo come mie. Le poche volte che cucinavo, perché magari avevo visto e comprato dei gamberi freschi, era tutto un pullulare di ricette con i gamberi, di storie sui gamberi e di quanto fosse crudele la pesca dei gamberi. Dentro casa iniziai a immobilizzarmi, ad accartocciarmi su me stessa e a dormire molto.
Iniziai anche a isolarmi, perché non potevo prevedere cosa le persone mi avrebbero detto o peggio chiesto, mentre in casa mia potevo limitarmi e controllare io stessa le informazioni che davo allo stalker, l’incontro con gli altri era sempre imprevedibile, non sapevo cosa avrei potuto dire e mi spaventava come Oloferne avrebbe potuto usare le mie parole. Altre volte, quando le persone che incontravo mi erano care, mi preoccupavo della loro privacy. Così, a differenza di come ero sempre stata, diventai solitaria e introversa, sempre meno incline a istaurare rapporti intimi con chiunque.
Ciò che mi annichiliva non era la paura del giudizio sulle mie azioni da parte di chi mi spiava, era che ogni mia parola, ogni mio gesto, ogni azione mi venissero sbattuti in faccia ventiquattro ore su ventiquattro, come se mi trovassi in una delle Infinity Mirror Room di Yayoi Kusama, stanze ricoperte di specchi che mi rimandavano all’infinito la mia immagine e l’unico scopo era farmi sapere che lui era lì, che c’era sempre, che era impossibile sottrarsi a questo sguardo. Ciò che mi annichiliva era il bisogno di trovare un perché a tutto questo, una ragione che non riuscivo a trovare e che trovata la quale, pensavo, avrei potuto usare per liberarmi.
Nei mesi durante i quali non ho avuto accesso alla rete, ho imparato come porre una distanza che mi permettesse di non subire queste forme di turbamento del reale, così viene definita una delle azioni di manipolazione del comportamento online nei documenti pubblicati da Greenvald in No place to hide, apprendendo l’arte del congelamento e dell’inespressività. Fingendo oggi, fingendo domani e il giorno dopo ancora, che queste notifiche non avessero nessun effetto su di me, è diventato quasi vero e ho iniziato a comprendere quale fosse l’effetto che lo stalker voleva produrre inviandomele.
Ritornai alla rete non soltanto perché sentivo il bisogno di stare con gli altri e di poter comunicare con i miei cari, ma soprattutto perché conobbi Miguel, un ragazzo giovane che per la modica cifra di 40 euro, ogni mese prendeva il mio pc e cambiava ogni componente fondamentale che poteva essere hackerata, poi me lo restituiva come nuovo. Come ho scoperto qualche anno dopo, nemmeno questo fu sufficiente ad impedire ad Oloferne di avere accesso alle mie produzioni scritte o fotografiche, ma in quel momento fu per me indispensabile credere, che in qualche modo, stavo riuscendo a sottrarmi al suo abuso e a contrastare questa violenza.
Fu indispensabile credere che, in qualche modo, riuscissi a difendere la mia inviolabilità.
Roma 8 aprile 2023 h: 1.00 p. m.
#LOVEINTblog#stalking online#Spagna#abuso#potere#resistenza#hacker#cyberstalking#misoginia#diritto alla pace#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#Gleen Greenvald#No Place ti Hide#inviollabilità della persona#empatia#loveintblog#privacy#azione
1 note
·
View note
Text
Capitolo 28 – Il male della sorveglianza (I parte)

“Si doveva vivere (o meglio si viveva, per un’abitudine che era diventata, infine, istinto) tenendo presente che qualsiasi suono prodotto sarebbe stato udito, e che, a meno di essere al buio, ogni movimento sarebbe stato visto.”
George Orwell, 1984
Quando si parla di privacy e di diritto alla privacy siamo tutti abbastanza confusi. Dite di no? Allora come ve lo spiegate che almeno una volta, durante la vostra giornata, dovete acconsentire al trattamento dei vostri dati personali affinché una procedura possa seguire il suo corso? Che sia inviando il vostro Curriculum Vitae, che sia per una transazione commerciale o per ricevere il referto delle vostre analisi, autorizzate qualcuno, sotto forma di azienda o di istituzione, a conoscere, trascrivere e conservare i vostri dati personali. Se stessimo realmente comprendendo l’importanza della nostra privacy, oggi non saremmo noi quelli obbligati a firmare un accordo di resa sui nostri dati, dovrebbero essere le aziende e le istituzioni a dover firmare, per garantirci che i nostri dati non saranno in alcun modo trattati.
La confusione però è attribuibile alla nostra responsabilità soltanto in parte, quello che ci confonde è il frutto di decenni di manipolazione dell’informazione. Note aziende vietano ai dipendenti di utilizzare piattaforme social di creazione straniera, accusando i governi di spionaggio. La diffusione di documenti segreti che rivelano gli abusi da parte dei governi durante le campagne militari in altri Paesi, ci ha sbattuto in faccia come quegli stessi governi, che per decenni hanno violato privacy di ogni cittadino facendo appello alla nostra sicurezza, avevano nel frattempo, un grande interesse a tenere nascoste le loro attività. Mentre si pretendeva la trasparenza da parte dei cittadini, contemporaneamente i governi pretendevano la segretezza sulle loro attività.

Per poter operare indisturbati e per poter continuare ad operare utilizzando un sistema di sorveglianza e di controllo di massa è stato necessario prima svalutare e minimizzare la privacy, dopo demonizzarla.
“I governi di tutto il mondo hanno speso notevoli energie per convincere i cittadini ad attribuire scarso valore alla privacy. Una litania di giustificazioni ha indotto le persone a tollerare gravi incursioni nella propria sfera privata e tale è il successo di quest’opera di persuasione che in molti plaudono alla raccolta, da parte delle autorità, di ingenti quantità di dati su ciò che la gente dice, legge, compra, fa e frequenta.”
Sono le parole di Glenn Greenwald tratte dal capitolo 4 del suo No place to hide, da cui prendo il titolo per questo mio capitolo, Il male della soveglianza. Come dice l’autore tale è il successo di questa opera di persuasione che non solo accettiamo che siano i nostri, o gli altrui, governi ad appropriarsi dei nostri dati e della nostra privacy, accettiamo che siano anche aziende commerciali a farlo e abbiamo persino ceduto alla persuasione del gamificare la nostra privacy con l’imprudente uso che facciamo della rete, dei social e di quello che condividiamo attraverso questi.
Greenwald sottolinea come anche i magnati di internet abbiano contribuito e supportato le autorità nell’assalto alla nostra privacy e cita le parole di Eric Schmidt, amministratore delegato di Google nel 2009, che in un’intervista alla CNBC così risponde alla crescente preoccupazione per la diffusione dei dati degli utenti raccolti:
“Se c’è un’azione che si vuol tenere nascosta agli altri, forse non bisognerebbe proprio compierla.”
Quando ho letto questa frase nel prezioso libro di Greenwald, mi sono chiesta se Schmidt sia umano. In un millesimo di secondo infatti, mi sono venute in mente moltissime situazioni, comprese esigenze fisiologiche che richiedono di solito una certa intimità e solitudine, per le quali l’aut aut del o in pubblico o non la fai, sembra abbastanza parossistico, se non una vera e propria tortura.
Ma a ben vedere la frase di Schmidt è perfettamente in linea con la propaganda di svalutazione e demonizzazione della privacy che è stata portata avanti in questi decenni e che ha indotto ogni cittadino e ogni cittadina a ritenersi al sicuro da una sorveglianza governativa mediante una svalutazione di se stessi e dei propri diritti. Quale interesse potrebbe avere il governo a spiare una persona qualsiasi come me? Che notizie rilevanti per la sicurezza del Paese potrebbe mai fornire un cittadino qualunque come me?
Ognuno di noi pensando che tiktok potrebbe spiarci avrà sorriso e pensato e allora? È questo il primo atto di svalutazione della nostra stessa privacy, pensare che dato che non stiamo facendo nulla di male, sia normale appropriarsi di quello che diciamo, di quello che facciamo, di quello che scriviamo, di ciò che leggiamo o mangiamo, di quello che ci accade mentre sediamo sulla tazza del gabinetto o nella nostra camera da letto. Questo primo atto è il segno che la persuasione ha fatto breccia in noi, perché siamo stati indotti a pensare alla nostra innocenza, siamo stati indotti a volerne dare una prova e a cadere nel secondo tranello della propaganda, indurci a pensare che soltanto chi ha da nascondere qualcosa deve temere di essere sorvegliato. È sospetto chi difende la privacy, non avrà per caso qualcosa da nascondere?

La privacy non è la prova della nostra innocenza, come non è qualcosa che possa essere ceduto per contribuire alla sicurezza nazionale di governi che sprecano le risorse dei contribuenti in sistemi di sicurezza atti a proteggere la segretezza del loro operato. La privacy non è un’azione che possiamo scegliere di fare o non fare, non è una scelta, non è una parte accessoria della nostra vita, ne è la parte essenziale.
L’ambito privato è quello in cui possiamo agire, pensare, parlare, scrivere, sperimentare e scegliere come essere, è il nostro luogo sicuro, in cui ci sentiamo al riparo anche dal giudizio degli altri. La privacy è una condizione imprescindibile dell’essere liberi.
Greenwald rintraccia la formulazione più famosa del perché la privacy sia desiderata in modo assoluto e universale, nelle parole del giudice della Corte Suprema Louis Brandeis che in un caso del 1928, riferendosi al diritto ad avere una privacy parla del diritto di essere lasciati in pace come il più vasto dei diritti e il più apprezzato da un popolo libero e attribuisce una portata assai più ampia di quella di molte libertà civili, al valore della privacy.
Greenwald cita un’estratto della sentenza:
“Gli estensori della nostra Costituzione si sono adoperati per assicurare condizioni favorevoli al perseguimento della felicità. Hanno riconosciuto l’importanza della natura spirituale dell’uomo, dei suoi sentimenti, del suo intelletto. Sapevano che solo una parte della sofferenza, del piacere e della soddisfazioni della vita risiede nelle cose materiali. Hanno tentato di proteggere gli americani nelle loro convinzioni, nei loro pensieri, nelle loro emozioni, nelle loro sensazioni. A differenza del governo, hanno conferito loro il diritto di essere lasciati in pace.”
La privacy è il nostro diritto alla pace, ad essere lasciati in pace, non ha a che fare con il nostro conto in banca, con i nostri possessi o le nostre risorse materiali, è la parte più importante della nostra esistenza, è ciò che ci consente di essere chi siamo.
Prima di diventare giudice di Corte Suprema, Brandeis in un articolo intitolato Il diritto alla privacy e apparso su Harwad Law Review, scrive anche
“Il principio che tutela gli scritti e ogni altra produzione personale, non dal furto e dall’appropriazione fisica, ma dalla pubblicazione in qualsiasi forma, non è in realtà quello della proprietà privata, ma quello dell’inviolabilità della persona.”
Era il 1890.
(Continua)
Roma, 2 aprile 2023 h: 4.41
#LOVEINTblog#stalking online#Spagna#abuso#potere#resistenza#hacker#cyberstalking#misoginia#diritto alla pace#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#speranza#empatia#loveintblog#privacy#azione
1 note
·
View note
Text
Capitolo 27 – L’indagine del tempo e del dolore

IV.14
È difficile conciliare
tre diverse andature,
tre differenti volontà direzionali.
Diventa faticoso il cammino.
Da quando siamo in tre
al mattino
il dolore sta davanti
Paco, guinzaglio permettendo,
a tratti lo affianca,
io li seguo stancamente.
da Canti Malinconici
Mio padre era il mio migliore amico, a lui potevo confidare ogni cosa, di lui potevo fidarmi e sapevo che qualsiasi cosa fosse accaduta, sarebbe sempre stato dalla mia parte. Ero sicura che se avessi avuto bisogno di aiuto, sarebbe stato pronto a venire in mio soccorso ovunque mi trovassi. Era la mia base sicura, quella che mi ha permesso di muovermi nel mondo vigile e senza paura.
Chiunque abbia avuto la fortuna di avere un genitore o una persona dalla quale si è sentito capito, conosciuto, protetto e amato, sa che nemmeno la morte può cancellare quel profondo sentimento. Introiettiamo dentro di noi l’amore ricevuto e diventa una guida per noi, una luce sempre accesa che illumina un passo e quello dopo.
Il lavoro del lutto, l’attraversamento del dolore, l’elaborazione della perdita di una relazione importante, conduce solitamente ad amarsi di più, proprio per rendere grazie dell’amore ricevuto. Ci si riprende, si ritorna a stare bene perché si è certi che quel nostro caro avrebbe voluto così. I dolorosi ricordi dei giorni della malattia e di quelli della separazione definitiva vengono sostituiti dai ricordi cari, si rievocano i momenti belli, quelli divertenti, la nostalgia prende il posto del pianto, il sorriso ritorna sul volto.
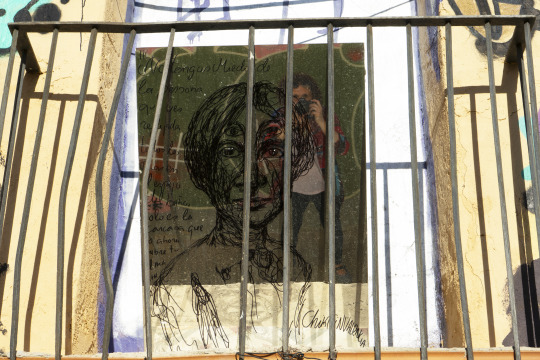
Vivere a Valencia, sola, senza poter comunicare con amici e familiari, sapere che ciò era dovuto al potere di un uomo che mi stava schiacciando, sopportare il fallimento dopo ogni mio tentativo di liberarmi da questo abuso, rese per molto tempo insopportabile la mancanza di mio padre, tanto da rendere il lutto molto complicato. Non c’era più nessuno che avrebbe fatto qualunque cosa per aiutarmi.
Ero depressa, mi sentivo sola al mondo e alcuni giorni mi sembrava quasi di non sapere più chi fossi. Mi alzavo al mattino solo perché dovevo portare fuori Paco e dopo la passeggiata non riuscivo a fare niente. Ero in una città bellissima e sconosciuta, ogni sera programmavo per il giorno seguente, la visita a un museo, a uno dei tanti giardini o semplicemente una passeggiata al mare e puntualmente il giorno dopo, la mia apatia annullava il programma. Mi sentivo impotente e me ne davo la colpa. Mi accusavo di essere stata una stupida a giocare uno stupido gioco con persone senza scrupoli, mi vergognavo della mia ingenuità e della mia incapacità di riuscire ad uscirne.

Sapere di essere vista in ogni momento, in un certo senso mi faceva sentire come paralizzata, mi muovevo il meno possibile e sempre al buio, o in penombra. Misuravo ogni passo e ogni parola. Fare la doccia aveva completamente smesso di essere un momento piacevole, ogni volta il cuore iniziava a battermi all’impazzata, mi sentivo in ansia e quindi iniziai a farne sempre meno. Ero diventata pavida, insicura, apatica e triste.
Prima di lasciare l’Italia, come ho scritto in un capitolo precedente, dissi ad alcune persone quello che mi stava accadendo ma rivelai il vero nome di Oloferne soltanto a tre persone, due delle quali non credendomi mi presero per una mitomane. Perché un personaggio famoso avrebbe dovuto interessarsi a me tanto da spiarmi?
Oggi come allora io so la verità ma fu bruciante come il sale sulla ferita aperta, sapere che chi mi conosceva, da quasi tutta la vita, potesse pensare di me che avessi bisogno di una menzogna per esistere. Fu doloroso vedermi con i loro occhi e pensare che per darmi valore avrei avuto bisogno di inventarmi l’amore ossessivo di un tipo famoso. Una di queste due persone nonostante la sfiducia iniziale, ha voluto capire cosa stesse realmente accadendo durante questi anni e ancora oggi, per come è in suo potere, mi aiuta e mi sostiene nella lotta a questo stalkeraggio, l’altra non è più nella mia vita.

Non ero nel mio momento di massima lucidità e stavo vivendo una situazione sopraffacente per le mie risorse, non trovare l’aiuto che cercavo e pensare che nessuno avrebbe creduto mai a questa storia, perché io ero nessuno e lui una persona di fama internazionale, mi fece sentire di non valere più niente. Il trattamento che avevo ricevuto ogni volta che avevo chiesto aiuto o avevo confidato a qualcuno quello che mi stava accadendo, non trovare empatia, compassione e nemmeno simpatia, nella maggioranza delle persone alle quali mie ero rivolta, trovare invece chi volesse guadagnarci, chi volesse approfittarne e chi ridesse di me, mi indusse a mettere in dubbio le mie possibilità, il mio valore, a mettere in dubbio chi fossi io, chi i miei amici e chi i nemici, a non saper più discernere il vero dal falso, a temere il futuro.
Per continuare a scrivere di questo periodo della mia vita che faccio molta fatica a rievocare, ho dovuto rileggere tutto quello che ho scritto in quel periodo, ho visto le foto che ho scattato, i disegni che ho fatto e so che ho veramente rischiato di perdermi. Mi ha tenuto in vita la fede, è stata la rete sottile che ha tenuto insieme l’essere frammentato che ero, ma di questo preferisco parlare in un altro momento, adesso riconosco, che ancora una volta, i miei salvavita sono state la pagina bianca e la macchina fotografica. Ho potuto dare forma all’indicibile quando l’indicibile era ammettere che stavo mettendo ogni briciola delle mie scarse forze nel sopravvivere ad un altro giorno di insopportabile malessere.

Mi rivolsi a uno psicologo e il percorso intrapreso mi fu molto utile per superare l’immobilità in cui mi trovavo e per riattivare le mie povere risorse.
È di questo periodo uno scritto che nessuno ha mai letto, tranne chi mi stalkerizza e mi spia, che s’intitola La domanda. Rifletto sulla sofferenza considerando la vita dell’uomo di tutti i dolori, Cristo, e cerco di trovare la risposta alla domanda:
quanto dolore può sopportare l’essere umano prima di morirne?
Scrissi anche un diario, il Diario di Valencia che conclusi il giorno prima del mio ritorno in Italia. Sentirmi, non tanto libera di scrivere, di disegnare o di fotografare senza sguardi indiscreti, quanto libera dal dover assistere alla predazione che ne faceva Oloferne e chiunque altro fosse presente, mi aiutò a stare ogni giorno un poco meglio. M’iscrissi a un corso di fotografia e a quel punto, per iniziare ad avere una vita sociale acquistai un nuovo smartphone, con un numero spagnolo collegato ad internet, ripresi i contatti con i miei amici e mi senti in grado di vivere dimenticandomi di quello che stava accadendo. Il corso di fotografia mi permise di stare insieme a delle persone con i miei stessi interessi e mi fornì molte occasioni per conoscere la città, anche di notte. Uscivamo per sessioni fotografiche e il tempo passava più piacevolmente. Incoraggiata dallo psicologo iniziai le pratiche per la richiesta del riconoscimento dei titoli accademici e professionali, mi stavo impegnando a stare bene e a ridare forma alla mia vita.

Anche se non ho mai provato a pubblicare niente di quello che scrivo e che fotografo, l’ho sempre fatto avendo un progetto in mente. I miei racconti o le mie riflessioni riguardano temi ben precisi, argomenti che in quel momento ho bisogno di conoscere e trattare. Così come le mie raccolte di poesia non sono momenti sparsi d’ispirazioni fugaci, sono indagini su qualcosa dentro di me e le mie serie fotografiche sono la forma che provo a dare a ciò che vivo.
Il primo progetto fotografico che iniziai ma non portai a termine fu Migranti. Avrei voluto fotografare solo persone che come me, avevano lasciato da adulti il loro paese natale per ricominciare una nuova vita. Feci soltanto due foto, perché per ritrarre qualcuno devo conoscerlo, devo ascoltare la sua storia, trascorrere del tempo insieme, osservare tanto, imparare a riconoscere le sue espressioni, catturare quella che ho scelto per rappresentarlo. Per come avevo in mente il mio progetto avrei dovuto espormi, conoscere e farmi conoscere, ascoltare le loro storie e raccontare la mia, ma era proprio quello che non potevo fare, perché io stavo facendo una fatica immane cercando di uscire fuori dalla mia storia, io volevo solo dimenticarla, fare finta che non ci fosse nessuna storia, così come avevano detto tutti.

Abortii il progetto Migranti e mi dedicai ad altri più accessibili al mio spirito. Sono di questo periodo le serie Claustrofobia, Are you alive e Piccoli Umani che ho pubblicato sul mio sito. Altri progetti di quel periodo invece non sono stati pubblicati.
Sul finire del 2020, quando ritornata in Italia, ho scoperto che Oloferne aveva pubblicato un libro nel quale intervistava fotografi che avevano ricevuto riconoscimenti importanti per le loro foto di migranti, ho comprato e ho letto il libro. Fu l’inizio della scoperta che in nessun momento della mia vita, aveva smesso di spiarmi e di utilizzare ogni mio pensiero, progetto o evento di vita, per farne una pubblicazione. Comprai il libro perché ancora una volta pensai che si fosse ispirato a me, ma con un’intenzione in qualche modo buona.
Mi dispiace aver sprecato il mio denaro, penso che sarebbe più giusto che i ricavati di questo libro andassero alle ONG che si occupano di salvare le vite dei migranti piuttosto che nelle tasche di Oloferne. Non c’era nessuna buona intenzione che riguardasse me, ero stata ancora una volta, solo una buona idea da sfruttare e da commercializzare. Parla di empatia in questo testo e considerando il fatto che non aveva smesso nemmeno un minuto di guardare, spiando, quanto stavo male e quanto soffrissi, non penso vi stupirete se affermo che in questo libro parla di empatia come un paleontologo parla di dinosauri, come chi ha studiato un fenomeno senza mai conoscerlo, senza mai sperimentarlo, senza mai viverlo e quindi senza poterlo comprendere davvero.

Roma, 30 marzo 2023 h: 4.47 p. m.
#LOVEINTblog#stalking online#Spagna#abuso#potere#resistenza#hacker#cyberstalking#misoginia#valencia#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#speranza#empatia#loveintblog#privacy#azione
1 note
·
View note
Text
Capitolo 26 – Si chiude una porta

“Quando si chiude una porta, si apre un portone”
È un proverbio che la mia nonna paterna era solita usare spesso, non lo ricordo io personalmente, perché è morta quando avevo solo dieci anni, i miei ricordi di lei hanno a che fare con odori, sapori, suoni e abbracci, sono ricordi fatti di emozioni e dubito che possano esserci state occasioni nelle quali abbia potuto dirlo per insegnarmi qualcosa o darmi conforto; che lo ripeteva spesso lo so attraverso mio padre, lui ha tenuto vivo nella mia vita il ricordo di lei ripetendo le sue parole, i suoi insegnamenti e anche la sua cucina.
La frittata di patate e cipolle, il pane fritto, la spremuta di mandarino, sono alcuni dei sapori della mia infanzia che con sorpresa ritrovai a Valencia, già dalla prima mattina in cui mi svegliai in quella città. Suppongo sia stata questa aria familiare a farmi decidere di restare lì, perché non avevo nessun motivo per restare, come non avevo nessun motivo per andare da qualsiasi altra parte. La porta di Barcellona, la stanza dell’amicizia di Cristian e la possibilità di liberarmi dagli hacker, si era chiusa e Valencia sembrava pronta ad accogliermi a braccia aperte; era semplice muoversi sia in auto che con i mezzi pubblici, o anche solo passeggiando a piedi. Paco poteva venire con me ovunque, entrare nei negozi, stare con me al bar, al ristorante, le case erano molto carine, anche quando erano piccole e i prezzi degli affitti piuttosto bassi. In una settimana, trovai un monolocale arredato, a due passi dal centro, che affittai subito.

Da quando avevo potuto percepire il piacere che Oloferne aveva provato non solo nel provocare la competizione tra me e l’altra instagramer, ma nel godere di come questa aveva prontamente e aggressivamente risposto, iniziai a provare fastidio per ogni suo tentativo di comunicare con me e smisi di comunicare con lui in qualsiasi modo, iniziai ad ignorarlo e questo non gli piacque affatto. Da quel momento in poi, i suoi post e le notifiche sul mio smartphone smisero di essere messaggi d’amore e divennero indicazioni e avvertimenti, continui segnali della sua presenza vigilante.

Il monolocale che affittai si trovava all’ultimo piano di un palazzo di una via chiamata Carrer Joaquín Costa. Una camera da letto, un bagno senza finestra e un piccolo soggiorno cucina con una porta balcone, per un totale di 20 mq. Con l’unica differenza della porta balcone che è stata una terrazza, e poi diventata un cortile, tutte le case dove ho vissuto da allora in poi, hanno mantenuto la stessa divisione degli spazi. Sempre piccoli quasi che li possa controllare meglio e sempre con bagni senza finestre quasi che si possa evitare di essere spiata. Fu in quella casa che iniziò, senza avere più termine, la sorveglianza globale dello stalker. Ancora oggi nessuna precauzione è riuscita a impedirgli di spiarmi.
Il giorno stesso che mi trasferii in quella casa, Oloferne postò sul suo Instagram la foto di un cane, dava il triste annuncio della morte del suo fedele compagno Joakim.
Avevo trovato nell’armadio della camera da letto, due piumoni invernali e avendo l’abitudine di parlare ad alta voce da sola, quando li vidi li definii di un opaco color foca. La prima notte dormii con i piumoni arrotolati intorno come sacchi a pelo, perché stavo morendo di freddo. La mattina dopo, quando ritornai dalla passeggiata con Paco e riattivai la connessione al mio telefono, trovai la notifica di un post di Oloferne, era il video di una foca sulla spiaggia che si stava svegliando, l’ora del post coincideva con l’ora in cui mi ero alzata.
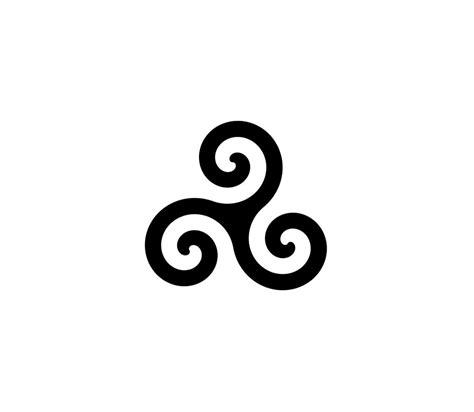
Due sere dopo acquistai, in una bancarella sotto casa un piccolo orecchino a forma di triskelis, che indossai la mattina dopo nel mio bagno senza finestre. Era un orecchino minuscolo, il suo diametro sarà stato di due o tre millimetri, era così piccolo che tra i capelli neanche si vedeva, inoltre la camera del mio telefono era oscurata come quella del mio pc e del mio iPad, ma lo stesso sul mio smartphone apparve, pochi minuti dopo averlo indossato, un articolo che parlava della leggenda del simbolo del triskelis.
Non sapevo come avesse potuto fare, ma era chiaro che Oloferne era in grado di vedermi e ascoltarmi anche dentro questa casa, anche quando non avevo il cellulare con me, anche quando nessun elettrodomestico era presente, anche senza alcuna connessione alla rete.

Cercai su internet informazioni sulle telecamere e i microfoni per intercettazioni ma non trovai granché, trovai solo che i prezzi per effettuare una bonifica ambientale erano esorbitanti e mentre ciò che leggevo mi demoralizzava sempre di più, una notifica di YouTube salì a darmi il colpo di grazia. Era un video che mostrava l’impossibilità di trovare oggetti così piccoli e ben nascosti dentro prese di corrente, appendini per accappatoi, top di lampadari senza essere provvisti di un’adeguata strumentazione. Oloferne voleva farmi sapere che era lì dove ero io, sempre. Voleva anche farmi sapere che non sarebbe stato per niente facile farlo andare via.
Più lo ignoravo e cercavo di liberarmene più diventava aggressivo nel mostrarmi fin dove poteva arrivare, quanto era in grado di vedere, di ascoltare, di ripetere postando.
Dopo pochi giorni trovai un negozio che forniva assistenza informatica e vi incontrai i primi che provarono a ripulire i miei supporti, quando anche loro si resero conto della difficoltà di liberarsi dello stalker, dato che dopo nemmeno un paio d’ore dalla consegna del pc depurato, Oloferne lo aveva già hackerato nuovamente, mi consigliarono di liberarmi di tutti i miei supporti, cambiare numero di telefono, indirizzo email e di andare a sporgere denuncia. Il resto lo sapete, ho già raccontato cosa ne è stato della denuncia. Non ha avuto seguito, nessuno ha indagato, non ci sono state ricerche, proprio come aveva previsto Oloferne.

Nel frattempo l’inverno era arrivato e fu il più freddo inverno che Valencia aveva vissuto negli ultimi 62 anni. Avevo freddo sempre, avevo le mani ferite dal freddo, piene di tagli e geloni, mi coprivo dalla testa ai piedi e anche quando mi trovavo in casa, ero sempre completamente vestita. Avevo ormai imparato a spogliarmi senza mai rimanere nuda.
Cercavo di tenermi impegnata, almeno al mattino facendo un po’ di esercizio, era anche l’unico modo che avevo per contrastare i sintomi della Sindrome da Affaticamento che erano ritornati. Avevo dolore di nuovo a tutto il corpo, soprattutto alle mani, e mi sforzavo di fare ogni mattina una lunga passeggiata con Paco lungo il Rio Turia, poi mi fermavo qualche minuto a fare ginnastica nelle sue palestre a cielo aperto. Avevo smesso di scrivere quando, dopo aver iniziato un racconto sul nuovo computer portatile che avevo comprato da pochi giorni, mi accorsi che sia il fotografo inglese sia Oloferne avevano utilizzato nei loro post un riferimento al nome che avevo scelto per la protagonista del mio racconto, Eulalia Monterosa. Il fotografo aveva postato la foto di un monte innevato immerso nella luce rosata di un tramonto e Oloferne aveva citato l’opera di una scrittrice di nome Eulalia. Ormai a questi rimandi reagivo sempre più bloccandomi e inibendo ogni mia ulteriore espressione. Continuavo a disegnare il mio Black Book, è di questo periodo il disegno in cui vado in frantumi, e scrivevo ogni tanto qualche poesia, ma soltanto su un quaderno usando una pilot.
Il resto della giornata lo passavo a giocare a scacchi online. Su una piattaforma gratuita, giocavo con degli sconosciuti collegati da tutto il mondo e per non correre rischi, non giocavo mai con lo stesso user più di una partita. Ero dentro un loop. Giocavo per non sentire quell’angosciante senso di impotenza in cui ero precipitata, giocavo per non pensare, per non sentire il vuoto del tempo trascorso. Ripetevo una procedura automatizzata per non sentire l’ansia e la paura. L’importante non era vincere, era continuare a giocare, giocare e non pensare.
In quei giorni Oloferne aveva creato un suo proprio canale YouTube, dove si registrava facendo brevi monologhi e parlando di quello che lo interessava al momento. In un giorno mi arrivarono due notifiche dei suoi ultimi video. Nel primo parlava del pianista M. Petrucciani e nel secondo parlava di se stesso. Nel primo video raccontava la storia di questo pianista affetto da una malattia incurabile a causa della quale le sue ossa andavano in frantumi, comprese le ossa delle sue mani. Il famoso pianista soffriva moltissimo mentre suonava, ma nonostante questo smise di suonare il piano soltanto alla sua morte. Nel secondo video Oloferne raccontava di essere stato sin da piccolo molto ambizioso e di aver cercato di raggiungere il successo più di una volta prima di riuscirvi. La prima volta, come talento musicale, da bambino suonava il piano e partecipava a delle competizioni ma non ottenendo il successo sperato aveva provato come giovane giocatore di scacchi, senza riuscire nemmeno qui. Oloferne concludeva che la sua perseveranza e il suo riuscire a non scoraggiarsi di fronte ai fallimenti, erano stati premiati da ciò che era sempre stato nel suo destino: diventare un uomo di successo. Mi pare almeno che fosse questo il senso. Ma qualunque fosse ciò che voleva trasmettere con questi video, io non potei evitare di pensare alle mie mani ferite e a quanto risultasse tagliente la parola fallimento che per così tante volte aveva ripetuto. In nessun momento del video si faceva il minimo accenno al fatto che il fallimento che mi riguardava direttamente era l’incapacità di liberarmi dal suo sguardo non voluto. In nessuna parte del video si accennava al fatto che il mio disintegrarmi fosse una reazione al continuo sciacallaggio che lui faceva dell’intimità dei miei giorni.

Vedere ogni giorno le mie parole, i miei disegni, le mie foto, il senso che a questi avevo dato, moltiplicarsi in una eco infinita sui social, non aveva su di me l’effetto di farmi sentire pensata, amata, importante o degna di attenzione come forse speravano di ottenere gli stalker, avevano l’effetto di prendere qualcosa di molto caro della mia vita, frantumarlo e lanciarlo al vento, libero di moltiplicarsi ovunque perdendo così la sua unicità, la sua coesione, ogni cosa di me si ripeteva di parola in parola, di immagine in immagine, cambiando sempre un poco e sbriciolando continuamente ciò che avevo usato io per tenere unita una traccia di me, conservarne un senso. Più Oloferne utilizzava la mia vita, più me la sbatteva in faccia senza nessun riguardo, più mi sentivo polverizzata. Non mi sentivo speciale in quel fiume di bolle che mi ripetevano e che come niente scoppiavano al tocco, mi sentivo banalizzata, era come la self-obliteration di Kusama, solo che non avevo scelto io di praticarla su di me, ma qualcun altro e non era un modo d’amarmi, era un modo d’odiarmi.
A poco poco mi feci immobile, sempre più piccola, sempre meno attiva. Smisi di giocare a scacchi, disinstallai Instagram e anche YouTube dal mio telefono, bloccai le notifiche, ma non fu sufficiente. Così feci l’unica cosa che si potesse fare a quel punto, sparii dalla rete. Comprai un telefono di quelli classificati per gente anziana, che hanno ancora la batteria estraibile. Mia madre mi mandò una Sim registrata a nome del più caro amico di mio padre. L’unico numero che avevo in memoria era il numero di mia madre. Accendevo il telefono una volta al giorno per chiamarla, poi lo spegnevo e lo tenevo sempre spento, con la batteria staccata.

Sapevo che Oloferne mi controllava anche dentro la mia abitazione, non avevo alcuna speranza di riuscire ad impedirglielo oramai, ciò che stavo cercando di fare era di liberarmi io dalla sua presenza, dalla sua invadenza, dalla sua violenza. Provai a fare finta che non ci fosse, e anche se era impossibile, provai a impedirgli di farmi sapere che c’era. Gli impedii di comunicarmi cosa vedeva e cosa ascoltava della mia vita, cosa ne faceva di ciò che rubava dai miei giorni, provai in questo modo a sottrarmi alla svendita del mio calvario.
Roma, 18 marzo 2023 h: 6.53 p. m.
#LOVEINTblog#stalking online#Spagna#abuso#potere#resistenza#hacker#cyberstalking#misoginia#valencia#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#speranza#empatia#loveintblog#privacy#azione
1 note
·
View note
Text
Capitolo 25 – Per Una, dieci.

“…la forza dura più a lungo del potere. E la forza viene dall’interno.
[...]Il femminile deve sostituire la dominazione con la cura, la competizione con la cooperazione, e il saccheggio del pianeta e dell’umanità con il nutrimento e il sostegno. La donna del XXI secolo può sostituire il potere con la forza. Una rivoluzione morale, se volete.”
Ece Temelkuran, La fiducia e la dignità. Dieci scelte urgenti per un presente migliore.
Il movimento del MeToo nasce nel 2017, come un hashtag che diventa virale sui social. Un’attrice, Alyssa Milano invita tutte le donne del mondo a postarlo, condividendo la propria esperienza personale sugli abusi e i sopprusi subiti da uomini, per dimostrare quanto sia naturale ed esteso il comportamento misogino. E dato che oggi, il movimento è conosciuto in tutto il mondo, possiamo farci un’idea di quanto naturalmente estesa sia la misoginia, il maschilismo e la violenza di genere.
Nel 2018 quando ancora mi trovavo a Valencia, sono state uccise 33 donne soltanto ad agosto in Spagna. Il dato letto in un altro modo significa che in un mese, ogni giorno è stata uccisa una donna.
Nel 2022 in Italia sono state uccise 120 donne, che sarebbe come dire 10 donne al mese, l’ultima in ordine cronologico è stata uccisa il 24 dicembre. Mi domando quanto ancora più impressionanti sarebbero questi dati se aggiungessimo gli accessi al Pronto Soccorso in codice Rosa avvenuti durante lo stesso anno; quanto ancora, se aggiungessimo anche le contusioni viste solo dai medici di base, dai familiari o da nessuno.
Stiamo parlando di Paesi europei, non ci stiamo domandando se sia possibile contare quante donne vengono picchiate, stuprate, violentate e uccise in Iran in questo preciso momento. In Ucraina, in Russia. Quante nei lager libici. In Eritrea, in Somalia, in Siria, in Turchia. Si potrebbe continuare così a lungo, fino a nominare ogni paese del nostro mondo finito e ovunque troveremmo un’estensione del comportamento misogino, perché come ha messo in luce il movimento MeToo, tale comportamento non è naturale ma è percepito come tale, direi piuttosto che secoli e secoli di barbarie lo hanno naturalizzato.
“[…]«Sono così stufo di dover rallentare quando cammino dietro a una donna di notte per non farla spaventare», mi ha detto un mio amico turco nel 2019. Gli altri uomini del gruppo hanno iniziato a lamentarsi animosamente di come anche loro ne avessero abbastanza di essere visti come potenziali predatori in questo mondo di MeToo. Le donne del gruppo sono rimaste in silenzio, con gli occhi spalancati, senza parole.”

A parlare è Ece Temelkuran una scrittrice, giornalista e commentatrice politica turca invisa al regime e la citazione è tratta dal suo libro La fiducia e la dignità. Dieci scelte urgenti per un presente migliore, scritto nel 2020 durante il lockdown. Come dicono titolo e sottotitolo, l’autrice prova a riappropriarsi del senso di alcune parole, scelte con molta cura e attenzione, per restituire speranza al genere umano e nel passo successivo alla citazione riportata, prova a darsi una ragione del pesante silenzio delle donne, lei compresa, seguito all’affermazione dell’amico infastidito. Forse, dice, fu colpa della confusione nel non saper scegliere da dove iniziare a rispondere agli amici. Informarli che in quel anno, non ancora terminato, in Turchia erano state uccise 474 donne? Che la maggior parte degli uomini accusati di femminicidio erano stati rilasciati perché avevano ‘espresso rammarico’?
“O con l’ineluttabile conclusione che la ragione ultima per cui gli uomini uccidono le donne sembra essere semplicemente perché possono?
[…]È troppo facile scegliere di credere che tutta la violenza contro le donne e la sua costante sottovalutazione avvenga altrove, tra i «bifolchi». In realtà, come ho capito quel giorno tra i miei amici, la violenza è ovunque e in realtà inizia nel momento in cui diciamo «Bene, allora cambiamo argomento».”
Sono d’accordo con l’autrice, le parole sono importanti. In esse si cela una saggezza infinita. Bisogna usarle bene e bisogna chiedersi spesso come usiamo le parole, e chiedersi anche come vengano usate. Bisogna dubitare di conoscerne il significato preciso. È necessario invece interrogarle spesso, indagare il loro significato nascosto dal tempo e sepolto dal loro uso presente. Con le parole costruiamo i nostri linguaggi e questi creano la nostra realtà, la modificano, la plasmano. Per questo considero molto importanti le questioni di inclusività nel linguaggio, non sono soltanto mere dispute accademiche, un linguaggio inclusivo è il valore di una cultura, di un popolo.
Se importante è il modo di esprimersi, allo stesso modo sono importanti gli argomenti di cui si parla e della violenza sulle donne si parla ancora oggi, purtroppo, con troppa diffusa retorica e spesso le oratrici sono le donne stesse.
Durante la Giornata Internazionale della Donna è stato diffuso alla radio, il risultato di un sondaggio che chiedeva agli uomini italiani se pensassero che la violenza di genere li riguardasse. Il 78% ha risposto di no, non si sentivano minimamente inclusi nell’argomento. Durante la stessa settimana mi è capitato di ascoltare altre due notizie una delle quali, data al radiogiornale della sera. Si informava il popolo italiano che un personaggio famoso, over 80, era diventato padre di un bambino dato alla luce dalla compagna, poco più che ventenne. Tralascio qualsiasi considerazione sul fatto che una notizia come questa venga data durante il radiogiornale di rai2 e passo alla seconda notizia che ho ascoltato. Riguardava un noto personaggio politico, famoso per le sue battute offensive nei confronti delle donne, anche lui over 80. Il conduttore del programma informava gli ascoltatori che alla fine della loro storia, ognuna delle sue giovani ex fidanzate, aveva ricevuto in regalo dal politico, un magnifico appartamento in zone centrali delle città di Roma o di Milano. La voce alla radio ironizzava sul fatto che si fosse sparsa la voce tra le modelle, che per avere un bell’appartamento bastava fidanzarsi per qualche tempo con il suddetto politico.
Penso davvero che l’amore non abbia età e non risenta di lontananze di tempo o di spazio, ma ascoltando queste due storie, mi sono posta la stessa domanda che mi posi quando lo stalker mi disse che mi spiava e mi stalkerizzava per amore, mi chiesi “Chi ama cosa?”.

In queste storie c’è qualcosa che, in modi differenti, mostra un medesimo comportamento maschile, del quale non si parla, perché non riguarda l’altrove dei bifolchi, riguarda uomini dei quali celebriamo il successo, prendiamo a modello le loro storie, quelle di chi si è fatto da solo e ha raggiunto ricchezza e fama grazie alle sue individualissime ed eccezionali doti, di chi ha raggiunto quel potere che fa sentire invincibile, eternamente giovane e totipotente. Parliamo di loro e il loro successo è promosso a modello da imitare, o da sposare.
Non parliamo dei peggiori aspetti (distruzione, opportunismo e presunzione) di quello che Ece Temelkuran definisce Maschio Radicale e del quale rintraccia rappresentanti in tutto il mondo, parliamo del comportamento naturalmente esteso.
“[…]Il maschio radicale non può sopportare nulla di fluttuante, che si tratti di genere o di fiumi; tutto deve essere fisso perché possa sentirsi sicuro. Tutte le irregolarità devono essere rese uniformi. Ciò che minaccia sia il corpo delle donne sia la Terra è lo stesso motto del Maschio Radicale: potere significa rompere, governare significa controllare, esistere significa possedere.”
Comunicare significa manipolare, amare significa dominare, intimità significa predazione, condivisione significa denaro.
Quando i Maschi Radicali sono ben nascosti tra i grandi dell’economia, della politica, dell’informazione, della cultura e dello spettacolo, è difficile che si parli di una storia alla quale nessuno crederebbe. Oppure che dopo dieci, forse quindici anni di processo, finirebbe con un’assoluzione completa perché il fatto non sussiste.

Per ogni donna che accetta un potere maschilista abusante ci sono altre dieci donne che perdono, in senso metaforico e letterale, la loro vita nel silenzio. Per ogni donna che ride per la battuta sessista del proprio marito o compagno, ce ne saranno altre dieci costrette a subire quella battuta sul proprio corpo. Per ogni donna che accetta di essere mostrata come un trofeo dal proprio partner, ce ne saranno dieci brutalmente trattate come oggetti. Per ogni donna che si ritiene soddisfatta di aver meritato, con la propria dedizione e pazienza incondizionata, di diventare sposa di un uomo che questo voleva, ce ne saranno altre dieci che saranno costrette al matrimonio. Per ogni donna che accetta di considerare il successo, inteso quale lusso e fama mediatica, come la forma giusta indicata dagli uomini, ci saranno altre dieci donne per le quali poter vivere una vita tranquilla, sarà l’unica forma di successo a cui aspireranno. Per ogni donna che raggiunta una posizione di responsabilità, usa il suo potere ripetendo dinamiche clientelari maschiliste, ce ne saranno altre dieci che nel buio, silenziosamente lavoreranno, preparando la cultura del secolo che verrà.
Roma 12 marzo 2023 h: 2.25 p.m. – 13 marzo 2023 h: 7.00 p.m.
#LOVEINTblog#stalking online#Ece Temelkuran#abuso#potere#resistenza#hacker#cyberstalking#misoginia#maschilismo#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#speranza#empatia#MeToo#YoTambien#azione#privacy#loveintblog
1 note
·
View note
Text
Capitolo 24 - Un viaggio altrove
IV.15
È solo che ho il mare dentro
E quando si alza la marea
Travalica le guance
Scende giù per il mento
Inondando il collo.
(Novembre 2017)
tratta dai miei Canti Malinconici.

Arrivai a Barcellona dopo diciotto ore di navigazione. Era già sera. Guidavo per raggiungere il B&B che avevo prenotato e avevo paura.
Avevo paura della sera, del traffico, delle strade, di non riuscire a trovare il posto, di aver dimenticato qualcosa, avevo paura e non sapevo nemmeno di cosa. Era diverso da ogni altro viaggio, l’eccitazione della scoperta e la curiosità del nuovo che mi avevano sempre accompagnato erano sparite, la paura come un gas aveva riempito ogni spazio dentro di me.
Secondo l’annuncio di Air B&B, avevo riservato un monolocale con cucina, bagno, un piccolo terrazzo e parcheggio coperto. Quando arrivai scoprii che l’appartamento aveva in condivisione bagno e cucina con i proprietari, una coppia che dopo cena andava a dormire ancora oggi non so dove, che la terrazza era una grande pozzo luce con intorno alti palazzi e che il parcheggio si trovava a qualche chilometro da Barcellona. Ero infastidita da queste novità non specificate nell’annuncio, così sistemati i bagagli, chiamai Cristian sperando di incontrarlo. Mi diede il benvenuto, s’informò sul viaggio e la mia sistemazione, dopo mi disse che era molto impegnato, aveva una scadenza per un lavoro importante e non poteva permettersi distrazioni, ma prometteva di chiamarmi non appena si fosse liberato.
Mi armai allora di pazienza e nei giorni successivi, iniziai a cercare una casa da affittare. Passata una settimana durante la quale non ero riuscita a vedere nemmeno Assumpta, mi sentivo sola e abbastanza sfiduciata, ma continuavo a ripetermi che quando Cristian sarebbe stato libero, il suo amico hacker mi avrebbe finalmente aiutato, che dovevo solo aspettare, continuare ad avere pazienza.
Dopo la pubblicazione della mia poesia, anche Instagram era diventato poetico, gli account che postavano poesie, versi o commemoravano la nascita, o la morte, di poeti e poetesse famosi si moltiplicavano a dismisura. In alcuni riconobbi Oloferne e iniziai a seguirli. Questi fake account, i suoi post e le continue notifiche sul mio telefono non lasciavano più dubbi sul fatto che l’hacker non era più il fotografo inglese, ma il personaggio famoso. In ogni pubblicazione c’era qualcosa di me, della mia giornata, delle mie parole, di quello che avevo scritto ne La scomparsa.
Nel B&B non mi trovavo bene. La mattina ero spesso svegliata da rumori intimi. La proprietaria, una donna russa trasferitasi in Spagna dopo il matrimonio, aveva una vivace vita sessuale mentre il marito era a lavoro, e mi capitò di trovare uomini in mutante che facevano colazione in terrazza o in accappatoio che uscivano dal bagno, lasciandolo in condizioni tali da non riuscire più a distinguerlo dal bagno di un autogrill. Quasi ogni sera, la coppia invitava amici a cena e occupava la cucina per ore, così avevo preso l’abitudine di cenare in un piccolo ristorante con i tavolini all’aperto vicino al B&B. Una sera, mentre seduta aspettavo che mi servissero, vidi passare Cristian. Non mi sembrò vero. Ero felicissima, lo chiamai, gli corsi dietro ma quando lo raggiunsi e mi riconobbe si mostrò freddo, sembrava imbarazzato. Fu sbrigativo e mi disse che aveva un impegno, era in ritardo, doveva andare, mi avrebbe chiamato l’indomani. Ero confusa. Mi sentivo delusa ma in un qualche modo sentivo di non potermelo permettere. Cristian era il mio unico amico a Barcellona ed era anche l’unico che poteva aiutarmi, sarei stata un’ingrata a giudicarlo o anche solo provando un qualsiasi sentimento negativo nei suoi confronti.
Ritornai al mio tavolo e il cameriere mi disse che avevano portato indietro la mia ordinazione perché me n’ero andata correndo e pensavano che gli avessi fatto un brutto scherzo, così dovetti aspettare un’altra mezzora prima di poter cenare.
Il giorno dopo Cristian non mi chiamò, mi scrisse un messaggio per dirmi che Pablo, il suo amico, era partito e bisognava attendere il suo ritorno. Mi disse anche che non poteva aiutarmi a trovare un alloggio, mi consigliava di rivolgermi ad un’agenzia e che presto ci saremmo visti.

Passò un’altra settimana, durante la quale visitai una media di 2 case al giorno, nessuna andava bene. O erano troppo care o non accettavano animali.
Una sera, ero già sotto le coperte, squillò il telefono. Cristian, con voce allegra e divertita, diceva di trovarsi a Gracia, il quartiere dove mi trovavo e m’invitava a bere qualcosa insieme. Parlava in Catalano, era strano perché anche se con il tempo, ho imparato a capirlo un po’, non lo parlo e con me Cristian aveva sempre parlato in Italiano. Nella mia Lingua risposi che ero già in pigiama ma se mi dava quindici minuti, lo avrei raggiunto. Lui si stupì del fatto che parlassi in Italiano, farfugliò qualcosa mischiando le nostre Lingue e capii che si era accorto di aver sbagliato persona, non voleva chiamare me, così tra la confusione e l’imbarazzo chiuse lasciandomi con il solito ‘Ti chiamo presto’.
Mi alzai dal letto, presi la giacca a vento e con Paco andai in terrazza. Passai la notte lì. Di tanto in tanto, la piccola luce arancione delle mie tante sigarette disturbava il buio, mentre il silenzio era rotto dai catalani che dalle finestre protestavano a suon di tamburi, nacchere e fischi, reclamando l’indipendenza.
All’alba andai a dormire, quando mi svegliai nel pomeriggio, feci i bagagli, lasciai il B&B e andai via da Barcellona. Pensai di allontanarmi solo per qualche giorno, di visitare una città che non conoscevo e impulsivamente scelsi Valencia. La scelsi perché Valiente in Castigliano significa coraggioso/a e Vale significa va bene, perché per arrivarci bisognava andare verso Sud e perché a Valencia c’è il mare.

Il pensiero che Cristian non mi avrebbe aiutato in nessun modo, nemmeno a liberarmi dall’hacker, mi faceva sentire come se stessi soffocando. Era come se d’un tratto i palazzi di Barcellona avessero iniziato ad allungarsi vertiginosamente inghiottendo il cielo e a moltiplicarsi infinitamente imprigionandomi in un pozzo luce piccolo e angusto, senza via di fuga.
Arrivai alle nove di sera dopo tre ore di autostrada, non conoscevo la città e non sapevo dove trascorrere la notte. Entrata in città, mi fermai nel primo parcheggio che incontrai e cercai su internet un albergo. Passai più di un’ora al telefono. Scoprii di essere arrivata il giorno prima del Moto GP, se non ricordo male l’ultimo Moto GP di Valentino Rossi, gli alberghi erano tutti pieni. Mi vedevo già con i cartoni ai finestrini dentro l’auto, a passare la notte sveglia insieme a Paco vigilando in attesa del giorno, quando finalmente ne trovai uno, alla periferia Nord della città, che aveva un’unica stanza libera. Accettavano anche i cani così la presi, senza chiedere altro che l’indirizzo.
La stanza era un attico all’undicesimo piano, aveva un parcheggio interno e anche se costava un accidente, non avevo altra scelta per i successivi due giorni. La vista era mozzafiato, Valencia brillava nella notte tutta davanti a me, era bellissima.
Forse fu per quella visione che iniziai a rilassarmi dopo giorni e giorni di tensione, forse fu la contentezza di aver trovato un rifugio o forse fu un altro delirio di grazia, ma ricordo che in quel momento cercai delle scusanti al comportamento di Cristian. Mi rimproverai di esser stata io troppo impaziente, che lui a pensarci bene, non poteva sapere quanto stressata fossi e quanto bisogno avessi che questo stalkeraggio finisse. Arrivai persino a pensare che fosse stato Oloferne con le sue capacità informatiche, a deviare la chiamata di Cristian sul mio telefono, per farmi sapere che mi stava evitando di proposito e non perché fosse impegnato. Mi accusai di essere stata troppo impulsiva, dissi a me stessa che avrei dovuto fidarmi di Cristian e confidare nel suo aiuto, che prima o poi mi avrebbe scritto o chiamato per mettermi in contatto con Pablo.
Non ho più sentito né rivisto Cristian. Non mi hai mai chiamata. Anche se ho cambiato numero di telefono molte volte da allora, non ha mai cercato di mettersi in contatto con me.
Quella sera, la mia prima sera a Valencia, presi lo smartphone con l’intenzione di scrivergli un messaggio e quando su WhatsApp aprii la nostra chat, apparve una notifica di Instagram. Era una notifica insolita, mai ricevuta prima, che mi segnalava una recentissima pubblicazione di una donna siciliana che seguivo da un paio di mesi. Non so se lavorasse in una libreria o utilizzasse Google, in ogni caso mi piaceva seguirla perché postava la citazione in epigrafe di un libro ogni giorno diverso. Mi stupì la segnalazione, era bizzarro che mi apparisse dato che non avevo impostato le notifiche per quel particolare account, la visualizzai e mi accorsi che insolitamente quel giorno aveva postato ben cinque volte e subito dopo, che ogni post era in relazione con gli altrettanti post di Oloferne.
La mia possibilità di liberarmi dall’hacker era sfumata nell’arco di una notte e un viaggio altrove, lo stesso tempo che Oloferne aveva impiegato per passare alla fase Soap opera del Love Gaming. Non fu un vero e proprio dejà vu perché questa volta la donna pensò di competere attaccando i miei post, questo fu ciò che mi colpì maggiormente.

In questi anni è successo che alcune persone mi invitassero a pensare, come a volermi consolare, che di sicuro non ero l’unica donna che Oloferne spiasse. Non so se sia solo per il fatto di essere una persona poco incline alla consolazione, ma ancora oggi, non riesco a capire come potrebbe essere consolante per me, sapere che un’altra donna sia vittima di stalking online, da parte dello stesso uomo o da parte di qualsiasi altro uomo. Se nel caso in questione la donna soffrisse come soffro io, perché la sua sofferenza dovrebbe consolarmi? In verità mi farebbe stare peggio sapere che ci sia qualcuno che come me, non sa come liberarsi. E se invece, come è accaduto in questi anni, le donne in questione sapendo di essere spiate ne fossero comunque contente, fossero innamorate e felici di vivere un amore di plastica con quel personaggio famoso, perché dovrei sentirmi consolata?
Mi sentirei rammaricata perché in qualche modo la loro scelta rende legittimo l’abuso. E più sola.
Nessun #MeToo questa volta.
Roma 8 marzo 2023 h: 7.27 pm
#LOVEINTblog#stalking online#Barcellona#abuso#potere#resistenza#hacker#amicizia#Love Gaming#trauma#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#speranza#empatia#competizione#loveintblog#privacy#azione
1 note
·
View note
Text
Capitolo 23 – Conquistiamo futuro recuperando il passato

IV.22
Nel cerchio di un anello
Alla ricerca di ricordi
affidati alla memoria
di chi c’era.
Assecondiamo
un movimento circolare,
percezione di una retta
un avanti che se continuo
fa ritorno.
Conquistiamo futuro
recuperando il passato,
architetti del presente
disegnatori specializzati
di memorie interne.
tratta da Canti Malinconici, una raccolta di mie poesie inedita.
Mi trovavo seduta sul lato passeggero, mia sorella stava guidando e scattai dal mio smartphone una foto del sole che stava tramontando su una curva di strada, nel traffico denso del Grande Raccordo Anulare. Qualche giorno dopo postai quella foto su Instagram con la poesia in epigrafe, era ottobre.
Dopo il rientro da Barcellona avevo ripreso a scrivere, a fotografare e avevo continuato a disegnare il mio diario grafico; il mio processo di elaborazione era finalmente iniziato. Sapevo di essere spiata quindi censuravo molto la mia scrittura, non toccavo direttamente il dolore, non lo fronteggiavo come avrei voluto fare e come avrei fatto, se avessi avuto la certezza di essere l’unica a leggere ciò che scrivevo, avevo trovato un modo di nascondermi tra parole e simboli mentre cercavo di maneggiare con cura il buio.
Partii per Roma, m’imbarcai su una nave che partiva da Palermo e dato che in navigazione internet non funziona, mi sentii libera di scrivere e quella notte in nave iniziai un racconto autobiografico che conclusi, qualche giorno dopo, durante la navigazione Civitavecchia - Barcellona.
Avevo da poco letto La scomparsa di George Perec. Il libro è scritto interamente senza mai, dico mai, utilizzare la lettera e; un gioco letterario in cui cela la più grande sparizione del suo libro. Sentivo che qualcosa di me stava scomparendo, mi trovavo a Roma anche perché dovevo ritirare dalla segreteria universitaria i documenti che mi sarebbero serviti, qualora avessi richiesto la convalida dei titoli in Spagna. Avevo detto a tutti che mi trasferivo lì per svolgere la mia professione, ma non lo sentivo vero. Non volevo più fare la psicologa, ero in totale burn out e capivo che non sarei stata in grado di svolgere la mia professione adeguatamente.
Intitolai il mio racconto La scomparsa e per undici capitoli, partendo dall’ultima sera trascorsa a Gela, presi a pretesto ciò che realmente mi accadde durante quei giorni e intrapresi un viaggio nei luoghi della mia memoria, della memoria delle persone che incontravo e di quelle che ritrovavo. Qualcosa di me stava veramente scomparendo ed io volevo fare come le farfalle, quando dopo essersi scrollate di dosso la carcassa del bruco, si allontano e camminando piano piano sulle zampe, si fermano e aspettano pazienti che il vento asciughi le loro ali.

A San Lorenzo, il quartiere dove si trova la Facoltà di Psicologia e la sua segreteria, camminando per via degli Apuli corre lungo un muro dove su uno sfondo color salmone, scorrono le sagome bianche delle donne uccise da uomini che dicevano di amarle. In ogni sagoma bianca c’è scritto il nome della donna, la data del giorno in cui è stata uccisa e chi l’ha uccisa: marito, ex-marito, padre, compagno, ex-compagno, fidanzato, fratello, amico, figlio e dopo, si ripetono uguali, per lo più ex qualcosa.

Il giorno che andai a ritirare i documenti passai davanti a quel muro vedendolo per la prima volta. In uno dei capitoli del mio racconto scrivo:
La segreteria era ancora chiusa ma decisi di aspettare fuori in modo da essere la prima. Dopo poco venne ad aspettare anche un ragazzo e condividemmo, come spesso accade nel mio Paese durante una fila ad un luogo pubblico, la nostra comune insoddisfazione per il modo di lavorare del luogo pubblico in questione, in quel caso la segreteria universitaria, da qui passammo alla critica dell’Università intera fino ad arrivare non so come, a parlare del caso Weinstein. Raccontai di aver letto proprio quella mattina che altre attrici si erano aggiunte alle denunce per molestie sessuali contro il regista, aggiunsi il mio rammarico sul fatto che alcune amiche, donne quindi, condividessero il pensiero di molti, riguardo all’opportunità che queste attrici avessero avuto di fare carriera in questo modo e riflettevo su quanto invece, sia spesso difficile per le vittime denunciare una violenza subita. A quel punto il ragazzo mi rispose:
«Come dice una tua conterranea (si riferisce a Carmen Consoli e cita la frase di una delle sue canzoni più famose) “Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, privarsi dell’anima comporterebbe una lauta ricompensa”, e io la penso come lei, magari adesso si sono pentite di averlo fatto e cavalcano l’onda della giustizia, ma sul momento hanno approfittato dell’opportunità».
A quel punto non parlai più, sembra che sia proprio atavico il pregiudizio che una donna che subisce violenza, in qualche modo ne sia responsabile.
Rileggendolo oggi aggiungerei che radicato è anche il pregiudizio che una donna che subisce violenza possa non averne sofferto così tanto, che sia anzi probabile che dall’esperienza qualcosa abbia persino guadagnato. Un pensiero brutale ma condiviso da molti, da così tanti che sembra quasi comprensibile che un produttore violenti le attrici con cui lavora mentre ci lavora, come brutalmente normale -tanto da essere legge- era considerato durante il secolo scorso, il matrimonio riparatore.
Rileggendo oggi quello che scrissi allora, mi fa ancora orrore ma non mi sorprende più se un ragazzo di vent’anni, un giovane studente di Psicologia, che si reca ogni giorno in Facoltà per seguire le sue lezioni, passando accanto a quel muro resta indifferente mentre gli scorre a fianco la sfilata della violenza. Non mi sorprende nemmeno quando ascolto notizie di cronaca su personaggi famosi, o come sempre più spesso accade su figli di uomini famosi, accusati di violenza sessuale nei confronti di donne e adolescenti. Adesso so che la fama talvolta può essere una maschera di carnevale, indossata la quale tutto è lecito. Non mi sorprende più ma continua a farmi orrore.

I Canti Malinconici e La scomparsa sono stati scritti per me, non per essere pubblicati o letti da chiunque. I Canti li ha letti soltanto un amico, che a sua volta mi ha permesso di leggere il suo romanzo mai pubblicato. L’unica persona che ha letto La scomparsa è Giò, a cui è dedicato un intero capitolo. Lei è l’unica persona che ha letto tutti i miei racconti, anche quelli più intimi. Mi piacevano sia le sue critiche che i suoi apprezzamenti, anche quando le sue riflessioni su ciò che esprimevo, o su come lo esprimevo, mi disturbavano un po’ mi spingevano ad andare oltre, ad esprimermi ancora e meglio di prima, ma soprattutto mi fidavo di lei e di come avrebbe usato il suo sguardo sulla mia intimità.

Non ci vedevamo da anni, ci rincontrammo a San Lorenzo lo stesso giorno che ritirai i documenti in segreteria, all’ora di pranzo avevamo appuntamento davanti l'entrata dell'Università. Lei fu la prima a cui confessai l’identità del personaggio famoso e dato che già lo seguiva su Instagram si accorse, nei mesi seguenti, delle risonanze tra quello che scrivevo io e ciò che lui pubblicava sul social.
Così scrivevo del nostro incontro e di quando le raccontai quello che mi stava accadendo
...Dell’amicizia però, il senso più nobile è la fiducia. Ecco perché è una forma d’amore. L’amico vero ti conosce, è quello che quando tutto il modo ti dà del matto, sa che sta accadendo qualcosa di grosso, che magari non capisce ma non dubita mai, nemmeno per un secondo, che tu sia impazzito.
...Giò sapeva e non dubitava della mia salute mentale, anche se capii che era in apprensione per la mia salute psichica. Con lei non fu difficile raccontare della storia virtuale, non fu difficile neanche confessarle quando la storia d’amore nel web aveva iniziato a tingersi di giallo e a diventare una storia di spionaggio, delazioni e delatori. Per la prima volta, riuscii ad esprimere il senso d’impotenza in cui mi aveva gettato l’essere vittima di un hacker che era in grado di fare qualsiasi cosa con il mio smartphone e con il mio iPad. Ascoltarmi, osservarmi, leggere i miei contenuti, i miei messaggi, i documenti, qualsiasi cosa, come se i miei supporti tecnologici fossero i suoi. Avere accesso completo a ogni sfera della mia privacy. Riuscii finalmente ad esprimere come il non avere i mezzi per poter porre fine a questo abuso, mi facesse sentire debole e sfiduciata, completamente impotente.

E poco dopo
“Cosa ti piaceva di lui?” Giò ha chiesto a un certo punto.
Cosa mi piaceva. Mi piaceva quello che diceva, come lo diceva. Mi piacevano le cose a cui dava importanza. Mi piaceva la sua azione sociale, condividevo quello contro cui lottava…
…Non ho l’animo della fan per i personaggi pubblici. Anche gli Stati con ancora i regni monarchici mi fanno uno strano effetto, così assurdo, quasi surreale.
..Dico questo per dire, che penso si possa apprezzare l’opera di qualcuno, di un personaggio pubblico noto, come non so uno scrittore, un artista o un politico per esempio, senza per questo innamorarsi o desiderare di avere una relazione più intima con lui o con lei. Il sentimento del fan penso, include questa speranza, come include una quasi morbosa curiosità per i dettagli della vita personale e privata di questo personaggio noto. Io non sento questo desidero per nessuno dei personaggi che ammiro, e non lo sentivo neanche nei suoi confronti, mi piaceva e lo ammiravo, e stimavo la sua capacità di vivere in una situazione particolarmente difficile come era quella in cui viveva lui.
(..ho iniziato)A sentire oltre le sue parole, a sentirmi chiamata dalle sue parole e a sentire una profonda empatia per lui. Ho iniziato a vedere quello che non mostrava, quello che tra parole, punteggiatura ed immagini restava un silenziosissimo urlo.

La corsa in auto con mia sorella finì in un locale di San Lorenzo, quello dove pranzai con i miei amici e la mia famiglia per festeggiare il giorno che discussi la tesi. Quella sera incontrai due compagne di studio che avevo perso di vista quando mi trasferii in Sicilia. C’eravamo tutte e tre laureate con una tesi in psicofisiologia con il prof. Vezio Ruggieri. Era stato il nostro maestro. Molto di quello applico nel mio lavoro me lo ha insegnato lui; ancora oggi utilizzo molti dei principi del Modello Psicofisiologico Integrato da lui creato per i miei interventi. In uno dei capitoli del mio racconto parlo dell’importanza che il prof. Ruggieri ha avuto nella mia formazione di psicologa, racconto dei seminari di teatroterapia e di musicoterapia che seguii con lui per tre anni, della mia partecipazione al montaggio e alle riprese del film che stava realizzando sulla filosofa Ipazia, di come le sue lezioni e il suo modo di osservare abbiano profondamente influenzato la mia maniera di intendere la psicologia e l’essere umano.
La scomparsa è un testo nel quale riannodo le fila di un lungo percorso di vita in un momento di totale frammentazione. Sto lasciando il mio Paese, ho quarant’anni e guardo indietro vedendo gli anni della mia gioventù, passo al setaccio i progetti che avevo e i sogni che mi spingevano a realizzarli per capire cosa ne è rimasto. Recupero pezzi di me recuperando amicizie lontane nel tempo, riscopro cosa hanno significato per custodire con più cura quello che mi hanno trasmesso. Rivedo i momenti in cui le mie scelte hanno deviato un corso che poteva andare altrimenti, riconosco i passi che mi hanno portato a diventare quello che mi scopro essere diventata.
Se oggi pubblico parti di questi scritti personali non è soltanto perché mi aiutano a ricordare, a raccontare e a trovare un senso, ma perché come ho detto all’inizio di questo blog, tutto ciò che pubblicherò qui, è tutto ciò che lo stalker ha visto spiandomi, ha preso e ha utilizzato per le sue pubblicazioni. Almeno quelle di cui mi sono accorta. Se ce ne siano di più di quelle che riporto non lo so, e confesso che sono anche contenta di non saperlo. Nel 2020 lo stalker ha pubblicato un saggio molto più corposo dei mie 11 capitoli, in cui scrive a se stesso ripercorrendo i luoghi e i personaggi, attraverso i loro libri, che sono stati utili alla sua formazione. Tra questi la filosofa Ipazia che, in un video di presentazione del suo libro arrivatomi in notifica sul mio smartphone, dice di amare letteralmente non soltanto metaforicamente. Non ho letto il libro, quello che so è quello che mi ha sbattuto in faccia con le sue notifiche e con i suoi post fino a quando l'ho seguito. Quello che ho visto è bastato a farmi riconoscere ciò che era mio, ciò che apparteneva alla mia vita.

In un certo senso la psicologa che ero nel tempo in cui scrivevo La scomparsa non c’è più, ce ne una diversa, una che conosciuto il trauma e lo stress traumatico non solo come professionista, come studiosa e per interposta persona, ma anche come vittima. O come sto cercando di fare, come protagonista. Alla maniera di Yayoi Kusama provo a riappropriarmi delle mie paure, dei miei dolori, delle mie ferite, le mostro e me ne libero, lasciandole qui libere di vagare nella rete.
Roma 26 febbraio 2023 h: 5.25pm – 27 febbraio 2023 h:5.05pm
#LOVEINTblog#stalking online#Yayoi Kusama#abuso#potere#resistenza#hacker#amicizia#maschere#trauma#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#speranza#empatia#loveintblog#privacy#azione
2 notes
·
View notes
Text
Capitolo 22 - Quella cosa alata

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.
Luigi Pirandello
Dalla mia tana uscii quando la mia amica Mariangela venne a prendermi, una notte d’inizio settembre, e mi portò alla Valle dei Templi di Agrigento, per ascoltare un concerto che si teneva all’alba. Era un concerto per archi, non ricordo cosa suonassero, ma ricordo bene il momento in cui il sole si levò alzandosi tra le colonne del Tempio di Apollo alle spalle del quartetto, in pochi secondi una luce rosata aveva falciato ogni ombra.
Dopo il concerto visitammo la casa di Pirandello, che si trova non molto lontano dalla Valle dei Templi. Nel modesto giardino della casa c’è un bellissimo pino secolare che entrambe ammirammo per molto più tempo di quello trascorso a visitare la casa dello scrittore. Sul suo tronco, gocce gonfie di resina brillavano alla luce già piena del giorno come lucciole nella notte.
Ritornata a casa che era ancora mattina, mi sentivo bene come non mi accadeva da tempo. La mia cara amica era riuscita a tirarmi fuori da quel senso d’immobilità impotente in cui si cade quando si perde la speranza. Mi aveva preso per mano e senza dire parole, mi aveva ricordato quanta bellezza ci fosse fuori nel mondo, quanto facile fosse raggiungerla, quanto valesse la fatica di una notte insonne per goderne. La sua empatia, la sua attenzione e la sua delicatezza mi avevano curato. Il suo volermi bene mi aveva restituito quel sano senso di fiducia nella vita così pesantemente rovinato dalle esperienze degli ultimi anni. Riuscivo adesso a sperare di nuovo e capivo che il mio isolamento doveva finire, non era più tempo di silenzio e solitudine, avevo più che mai bisogno di avere vicino i miei affetti e i miei amici.

Acquistai un biglietto per Barcellona e andai a trovare due amici di vecchia data che vivevano lì, Cristian e Asumpta. Avevo conosciuto Cristian quando vivevo a Roma ai tempi dell’Università, lui era uno studente di Filosofia in Erasmus e io stavo completando la stesura della mia tesi in vista della laurea. C’incontrammo a una festa e dopo a poco diventammo amici, ci univa il comune interesse per l’arte, la poesia e la filosofia. Passavamo le notti facendo lunghe passeggiate a piedi o con la mia vespa per Roma e nonostante parlassimo due Lingue diverse ci comprendevamo perfettamente, forse anche per via del motto che Cristian scelse per intitolare le nostre serate: “Un vaso y la vìa!”
Cristian venne varie volte a visitarmi in Sicilia, conobbe la mia famiglia e i miei amici, che diventarono anche i suoi amici. Andai spesso a Barcellona a trovarlo e conobbi anche io la sua famiglia e i suoi amici, Asumpta fu una tra questi. Lei e Cristian si conoscono da quando erano bambini e non ci volle molto perché Asumpta si unisse a noi durante le nostre discussioni passeggiate, che con la sua fresca eleganza rinominò: “Una copa de tinto y vìa!”.
Negli anni avevo seguito i vari traslochi di Cristian, i suoi cambi di lavoro, lui i miei. Asumpta era diventata una creatrice di gioielli e madre di due splendide bambine, che finalmente avrei conosciuto di persona, dopo averle viste soltanto in foto.
La sera che arrivai a Barcellona, andai a cena con Cristian e lasciai il mio telefono in albergo. Tra le tante cose di cui parlammo durante la cena, gli dissi che avevo da poco letto un libro di Oloferne, era uno dei suoi libri meno recenti e un’amica, non saprei dire quando, me lo aveva regalato ma l’avevo tenuto fino ad allora, nella mia pila di libri da 'leggere un giorno'. Era un libro d’inchiesta sulla produzione e la distribuzione della droga e i dati che condivideva sul guadagno annuo dei trafficanti, mi avevano colpito così tanto che ne parlai con il mio amico.
Dopo aver acquistato online il mio biglietto aereo, avevo anche comunicato il mio arrivo per email e per WhatsApp ai miei amici. Qualche giorno dopo, Oloferne pubblicizzò sul suo account Instagram un suo prossimo viaggio a Barcellona per presentare il suo ultimo libro. Quando lo lessi, ricordo bene che fui contenta del fatto che i giorni coincidessero e che avrei potuto andare alla presentazione e incontrarlo di persona. Quella sera lo dissi a Cristian, conosceva la biblioteca dove avrebbe avuto luogo la presentazione e propose di accompagnarmi. Disse anche, salutandomi nella hall dell’albergo, che un suo amico una specie di genio informatico, mi avrebbe aiutato a liberarmi dell’hacker.
Non credevo a quello che avevo appena sentito. Salii in camera volando, finalmente qualcosa stava cambiando, vedevo di nuovo delle possibilità. Mi riconobbi il merito di aver continuato a sperare e mi convinsi che una volontà provvidenziale mi aveva spinta a intraprendere questo viaggio.
Ero quasi così felice che mi sarei messa a ballare e cantare come non so chi né come. Non amo molto i musical quindi ne conosco pochi e mi viene in mente soltanto la scena del film Dancer in the dark di Lars Von Trier in cui Bjork, che interpreta una povera donna, un’operaia che sta perdendo la vista, canta Cvalda tra i macchinari della fabbrica nella quale lavora.
Più o meno sarebbe stata così l’atmosfera della mia felicità, infatti una volta in camera quando ripresi il mio telefono e tolsi la modalità aereo, per la prima volta salì una notifica con un video musicale suggerita da Youtube. Non era mai successo. Il video era una canzone di un film animato interamente prodotto in Italia, il titolo era: A chi appartieni?. Pensai subito che fosse opera di Oloferne anche se non potevo esserne sicura, era la prima volta che usava questo modo per comunicare con me, mi sembrò uno modo impacciato ma tenero di comunicarmi la sua gelosia. Guardai il video e mi piacque, per cui non diedi importanza alla cosa, pensando che presto nessuno avrebbe più avuto il controllo del mio telefono.
Quello che successe dopo fu che lo stalker iniziò a tempestare il mio telefono di notifiche di Youtube. Canzoni d’amore, poesie d’amore, video con suoi interventi a festival o a trasmissioni televisive, cartoni animati e quanto altro servisse a comunicare con me, o come da intenzione da lui dichiarata, con quanto servisse a manifestarmi il suo amore.
Il pomeriggio della presentazione, Cristian fu bloccato da un contrattempo di lavoro e io andai da sola. L’ospite preferì parlare in Italiano data la maggiore presenza di italiani in platea, in quel momento non pensai nemmeno per un attimo che fosse a conoscenza del fatto che mi trovassi tra il pubblico e per nessuna delle cose che disse pensai che si stesse rivolgendo a me. Nonostante non fosse proprio pertinente con la presentazione del suo romanzo, Oloferne parlò del libro d’inchiesta che avevo letto di recente e citò proprio l’importanza dei dati che mi avevano colpito e di cui avevo discusso con Cristian, la sera che ero arrivata a Barcellona. Mi colpì piacevolmente, la presi per una coincidenza, non sospettai nulla, anzi mi sembrò la conferma di una corrispondenza di amorosi ideali tra di noi.
Alla fine dell’incontro si fermò per autografare le copie vendute. Ne presi solo una in Catalano per regalarla a Cristian dato che non era riuscito a partecipare, mi misi in fila pensando a cosa gli avrei detto quando mi sarei trovata faccia a faccia con lui. Non mi aspettavo chissà cosa, ma di sicuro non mi aspettavo niente di quello che accadde. Lui fece finta di nulla e ridendo mi chiese se fossi catalana, io risposi dicendo che il libro era per Cristian, un amico che non aveva potuto esserci. Prese la copia e scrisse: A Cristian, un abbraccio. Ci salutammo con una stretta di mano e mentre scendevo dal palco mi accorsi che stavo tremando.
Tremavo non come succede quando ci s’innamora e sembra che le gambe cederanno da un momento all’altro, tremavo di paura e non trovandone la ragione scambiai il tremore per emozione.
Il giorno dopo, Instagram postò la foto di una ragazza spagnola che indossava una salopette di jeans con una maglia rosa che faceva non so cosa, mi colpì il fatto che fosse vestita esattamente come ero vestita il giorno della presentazione. Oloferne sul suo account, postò una foto di lui sul palco di Barcellona con gli organizzatori, ringraziava del calore ricevuto in particolar modo dal pubblico italiano presente, che abbracciava forte.
Passai gli ultimi giorni del viaggio a casa di Cristian, libero dal lavoro per il fine settima. In quel momento parlò con il suo amico e io lo ascoltai in vivavoce mentre spiegava a Cristian che ogni mio sospetto era assolutamente fondato. Disse che era possibile hackerare non soltanto pc, notebook, IPad che come ogni supporto Apple aveva la fama di essere inattaccabile, ma anche moltissimi elettrodomestici tra quelli che chiunque teneva in casa, un frullatore, una radio, e che potevano contenere al loro interno, microfoni e telecamere che potevano essere attivate da remoto per spiarci, vederci o ascoltare senza che si abbia la possibilità di accorgersene. Ci spiegò che attraverso la mia rete di contatti, lo stalker poteva spiarmi anche quando non avevo il telefono con me, hackerando quello dei miei familiari, dei miei amici e di tutti i miei contatti in rubrica. Ci disse che poteva sfruttare la posizione sul mio telefono, per sapere in ogni momento dove mi trovassi. Per aiutarmi però, aveva bisogno dei miei supporti che non avevo portato con me. Rimanemmo d’accordo che a ottobre quando sarei ritornata, ci saremmo visti e gli avrei consegnato tutto: usb, hard-disk portatili, notebook, IPad e anche la mia macchina fotografica.
Alla fine della telefonata tremai di nuovo. Cristian mi chiese perché, secondo me, quest’uomo stava facendo tutto questo. Risposi che anche io non riuscivo a capirlo.
Rivedere i miei amici mi fece molto bene. Pensai che trasferendomi lì per qualche tempo sarei stata meglio. Avrei seguito un corso, o semplicemente avrei imparato il Castigliano, o magari il Catalano. La Spagna mi sembrava accogliente, ordinata, pulita, colorata e allegra, inoltre non sarei stata sola, c’era Asumpta e c’era Cristian che m’incoraggiò a prendere questa decisione, mi offrì il suo aiuto e mi disse: “Sarò per te quello che tu sei stata per me quando arrivai a Roma, quando non parlavano Italiano, non conoscevo la città e non avevo amici!”.

Tornai in Sicilia per predisporre il mio trasferimento in Spagna, una nuova energia mi animava era quella cosa alata, la speranza, che mi muoveva.
Roma 19 febbraio 2023 h: 2.47 pm
#LOVEINTblog#stalking online#Luigi Pirandello#abuso#potere#resistenza#hacker#amicizia#maschere#trauma#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#speranza#empatia#loveintblog#privacy#azione
0 notes
Text
Capitolo 21 – Di segni e di dolori

Era tempo di silenzio e di solitudine, mi limitai a starci dentro immobile, come un divano nel soggiorno di un appartamento. Era tempo di lutto.
Dopo la morte di mio padre passai un mese chiusa in casa, uscivo con Paco per le sue passeggiate di servizio e per fare la spesa. Mia madre era partita con mia sorella e dopo la frenesia degli ultimi mesi, avevo per la prima volta un tempo tutto per me. Dormivo molto, leggevo tanto, scrivevo meno di quanto avrei voluto perché sapevo, già allora, che sui miei supporti c’erano sia il fotografo che il personaggio famoso e non riuscivo più a scrivere senza considerare la loro presenza.
Probabilmente ancora preda di un delirio di grazia, consideravo l’hackeraggio dei mie supporti da parte del personaggio famoso come un’azione necessaria per aiutarmi contro l’hackeraggio del fotografo, così continuai a comunicare con questo come avevo fatto in passato con l’altro, senza inviare nulla, senza postare niente, solo scrivendo sul mio IPad.
Ma era il tempo del lutto ed io avevo bisogno, proprio per attraversare quel momento, di ascoltarmi, di ascoltare il mio discorso interiore, di poterlo esprimere, di dargli forma, di viverlo, avevo bisogno di poterlo affrontare come avevo imparato a fare in quarant’anni vissuti, avevo bisogno di farlo con i miei abituali strumenti, quelli che mi avevano permesso di trarre un senso utile, o buono, dalle esperienze di perdita e di dolore che avevo vissuto fino ad allora, gli stessi strumenti che mi avevano permesso di andare avanti, di sopravvivere e superare i momenti più difficili. Avevo bisogno di scrivere; e di piangere anche.
Applicai però una ferrea censura ad entrambi i comportamenti perché ancora oggi, non sopporto l’idea di mostrare il mio dolore a chi mi spia senza nessuna pietà, senza compassione. Vi auguro di non trovarvi mai in circostanze che vi permettano di conoscere la sconvolgente sensazione che si prova quando qualcuno vi guarda mentre state soffrendo e non fa niente, assolutamente niente, anzi continua solo a guardare.
Il pianto è un’azione fondamentale che il corpo attua per liberarsi dal dolore, per sciogliere una tensione troppo alta o troppo a lungo accumulata, e questo è vero sia in senso psichico che somatico, è necessario piangere ciò che dev’essere pianto, per dare un sano corso all’evolversi dei tempi del lutto e giungere alla sua conclusione. Inoltre, il pianto è la prima forma di comunicazione che utilizziamo per chiedere aiuto, quando il neonato piange la madre accorre; il pianto ha quindi una fondamentale funzione di sopravvivenza per l’essere umano sin dal suo primo respiro. Il mio invece era uno di quei casi in cui, per sopravvivere non si doveva piangere né mostrare quanto deboli si fosse.
Quando da una serie di post e notifiche, alcuni dei quali pubblicizzavano lingerie con foto di modelle che indossavano biancheria intima della stessa marca, stesso modello e colore di quella che indossavo io quel preciso giorno, con una coincidenza del 100% per ogni notifica, iniziai a sospettare di essere vista anche in bagno e in camera da letto. Fu durante quei giorni di agosto che iniziai, senza mai smettere, a spogliarmi, a vestirmi e a fare la doccia completamente al buio. In quegli stessi giorni il pianto si bloccò. Ogni volta che piangendo pensavo che qualcuno, che nemmeno conoscevo, in quel preciso momento mi stesse guardando, smettevo di piangere improvvisamente, le lacrime si congelavano e il dolore si rintanava silenzioso in qualche posto tra il diaframma e il cuore.
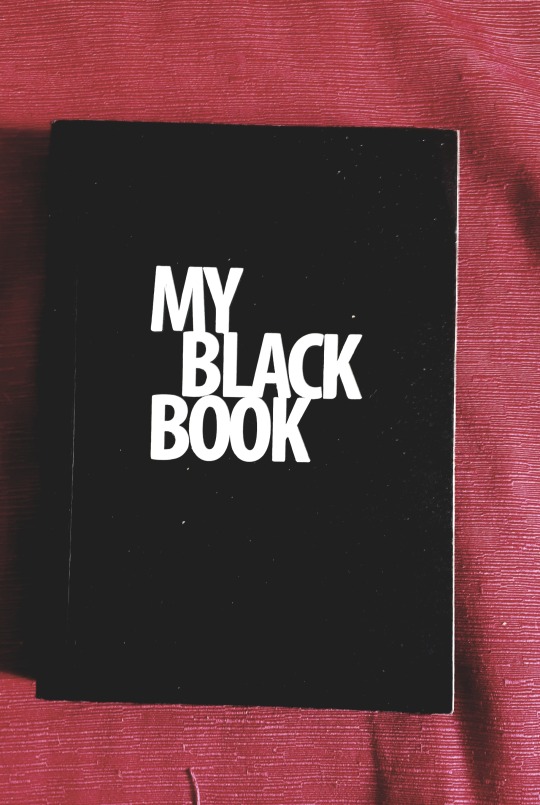
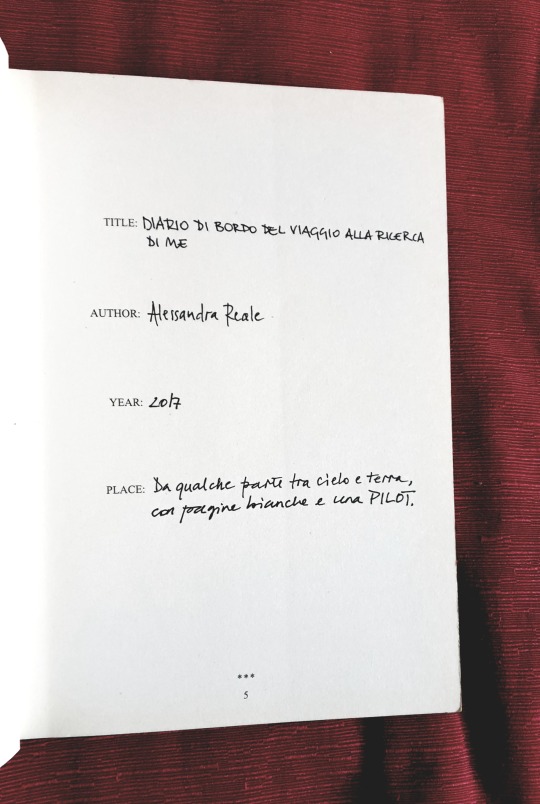
Pensai allora che con penna e fogli di carta sarei stata al sicuro dagli sguardi indesiderati degli hacker, il disegno insieme alla scrittura e alla fotografia era uno degli strumenti che avevo per fare ordine dentro di me o per modellare ingorghi emotivi troppo ingarbugliati. Inaugurai il mio Black Book intitolandolo Diario di bordo del viaggio alla ricerca di me, iniziai un diario grafico di modo che le linee d’inchiostro piangessero al posto mio.

Ero a pezzi, stavo esprimendo questo. Lo stavo facendo in un modo che era solo per me, serviva solo a me, non lo stavo facendo pensando che un giorno l’avrei pubblicato o condiviso con altri chiunque fossero questi altri, amici o sconosciuti sui social, era solo il mio privatissimo modo di vivere il dolore, era la mia arteterapia senza terapista e senza nemmeno la pretesa di fare arte.
Di recente ho letto Infinity Net l’autobiografia di Yayoi Kusama, l’artista giapponese conosciuta in tutto il mondo per le sue zucche giganti, per i suoi pois, per le sue stanze fatte di specchi che ripetono all’inifnito l’immagine dei visitatori dentro e per i suoi scioccanti happening degli anni Sessanta.
Kusama è una delle mie artiste preferite, della sua opera e della sua autobiografia tornerò a parlare, adesso voglio solo riportare un breve passo nel quale l’artista spiega cosa significhi per lei fare arte, cosa significhi la sua arte
“In genere gli artisti non esprimono in modo diretto i loro complessi, mentre io li scelgo come temi delle mie opere, insieme alle mie paure.
[…]Lavoro, lavoro e ancora lavoro finché non resto seppellita nel processo. È ciò che chiamo obliterazione.
Per esempio applicando pois su tutto il mio corpo e poi ricoprendo di pois anche lo sfondo mi annullo (self-obliteration). Oppure applico i pois su un cavallo e sullo sfondo, in modo che la sagoma dell’animale scompaia assimilata dai pois. la massa del cavallo è assorbita da un’entità infinita. E quando accade io stessa mi sento cancellata.”
Creare delle sculture rappresentando gli oggetti delle sue paure, creare ossessivamente ripetendo questi oggetti in grandezze diverse, con materiali diversi in differenti colori, riempire spazi enormi fino a farli straripare di queste sculture, lasciarsi inghiottire, insieme a questi, da una rete infinita di puntini o perdersi nel riflesso di infinite immagini, è ciò che Yayoi Kusama definisce Arte psicosomatica con la quale, mediante l’obliterazione dell’artista nell’opera, attraverso il suo confondersi e fondersi in essa, l’artista trova sollievo e cura, annullandosi nelle sue paure le annulla, la creazione diviene un movimento continuo in una rete che collega ogni cosa, senza fine né principio, una rete infinita.
Dopo gli anni americani durante i quali è diventata l’artista internazionale che è oggi, è ritornata in Giappone. Per propria scelta vive in un ospedale psichiatrico dal quale si allontana ogni giorno, solo per raggiungere il suo studio dove ancora lavora e crea. Nella sua autobiografia narra di come con la sua arte psicosomatica abbia potuto mettere in scena i suoi più orrendi incubi, dare forma alle immagini dei suoi più terrificanti deliri e alle sue fobie, come nell’arte abbia saputo trovare una via di fuga e di salvezza dai ripetuti esaurimenti nervosi e dalle devastanti esperienze di depersonalizzazione che vive sin da quando era bambina.
Yayoi Kusama è sempre stata un’artista ben consapevole del suo ruolo e del messaggio che intende trasmettere con la sua opera artistica. È una rivoluzionaria che ha usato la sua creatività per criticare valori sociali e morali oppressivi, ha usato le sue sculture giganti e ossessive per farci sentire sommersi dai complessi di una società che accumula, mercifica, ripete all’infinito. La sua arte, sin dall’inizio, non voleva essere solo una cura per lei stessa, ma per il mondo intero. Kusama voleva mostrarla e condividerla con tutti e questo come lei stessa dice, è ciò che le permette di vivere come vuole nascosta tra segreti e simboli sotto gli occhi di tutti.
Kusama mi fa pensare ad un’altra artista, una eccezionale che non si studia al Liceo, Artemisia Gentileschi perché anche questa pittrice ha dipinto per tre volte lo stesso soggetto, l’episodio biblico di Giuditta che decapita Oloferne e in qualche modo anche questa ripetitività mi fa pensare che il tema avesse a che fare con l’elaborazione, da parte dell’artista, di una dolorosa esperienza personale riprodotta segretamente trasfigurata e nascosta tra simboli.

Vi sarete accorti che a differenza di queste grandi artiste, il mio modo di scarabocchiare è abbastanza lontano dall’arte, il mio tratto è naïve, è fatto solo per essere visto da me. Disegnando non volevo rivoluzionare l’arte del fumetto o del racconto grafico, non volevo condividere un significato profondo al quale ero approdata per aiutare chi avrebbe potuto trovarsi nella mia stessa situazione, volevo solo tirare fuori quel momento così difficile senza parlare, volevo lasciare una macchia, una traccia per me stessa, per quando sarei stata pronta a nominare ciò che in quel momento era impronunciabile, per quando avrei potuto guardare quelle linee, seguirle e sorridere del segno che aveva seguito il dolore per scomparire. Non volevo in alcun modo che il mio diario fosse visibile a nessuno e men che mai ad uno sconosciuto.
Ancora oggi, dopo aver avuto la conferma che anche il mio Black Book, scritto a penna stando seduta ogni volta in una delle diverse stanze in cui ho vissuto tra Gela e Roma, passando per Valencia, è stato visto e i suoi contenuti sono stati usati e pubblicati, come fossero contenuti della vita di questo personaggio famoso, di questo stalker, che da ora in poi con licenza poetica chiamerò Oloferne, non ho mai mostrato a nessuno il mio diario grafico, né interamente né in parte.
Pubblico qui solo questo disegno con il quale accompagno questo capitolo, perché nel 2021 Oloferne, dopo aver scritto e pubblicato per anni principalmente libri d’inchiesta, saggi e forse un romanzo, improvvisamente esce con una graphic novel scritta da lui e disegnata da un fumettista professionista, nella quale racconta un momento particolarmente difficile della sua vita, che poi è quello che lo ha portato al successo. Ho saputo di questa pubblicazione non perché segua le notizie che riguardino l’attività di Oloferne, ho smesso di farlo proprio dopo per questa sua ultima pubblicazione. Non ho letto la novel, né ho intenzione di farlo, ormai mi sento male ogni volta che ritrovo un po’ di me nelle sue pubblicazioni, ne sono venuta a conoscenza perché un giorno, se non sbaglio era ottobre, ho ricevuto una notifica sul mio smartphone, era un articolo dedicato all’uscita del fumetto e che pubblicizzava la sua presentazione con la presenza dell’autore, a Roma quello stesso giorno. L’articolo era accompagnato dalle foto di due disegni del fumetto, uno di questi era una tavola dai toni grigi dove il corpo del personaggio famoso era in mille pezzi, tranne la sua testa che giaceva in terra con gli altri frammenti, integra e con la sua faccia ben riconoscibile.
Non ricevetti la notifica per caso, non fu una scelta infelice dell’algoritmo, fu proprio lo stalker a volermela mostrare perché sapeva che avrei riconosciuto nel disegno qualcosa che apparteneva a me. L’anteprima della notifica mostrava infatti il titolo dell’articolo, la foto dello stalker e delle due immagini che si potevano vedere scorrendo la lettura dell’articolo, solo quella in cui si rappresentava a pezzi era visibile. E aveva ragione, perché vedere quel disegno, riconoscervi qualcosa di mio, fu ciò che mi portò a leggere l’articolo interamente.
Dopo essermi interrogata a lungo sul perché questo stalker si ostinasse a spiarmi in maniera così ossessiva e abusiva, mi sembrava finalmente di aver capito quale fosse lo scopo, il movente, il suo bisogno impellente.
Roma 13 febbraio 2023 h: 1.45 pm
#LOVEINTblog#stalking online#abuso#potere#resistenza#Yayoi Kusama#trauma#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#hacker#loveintblog#privacy
0 notes
Text

“La perdita della sensazione di essere ancora in qualche modo un soggetto umano si basa sul fatto che, nel campo di concentramento, l’uomo non solo sperimenta in modo totale di essere un oggetto all’arbitrio delle guardie, ma sa anche di essere un oggetto del destino, una sua palla da gioco. Avevo sempre pensato e detto che l’uomo generalmente sa cinque o dieci anni dopo a cosa è servito un evento della sua vita. Già ad Auschwitz mi forgiai un principio che doveva presto mostrarsi “giusto” e che più tardi i miei compagni presero a cuore. Quando mi chiedevano qualcosa, rispondevo in genere secondo verità”
Viktor E. Frankl, L’uomo in cerca di senso
A differenza di altre cose che ho scritto in passato, i capitoli di questo blog procedono molto lentamente, non soltanto perché la comprensione di un evento abnorme chiede tempo, ma perché ricordare per raccontare mi costa moltissimo.
Ricordare gli ultimi cinque anni della mia vita per raccontare un evento, che esattamente come per i sopravvissuti ad Auschwitz, è servito alla mia vita come il terremoto è servito alla Siria o alla Turchia, è estremamente difficile per me. M’impone di rievocare momenti della mia vita che preferirei considerare solo i brutti ricordi di qualcosa che è finito per sempre, ma così non è; quando guardo indietro, quello che vedo è un tempo congelato, dove ogni tentativo di liberarmi da questo incubo porta a un nuovo fallimento, a informazioni ancora più inquietanti, allo stesso sentimento d’impotenza.
Viktor Frankl racconta che in principio avrebbe voluto pubblicare il suo testo Uno psicologo nei lager senza utilizzare il suo nome, ma firmandolo solo con il suo numero 119.104, in questo modo intendeva dare rilevanza al suo proposito di riportare la sua esperienza, non come qualcosa di personale o come un resoconto scientifico di chi osserva e studia, ma come il vissuto di sofferenza delle “piccole” vittime e della “piccola” morte di una grande massa, alla quale lui stesso appartiene, solo come uno tra tanti, piccolo e di poco conto.
La verità è che per raccontare il dolore lo si deve comprendere, ma come si fa a comprendere l’orrore di una violenza da parte dei propri simili che non ha giustificazione né senso?
Per farlo bisogna mettere una distanza, una lunga distanza di tempo o di sentimento e prima di farlo, è necessario passare attraverso quella che Frankl definisce la svalorizzazione dell’io: la perdita della sensazione di essere ancora in qualche modo un soggetto umano, di essere io, con un nome e una storia, con un passato e un futuro dinnanzi, con relazioni familiari e una comunità alla quale si sente di appartenere.
Quanto inenarrabile sia l’orrore e quanta destrutturazione dell’io sia necessaria per dare forma agli eventi accaduti è magistralmente mostrato ne Il paese delle prugne verdi di Herta Müller, la scrittrice fu perseguitata dalla polizia segreta del regime di Ceaușescu, riuscendo a fuggire dalla Romania nel 1987 ed emigrando in Germania. In questo suo bellissimo libro gli oggetti e l’ambientazione prendono vita, si animano a volte di una volontà che sovrasta la protagonista alienandola completamente da sé stessa.
Quanta alienazione da sé stessi e distanza dai propri ricordi siano necessarie per sopravvivere al dolore è invece testimoniato da un’altra sopravvissuta ad Auschwitz, la dr. Edith E. Eger che ne La scelta di Edith racconta come le siano serviti più di quarant’anni, durante i quali ha dovuto convivere con flashback improvvisi e invalidanti attacchi di panico, prima di poter elaborare l’esperienza vissuta e darvi un senso. La sua scelta è stata proprio quella di cercare e trovare, attraverso la narrazione, un significato alla terribile esperienza vissuta, per non rimanere prigioniera con la mente ancora in quel campo di concentramento, perché quel “sopravvissuta”, participio passato di una brusca svolta nel suo cammino, prendesse il giusto posto nella narrazione, andandosi a collocare come soltanto uno dei capitoli, uno tra quelli più lontani dalla fine del libro della sua vita.

Sono passati pochi giorni dalla celebrazione della Giornata della Memoria e quel pomeriggio stavo ascoltando Fahrenheit un programma radiofonico di Rai 3. Il conduttore stava intervistando Rezak Hukanovic autore di un romanzo autobiografico sulla deportazione nei campi di concentramento bosniaci. Anche lui affermava di aver avuto bisogno di raccontare la sua testimonianza in terza persona, il protagonista del suo romanzo è lui stesso ma tra l’autore e il personaggio c’è distanza, c’è una terza persona tra chi ha vissuto gli eventi e chi li racconta, c’è il dolore tra di loro. Quando il conduttore gli chiede come si può dare senso al fatto che, un giorno così all’improvviso, i tuoi vicini di casa o i tuoi colleghi di lavoro ti stanno puntando un fucile contro la nuca o stanno sparando a un tuo amico, Rezak Hukanovic risponde che l’unica cosa a cui pensa adesso è di sentirsi fiero di poter camminare a testa alta, di essere rimasto sé stesso nonostante l’orrore vissuto, di non aver perduto la sua dignità e la capacità di opporsi al male e all’ingiustizia.
Quando a Primo Levi fu posta la stessa domanda rispose “non li odio, ma non posso perdonarli”. Nelle testimonianze di Viktor Frankl, di Edith Eger, come di altri sopravvissuti ad atroci esperienze di violenza, ritorna sempre questo dignitoso rispetto per sé stessi, per l’essere rimasti in grado di discernere cosa fosse giusto da cosa sbagliato e capaci di scegliere e difendere il bene, sempre e comunque.
Tempo fa qualcuno che conosce bene i dettagli di questa storia, anche quelli prettamente tecnici, mi espresse il suo stupore nel constatare come in tutti questi anni sia riuscita a rimanere me stessa. Non capii subito cosa intendesse dire perché so che questa esperienza mi ha molto cambiata, ho iniziato a capire cosa intendesse dire quando chi mi vuole bene, potendo assistere ad alcuni atti di stalking proprio mentre accadevano, non è riuscito a trattenere la sua rabbia contro lo stalker. Ho capito ancora di più, quando qualcuno mi ha chiesto se ero consapevole che un blog non era il modo più adatto per ottenere giustizia.
Cosa vuol dire ottenere giustizia? Che il cattivo finisca in prigione, sia giudicato e condannato? Che marcisca in prigione? Che vi muoia? Che ciò che è accaduto non si ripeta mai più? Che le vittime vengano risarcite?
Qualche giorno dopo la pubblicazione del mio ultimo articolo, è avvenuta la cattura di Matteo Messina Denaro, un evento epocale, tale da dichiarare soddisfatti giustizia è stata fatta! Ma dopo così tanti anni c’era chi invece di rallegrarsi sfogava la sua rabbia sui dettagli: perché non gli hanno messo le manette? Perché dobbiamo pagargli la chemioterapia? Il viagra, i gioielli, i biglietti di viaggi in posti esotici trovati nei suoi nascondigli, ogni dettaglio che possa far immaginare una latitanza all’insegna del piacere e del divertimento, fa aumentare l’indignazione per tutto il tempo che è riuscito a sfuggire alla cattura.
L’ingiustizia provoca rabbia ed è questo che tutti si aspettano dalle vittime, che provino rabbia e odio nei confronti dei loro carnefici, che vogliano giustizia come fosse una vendetta, che ottengano un risarcimento. Come se si potessero quantificare il dolore, la paura, il senso di smarrimento e d’impotenza, le perdite subite, i giorni senza fame, senza gioia, la sfiducia preventiva, e tutti i segni invisibili della violenza subita.
Quando si verificarono gli eventi di quella che fu poi definita la Strage di Gela, io avevo 13 anni e frequentavo il quarto ginnasio. Una delle sparatorie avvenne a pochi metri in linea d’aria dalla casa dei miei genitori dove vivevo, altre due sotto casa dei miei nonni, nella stessa casa dove andai a vivere qualche decennio dopo.
Dopo la strage furono messe in atto misure drastiche per dare, si disse, un chiaro messaggio alla criminalità organizzata, a Gela arrivò l’esercito. Non c’era angolo della città senza sorveglianza militare, senza camion e posti di blocco. Alcuni commercianti iniziarono a denunciare e nacque l’antimafia. Alcune delle persone che ricoprirono cariche di rilievo nella commissione che fu istituita sono finite sotto accusa negli anni successivi, per aver abusato delle loro posizioni perpetuando modelli mafiosi nel loro operato. A Gela un sindaco, omosessuale, comunista e cattolico, portava la croce di Cristo sulle spalle durante la via crucis del Venerdì Santo, per presentarsi come il martire della mafia, e per le minacce di morte ricevute per il suo impegno nella lotta contro la mafia, oltre la scorta armata, aveva dovuto proteggersi costruendo una villa di trecento metri quadrati con sorveglianza di altissimo livello, grazie al denaro dei contribuenti. È stato uno dei tanti sindaci che hanno amministrato il paese, affidando cariche e appalti pubblici ai propri fidati amici, parenti e amanti.

Cosa significa giustizia per me, non è qualcosa che riesco a ritrovare nel mondo e nella società in cui sono cresciuta e vivo. Mi sembra che nel mio Paese tutto funzioni con dinamiche simili alla criminalità organizzata. La militanza, l’obbedienza e la lealtà agli interessi di un’organizzazione, di un partito, di un Ordine, di una cosca, sono spesso ritenuti crediti formativi più validi di molti titoli accademici e sono più utili a fare carriera, o anche solo ad accedere al mondo del lavoro.
Giustizia sarà fatta quando il prestigio dei nostri politici, dei nostri intellettuali, dei nostri scienziati, dei nostri accademici, dei nostri sanitari si baserà sui loro risultati e sui loro reali meriti piuttosto che sulla loro fedele militanza a qualche ideologia.
Non aspetto giustizia per me, per come vanno le cose quello che mi aspetto e quello in cui credo è che la verità presto o tardi, di solito tardissimo, si riveli. La verità è più certa e duratura della giustizia, soddisfa di più di qualsiasi vendetta o risarcimento perché rende liberi. È questa che io aspetto mentre cerco di trovare un senso a quello che mi è accaduto, rimanendo me stessa.
Roma 09 febbraio 2023 h: 7:14 pm
Capitolo 20 – La verità rende liberi
#LOVEINTblog#stalking online#Victor Frankl#abuso#potere#resistenza#Eva Edith Eger#mafia#Matteo Messina Denaro#trauma#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#hacker#Herta Müller#loveintblog#empatia#azione#privacy
0 notes
Text

Se il 2016 era stato un anno terribile, il 2017 fu il mio annus horribilis. Lo stesso giorno che diedi le dimissioni, arrivò il referto della PET di mio padre. Iniziarono i nostri numerosi e interminabili viaggi a Catania e a Palermo, per ascoltare i pareri degli specialisti e valutare le possibili cure. Una volta fissato l’intervento, mia madre ed io affittammo un B&B a Catania vicino all’ospedale dove avevano ricoverato mio padre. In quella occasione portai con me Paco, un cagnolino che l’anno prima avevo trovato abbandonato al centro dove lavoravo e dal quale mi ero dimessa, e che avevo adottato. Mostrai a mia madre per farla ridere, dato che non viveva con noi e conosceva poco Paco, come si andasse subito a nascondere sotto il letto, quando mi vedeva indossare i guanti di gomma o quando gli dicevo “Andiamo a fare il bagno!”, odiava il momento della toletta.
Il venerdì successivo su Instagram il contest chiedeva: cosa fa nascondere il tuo animale domestico? La meta era di postare durante il week-end foto e video (era stata aggiunta la nuova funzione) che ritraevano i comportamenti dei propri animali domestici in situazioni familiari e casalinghe. Il post della chiamata mostrava un gatto che si nascondeva furtivo, dopo aver mangiato un pezzo di torta lasciato sul tavolo.
Continuavo a pensare ancora che fosse opera del fotografo inglese, non capivo però questo accanimento, qualcosa non tornava. Era come se cercasse proprio di farsi odiare, selezionava e prendeva momenti della mia vita così intimi e privati come non aveva mai fatto in precedenza, sembrava che dovesse arrivare ovunque io fossi, che non dovesse perdersi nemmeno un minuto della mia vita, incurante dell’effetto che questo potesse avere su di me in quel momento così delicato. Avermi hackerato era già un motivo sufficiente per non aspettarmi il bene da questa persona, ma fino al momento in cui ancora lo seguivo, non aveva mai usato modi aggressivi o offensivi, non aveva preso nulla di intimo dalla mia vita privata, aveva utilizzato quello che condividevo sul social e quello che condividevo con per comunicare con lui, solo come fonte d’ispirazione e almeno sul suo account ufficiale, aveva continuato a farlo anche quando smisi di seguirlo.
L’inquetudine veniva da Instagram. Era l’account ufficiale di Instagram che parlava un linguaggio diverso e aggressivo, che si esprimeva attraverso la scelta dei contenuti più intimi e personali della mia giornata. Le immagini erano meno belle, i messaggi non erano più sofisticatamente celati nell’equilibrio tra immagine e parole, erano diventate una palese eco, una rozza ripetizione di quello che dicevo o che mi accadeva, nient’affatto mascherata. Anche la scelta dei profili da promuovere era cambiata. Gli istagramer selezionati non erano più artisti scelti prevalentemente per l’originalità delle loro opere, erano adesso persone comuni scelte per quello che facevano, per le campagne in difesa dei diritti che promuovevano, con una netta preferenza per le minoranze. Ma apparivano anche contenuti legati alla moda come sfilate e fotomodelle, donne che facevano yoga o si occupavano di bellezza delle donne, rapper e chi si ribellava a quello che oggi chiamiamo body shaming.
Nello stesso periodo in cui avevo smesso di seguire l’hacker-fotografo, avevo iniziato a seguire un personaggio famoso, uno scrittore italiano del quale avevo letto un paio di libri e il cui account ufficiale mi fu suggerito dalla piattaforma. Come dissi all’inizio di questo blog, mi sembrò di poter rintracciare l’inizio di quello che in seguito è diventata la pratica di stalking online di cui sono vittima, nel momento in cui lasciai un commento su un suo post, oggi che però, ho molte più informazioni e sono passati anni, posso senza ritenermi troppo lontana dal vero, affermare di essere stata indotta a seguire tale personaggio e di essere stata provocata ad interagire con lui. Mentre nel passato ho maledetto non so quante volte le mie azioni, ritenendomi l’unica responsabile di quello che mi stava accadendo e del fatto che non riuscissi a liberarmene, oggi posso riconoscere quanto la mia ingenuità riguardo le pratiche di hackeraggio, diciamo proprio la mia ignoranza, ma soprattutto lo stress che vivevo in quel momento della mia vita, siano stati crudelmente sfruttati per condurmi a cadere nella ragnatela che aveva tessuto.

Un giorno lasciai un commento su un suo post, non mi rispose ma nei suoi post successivi utilizzò il contenuto del mio commento e i temi dei miei post. Lo notai ma non mi agganciò fino a quando un giorno, postai il video con il canto di due uccellini. Ero in ospedale, mio padre aveva già subito l’intervento e mia madre si era trasferita in ospedale con lui per assisterlo, io mi occupavo di quello che serviva da fuori, finito l’orario di visita serale tornavo al B&B. Una di quelle sere, scendendo le scale dell’ospedale avevo sentito due uccellini cantare, due canti diversi, quasi un dialogo. Mi affacciai dalla finestra e li vidi, presi il telefono e li filmai. Il maschio cantava la femmina rispondeva, finché l’uno volò sul cornicione opposto raggiungendo l’altra, per poi volare insieme e sparire dalla mia inquadratura.
Nonostante ciò che era accaduto su Instagram, mi persuasi che fosse necessario continuare a condividere un po’ di magia, un po’ di naturale poesia della vita con la comunità del social. Anche se il mondo stava accadendo a pezzi intorno a me, e forse proprio per quello, cercavo sempre qualche cosa, anche piccolissima, in ogni santo giorno, che mi facesse sorridere o mi invogliasse a sperare.
Il post successivo fu un video in cui lo scrittore appariva sorridente, alle sue spalle degli alberi e in sottofondo uccelli che cantavano, come sottolineavano le sue parole, mentre esprimeva la sua felicità nel trovarsi in un così poetico scenario. Da quel momento in poi capii quello che mi era sembrato solo un sospetto, la fase dell’aggancio era avvenuta e a differenza di quello che mie era accaduto prima, non si trattava di messaggi celati tra dettagli figurativi, questo user ci metteva la faccia, si faceva selfie, si riprendeva in video mentre leggeva poesie d’amore e gli effetti speciali non finirono qui.
Quando mio padre tornò a casa dall’ospedale, iniziò la fase più difficile della sua malattia, l’allettamento; dal rientro in ospedale non uscì più e non riusciva ad alzarsi dal letto nemmeno per mangiare. Tranne i momenti in cui lavoravo, un paio di pomeriggi a settimana, le mie giornate consistevano nel districare la burocrazia per l’assistenza domiciliare di mio padre, andare a Catania per ritirare referti o parlare con i medici che lo avevano in cura e trascorrere il resto del mio tempo a casa dei miei genitori, per stare con lui. La domenica andavo a prendere dei dolci nella sua pasticceria preferita e i giornali, mi recavo a casa dei miei e mentre mia madre preparava il pranzo, mio padre ed io leggevamo i nostri giornali. Per lui prendevo La Repubblica e per me il Sole 24 Ore, del quale leggevo solo Il Domenicale.
Quando mia sorella ed io vivevamo insieme a Roma, nei nostri anni di studi universitari, circa una volta al mese ricevevamo una grossa busta che conteneva una selezione di articoli provenienti da quotidiani o riviste che mio padre, dopo aver letto, selezionava appositamente per ognuna di noi. Per mia sorella principalmente articoli di filosofia, per me di psicologia o di scienza. Era un modo di continuare un’abitudine familiare, che aveva iniziato quando eravamo ancora liceali e ci passava il giornale dopo aver letto un articolo che riteneva potesse interessarci.
Lo stesso fece quella mattina, porgendomi un articolo del personaggio famoso con quale giocavo su Instagram. L’articolo parlava di una ragazza che gli chiedeva se fosse possibile essere felici in Italia, mi sembrò un artificio letterario non troppo riuscito, nel senso che mi domandai perché chiunque avesse dovuto chiedere proprio a lui, qualsiasi cosa sulla possibilità concreta di raggiungere la felicità, in Italia come in qualsiasi parte del mondo, ma ad ogni modo, quella stessa sera tornata a casa mia, mi misi a riflettere sulla felicità.

Nei mesi precedenti a questo episodio, su suggerimento di un amico che si occupava di informatica e seguendo la sua guida, comprai un altro telefono, smisi di utilizzare il mio computer e presi un notebook, comprai una chiavetta per collegarmi e un IPad sul quale potevo anche disegnare. Cambiai il mio indirizzo email, tutte le mie password e seguii tutte le istruzioni che mi diedero per contrastare un attacco hacker.
Usavo l'IPad per scrivere, disegnare o guardare film su Netfilx, mentre ero in attesa in ospedale o assistevo di notte mio padre per fare riposare mia madre. Avevo creato un account di posta nuovo e non accedevo a nessun social. Quella sera sentendomi abbastanza sicura, usai l'IPad per scrivere quello che pensavo sulla felicità e immaginando di parlare con lo scrittore, scrissi un file che come in passato non inviai a nessuno.
Mi tornò alla mente una seduta con una mia paziente, che avevo avuto il venerdì precedente, nella quale mi diceva che lei non sapeva cosa fosse la felicità. La mia paziente era una giovane madre di due bambini piccoli, che aveva vissuto in una famiglia abusante. Non sospettai minimamente che lo scrittore fosse già diventato il mio stalker e avesse potuto ascoltare le mie sedute, anche perché avendo cambiato telefono e continuando a tenerlo in modo aereo durante il lavoro, mi sentivo protetta nella mia privacy e sicura di stare proteggendo anche quella dei miei pazienti. Tra le cose che scrissi in questo file condivisi la risposta che diedi alla paziente, la riporto dal file che ancora conservo, quando scrivo mi riferisco alla mia paziente che chiamai con il nome fittizio di Chiara:
“…Poi continuò dicendo che si era sentita confusa perché non sapeva cosa fosse la felicità e voleva che glielo dicessi io.
Ho abbastanza consapevolezza da sapere di non essere in grado di rispondere a domande di questa portata e infatti, eludo tali domande con un invito a cercare, anche solo un tentativo di risposta, dentro di loro. Con Chiara però, non si poteva, almeno all’inizio e per molto tempo, a lei bisognava rispondere, fornire informazioni, aprire la possibilità di immaginare, oltre che di ricordare. Mi ricordo che iniziai dicendo che la felicità è come l’odore del caffè al mattino in casa propria, ha la stessa durata e lo stesso sapore e continuai cercando di utilizzare qualcosa che conoscesse già ma vestendola di novità. Parlai di sensazioni corporee, dell’accoglienza dei bambini in cucina, del progetto della giornata, e di ciò che era particolarmente duro nella sua vita e nella sua quotidianità.
Non è molto di più di questo, l’odore del caffè al mattino! Fu la conclusione.”
continuai lo scritto sostenendo quanto fosse semplice la felicità e quanto fosse faticoso il lavoro necessario per riconoscerla, saperla vivere e conservarla nei propri ricordi. Concludevo dicendo che perfino io quella sera potevo dirmi felice, se ripensavo al momento in cui salutando mio padre, lui mi aveva augurato la buonanotte aggiungendo: “È stata una bellissima giornata, grazie”.
L’indomani l’account di Instagram postò la foto di una bambina con i capelli ricci, seduta su un seggiolone davanti alla sua colazione, accompagnata da una didascalia che ripeteva le parole della madre, un’afroamericana autrice della foto, che diceva più o meno: quando la mia principessa arriva al mattino in cucina, mentre l’odore del caffe si spande ovunque, mi sento felice o arriva anche la felicità.
Ero furiosa. Pensavo che il fotografo avesse hackerato anche il mio IPad e per la prima volta dopo molto tempo gli scrissi un messaggio diretto sul social, la funzione di messaggeria diretta era stata attivata da qualche anno. Inviai la foto del post di Instagram e senza curarmi di tradurre in Inglese, gli scrissi che non aveva alcun diritto di farlo, che doveva smetterla, che ero furiosa. Mi rispose subito e non ribatté come mi sarei aspettata, chiedendomi di cosa stessi parlando o farfugliando una risposta che risposta non era, mi scrisse chiaramente che lui con quel post, non c’entrava nulla. Mi rifiutai di credergli, come mi rifiutavo di credere che fosse opera del personaggio famoso, nonostante ci fossero stati diversi episodi che mi avevano lasciato perplessa.
Per esempio, un giorno arrivai a casa dei miei genitori, alle nove di sera e trovai una situazione carica di tensione. C’erano stati alcuni imprevisti con l’infermiere domiciliare, con le sacche dei cateteri e soprattutto mio padre stava male, sentiva dolore ma resisteva. Arrivai da loro tardi direttamente di ritorno da Catania, era il secondo viaggio che facevo in quel giorno: la prima volta andai per prendere un referto e portarlo al medico che era in sala operatoria e che mi avrebbe risposto quando sarebbe stato libero; volevo fermarmi considerato che tra la strada per arrivare a Catania e quella per raggiungere il Policlinico Universitario impiegavo a seconda del traffico dalle 3 alle 4 ore, ma l’infermiera mi consigliò di ritornarmene a Gela. Lo feci e nel pomeriggio mi chiamarono dall’ospedale, perché il medico voleva che gli portassi tutte le PET precedenti a quella che gli avevo lasciato al mattino. Così ritornai a Catania.
Quando arrivai a casa dei miei, la tensione dell’attesa di ascoltare da me il parere del medico, unita alla tensione dovuta agli imprevisti della giornata, aveva generato così tanta frustrazione nei miei genitori, che mi ritrovai a girare in macchina per il paese in cerca di una doppia presa, che sembrava essere l’unica cosa capace di risolvere tutti i problemi e di far dimenticare quella tremenda giornata. La trovai, in un grande magazzino cinese che era ancora aperto alle dieci di sera, cosa insolita per un paese siciliano. Tornai a casa dei mei trionfante, attaccai tutti i macchinari necessari per la notte a quella doppia presa e me ne ritornai a casa esausta, a cenare con cracker e sigarette.
Entrai su Instagram e lo scrittore famoso dopo pochi minuti postò un video, in cui raccontava del prigioniero politico cinese che durante la sua carcerazione aveva inventato o costruito proprio una doppia presa.
Mi rifiutavo di credere che stesse accadendo una seconda volta. Mi rifiutavo di credere che uno scrittore sempre pronto a difendere i diritti fondamentali, sempre in prima linea nell’accusare regimi e governi di ingiustizie e abusi, potesse essere uno stalker, anzi mi attaccavo alla speranza che mi avrebbe anche potuto aiutare a liberarmi dall’hacker.
Oggi penso che in quel momento mi trovassi in uno stato simile a quello di cui parla in Uno psicologo nei Lager, Viktor Frankl quando espone l’evoluzione delle diverse fasi del vissuto psichico di un prigioniero in un campo di concentramento nazista, e che ha definito un Delirio di Grazia.
Nel delirio di grazia, nonostante non esista nessuna indicazione e non ci sia stato nessun evento che consenta di nutrire tali speranze, il prigioniero si lascia trasportare dalla sensazione di essere riuscito a istaurare un contatto umano con un kapò o con una guardia, di aver con questi una qualche relazione e di potersi fidare a tal punto da consegnargli i suoi ultimi averi, il suo orologio o le sue scarpe rotte, in cambio della promessa di risparmiarlo dai lavori forzati, o dal trasferimento in un altro campo più duro o dalla selezione per una doccia a gas.
Le speranze venivano puntualmente disattese e nonostante tutti assistessero a questi eventi, prima o poi, chiunque cadeva in un delirio di grazia confidando nella pietà del nemico.
Roma 19 gennaio 2023 h: 5:23pm
Capitolo 19 – 2017 Annus Horribilis
#LOVEINTblog#stalking online#Love Gaming stalker#abuso#potere#resistenza#malattia#privacy#trauma#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#hacker#instagram#loveintblog#azione#empatia
0 notes
Text

Come in ogni pseudo-ambiente gamificato anche nella socialità virtuale di Instagram, le regole del gioco le detta la volontà sovrana della piattaforma, gli algoritmi specificano gli obiettivi che dobbiamo raggiungere e il risultato è quello stabilito dal suo proprietario. Gli obiettvi specificati dagli algoritmi sono scritti dai programmatori e dagli sviluppatori, che sono uomini in carne e ossa e che ci dicono di fare quello che chiede il proprietario: rimanere sempre connessi, competere e condividere.
Nel 2014-15, Instagram inviava direttamente a casa dell’user che aveva raggiunto i 1000 follower, un regalo che non ricordo con certezza cosa fosse, probabilmente un instabook con le foto dell’user che avevano ricevuto più like, ma ricordo che qualunque cosa fosse era custodita da una scatola, con impressa l’immagine del primo logo di Instagram. Era sempre l’icona di una macchina fotografica ma con colori diversi e con un desing leggermente differente. Questa scatola affidata alla creatività dell’user premiato, veniva inserita ben in vista in una foto, che diventava il post per comunicare il successo raggiunto e per ringraziare la comunità di follower che lo aveva permesso.
Chi aveva 1000 follower raggiungeva l’agognata reputazione e riceveva direttamente a casa sua, l’attestazione di merito.
Non ricordo con precisione quale fosse l’oggetto ricevuto in regalo perché, come avrete chiaramente dedotto, non raggiunsi i 1000 follower, né durante quella campagna né quando nel 2018 uscii da Instagram e cancellai il mio account.
Una volta capito che colui che scriveva gli algoritmi, anche quelli che spingevano a seguire alcuni user piuttosto che altri facendoli ricchi di follower, era il fotografo inglese, la questione dei premi e delle classifiche non fu qualcosa a cui mi dedicai competendo e senza rendermene conto ero diventata un user che non seguiva le regole. I numeri non m’interessavano, non mi agganciavano le comunità degli user che si seguivano tra loro e per di più, rompevo ogni schema della gamificazione, non soltanto chiedendo di fare un accordo di gioco, ma proponendo di cambiarne radicalmente le regole. Chiedevo uno spazio e un tempo delineati e limitati, chiedevo presentazioni di volti e suoni di voci.
Ma le regole, come abbiamo detto, in un ambiente pseudo-gamificato non si cambiano. Non si passa dalla piattaforma alla realtà, non si smette di giocare, di competere, di accumulare, di filtrare, di ripetere, di promuovere e di riprodurre all’infinito una prestazione.
Per me si trattava di un incontro un po’ speciale nato come un gioco e che avrebbe potuto diventare, se portato nella vita reale, magari a un’amicizia. Per il fotografo era solo lavoro e questo lavoro si svolgeva in maniera illegale.
La mia richiesta di realtà era una richiesta di riconoscimento che avrebbe implicato da parte del fotografo, assumersi la responsabilità di una comunicazione diretta e personale, ma era proprio quello che l’hacker non poteva e non doveva fare. Non poteva avere un rapporto di nessun tipo con me, né nella vita reale né in quella virtuale, perché avrebbe creato un legame, un collegamento rintracciabile tra me e lui, e questo non poteva assolutamente accadere mentre stava praticando un’attività illegale.
Cosa fare allora? Bisognava farmi rientrare nei ranghi, farmi capire come si gioca e obbligarmi a seguire le regole. Bisognava generare un conflitto e una paura.
Nei mesi in cui smise di pubblicare con il suo account ufficiale, era già il 2015, il fotografo continuò a comunicare con me e continuava a postare con il suo fakeaccount spagnolo. Usando questo account, in maniera molto esibizionistica e piuttosto in contrasto con la riservatezza mostrata fino a quel momento, iniziò lo stesso tipo di comunicazione che usava con me, con una istagramer spagnola. Anche le pubblicazioni di Instagram cambiarono seguendo i temi condivisi da questa donna sul suo profilo. Al tempo mi stupì la rapidità con la quale la donna avesse capito e iniziato a rispondere, soltanto nel tempo mi accorsi di quanto questo gioco sia ancora diffuso e giocato sui social. Mentre cercavo di districarmi tra le emozioni che mi provocava vedere questo, dopo mesi di silenzio sul suo account ufficiale, il fotografo postò la foto di una donna americana. Dalla didascalia e dai commenti sulla foto, si poteva ricostruire questa storia: si erano conosciuti su Instagram e lei gli aveva chiesto di seguirlo in una delle sue passeggiate in montagna, che faceva con i suoi amici per fotografare paesaggi.
In nessuna delle due occasioni mi passò per la mente di competere con queste due donne. Non mi passò per la mente di seguirle e di seguire le loro vicende, non per un sentimento di qualsivoglia senso che mi ponga in superiorità o in inferiorità rispetto a queste donne, ma perché penso che iniziare una qualsiasi forma di socialità e di amicizia sia pure virtuale ponendosi in rivalità, sia proprio tipico della pseudo-socialità, di quegli incontri nei quali non ci si scambia niente, non ci si arricchisce, perché si è troppo impegnati a difendere il proprio e a invidiare l’altrui. È ciò che definisco il tipico schema da soap opera.

Le soap che arrivarono da noi negli anni Ottanta (alcune di queste iniziate allora durano ancora oggi), avevano lo scopo di intrattenere il pubblico con storie di famiglie e per poter continuare, anni e anni e anni, avevano bisogno di costanti conflitti, di lacerazioni morali, di eventi che mettevano in pericolo lo status quo, serviva la giusta dose di tensione emotiva e di colpi di scena. Le soap, però, avevano una caratteristica fondamentale, le storie narrate si svolgevano tutte esclusivamente in ripresa d’interni, principalmente le case e le stanze, spesso le camere da letto, dei protagonisti, i loro uffici o i ristoranti che frequentavano.
Ora, cosa possiamo aspettarci che accada tra quattro mura e tra persone che sono sempre le stesse? Quali pensiamo che possano essere questi conflitti, queste tensioni emotive, questa suspense, che consentano di prolungare la zuppa all’infinito?
Possono essere solo i sentimenti e quelli che garantiscono una calamitante tensione emotiva sono i tradimenti, i tradimenti d’amore e di fedeltà. Qualcuno ruba la moglie al fratello, qualcuno il denaro all’amica. Un tipo di socialità apatica e piuttosto tossica a mio modo di vedere, ma un tipo di socialità a cui siamo stati esposti in tutti questi anni di produzioni televisive, che si sono intensificate con format come Grande fratello, le varie isole dei famosi e non, e un pullulare di talkshow sulle reti Mediaset, che andavano in onda allo stesso orario delle soap (dopo pranzo), pieni di gente comune che s’innamorava o s’insultava.
Un tipo di socialità che serve a nascondere la mancanza di contenuti nelle relazioni, la mancanza di progettualità, in cui l’affettività è sostituita dalla competitività, nella quale il successo individuale è in contrasto e si oppone a una crescita comune, nella quale è impossibile cambiare le regole.
La fase soap opera è l’ultima fase del Love Gaming, perché poi si può solo ricominciare da capo, con qualcun altro o decidendo di competere contro il/la rivale e vincere. Come in un loop. Dipende da quanta tensione emotiva decidiate di metterci, da quanta conflittualità, da quanto riusciate ad essere competitivi, cosicché esattamente come in una soap, la vita dei personaggi nelle stanze possa durare ed emozionarvi all’infinito.
Sul finire del 2015 i contenuti dei post del fotografo e di Instagram avevano iniziato ad inquietarmi perché erano stranamente coincidenti con qualcosa che si trovava nella mia galleria fotografica ma che non avevo condiviso, oppure riguardavano il contenuto di un’email a un amico o ancora il contenuto di una conversazione telefonica con mia sorella o con un’amica.
Fu allora che capii per la prima volta cosa significasse essere stati hackerati. Per dimostrare la mia tesi, scrissi a mano su un foglio di carta, un messaggio con una domanda per il fotografo, lo fotografai con il mio telefono ma non lo inviai. Dopo poco tempo il suo post, rispondeva esaurientemente alla mia domanda. Provai numerose volte a comunicare con lui in questo modo e la risposta era sempre precisa e puntuale, anche se mai diretta.
Quando cominciò a fare coppia fissa con un’istagramer francese che si era trasferita dove viveva lui, una sera tornata dal lavoro seduta a gambe incrociate sul divano, scrissi su un file word direttamente sul mio telefono, una lettera, anche questa mai inviata ma che rimase giacente tra le mie cartelle, fino a quando non buttai il cellulare. Scrivevo che la sua risposta alle mie proposte mi sembrava ormai abbastanza chiara e lo salutavo garbatamente, augurandogli che nella vita l’amore fosse come l’aria fresca del mattino. Stranamente quella sera non vi fu risposta. L’indomani, quando poco prima di entrare a lavoro entrai su Instagram, apparve il suo nuovo post, una luminosa mattina su un paesaggio di montagna innevato, vi era un solo hashtag #freshair, che di lì a poco tutti i suoi follower ripeterono postando. Lo trovai indisponente e smisi di seguirlo, pensando che in questo modo sarebbe finito tutto, pensando che questo sarebbe stato sufficiente a farlo sparire anche dai miei supporti.
Niente di più lontano dal vero.

L’anno 2016 fu terribile, mentre prima le condivisioni sulla piattaforma facevano eco a qualcosa che riguardava la mia fotografia, quello che condividevo o che avevo scritto all’hacker, e questi post mantenevano un messaggio seduttivo, amichevole o che puntasse a suscitare in me un’emozione piacevole, dal momento in cui smisi di seguirlo, ogni post era diventato un modo sempre più inquietante per farmi capire fino a che punto fossi visibile, fin dove potesse arrivare a scavare nella mia vita privata, fino a che punto fossi sotto controllo. Iniziai a coprire la fotocamera del mio cellulare e mettere in modalità aereo il telefono ogni volta che iniziavo a lavorare; lo riattivavo solo nelle pause o quando finivo di lavorare. Penso possiate immaginare quante difficoltà mi creasse, durante la giornata lavorativa, essere tagliata fuori da ogni comunicazione, non soltanto per la difficoltà dei colleghi e dei pazienti di contattarmi, ma soprattutto per le difficoltà che creava nella mia vita privata, dato che fu in quel periodo che mio padre iniziò a stare male e anche io.
Leggere tra le righe è qualcosa che alcuni di noi imparano molto presto, parlare senza parole, comunicare mediante il non-detto, fa parte di ogni relazione intima. Ciascuno di noi ricorda uno sguardo, un gesto o una particolare espressione della propria madre o del proprio padre che stava per facciamo i conti a casa o per qualche altro avvertimento, come anche per qualcosa di gioioso o divertente; ognuno di noi potrà ritrovare nelle proprie relazioni sentimentali espressioni, posture, gesti, oggetti o anche una sola parola, che racchiudono un intero evento che abbiamo condiviso con una persona cara. Usiamo un’espressione o un’immagine per rievocare quello che ha significato, per trasmettere l’emozione che abbiamo vissuto in quel preciso evento, condiviso con qualcuno a noi intimo, che sa a cosa ci stiamo riferendo.
La cultura nella quale sono cresciuta è una cultura che predilige un tipo di codici comunicativi che si fondano essenzialmente sul non detto, sia perché come ogni cultura a Sud del mondo, si esprime in tutta la sua fisicità con gesti, posture e suoni che appartengono più al linguaggio non verbale che a quello verbale, sia perché è una cultura fortemente stratificata che si regge su una serie di regole implicite, che solo chi appartiene alla cultura conosce e solo chi accetta può continuare ad appartenervi. Che una cosa sta per un’altra da dove vengo io s’impara presto e ritornando a Gela, lavorando in ambito sanitario, fui costretta non solo a leggere tra le righe, ma imparai che un medico con una specializzazione in Urologia poteva dirigere il centro di Neuropsichiatria infantile del Servizio Sanitario pubblico e fare diagnosi come(stare per) un Neuropsichiatra infantile di ADHD a bambini che non riuscivano a stare perfettamente immobili su una sedia, mentre il medico effettuava la raccolta anamnestica sottoponendo alla madre molte domande su parto e gravidanza, o che un Disturbo del Linguaggio stava per un Disturbo dello Spettro Autistico se i genitori non volevano assolutamente accettare la diagnosi corretta.
La diagnosi precoce in qualsiasi tipo di disturbo dello sviluppo è di fondamentale importanza per il trattamento del disturbo stesso, specialmente in età infantile. Lo sanno bene tutte quelle persone che hanno scoperto di essere dislessici, dopo anni di sofferenze e di dubbi sulle proprie capacità. Ricevere una corretta diagnosi significa per tutti i minori, aver diritto gratuitamente, alle cure specifiche e al sostegno necessario, significa poter stare bene. Significa per tutta la società avere cittadini sani che possono vivere in autonomia, invece di cittadini non autonomi che necessitano di sostegni di vario tipo a carico dello Stato. La ricchezza di uno Stato dovrebbe essere la salute dei cittadini, non la loro malattia.
Dopo cinque anni, in cui avevo dovuto destreggiarmi tra medici che stavano per altri medici che non erano nel posto giusto, dopo aver dovuto lavorare di diplomazia, dopo aver visto quanta mancanza di competenza, di onestà e di professionalità ci fosse all’interno della Sanità gelese, fui costretta a vivere l’esperienza anche come paziente e come parente prossimo di un paziente.
Prima di giungere alla diagnosi di Sindrome da Affaticamento Cronico ho fatto mille esami, mille accertamenti, mille visite, ho assunto differenti farmaci, non so quanti integratori, ho conosciuto così tanti medici che mi chiedevano 300 euro alla fine di una visita inutile e se chiedevo la fattura alzavano il prezzo a 400, nel tentativo di scoraggiarmi e indurmi a preferire il loro lavoro in nero, piuttosto che legalità e la mia possibilità di scaricare le spese mediche dalle mie tasse.
Ma la peggiore esperienza con la sanità siciliana l’ho vissuta con la malattia di mio padre. L’urologo che lo ha operato, lo so soltanto adesso, per le condizioni in cui era mio padre, avrebbe dovuto sapere che lo stadio della malattia era talmente tanto avanzato, che non si poteva più fare nulla per farlo sopravvivere, che bisognava immediatamente passare alle cure palliative. Invece lo ha operato alla modica cifra di 3500 euro. E quando ormai l’unica terapia possibile era quella del dolore, all’hospice dove fu ricoverato durante gli ultimi giorni di vita, il direttore sanitario prescrisse di ridurre il dosaggio di morfina improvvisamente, solo per contraddire e competere con il medico di Catania che aveva in cura mio padre privatamente, prima del ricovero all’hospice. Mio padre è morto tra i dolori e la mancanza di ossigeno, mentre su una barella correvamo dalla stanza dell’hospice all’ambulanza, in modo che potesse morire a casa, come disse il direttore agli infermieri dando l’ordine di dimetterlo.
Nel novembre del 2016 diedi le mie dimissioni dal Centro in cui lavoravo, non avendo un contratto di assunzione a tempo indeterminato ma un contratto che si rinnovava di tre mesi in tre mesi, ormai da cinque anni, per ottenere malattie e ferie arretrate o una liquidazione avrei dovuto fare una vertenza, ma tra l’hackeraggio, la mia malattia e quella di mio padre, l’unica cosa che pensai di fare fu solo togliermi dal burnout in cui quell’ambiente lavorativo mi aveva precipitato.
Decisi di seguire soltanto i miei pazienti a studio, di sostenere e accompagnare i miei genitori in quello che è stato il periodo più difficile della nostra famiglia e negli sprazzi di tempo che mi rimanevano, cercavo di capire come potermi liberare dell’hacker, cosa che in quel momento della mia vita mi sembrò del tutto secondaria. Mi muovevo faticosamente nel mondo portandomi dentro un camposanto con la terra ancora fresca delle ultime sepolture e la lapide pronta a sigillare quella che sarebbe stata presto, la mia più grande perdita. Anche se m’inquietava e mi disturbava sapere di essere spiata, ritenevo che in quel momento le mie poche energie dovessero concentrarsi sulle cose veramente importanti.
Roma 11 gennaio 2023 h 10: 53 pm – 13 gennaio 2023 h: 4.03 am
Capitolo 18 Love Gaming – Conclusione
#LOVEINTblog#stalking online#Love Gaming stalker#abuso#potere#resistenza#mirroring#malattia#privacy#trauma#solidarietà#libertà#sorveglianza#socialmedia#verità#hacker#instagram#loveintblog#azione#empatia
0 notes
Text

La prima fase del Love Gaming inzia con l’aggancio, che raramente consiste in azioni chiare o esplicite, come inviare un messaggio diretto o diventare un follower della persona che si vuole agganciare; è un’azione che si esplica nei dettagli di spazio e di tempo, nel decifrare post con messaggi criptati che attirano la nostra attenzione, proprio perché fanno eco a qualcosa di personale, di specifico e di riferibile solo, e soltanto, a noi.
Sul finire del 2014 Instagram rispetto ad oggi, aveva poche funzionalità, permetteva di postare una sola foto in formato 1:1, quindi un quadratino, il testo che accompagnava la didascalia al post non poteva essere molto lungo, ma aveva un numero finito di caratteri, non si potevano ancora aggiungere link e anche gli hashtag usati erano sempre gli stessi e avevano lo scopo di assicurare al nostro post la maggiore visibilità possibile, sfruttando i contenitori più grandi e noti. Un post era dunque composto da una foto, una didascalia e degli hashtag. Ognuno di questi tre componenti poteva diventare un blocco testuale che, unito agli altri due, serviva a comporre un discorso più ampio di quello manifesto, serviva a comunicare un messaggio a chi sapeva, o aveva imparato, o a chi era stato istruito a leggere tra le righe.
Il fotografo britannico, il terzo account che avevo iniziato a seguire su Instagram, cercò subito di attirare la mia attenzione, servendosi della sincronicità, della somiglianza e della ripetitività. Pur non seguendomi postava una foto immediatamente dopo di me, era una foto che aveva una somiglianza di tema con la mia, per esempio un bosco nella luce del primo mattino, o di palette, un tramonto tinto di viola, oppure nella sua didascalia o tra i suoi hashtag, c’era una parola che avevo usato nel mio post o nei miei hashtag. Questo accade molte volte, tutte le volte necessarie finché non capii che era un modo di comunicare con me. La cosa mi sembrò divertente e risposi, anche io giocando questo gioco.
L’aggancio era dunque avvenuto e poteva iniziare la seconda fase, quella degli effetti speciali.
Una volta addestrata a leggere tra le righe, mi sorprendeva in un modo ogni volta diverso, per esempio quando le didascalie dei suoi post erano laconici titoli, quegli stessi erano i titoli di bellissime canzoni, che potevo ascoltare cercando su Youtube. Mi insegnò a comunicare seguendo le sue attività, guardavo cosa gli piaceva e si profilava un lungo discorso che iniziava con un saluto, scorrendo account di artisti, a volte eccezionali, che da tutto il mondo condividevano le loro opere, con poesie, canzoni e pensieri di altri, parlava di quello che ci stava accadendo. Mi sembrò un modo di comunicare straordinario. Ero incantata, passavo ore sul social, dimenticandomi del tempo e dello spazio, condividevo sempre di più e quando non lo facevo pensavo a cosa avrei condiviso. Gli effetti speciali non finivano mai, un giorno postai una foto che fu l’inizio di una serie di post, dei quali la parola chiave era mood, umore. Il social si riempì di account con questa parola, @inthemoodoftheday, @inthemoodof, @mymood, eccetera eccetera, ma mi sembrò una coincidenza, anche quando il venerdì dopo la call su Instagram fu proprio #mood. Poco tempo dopo, postai una foto, era il mare d’inverno, agitato, eccetto la schiuma delle onde e le nuvole entrambe bianchissime era tutto azzurro e tra gli hashtag scrissi, in Inglese però, #voglioubriacartidiblue.
A quel punto tutto il social diventò blu, Instagram fece la sua call #blue, tutti postavano foto blu, era tutto blu. Stupore e ansia si mischiavano in egual parte.
Presi il coraggio a due mani e scrissi un’email nel mio sgangherato Inglese a questo istagramer, dato che il suo indirizzo era sul suo profilo pubblico. Scherzai sugli effetti speciali che mi aveva mostrato fino a quel momento e gli dissi che per quanto belli, secondo me, nulla poteva essere meglio di una conoscenza reale e gli proposi di conoscerci magari scrivendoci, data la distanza geografica.
Rispose alla mia email in maniera garbata e formale, concluse dicendo che non era solito condividere informazioni personali attraverso la rete.
Sì, rispose proprio così.
Non pensai minimamente a leggere tra le righe, e mai avrei immaginato quanto questa frase avrebbe contato per me negli 8, ormai 9, anni successivi. La sua risposta formale mi fece dubitare di quanto avessi vissuto, mi chiedevo come facesse a seguirmi se non mi seguiva, mi domandavo perché proliferavano account che avevano a che fare con me, perché Instagram? Mi fece dubitare a tal punto che mi bloccai, non postai per qualche giorno, guardavo soltanto.
Le cose più importanti accaddero proprio in quel momento. Il fotografo che mi aveva risposto così freddamente, non mancò di postare sul suo account foto che facevano riferimento al contenuto della mia email, così fece Instagram e ogni account di cui avevo dubitato o sospettato. Quegli stessi account selezionarono e pubblicarono una delle sue foto e così fece anche Instagram, che una volta a settimana sceglieva un/a fotografo/a da presentare alla comunità. Apparve una delle sue foto e un articolo con una breve intervista.
Poco dopo, i suoi post cambiarono, non erano più paesaggi ma ritratti di persone, di solito donne, che presentava proprio come faceva l’account di Instagram. Iniziò anche a seguirmi con l’account di un fotografo che si diceva spagnolo.
Mi sembrò di iniziare a capire. Capii che tutti questi account tematici, compreso quello ufficiale di Instagram erano gestiti da persone in carne e ossa, e che con ogni probabilità lui era una di queste, o tutte queste. Non capivo a quel tempo perché lo facesse, pensavo fosse il suo lavoro e pensavo che volesse mantenere una comprensibile riservatezza, così continuai a scrivergli delle email alle quali rispondeva raramente con sue email, ma non mancava mai di usarne il contenuto costantemente sul social. Continuava a sembrarmi solo una forma originale di comunicare, così continuai anche io a comunicare con lui, che nel frattempo continuava a creare tendenze e comunità, facendomi pensare che stesse favorendo la socialità e la cultura, che provasse a promuovere l’arte e la creatività attraverso il social.
Lo scopo vero l’ho capito molto tempo dopo quando ho potuto riconoscere lo schema, quello di tenere gli utenti sempre agganciati alla piattaforma, sempre in rete e sempre pronti a condividere, come anche quello di creare reti tra di loro.
I follower erano spinti a creare comunità tra di loro, usavando gli stessi hashtag, concorrendo per le stesse, a volte, elitarie call, erano chiamati a distinguersi non soltanto come singoli ma come gruppo. Questo era quello che il fotografo che seguivo faceva, sia con la sua identità pubblica, creando attorno a sé una comunità di fotografi vicini per area geografica o pronti a partire, generando contesti fotografici e account che li avrebbero poi pubblicati, sia celandosi attraverso fakeaccount con nazionalità diverse e nomi di fantasia, sia anche utilizzando gli account tematici che lui stesso generava, o quello ufficiale di Instagram.
Vi starete chiedendo a che serve tutto questo. A che serve creare gruppi e comunità di utenti? Non basta creare contesti per ottenere visibilità, follower, premi? Non basta che i singoli utenti siano costantemente collegati alla piattaforma?
No, è necessario che siano anche in rete, uniti tra loro, in comunicazione tra loro, perché quando ci si conosce si condividono molte più informazioni personali, ci si scambia l’inidirizzo email, il numero di telefono, l’indirizzo di residenza. E molto, molto di più, ci si scambia emozioni. Questi sono metadati importanti per conoscerci. Sono informazioni su di noi, che possono essere acquisite solo osservandoci agire e interagire. Inoltre vi ricordo che per utilizzare Instagram, e qualsiasi altra applicazione social, bisogna dare il consenso affinché l’applicazione possa accedere ai nostri contatti e alla nostra fotocamera, due delle cartelle più private che abbiamo sui nostri smartphone e le più ricche di dati sensibili su di noi e sulla nostra rete di relazioni.
Ad un certo punto, il fotografo mise in vendita delle sue foto, io ne acquistai qualcuna e senza il minimo sospetto gli fornii il mio indirizzo di residenza e probabilmente la possibilità di recuperare i miei dati anagrafici, dalla carta di credito che usai per pagare in sterline quelle foto.
Capii che era anche uno sviluppatore della piattaforma quando, dopo avergli scritto un’email in cui speculavo, o sarebbe meglio dire straparlavo in una lingua che mal padroneggiavo, sull’importanza di considerare la vita non soltanto nella sua dimensione orizzontale, la dimensione terrena e quotidiana, ma di lasciarsi ispirare e guidare dalla dimensione verticale dell’esistenza, quella che preme per ascendere, per farsi infinito, la piattaforma annunciò un nuovo aggiornamento, scaricato il quale, potevamo postare le foto scegliendone l’orientamento: orizzontale o verticale.
Qualunque effetto speciale potesse mettere in campo, non mi divertivo più. Avevo come l’impressione che ad ogni cosa che condividessi, ne scaturisse fuori un’eco che si ripeteva così all’infinito da perdere del tutto senso. Mi sentivo frustrata, da questo suo modo di darmi attenzione che mancava di qualsiasi riconoscimento, come mancava di una vera e sana comunicazione. Così come da mia ingenua abitudine, pensai che parlarne sarebbe servito a far evolvere questa esperienza, che per quanto stupefacente all’inizio, si stava rivelando non solo povera di veri contenuti ma decisamente asimmetrica e unilaterale.
Scrissi l’ultima email, a quello che oggi so essere stato il primo ad aver hackerato i miei supporti, una lettera, nella quale gli raccontavo di una persona che incontrai qualche anno prima. Erano i primi anni del 2000 e mi trovavo all’aeroporto, stavo tornando a Roma, non ricordo con esattezza se da Barcellona o dalla Sicilia. Ero seduta in attesa dell’imbarco e stavo leggendo un libro su Second Life, uno dei primi giochi interattivi creati. Il gioco consisteva nel crearsi una seconda vita virtuale, ci si iscriveva e si creava un avatar (il film penso si sia ispirato a questa esperienza perché è successivo) che poteva avere le sembianze che ognuno preferiva. Attraverso una serie di tappe si potevano guadagnare soldi virtuali, ci si poteva costruire una casa, mettere su un’azienda, diventare sindaco di una comunità, costruire città, insomma riprodurre una vita virtuale in ogni aspetto simile a quella reale.
Mi ricordo che mi colpì molto il fatto che le persone scegliessero di cambiare il loro aspetto, principalmente modificando il colore dei loro corpi e aggiungendovi una parte animale, per cui la loro pelle poteva essere blu, rossa, verde e potevano avere orecchie e coda da gatto, musi da lupi o artigli da pantere. Stavo leggevo il testo quando un signore americano, sulla cinquantina, si sedette nel posto accanto al mio e sbirciando il mio libro, attaccò bottone chiedendomi se lo trovassi interessante. Iniziammo a parlare e mi disse che era un sociologo che studiava i processi sociali attraverso le teconologie informatiche, che stava andando a Roma perché avrebbe insegnato per un semestre in una università della Capitale e meraviglia della vita che non smette mai di sorprenderti, che era stato uno dei sociologi che aveva partecipato allo studio dei processi sociali, a partire dal suo lancio, proprio di Second Life!
Facemmo amicizia, ci scrivemmo qualche email e ci incontrammo qualche volta a Roma, ma io ero poco più che ventenne e parlavo un pessimo Inglese, per cui la nostra amicizia non continuò a lungo, ma abbastanza da permettermi di capire che in parole poverissime, lo studio aveva dimostrato che nonostante lo schermo, nonostante l’avatar e il mascheramento, ognuno di quelli che aveva partecipato a Second Life, alla fine aveva riprodotto la stessa vita, lo stesso tipo di relazioni, lo stesso tipo di dinamiche sociali che viveva nella vita reale, quella fuori dal gioco, quella non virtuale. Non cambiava niente tra le due vite. Infatti il gioco ebbe vita breve.
Raccontai di questa storia al fotografo e conclusi che pensavo che su Instagram accadesse proprio lo stesso e che preferivo la vita vera a quella virtuale. Conclusi con un invito all’amicizia, al dialogo vero e franco e gli proposi anche d’incontrarci.
Mi rispose dicendo solo di ‘non essere sicuro di cosa fosse reale e cosa non lo fosse’ e da quel momento sparì. Sul suo account ufficiale smise di apparire. Non mi rispose mai, ma l’account del National Geographic proponeva bellissime mete di viaggi. I miei follower aumentarono di account di uomini che prima o poi, si rivelavano essere lui. Era iniziata l’ultima fase del Love Gaming, la fase soap opera.
Roma 11 gennaio 2023 h: 3:36 pm
Capitolo 17 Love Gaming – VI parte
#LoveGaming#hacker#Instagram#socialmedia#loveintblog#libertà#privacy#potere#stalking online#verità#abuso#azione
0 notes