#quando si parla di immedesimazione...
Explore tagged Tumblr posts
Text
Ma quanto è bella la scena in cui tancredi confessa a umberto quello che prova per rosa? è impossibile descriverla a parole, ma ci proverò. Solitamente è la figura femminile che mostra apertamente le sue fragilità, le sue vulnerabilità quando ammette i suoi sentimenti. Qui invece è un uomo, una figura controversa per molti aspetti, che ha dovuto per tutta la sua esistenza nascondere le sue fragilità e insicurezze dietro una corazza. una corazza che però ha le sue crepe, e da quelle crepe fuoriescono dolore e sofferenza. Ma da quando ha conosciuto rosa, una giovane donna completamente diversa da lui (diversa? beh non proprio) che lo ha ascoltato, lo ha difeso e lo ha rivalutato come persona, tancredi riesce finalmente a togliersi piano piano quella corazza, ad aprirsi e a mostrare a se stesso e agli altri le sue fragilità, vulnerabilità, insicurezze. e infine, a sperare che l'amore che ha perso possa stavolta scegliere e accogliere lui.

il timore, la speranza che si riflettono in quegli occhi così lucidi... quest'uomo ha un desiderio di amore talmente profondo che quasi lo annega.
mai avrei pensato di volere così ardentemente il lieto fine per un personaggio come lui, eppure...
Questa storyline è un vero capolavoro; se gli sceneggiatori sceglieranno di rovinarla, sento che mi si spezzerà inesorabilmente il cuore.
#il paradiso delle signore#il paradiso delle signore stagione 9#tancredi di sant'erasmo#tancredixrosa#rosaxtancredi#tancrosa#il modo in cui stanno sviluppando questo personaggio è semplicemente SUBLIME#sulla carta sarebbe un personaggio da odiare lo so#eppure lo adoro talmente tanto che quando soffre soffro anch'io#quando si parla di immedesimazione...#speriamo sul serio in un lieto fine con rosa. se lo merita.#vi prego sceneggiatori
2 notes
·
View notes
Text
Immedesimazione (forse parte 1)
Qualche giorno fa mi è capitato un tweet sotto gli occhi - in realtà era uno screen che ormai il web è fatto da screen che girano - dove veniva detto ci come gli uomini pensano che la cameriera ci provi con loro perché gentile quando fa soltanto bene il suo lavoro. Il tono era un po' a presa in giro che ci sta alla fine. A volte vado un po' più a fondo come Pirandello quando parla della donna di mezza età truccata - non che io voglia paragonarmi a lui eh, non fatevi cattive idee sulla mia autostima - e dice appunto che uno prima ci rede e poi ci riflette - FA RIDERE MA ANCHE RIFLETTERE - e dunque ho fatto un po' la stessa cosa e mi sono un po' immedesimato. In un certo senso non dico che non avrei avuto pensieri diversi né è una cosa intrinseca negli uomini. E proprio perché potrei fare quei pensieri e tali farli rimanere chiusi e nascosti nella mia mente che mi chiedo: perché un po' di gentilezza fa subito scattare l'idea che una ci sta provando? L'immedesimarmi mi porta dunque a pensare che magari uno non riceve mai o quasi atti di gentilezzada cui banalmente consegue che, in quanto atto raro, c'è qualcosa sotto
E quindi? Due cose mi vengono in mente per voler tirare fuori un insegnamento che mi può tornare utile in futuro: il primo è di non fermarsi troppo all'apparenza soprattutto di fronte a comportamenti che possiamo descrivere come sbagliati; andare a fondo e capire la causa scatenante è importante per evitare che si ripetano o che siamo noi stessi causa. Se gli uomini vengono cresciuti ricevendo atti di gentilezza disinteressata non la scambieranno poi in futuro per una che ci prova. La seconda è l'immedesimazione che trovo sia la chiave di volta che ci distingue dagli animali e ci permette di migliorare.
Immedesimazione, immedesimazione, immedesimazione...
3 notes
·
View notes
Text
L’Egenio Oneghin, Puskin e il primo dèmone del nichilismo russo

Il ritratto di Eugenio Oneghin che Puskin dipinge nel primo capitolo del suo romanzo in versi offre più di un motivo a chi voglia apprezzare la qualità di una poesia non riducibile alle maniere romantiche della tradizione europea. Vi è nella coloritura del personaggio di Onegin una baldanza e un ritmo canzonatorio (e anche di ‘canzone’) che travalica le affettazioni di altri acclamati eroi ‘byroniani’, inclini a suggellare nel disincanto una sorta di passionale autoaffermazione.
In Onegin la erosione dell'ideale non esalta la personalità individuale ma la dispone al gioco distruttivo fine a sé stesso della ironìa. Proprio perché in lui non vive più la coscienza di un ��io’ da opporre al mondo ma la percezione di un distacco irrimediabile dal senso e dalla esperienza collettiva. Entra in funzione un elemento tipico dello spirito russo quando perde lo stimolo alla coralità ("Il popolo compone, noi ci contentiamo di elaborare",disse il contemporaneo Glinka, enunciando indirettamente le condizioni della esperienza estetica e lirica russa).

Seguiamo lo sguardo di Puskin sul protagonista: Onegin si afferma nel dettaglio, nel ritmo di un carattere individuale come la silhouette di un figurino su carta. Vi si nota un’ immedesimazione quasi autobiografica e compiacente che bordeggia il tono sarcastico quando Eugenio entra in società abbigliato come un ‘dandy’ all'ultima moda -ovviamente ‘di Londra’- e parla perfettamente francese ballando la polacca mazurca con tanto di inchino (‘volete di più? Per la gente/ era assai caro e intelligente’).
Sulla innaturalezza dello Onegin giovin signore occidentalizzato e pietroburghese, ’artificiale’ come la sua città, si concentra il nucleo della ispirazione poetica: ne derivano antitesi efficaci e congeniali ad una melodia dei versi che lascia trasparire l' ordito di un dramma appartenente alla Russia risvegliata alla modernità del secolo XIX. Onegin, si sa, ‘aveva il dono fortunato/ di sfiorare in conversazione/ agevolmente ogni argomento’; e da ‘bravo alunno delle mode’ derideva Teocrito e Omero, ‘ma Adamo Smith però leggeva’ e non era punto dalla minima voglia ‘di rovistare in profondo/ la polverosa storia del mondo’.
Eugenio Onegin appare il protagonista di un già annunciato fallimento: è in sé stesso una caricatura, un derivato, il prodotto psicosociale di un connubio impossibile, anima ‘russa’ e ‘moda’ europea. Un ritratto intraducibile al punto che il dettaglio, dice ironicamente Puskin, non si può riferire senza l'ausilio della espressione forestiera: ‘ma parola russa non c'é/ per 'pantalons','frac' e ‘gilet'�� ".
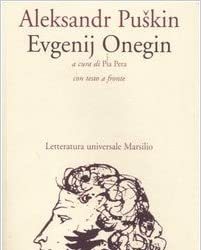
Nell'animo del poeta, del decabrista, del raffinato intellettuale Puskin si agitano molte passioni: cosa è veramente Onegin? Ci si può leggere il suo autoritratto? Nella scrittura poetica Puskin diventa lo spietato osservatore della sua immagine pubblica, mondanamente ridotto a letterato alla moda tra appuntamenti cortesi, salotti e spettacoli di teatro.
E' una dissociazione che si riconosce al momento di definire il suo disagio di vivere: quasi uguale al britannico ‘spleen’ ma esprimibile piuttosto con la parola russa ‘chandrà’, uno stato dell'anima che guarda freddamente alla vita (‘nulla ormai più lo smuoveva/ di niente più si accorgeva"…).
E' la presenza della ‘chandrà’ a suggerire il motivo nichilistico che sostiene l'andamento del poema. Esso procede per otto capitoli che snodano il romanzo in versi tra puntigliose descrizioni di oggetti, azioni, ambienti e situazioni umane .

L' amore ‘wertheriano‘ appare sottotono come appendice della trama la quale va oltre il destino dei personaggi -da Tatiana a Lenskij alla volubile Olga- e non suggerisce architetture conclusive proprio perché non vi è altro al di fuori dell' avventura senza limiti e cioè sprofondata nel ‘nulla’ di Eugenio Onegin, questo ‘dandy’ insoddisfatto della sua identità la quale ormai gli appare come abito tagliato in foggia d'altre lingue, d' altre culture, d' altre civiltà.
Ben oltre il tributo alle nuove mode poetiche – ‘quello stile oscuro e fiacco-scrive Puskin-che chiamiamo Romanticismo’- siamo in presenza di una temperie espressiva corrispondente ad elementi tipici dello ‘spirito russo’, al contrastato rapporto con la cultura occidentale europea, abito troppo misurato per un sentimento che si riconosce nella perdita di misura, quando abbandona le vie di una liturgìa dei suoni, delle immagini, delle parole tradizionali.
Puskin supera molti codici espressivi riducendoli alla vena sincera di un canto che mescola citazioni culturali a motivi della tradizione russa: dalla invocazione alla terra (con omofonìa tra l'oraziano ‘O rus!‘ e la parola Russia) ai romanzi di formazione (Rousseau, Richardson) a Shakespeare e Chateaubriand, tutto è ragione di presentare l'anima bella di Tatiana, questa Gretchen col samovàr destinata ad incarnare la persistenza di costume morale, grazia e regola, che aveva nel nome sentore ‘di antichità e di serva’, stemperando il suo sentimentalismo nel gioco permanente delle felici abitudini’.

E spetterà significativamente a Tatiana, personificazione dei valori tradizionali, il ruolo di eroina di una catastrofe da camera come quella dell'amore non corrisposto da Onegin e vissuto idealmente-letterariamete come vuole la ‘moda romantica’, come il ribelle infelice Werther o il senza pari Grandison (‘che invece a noi fa venir sonno’). E sarà Vladimir Lenskij, l'amico aspirante poeta, innamorato e tradito dalla vivace Olga, testimone ancor più fedele di un certo sentimentalismo mescolante ‘Lindori e Leandri del cuore’ con la lettura di Chateaubriand e Goethe per avvincere nel tono elegiaco il cuore della amata.
Sappiamo come andrà a finire: con Tatiana respinta e congiunta in matrimonio ad un onesto benestante e Lenskij ucciso in duello dall'amico Onegin dopo avere egli teso con successo una trappola di seduzione ad Olga durante un ballo in una residenza di campagna.
Morale: sono i sentimentali e i beneducati a soccombere nel gioco della vita, o pure nel sogno leggero di un gioco passionale ‘accomodato’ da versioni letterarie, o meglio inautentiche. Così il pensiero poetante e ‘spiritoso’ (‘Geistreich’, ricco di spirito, aveva scritto Hegel nella Fenomenologia sul potere della ironìa ) perviene ad una composizione davvero ‘diabolica’ del romanzo in versi, capo d'opera della letteratura russa.

Onegin, eroe del tempo moderno, è già in qualche modo aldilà del bene e del male, supera l'orizzonte romantico ed anticipa nel connubio caratteriale di freddezza e ironìa la temperie di un Kirillov e di un Raskolnikov.
Non a caso Dostoevskij apporrà in calce a ‘I dèmoni’ i versi di una omònima poesia di Puskin la cui allusività è più che eloquente: ‘...Non c'é traccia! Siamo perduti, cosa fare? / Un demònio ci conduce per il campo / e ci fa girare di qua e di là / Quanti sono ? Dove ci portano ? / Perché si lamentano così ? / Forse seppelliscono un folletto / O pure celebrano le nozze di una strega....’.
Quel che in Dostoevskij è definizione psicologica in Puskin è azione, situazione, ambiente e fisiognomica. Onegin mette in scena con più di mezzo secolo d'anticipo il tipo del dèmone dostoevskijano. Questo profilo umano che lascia dietro di sé la romanticheria letteraria e fissa lo sguardo senza mèta del nichilismo non fu perseguito da Puskin in consapevolezza piena: ma scomponendo i tratti della sua stessa personalità-metà Onegin, metà Lenskij- egli ottenne uno straordinario effetto lirico con voce narrante fuori campo che assume i tratti del canto popolare, storia sceneggiata da intepretare coralmente in una pubblica recita di versi.
Non a caso del resto la lettera d'amore di Tatiana a Onegin è mandata a memoria ancora oggi dalle ragazze russe (‘…Perché da noi siete venuto ? / In questo villaggio spento / io non avrei mai conosciuto / né voi né il mio aspro tormento…’) e tutto il poema in versi è ricco di digressioni (paesaggi di Russia, coloriture fiabesche, vita di campagna, canti di giovincelle in primavera, vita di società, inverni ghiacciati, sogni divinatori) che sposano il sottile e raffinato gusto letterario ad un impulso emozionale di grande portata per la vita russa, i suoi colori, le sue forme, le sue immagini inconfondibili.
Se molti guardarono a Puskin come fonte di ispirazione letteraria o musicale lo si deve alla sua capacità di riassumere i più disparati fattori del sentimento russo. Anche l' occidentalizzante Ciaikovskij nel suo arioso sinfonismo lo amò (come del resto per altri versi Musorgskij) riconoscendovi gran parte di quel patetismo eloquente che pure gli apparteneva: languore ed esultanza, attimi di esaltazione e di depressione, e la capacità di stemperare in architetture brillanti e garbate le pulsioni del sentimento.
Temperamento lirico, amante del ritmo nella parola e nella strofa, Puskin si nutre della intensità di immagine e del suo potenziale figurativo (amico e protettore di pittori, è da ricordare la sua intimità col raffinato ritrattista di gran dame, Brijullov). Valga la precisionedi dettaglio, istante, sensazione e immagine con cui si narra un attimo del duello tra i due ex amici, Onegin e Lenskij: "…Brillano le pistole / lucenti e sollevate contro il sole./ Si sente già picchiettare / la bacchetta, i piombi che entrano / in canna e il cane scattare. Grigiastro rivolo scende / nel fondello la polvere, mentre / rialzano l'acciarino avvitato / stretto....".
In questa poesia del particolare Puskin rivela originali qualità per il motivo lirico dell'immagine che scandisce ritmi di azione, modula i toni della parola in una perfezione di verso. Capriccioso e folleggiante, temperamento visivo e rappresentativo, Puskin ebbe il merito di fare ‘poesia solenne, grandiosa e come fuori del tempo con elementi e oggetti particolari, minuti, consistenti, insomma quotidiani e contingenti’( T. Landolfi). In questa paradossale leggerezza è tutta la sua profondità: il fine intellettuale allevato alla scuola europea, il decabrista non slavofilo, l' uomo elegante attraversato dalle passioni, poteva solamente accennare al profilo di una vita morale della poesia.
Ma il suo Onegin, nato come romanzo byroniano, prese col tempo una andatura che rovesciava le sue premesse, mettendone radicalmente in dubbio la consistenza. E quel progressivo rigetto di moduli romantici, oltre a segnare il più autentico travaglio del poeta, avrebbe anticipato la fioritura successiva di una delle più straordinarie stagioni della letteratura russa.
2 notes
·
View notes
Photo

THE STROKES
Per comprendere le origini e lo stile di questa band, è bene partire dal titolo: cosa significa esattamente «stroke»? Un'efficace interpretazione del termine, in inglese e in italiano, non esiste: «colpo», «movimento», «botta», «tocco» sono solo alcune delle parole a cui essa può corrispondere. Sullo stile, il nome «riflette perfettamente l'impatto della nostra musica: a volte duri e aggressivi, a volte delicati e melodici», affermano loro stessi. Nati nel 1998 a New York, il genere degli Strokes è riconducibile al post-punk revival, garage rock revival, gettando le basi per l'indie rock, genere di cui negli ultimi anni si sono affermati come una delle band portavoce. Si definiscono figli di artisti quali Lou Reed, Nirvana e Pearl Jam. Una caratteristica essenziale della band è la voce, annoiata e biascicante a tratti, altre volte arrabbiata e urlante, di Julian Casablancas, che racconta della vita nella metropoli, di serate vuote, di relazioni sbagliate, fraintendimenti, insicurezze, insieme a numerose denunce sociali e politiche. La formula che adottano è semplice: un sound sporco su melodie orecchiabili, la sensazione di essere in sala prove ad ascoltare degli amici che suonano, una forza di fascinazione e immedesimazione irresistibile, che appare totalmente genuina e spontanea: gli Strokes diventano portavoce di un’intera generazione, che risponde loro senza esitazione, portandoli fin da subito sulla rampa di lancio del successo mondiale. Sono reduci del periodo appena seguente alle Torri Gemelle, il fardello che si portano dietro è colmo di insicurezze che riversano nei temi delle loro canzoni. Basso e batteria concorrono a creare una base ritmica che sembra studiata sullo scandire dei vagoni della metropolitana sui binari, dei passi affrettati sui marciapiedi, della velocità claustrofobica della città. Ritmi serrati, come quelli della celeberrima «Last Nite», si contrappongono a episodi lenti e ovattati, in cui il contatto con la realtà sembra perso, insieme alla propria identità, in una lenta e progressiva decomposizione dell'io. Stiamo parlando di un gruppo che necessita tempo e metodo da parte dell'ascoltatore per riuscire a comprenderne la profondità e la bellezza: trattandosi di testi e musica unici nel loro genere, hanno bisogno di una certa maturità per poter essere davvero apprezzati.
THE NEW ABNORMAL (2020)
The New Abnormal è il loro ultimo album in studio, uscito da pochissimo dopo ben sette lunghi anni dall'uscita del precedente, creando un hype di proporzioni gigantesche. Innanzitutto, gli Strokes offrono un'esperienza di ascolto singolare, ricca di sperimentalismi, che è il filo conduttore di tutto l'album: l'impiego di numerosi strumenti diversi, tra cui anche sintetizzatori, una commistione di sonorità differenti e contrastanti fra loro, l'uso di particolari effetti, come - oltre alla classica distorsione vocale che caratterizza un po' tutte le canzoni indie rock - phaser e delay, con l'aggiunta anche di out-takes alla fine delle tracce, cioè una sorta di «behind the scene» dietro alla registrazione dell'album. Tutto ciò testimonia una ripresa di quel sound tipico delle canzoni anni '80, in cui la presenza degli elementi sopracitati era all'ordine del giorno: possiamo riscontrare questa particolarità soprattutto in canzoni come «At The Door» e «Brooklyn Bridge To Chorus», che tradiscono un inconfondibile sentimento di malinconia da parte della band nei confronti di quegli anni. Si tratta di un disco davvero interessante da analizzare, un album che dal primo ascolto potrebbe non entusiasmare un ascoltatore non abituato, considerate le innumerevoli particolarità racchiuse al suo interno. The New Abnormal è l'incarnazione della nuova generazione: gli Strokes diventano portavoce della frammentazione dell'io che sta logorando il nuovo anormale, che non viene nemmeno ascoltato dagli adulti in cui egli ripone la loro fiducia. «The New Abnormal è un bell'album, pieno di stile e che intrattiene piacevolmente. In quest’era dove la musica non sembra più in grado di essere rivoluzionata, dobbiamo sperare che chi ha già fatto la storia riesca a ritrovare verve e ispirazione per farci godere una volta ancora, prima che il mondo imploda portandoci con sé.» - Da un articolo di "On Stage". LAST NITE - Is This It? (2001) L'elemento chiave di questo singolo è l'inconciliabilità di testo e musica: quest'ultima, spigliata, molto catchy grazie all'effetto creato dalla batteria sincopata e dal basso, viene soppressa dal tono malinconico delle parole. Gli affetti più cari di Julian cercano di comprendere invano il suo misterioso malessere, apparentemente ingiustificato poiché nemmeno lui stesso riesce a capirne la natura, si sente disorientato come se la vita che sta vivendo non fosse la sua. Allora cerca di evadere dalla realtà, e i quindici minuti iniziali di fuga diventeranno poi anni e anni, lasciandosi completamente alle spalle il passato. UNDER COVER OF DARKNESS - Angles (2011) «Under Cover of Darkness» si può considerare una sorta di prosecuzione di «Last Nite», sebbene la loro uscita sia distanziata temporalmente di 10 anni. Musicalmente, si ricollega a quello precedente per il ritmo incalzante. Il testo, invece, parla di Julian che finalmente ha trovato il coraggio di scappare e, non avendo un'idea chiara su cosa sarà il suo futuro, decide di arruolarsi nell'Esercito. Ovviamente, trovandosi in quella condizione gli riesce difficile poter contattare i suoi cari che ha deciso di abbandonare, e si immagina le loro voci che lo esortano a tornare indietro, sono disposti a dimenticare tutto e ad accoglierlo. Riflettendo su come agire, Julian ci racconta di come nel frattempo giri per la città, riprendendo esattamente quello che, in «Last Nite», era solito fare per evadere dal torpore della sua vita. Aggiunge anche un verso in cui afferma che tutti stanno cantando la stessa canzone da 10 anni, metafora del fatto che nulla è cambiato da quando è partito e non ha senso ritornare perché proverebbe nuovamente la stessa sofferenza (curioso come la canzone in questione possa essere proprio «Last Nite», essendo stata rilasciata 10 anni prima). Un segno della maturazione di Julian lo riscontriamo nella canzone «Brooklyn Bridge To Chorus»: se in «Is This It?» (2001) la colpa veniva proiettata sugli altri ("Dear, can’t you see? It’s them, it’s not me"), ora (2020) possiamo notare come metta in discussione questo fatto, ammettendo che potrebbe anche essere lui il responsabile del suo male ("Thought it was them, but maybe it's me"). THE ADULTS ARE TALKING - The New Abnormal (2020) "The Adults Are Talking" è la traccia di apertura di The New Abnormal. La traccia assume un tono ribelle contro i poteri forti, coloro che governano il mondo. Si tratta di un tema ricorrente nella discografia degli Strokes: Julian, il cantante, parla delle persone del mondo degli affari, che mentono e che vogliono, in senso figurato, "arrampicarsi sui muri", cioè ambiscono a ottenere tutto quello ciò che desiderano con grande avidità. Il ritmo della batteria è marcatissimo, inizialmente quasi martellante, ma successivamente, con l'aggiungersi degli altri strumenti, si fonde perfettamente con la canzone. Il cantato è ovattato, quasi sussurrato, forse per amplificare il contrasto tra la volontà di protesta e la censura a cui la band è costretta.
di Lorenzo Morelli
1 note
·
View note
Photo

RECENSIONE: Tash Sultana - Notion EP (Lonely Lands Records, 2016)
La polistrumentista australiana Tash Sultana dimostra la straordinaria varietà dei suoi talenti e la sua ardente passione all’interno di Notion, l’EP di debutto dopo il successo che l’ha travolta sul web. Sultana, appena ventenne, ha un passato come busker per le strade della sua Melbourne, professione che si è vista costretta a praticare dopo una grave psicosi indotta da droghe all'età di diciassette anni. L’impatto subito a fronte di questo difficilissimo periodo si percepisce ascoltando Notion e l’esperienza che ha acquisito dedicandosi alla musica come forma di guarigione le ha permesso di costruirsi delle solide fondamenta che la concretizzano come artista in partenza. Chiaramente, Sultana ha fatto tesoro di ciò che ha vissuto sulla sua pelle, trasformandolo in canzoni una volta uscita dalla riabilitazione.
Il modus operandi di Sultana è parecchio interessante e diventa assolutamente ipnotico quando la si guarda esibirsi sul palco, dove si dimena senza fermarsi un attimo tra microfoni, chitarre, fiati, loop station e drum pads - strumenti che ha imparato a suonare da autodidatta. Infatti, nel 2016, non appena inizia a pubblicare le sue performance su Youtube i suoi video esplodono di visualizzazioni.
A causa di ciò che ha passato l'anima di Sultana sembra più vecchia della sua età anagrafica e nelle sue canzoni traspare una certa consapevolezza, una capacità di analizzare se stessa e le persone che le stanno vicino, un’intensità che le si legge in faccia e che trasferisce direttamente nell’esecuzione. Notion parla dei brutti anni della psicosi, durante i quali riferisce di aver vissuto una realtà alterata piena di allucinazioni, trovandosi incapace di ritornare alla normalità e riuscendo a dedicarsi solo alla musica. In Jungle l’artista descrive quella realtà come una giungla. “You throw me into the deep end / Expect me to know how to swim / And I put my faith inside my hands / Cause I will be just fine / Welcome to the jungle / Are you gonna dance with me?"
youtube
Ma c’è di più, oltre a riferirsi al tremendo episodio con le droghe le sue parole potrebbero avere un duplice significato ed è possibile che alludano altrettanto ad una persona nella sfera amorosa che non riesce a capire la sua situazione. Jungle e Notion sono le due tracce che avevano già catturato l'attenzione sul web, ora registrate in studio ed inserite nell'EP. Sotto queste nuove vesti non si perde la sensazione d'improvvisazione, il coinvolgimento sia di Sultana sia dell'ascoltatore che si sente parte dell'esperienza, avvolto dalla voce vibrante, emozionata, echeggiante e virtuosa alla quale combina intricati strati di arpeggi e assoli con la chitarra, basi sintetiche dai ritmi sostenuti e loop di batteria. “These notions / they're deep as ocean / Calling out my name / Screaming out in vain / Singing hallelujah”
youtube
Anche in Synergy e Gemini - in cui si sentono sfumature ed influenze diverse che hanno l’intenzione di arricchire la palette sonora - il livello di immedesimazione e di focalizzazione è ad un certo livello, portando l'EP ad uno standard piuttosto alto. Sultana risente contemporaneamente delle influenze raggae, neo-soul, funk, rock ed art-pop, sintetizzandole in una sua mistura ibrida tipica degli artisti di strada. L'esecuzione è allo stesso tempo colma di anima e precisa, la lunghezza prolungata delle canzoni - che possono arrivare ad oltre cinque minuti e con frequenti semplici parti strumentali - lasciano molto spazio per respirare senza però essere inconcludenti. Al contrario, sono fondamentali per costruire un crescendo e per far assaporare meglio la struttura delle canzoni che si evolvono, replicando un pò l'esperienza dal vivo. In questo Sultana è proprio brava e riesce a creare un’atmosfera che è difficile associare a dei generi musicali precisi. In questo contesto fa piacere concludere l'ascolto, soprattutto dopo quattro tracce molto intense e varie, con il live di Big Smoke, un inedito diviso in due parti che continua ad evidenziare le capacità di Sultana sia come cantante sia come musicista. Il mondo di Tash Sultana nasce sicuramente da una visione molto intima e delicata, ma quando la mette in musica riesce a creare per tutti qualcosa di evocativo, appassionante e spirituale.
TRACCE MIGLIORI: Notion, Jungle
TRACCE PEGGIORI: Synergy?
CLICCA QUI PER LA VALUTAZIONE FINALE
2 notes
·
View notes
Text
Fabio Volo (mica scemo, anzi, un gran paracu*o) si merita almeno un paio di stroncature. Qualche buona ragione per evitare “Una gran voglia di vivere”
Fabio Volo ha capito quali storie bisogna scrivere, ma non ha le palle per farlo fino in fondo
Tutti tendono a sminuirlo, ma lui è tutt’altro che scemo. Casomai, è un gran paraculo. Sono anche convinto che, scherzando e ridendo, abbia letto più di tanti conclamati scrittori. Infatti, al netto di tutti i presunti ghostwriter ed editor, Fabio Volo è uno dei pochi ad aver capito che storie sia necessario raccontare oggigiorno. Rispetto alla maggior parte degli autori blasonati – ma non per questo meno commerciali –, le cui trame sono spesso così sopra le righe da risultare idiote, lui è addirittura uno dei pochi realisti in circolazione, una specie di Emile Zola da supermercato che produce libri su base industriale, come altri fanno detersivi.
Una gran voglia di vivere (Mondadori, 2019) è una storia semplice. Una famiglia, tutto sommato senza strambe particolarità o problemi, una coppia che si ama – o si amava – e un figlio, una buona casa in città, a Milano. Naturalmente, la coppia va a ramengo. Problema in più problema in meno, lavoro ben retribuito o no, si tratta di un racconto che potenzialmente potrebbe avere come protagonista la maggior parte degli italiani. In tal senso, Fabio Volo è di molto superiore a tanti: un libro per essere un grande romanzo deve tendere all’universale, al generazionale, alla possibilità di immedesimazione da parte dei lettori con la storia raccontata. E lui ci riesce, anche molto più di una Elena Ferrante qualsiasi con tutte le sue amiche geniali. Volendo azzardare un paragone grosso e quasi blasfemo, il suo libro è un episodio da nuova Commedia Umana – Balzac ci perdoni.
Ma Fabio Volo ha del genio commerciale ed è dunque abilissimo nel sollevare un problema cruciale, quale quello dello sfaldamento del legame sociale principale, ovvero della famiglia, e poi lavarsene le mani, evitando di trarne le conseguenze e quindi svelare il tragico. No, lui preferisce vendere una speranza a buon mercato. Potrebbe chiedersi perché il rapporto tra il protagonista e la moglie si deteriori, perché lei, dopo aver deciso di restare a casa a seguito della maternità, soccomba a un senso di frustrazione, alla fantomatica idea che facendo la madre si stia in fondo sempre perdendo qualcosa, alla sua ossessione che la vita non può ridursi a questo e possa essere altrimenti. Dovrebbe allora spingersi verso una riflessione più ampia che consideri i decennali tentativi della propaganda per mandare in vacca la famiglia tradizionale e generare l’atomizzazione sociale. Certo, se lo facesse, non sarebbe Fabio Volo, ma un Houellebecq italiano con problemi nel trovare un editore e non avrebbe più un posto d’onore in tutti i market e gli autogrill. Dovrebbe pure essere politicamente scorretto, inviso a molti, troppi per essere uno scrittore di grido. Palesemente, però, per fare questo ci vorrebbero due coglioni d’acciaio. Fare i duri ha un prezzo e lui lo sa bene. Ha già visto quanto gli è costato dire un qualcosa che dovrebbe essere chiaro a chiunque, ovvero che Ariana Grande vestita da zoccola ha un’aria un po’ da troione e che un padre che voglia dirsi tale certo non applaudirebbe alla figlia che esce combinata come una che sta per cominciare il turno in casino. Ma quella era una voce dal sen fuggita e subito rimangiata che qui si fa presto a passare per retrivi reazionari, patriarcali, e – rullo di tamburi – fasssssistttiii.
Ecco dunque ben confezionato il volume giusto per un innocuo regalo di Natale – il libro non è scritto male, ma del resto oggi tutti scrivono in modo piatto ma scorrevole, grazie agli editor. Alla fine, forse la famiglia non si ricomporrà, o altrimenti, che diavolo, una soluzione di affido condiviso del bimbo la si troverà. Basta evitare di raccontare il seguito della storia: una donna che a cinquantacinque anni si ritrova sola, dopo una serie di sfortunate relazioni che più che altro si sono limitate a chiavate che l’hanno interiormente annichilita; un uomo dallo stipendio dimezzato che vive in un monolocale, torna a casa e si riscalda un cibo surgelato, mentre guarda alla tele il culo di una qualche velina; un figlio che ha giusto qualche problema relazionale, bullizza o è bullizzato, prende psicofarmaci per dormire e ha come migliori amici il suo psicologo e la sua psichiatra. Ma perché dirlo? Meglio pensare positivo, fare i moderni. Del resto, di romanzi in cui si mette in luce che questo mondo ha qualcosa di malato e perverso ce ne saranno già una cinquantina e forse sono fin troppi – e soprattutto, per le feste, chi cazzo lo vuole un regalo del genere?
Matteo Fais
*
A Volo manca quel guizzo che fa la differenza, ma alla fine il pubblico è sovrano
Credo che il modo migliore per recensire l’ennesimo libro di Fabio Volo sia non parlare affatto del libro. In fondo, a chi interessa? I lettori sembrano essere già spaccati in due fazioni inconciliabili: quelli che lo adorano, e se ne fregano delle recensioni, e quelli che si dannano a chiedersi come possa esistere chi lo legge e apprezza. I libri di Volo non sono oggetto d’indagine, o meglio, non lo sono più. Perché continuare a recensirli? È già stato detto tutto ormai. Lo stile scorrevole, le storie di vita quotidiana, i problemi del nostro tempo, la facilità a riconoscersi nei personaggi, le metafore non eccelse ma immediate, gli aforismi pronti all’uso, i finali positivi o comunque mai privi di speranza. D’altra parte, a ogni nuova uscita, e si parla in media di un libro ogni due anni, Volo tende a ripetere lo stesso schema, nello stile come nelle trame. È quindi il primo a non portare grandi novità al dibattito sulla sua scrittura. Oggetto di discussione perenne sono invece le ragioni del suo successo.
In realtà i motivi sopra elencati, in particolare la gradevolezza e la facilità di immedesimazione, potrebbero essere già sufficienti, e si potrebbe anche citare per l’ennesima volta La fenomenologia di Mike Bongiorno di Umberto Eco e la confortante identificazione del lettore, in luogo dello spettatore, con l’uomo medio, l’everyman. Ma a che servirebbe, se è già tempo di scrivere la fenomenologia di Fabio Volo? È lui il nuovo paradigma della mediocrità, oggetto di una demonizzazione eccessiva almeno quanto il suo successo. In quest’ultimo libro, Una gran voglia di vivere, titolo persino più lezioso del solito, una coppia un tempo felice ma ora in crisi, con un bambino piccolo, parte per un lungo viaggio in Australia. Basterà a ritrovarsi o la separazione sarà inevitabile? Fondamentalmente, chi se ne frega! Questo è il pensiero costante che mi ha accompagnata durante la lettura, portata a termine con la stessa noia indulgente con cui ascolto i racconti delle vacanze degli amici più affezionati. Però senza l’affetto. Il problema non è tanto raccontare storie di vita normale, cosa di per sé legittima e persino auspicabile, quanto lo stile piatto, a tratti didascalico, con qualche raro risveglio.
Cosa gli manca, per essere vera letteratura? Manca lo stupore, il guizzo, il gusto del paradosso, lo spingersi al limite, gli arresti e i gol in rovesciata, i pugni e le carezze al lettore. Tutto quello che alla fine di un libro ti fa sentire diverso da prima. “Quando Anna era arrivata nella mia vita tutto era cambiato, contava solo lei e il tempo che passavamo insieme”, dice l’autore, nelle prime pagine. “Essere o non essere con te è la misura del mio tempo”, scriveva Borges ne Il minacciato. In fondo il concetto è lo stesso, ma fare letteratura è dirlo come nessuno prima aveva mai pensato. La frase di Volo, al contrario, potrebbe essere pronunciata da ciascuno di noi, al telefono con un amico o tra sé e sé. Attenzione, dal punto di vista narrativo lui è coerente. Racconta in prima persona la storia di un uomo qualunque, e si esprime come un uomo qualunque. Alla lunga però la mancanza di contrasto tra la voce del narratore e quella dei personaggi rende monotona la lettura: da una parte dialoghi ben gestiti ma un po’ troppo pettinati, privi di crudezza realistica e di quelle imperfezioni tipiche del vero parlato, dall’altra una narrazione mancante di slanci espressivi.
Ma forse è proprio questo il punto, il suo lettore non vuole allontanarsi troppo da sé stesso, desidera piuttosto guardarsi per un attimo dal di fuori, giusto il tempo di mettere in ordine i propri concetti. La scrittura di Volo non fa che aggiungere un po’ di editing ai pensieri dell’uomo comune, togliere qualche ripetizione, sostituire alcune parole.
Io non ne ho bisogno, i pensieri me li edito da sola. Ma chi sono per dire che è giusto così? Se si parla di scrittura, la mia asticella del gusto è un po’ più alta della media, ma non lo è ad esempio per la musica: spesso non ho voglia di affrontare la complessità della classica e preferisco il pop. A tavola, poi, ho sempre preferito la mortadella al caviale. Perché, dunque, altri non dovrebbero ragionare in questo modo in merito alla scrittura? Alla fine, piaccia o no, il pubblico è sovrano, e ci saranno sempre la massa e la nicchia, sia tra i lettori che tra gli scrittori. Sappiamo bene che l’editoria è sostenuta per la maggior parte da un manipolo di irriducibili, i cosiddetti ‘lettori forti’, che Volo non lo leggono. Ne ho conosciuti, di lettori forti. Sono curiose creature, perlopiù intelligenti e amabili, ma anche capaci di piccole e inaudite crudeltà. Ad esempio, se dici loro che non stai leggendo nulla, ti guarderanno di certo con profondo disprezzo, chiedendosi come tu possa ancora respirare. C’è poi un’altra fascia, molto più ampia, che non legge più di due o tre libri l’anno, e tra questi è facile trovare chi apprezza i libri di Volo. Se tali libri non esistessero, costoro affronterebbero Kafka o Proust? No, più probabilmente non leggerebbero niente, quindi ben venga Volo, che comunque porta soldi all’editoria.
Scegliere che lettore o che scrittore essere, spesso non è nemmeno possibile. Tanti dicono, sono capace anch’io di scrivere come Volo! E allora, verrebbe da chieder loro, perché non lo fai? E qui penso soprattutto ai miei amici scrittori, quelli che al successo non sono arrivati, o non ancora. Qualcuno anche cialtrone e vanesio, ma svariati davvero bravi e meritevoli. Mi ci metto anch’io, nei miei momenti di presunzione, tra i sedicenti sottovalutati. Penso a quelli che ergono Volo a simbolo di ogni male, del degrado del mondo editoriale, della stupidità e ignoranza dilaganti, spesso additati come rosiconi. E a quelli che al contrario lo ammirano in modo acritico, riconoscendo nel successo e nei soldi l’unico parametro di valore. Credo che al riguardo si potrebbe aprire un dibattito, più che sulla scrittura, sull’invidia, sentimento molto più profondamente umano e necessario di come spesso viene dipinto, sempre al confine con l’ammirazione. Ha più senso invidiare il successo meritato o quello immeritato? È meno nobile invidiare Volo per senso d’ingiustizia, o Borges perché ci mette di fronte ai limiti del nostro talento, alla grandezza che mai raggiungeremo?
Il successo di Volo in fondo non è se non la prova che realizzare i propri sogni di gloria, nella scrittura ma anche in altro, non è un teorema matematico: non è detto che il conto torni. Non è nemmeno un esperimento di fisica, perché le condizioni iniziali non sono mai le stesse per tutti. È più un allineamento di pianeti, un complesso di fattori non sempre razionali e il talento forse non è nemmeno il primo della lista. Eppure, la passione vera spinge perseverare, alla faccia dei propri pianeti disallineati. Io a scuola volevo sempre stare in banco con quelli più bravi di me, quindi continuerò a invidiare Borges molto più di Volo.
Viviana Viviani
L'articolo Fabio Volo (mica scemo, anzi, un gran paracu*o) si merita almeno un paio di stroncature. Qualche buona ragione per evitare “Una gran voglia di vivere” proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2JwEGzC
0 notes
Text
“Sono ossessionato dalle donne disinibite e autoritarie. E comunque, chi parla di libri è il sacerdote di una religione morente”: dialogo con Fabio Orrico
Una leggenda racconta che Dio non annienta la letteratura per merito di un manipolo di giusti dei libri, che si adopera, infaticabile, per divulgare, recensire, ma soprattutto leggere e segnalare le opere che meritano di sopravvivere. Si tratta di oscuri insegnanti, magazzinieri, infermieri, banconisti di macelleria, cui raramente viene data voce nei grandi palcoscenici. Fabio Orrico è un giusto dei libri: un grande lettore. È promotore culturale, creatore di riviste on line, blogger e vlogger, recensore vigoroso di libri e film. Uomo appassionato, cultore della parola e delle immagini, affascinato dai segni e dalle icone, non smette di cercarne. Si sa per certo che Fabio è un famelico cultore di letteratura e cinema, ne appare come drogato. Non è raro assistere a questa scena: Fabio, alla luce di un faretto, legge le ultime pagine di un libro. Lo richiude. Ci pensa un po’ su, ma proprio poco. Qualche secondo. Se ne esce con un commento fulminante regalato al soffitto. Lo ripone su un ripiano. Ne piglia un altro, da una fila proprio accanto. Lo apre. Si abbandona nuovamente alla sua estasi mistica, senza soluzione di continuità, impossibile distrarlo. Un libro via l’altro. Di lui si dice che legga al posto di respirare.
Qualcuno dice che per saper scrivere bene è necessario leggere molto. Beh, in Fabio la condizione essenziale è rispettata. Poeta (Strategia di contenimento, Della violenza), si è cimentato con il thriller (Giostra di Sangue ed Estate nera, scritti a quattro mani con Germano Tarricone), con il romanzo erotico (Il Bunker). Sta per uscire per Italic Pequod il suo ultimo romanzo: Giorni feriali è un nuovo inizio. Un esordio.
Nel tuo immaginario mi sembra di vedere immagini e scene di film, come se tu costruissi la tua prosa e la tua poesia attraverso quadri, come scene ancor più che come sequenze.
Dopo anni di militanza cinefila penso di aver la testa piena di immagini di film e ti confesso che mi viene la voglia di guardare direttamente a scene che mi sono piaciute e scriverle, magari incastonandole dentro alla storia. Si potrebbe parlare di citazioni in maniera giusta, però trasferendosi da un medium a un altro cambiano natura. Se io cito una scena aumentandola diventa altra cosa, non un vezzo. Probabilmente tutto quello che ho scritto ha dentro di sé tante immagini cinematografiche che mi hanno colonizzato.
Qualcuno potrebbe dire che sei un uomo film.
Sì esatto come gli uomini libro di Fahrenheit 451. Però non mi prendo un film solo da testimoniare, me ne prendo tanti. È una cosa di tutti i cinefili, non soltanto mia.
Nonostante nel tuo immaginario ci siano storie e immagine raccontate, pensate e costruite da altri in tutto quello che scrivi c’è questo senso di autenticità, di onestà. Senza voler per forza usare parole abusate, sei spietato con i tuoi personaggi, che non nascondono difetti e limiti, ma tirano fuori le debolezze con spontaneità.
Secondo me ci sono autori che hanno una distanza considerevole ed evidente dai personaggi e sembrano quasi incombere su di loro. Parlando di cinema il regista che più risponde a questo modo di concepire l’invenzione è Kubrick. Nei suoi film si sente sempre la sua intelligenza cupa che si affaccia sui personaggi, come se fossero osservati dall’esterno, giudicati. Un atteggiamento rispettabile, che però non sento mio. Non mi arriva. C’è una frase di De André che dice “quando si racconta il porcile è bene farlo sposando il punto di vista del maiale”. A me piace moltissimo questa frase e cerco di muovermi in quella direzione: l’essere spietati con i propri personaggi non significa non amarli.
Hai un modo di osservare che passa attraverso le persone che incontri, le storie che raccontano, l’affetto che nutri per loro che diventa immedesimazione nelle vicende.
Negli ultimi dieci anni ho scritto cose anche molto autobiografiche e la cosa curiosa è che rileggendole dopo molto tempo non le riconoscevo, mi sembravano finte. Allo stesso tempo ho raccontato cose successe ad altri e paradossalmente quando le rileggevo mi sembravano vere. Questo è curioso, forse possiamo formulare un teorema, non valido in senso assoluto, ma valido per me. Mettermi in scena comporta fatalmente una quota piuttosto rilevante di parzialità. Alla fine sono sempre io quello che ha ragione. Per forza! Lo voglia o no io sono il protagonista della mia vita, ma se provo a modificare la prospettiva, le cose cambiano e si fanno più interessanti.
Nelle nostre esperienze di lettura, di visione di film, di ascolto di testi di canzoni, c’è sempre un punto: qualcosa deve arrivare. Ami ripetere che in un libro cerchi qualcosa che ti tocchi, indipendentemente dal fatto che sia un libro essenziale, popolare, con una ricerca linguistica, con una scrittura difficile o piana.
Ognuno di noi ha un nostro canone, è naturale. Si può preferire Hemingway a Foster Wallace o viceversa. Per quanto mi riguarda ho delle predilezioni, ma amo con la stessa intensità Paolo Volponi e Romano Bilenchi, che sono due scrittori opposti: Bilenchi funziona sulla forma breve, Volponi ha bisogno di almeno duecento pagine per dire quel che deve dire. Bilenchi ha una lingua semplice, Volponi carnosa ma l’emozione che io ho provato leggendoli è stata intensa con entrambi.
Bilenchi e Volponi hanno però molto in comune. Sono riferimenti importanti nella letteratura sul lavoro, anche se in momenti storici diversi. Il lavoro è tornato ad essere presente con insistenza nella letteratura del nuovo millennio. Esiste ormai una corrente che si è concentrata, in modo che a me inizia a sembrare fastidiosa, sul tema della precarietà vissuta da finti precari. Ragazzi con due lauree che vivono il lavoro come intermezzo o un fastidio necessario per raggiungere altri obiettivi. In Bilenchi e Volponi ma anche nelle tue opere, si parla del lavoro in maniera molto più vera: da dentro, da chi il lavoro lo conosce e lo vive, dalla mattina alla sera e ne percepisce le contraddizioni e l’importanza, nell’averlo e dunque anche nel perderlo. Il significato di quell’esperienza è completamente diverso da una ricerca un po’ finta e spocchiosa che ha piacere nel non trovare e nel piangersi addosso.
La letteratura non è molto democratica: anche un finto precario può tirar fuori un libro pazzesco. Certo è diverso trattare il lavoro da posizioni di privilegio e dalla morchia della fabbrica. Durante la presentazione di un suo libro Emanuele Tonon parlava di Paolo Volponi, peraltro indicato come uno dei suoi punti di riferimento, e diceva che un libro come Memoriale era comunque un libro scritto da un dirigente mentre lui aveva lavorato in fabbrica alla catena di montaggio e la sua esperienza comprendeva anche i calci in culo del capo reparto. Attenzione, non era critico nei confronti dei risultati: Volponi aveva raccontato il lavoro in fabbrica con grande verità ma sempre forzatamente dal punto di vista di un responsabile che vede la produzione da un ufficio separato da vetri insonorizzati e questa cosa la senti e non è detto che sia per forza qualcosa di negativo. L’analisi di Volponi, quindi di un intellettuale, poteva essere ancor più pregnante perché nasceva da fuori ed era meno viziata emotivamente. In ogni caso Tonon rivendicava questa peculiarità: lui la fabbrica l’ha raccontata dal punto più basso. Sono punti di vista la cui differenza si avverte. Tutto questo per dire che l’aureo motto di Tolstoj “parla del tuo cortile e parlerai del mondo” è sicuramente giusto ma non va a detrimento di chi non parla di ciò che conosce.
Quando si è affacciata al pubblico la generazione degli scrittori nati tra i settanta e gli ottanta è arrivata questa ondata di call center, precariato, lavoretti che a mio avviso non rispecchia per niente il nostro tempo. Un esercito di radical chic che intende il lavoro come una scocciatura strumentale per potere scrivere il grande romanzo, oppure per girare il grande film, per cogliere l’immagine fotografica perfetta, o per dipingere il capolavoro immortale. Ne viene fuori molto più il prolasso di una generazione illusa e presuntuosa, che una denuncia sociale.
Se uno vuole intendere il lavoro come una scocciatura strumentale per poter scrivere il grande romanzo sono affari suoi, poi leggiamo il romanzo e vediamo se è effettivamente grande. Resta il fatto che il lavoro è un problema nevralgico del nostro tempo, specie per gente come me che non ha voglia di lavorare, ma nemmeno di morire di fame quindi lavora. Diciamo che se in passato è stato prezioso capire quanto il lavoro fosse determinante nelle nostre vite adesso è altrettanto importante raccontare quanto pesi l’assenza del lavoro o l’assenza del lavoro come lo abbiamo conosciuto fino all’altro ieri. Poi bisogna aggiungere che io scrivo di gente poco scolarizzata, senza grandi ambizioni o prospettive. Forse è per questo che, nelle mie storie, se uno lavora in un magazzino non percepisce questa situazione come un abuso o un’ingiustizia della sorte. Voglio comunque rivelarti una mia bassezza: tendo al vittimismo. Anche per questo, perché conosco la noia che il vittimismo provoca, l’insofferenza che il lamento scatena, i miei personaggi non lo possono essere, vittimisti.
I tuoi personaggi non lasciano che la vita accada, nella vita in fabbrica, nel tentativo di sbarcare il lunario, nelle relazioni umane, negli incontri e nell’erotismo, ma seppur nell’attesa, nella riflessione e nell’autoanalisi sono proattivi, a un certo punto di muovono, possono ribollire poi esplodono.
Parliamo di narrativa: nel primo libro che ho scritto con Germano Tarricone, Giostra di sangue, che rivendica orgogliosamente il suo essere un thriller al grado zero, una pulp fiction da edicola, avevamo una protagonista troppo passiva e le successive stesure sono servite a correggere questo suo difetto. Il lettore non perdona la passività dei personaggi, a meno che non sia un elemento essenziale dell’identità e dell’intreccio, un carattere fondamentale e riconoscibile. Un personaggio passivo è l’anticamera di un romanzo sbagliato e lo dico con tutto il fastidio che provo per gli accorgimenti e le regole della buona scrittura. Neanche i personaggi monologanti e arresi alla vita di Thomas Bernard sono passivi. Se pure si arrendono, il loro cedere le armi prevede comunque uno scontro frontale.
L’assenza di azione può essere uno strumento vigile per conoscere e capire il mondo, per accoglierlo, come nei poeti, penso a Paterson. Quando ho visto il film mi sono detto: sai che questo personaggio assomiglia tantissimo a Fabio Orrico?
Questo film di Jarmush che hai citato l’ho amato davvero molto. Se fossi un regista (che poi è il sogno proibito della mia vita) vorrei fare un film così, con lo stesso sguardo fenomenologico su ciò che accade, nitido e dettagliato. In più Paterson ha il pregio di riuscire a parlare di poesia senza cadere nel ridicolo. Cosa rara al cinema. Mi viene in mente Il mistero dell’acqua della Bigelow, dove il protagonista, interpretato da Sean Penn, è un poeta e a mio avviso dà un’idea molto falsa della poesia, come pura contemplazione, come tiramento di culo inessenziale. In una scena Sean Penn davanti al tramonto dice: chiunque può tirare fuori qualcosa di bello da questo tramonto, una stronzata, battuta sciocca, ingenua. Addirittura in quel film Sean Penn è descritto come una rockstar: viene riconosciuto per strada, il che è ridicolo. Le persone non riconoscono per strada Stephen King, figurati se riconoscono un poeta.
La poesia in Italia è maltrattata. Non se ne conosce né la potenza né il ruolo. I poeti sono misconosciuti.
Riesumare e resuscitare i poeti dimenticati sarà il lavoro di molti per molto tempo. La mia impressione è quella di un terreno dove, specie nei momenti di analisi, vige la soggettività più estrema alternata in modo schizofrenico a una pigra conferma dei canoni. La critica agisce ai margini e spesso non sa essere incisiva, rinunciando alla chiarezza e perdendosi in astruserie e, soprattutto, commettendo il grande errore di separare la poesia dal resto della letteratura. C’è differenza tra poesia e romanzo, ma parliamo comunque di due ragazze sedute allo stesso tavolo che si frequentano e si influenzano a vicenda, traendone beneficio. La mia impressione è che sia stato emesso un verdetto nei confronti della poesia, parte di un verdetto più generale nei confronti della letteratura, che la relega fuori dai giochi. Mi spiego con un esempio: in un racconto di Moravia di cui non ricordo il titolo c’è un personaggio spregevole e meschino e per farci capire quanto è ignorante, di lui Moravia dice che legge al massimo quatto o cinque libri all’anno, tutti gialli. Capisci bene che uno così nell’Italia del 2018 è un raffinato intellettuale! D’altra parte Moravia si sposa la Morante e va a cena con Pasolini: evidentemente è abituato a conversazioni altissime. Io che sono un uomo della strada mi rendo conto che la letteratura sembra essere morta anche come semplice evasione. Adesso l’oggetto libro è remoto alla maggior parte delle persone, qualcosa che non si sa bene come maneggiare. Non voglio essere spocchioso, ma credo sia indiscutibile. Questo relativizza le polemiche che leggiamo ovunque, sul web e sui giornali, anche se in misura molto minore rispetto a un tempo. È un dialogo tra morti. Siamo come i sacerdoti degli antichi dei quando si stava affermando il cristianesimo. Non ci rendiamo conto, non capiamo cosa porterà questa nuova religione. Chi parla di libri sembra non capire che è accaduto qualcosa che ha condotto il libro fuori dai giochi dell’umanità. La poesia vive al cubo questa situazione, forse perché non si possono trarre film o serie TV dai sonetti.
Non si annuncia nessun Dio all’orizzonte?
È un fatto economico. Una volta era un affare pubblicare una collana di gialli o di letteratura rosa, adesso semplicemente non lo è più. Chi cercava nei libri solo un’occasione per svagarsi, ora fa altro. Questo è centrale, perché toglie di mezzo il grasso della letteratura, quella riserva che permetteva l’emergere di qualche raro grande capolavoro. La letteratura non segna più la società, diventa astratta. Un editore vuole vendere, anche se poi misteriosamente non è che si sbatta più di tanto a promuovere i propri libri. Pubblica a grappolo poi qualcosa venderà da sé.
Come mi diceva Alberto Gaffi in Italia esistono duecentomila lettori dal dopoguerra, e quelli sono rimasti. Non sono affatto diminuiti, sono sempre i soliti. Si è ingrossata invece la schiera degli scrittori.
Questa cosa non mi indigna. Mi sento un lettore infaticabile. È anche vero che spesso intellettuali di vaglia ostentano un cinismo verso chi scrive che non è onorevole. Quando ho fondato la rivista on line “scrittinediti”, nei suoi primi anni di vita, ricevevo carrettate di materiale, che adesso non ricevo più perché la gente si fa il blog da solo, o si autopubblica. C’è una tendenza cristallizzata dal non mettersi più in gioco. Non rischiare nemmeno il verdetto di una redazione, il giudizio di terzi, di chi la letteratura la conosce perché ci lavora. È anche un fatto statistico, è ovvio che quest’oceano di materiale è costituito per lo più da cose mediocri. Scrivere deve essere un fatto consapevole, molto spesso non lo è, ma una volta che depuriamo il nostro giudizio da questa constatazione, il gesto di scrivere merita rispetto. Meno cinismo aiuta, anche a scegliere, anche a scovare frammenti lucenti nella porcilaia. Leggo molte recensioni poco argomentate. Le poco volte che si stronca lo si fa in modo offensivo. Si insulta l’autore. L’autore a sua volta si offende, inspiegabilmente, anche di fronte a perplessità legittime ed espresse in modo civile. La recensione che amo scrivere o amo leggere è fatta di argomentazioni. La stroncatura ha una sua onestà, certo, se fondata su fatti e analisi accurate. Un critico non è un oracolo che sputa parole d’oro, è uno che prima di tutto argomenta il suo gusto. Per questa ragione la recensione orienta la scelta: scelgo libri da leggere e film da vedere fidandomi della parola di un critico che mi piace. Bada bene: non tutti, ma quello con cui sento un’affinità, quando lo conosco abbastanza da capire che abbiamo giudizi comuni.
Il destino della letteratura c’entra con la morte ed è forse la ragione per cui la amo. La letteratura muore e parla della morte. Nei libri vediamo la morte al lavoro.
Cocteau diceva: “il cinema è la morte al lavoro”, perché vedi il tempo che agisce sui personaggi, sui paesaggi, sulle città. Adesso accade in modo evidente con le serie TV. Un adolescente cresce durante le stagioni e si fa uomo o donna. Ma anche in certi film. Penso a Sorelle mai di Bellocchio, un film straordinario, o a Boyhood di Linklater, la cui lavorazione è spalmata nel corso di anni, documentando la crescita di un attore. La letteratura ha filtri diversi. Un libro è un universo controllato. Su altra scala rispetto ad altre arti, il cinema, ma anche il teatro e la musica. La possibilità di controllo, rifinitura e cesello che ha la letteratura non esiste altrove. Anche se si parte con tutte le possibilità di averlo, il controllo. Ne hai gli strumenti: collaboratori, troupe, tecnologia. Eppure il controllo totale non potrai mai averlo. D’altra parte, e adesso mi contraddico, Tondelli amava le pagine che arrivavano in libreria ancora acerbe, dove sentivi la pennellata grumosa, dove percepivi l’intervento della realtà fuori controllo. In effetti la letteratura non si lascia catalogare in schemi certi.
Infatti sei un fanatico apostolo di autori anche molto diversi tra loro. Penso ad Antonio Moresco, che per te è un totem. Ma anche Emanuele Tonon. Ami gli scrittori che hanno una passione sensuale, carnale con la lingua: Amelia Rosselli, Dino Campana, Gianni Celati.
Sì, ma tieni presente che amo Moresco ma anche Stephen King. Se metto l’accento sugli scrittori che citi è perché spesso vengono definiti difficili e questa cosa mi manda fuori di testa. Non mi piace questa categoria, questa storia del libro difficile. In realtà le cose difficili non esistono, piuttosto ci sono testi che ci parlano immediatamente, ci raggiungono e ci ammaliano e altri che non ci dicono niente e spesso per ragioni che fatichiamo a definire. Posso innamorarmi di Sotto il vulcano e annoiarmi con l’Ulisse o viceversa ma credo che questo riguardi la mia sensibilità e disponibilità di lettore. Poi nutro forse un po’ di insofferenza per la struttura in tre atti, per una forma di romanzo che non si concede mai digressioni, perché sostanzialmente trovo puerile titillare il lettore con il solito bric a brac di colpi di scena e caratterizzazioni insistite. Detto questo, i miei romanzi penso si basino su una struttura solida e insieme testimoniano con una certa evidenza il mio amore per la narrativa di genere. Come lettore di narrativa, banalmente, cerco un testo che mi conquisti e io sono incline a lasciarmi conquistare da scrittori diversissimi fra loro: Volponi ma anche Carver, Tanizaki ma anche David Goodis, Willa Cather ma anche Renato Olivieri.
Sembra che tu abbia un’ossessione per la guerra. Usi metafore guerresche, nei titoli delle tue opere. Strategia di contenimento, Il bunker, Una guerra di nervi. Metafore cruente per parlare di sentimenti, pudori, ritrosie, consapevolezze amare. Eppure gli esempi di guerra guerreggiata del nostro tempo non ci mancano. C’è un dislocamento quasi fastidioso tra le gole sgozzate nei deserti, i bombardamenti governativi o alleati e il tuo canto: cupo, grigio e accorato. Come se le nostre civiltà acquisissero significato nel confronto con la barbarie. Nei tuoi versi c’è sempre questo iato. La voce di un’umanità che assiste alla storia e fatica a rendersi conto che ne è soverchiata e annichilita.
Sì, sono un uomo ossessivo e sono ossessionato dalla guerra. L’essere umano è naturalmente incline alla violenza e alla sopraffazione, siano esse espresse con forme attive o passive. Credo sia un po’ il sottofondo morale di tutto quello che ho scritto e, immagino, scriverò.
Un tema forte nelle tue opere è il sesso. O meglio la perversione. L’incontro carnale, sempre intrinsecamente allacciato alla partecipazione emotiva, mai gratuito, trova la sua forza fuori da sé. Nella violenza, negli oggetti, nel travestimento. Penso al ruolo che hanno le armi da fuoco o da taglio, nell’amore. Il gusto per il feticismo. La curiosità e l’attrazione per il mercimonio dei corpi. È una smania a volte divertita più spesso struggente, un’indagine, l’atto di un desiderio inesauribile di esplorazione.
Vado matto per i travestimenti. Una cosa che mi diverte molto è andare alle fiere del fumetto e guardare sfilare i cosplayer. Ho una mia personale classifica delle varie Wonder Woman che ho visto nel corso degli anni ma per delicatezza resterà segreta. Le serate fetish dei club privée e le riunioni di cosplayer si assomigliano tantissimo, pratiche erotiche a parte (nelle prime più o meno esplicite, più o meno mediate, nelle seconde sarei tentato di dire surrettizie). La tua domanda mi sembra faccia balenare un immaginario torrido e cupo e magari in parte è così ma credo che ne Il bunker come nel romanzo che sta per uscire questo aspetto, molto presente, è raccontato sotto una luce positiva, nel senso che i protagonisti sanno cosa gli piace fare in camera da letto, lo fanno e si divertono.
Leggendo le tue storie e le tue riflessioni sembra che il vero amore possa nascere solo con le puttane, in senso ampio. Come se con loro ci fosse una vicinanza, una similarità, che permette di essere pienamente se stessi. E sei convincente. Sgradevole e illuminante. Leggendoti ci riconosciamo tutti compromessi.
Ti confesso che non ho mai pensato un solo secondo in vita mia che il vero amore possa nascere con le puttane ma se questa è la lettura che emerge vorrà dire che dovrò essere più bravo in futuro. Sono ossessionato dalle donne disinibite e autoritarie, questo è vero. Ciò che mi attrae è il senso di completa libertà nell’intendere il piacere e il proprio corpo, come se fosse un segnale, rivelatore di una libertà più ampia del pensiero e dell’intelligenza. Riflettendo sulla tua domanda in modo più didascalico: essere se stessi in un rapporto mercenario non è una nota di merito. È la disinvoltura del cliente, il tipo più diffuso di italiano, arrogante e indisciplinato, incapace di stare un solo secondo in coda alla cassa del supermercato o alle poste senza scatenare un putiferio e di minacciare di adire alle vie legali con chiunque gli capiti a tiro. Se ci sentiamo noi stessi, liberi e in pace è perché mettiamo mano al portafoglio quindi possiamo pretendere pretendere pretendere, serenamente e senza nessun bisogno di mettersi in gioco. Allo stesso tempo la prostituzione, come la guerra, è una metafora facile e perfetta, anzi, è più che una metafora: io per esempio mi prostituisco e su questo non ho dubbi. Faccio un lavoro che mi piace ma se non avessi bisogno di soldi per mangiare, vestirmi e scaldare il mio appartamento sono quasi sicuro che farei altro. Anzi, ti dirò che quando rido con eccessivo trasporto alle battute del mio capo mi sembra di mimare certi manierismi da prostituta (“amore, tesoro, mi hai fatta venire, etc etc”).
Quale disincanto dobbiamo aspettarci da Giorni feriali? Quale ferita stai per infliggerci? O stai per darci una speranza?
Non lo so, sinceramente. È un librino piuttosto agile, spero divertente e sicuramente digressivo. Parla di un ragazzo che perde il lavoro e si mette nei casini, un tipo molto ordinario con una manifesta difficoltà nel dominare i propri sentimenti. Diciamo che dentro ci ho messo tutte le cose che amo di più e che più temo. In ordine sparso: la campagna ravennate, donne disinibite e autoritarie, i due Michael (Mann e Cimino), l’abbandono, la solitudine.
Simone Cerlini
L'articolo “Sono ossessionato dalle donne disinibite e autoritarie. E comunque, chi parla di libri è il sacerdote di una religione morente”: dialogo con Fabio Orrico proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2ugfvt4
0 notes