#dipinto fatto con la pasta
Explore tagged Tumblr posts
Text



Elice 🪁📸
#pensieri per la testa#persa tra i miei pensieri#fotografia#foto#scatto fotografico#dipinto#arte#esposizione#quadri#opere del territorio#Abruzzo#abruzzese#sagra della scrippella#elice#pasta#dipinto fatto con la pasta#dettagli#particolari#cultura#tradizione#tradizione popolare#elogio al territorio#agricoltura#ulivi
1 note
·
View note
Text
Resoconto Giorno 142
Ieri sera non riuscivo a dormire a causa di una voglia improvvisa di cioccolata e mi sono addormentata solamente quando ho finalmente mangiato uno snickers. Ho dormito abbracciando il cuscino.
Mi sono svegliata con Lola sulle gambe. Ho sognato di dire a Robb che lui è il mio migliore amico e lui mi diceva di essere il figlio di Roberto Baggio. Appena sveglia ho letto una poesia con Robb che si chiama Puntini in cielo, questa sera la commenterò. A lui non è piaciuta un sacco, forse non l’ha capita molto o l’ha letta nel momento sbagliato. Mi sono lavata e vestita, son proprio carina oggi ddddai. Babbo mi ha accompagnata da Imma verso le undici e mezza.
Sono stata aperta dalla nonna Maddalena che mi ha detto di trovare al piano di sopra Imma e la nipotina Martina che stava svolgendo i compiti. Appena ho visto Imma ci siamo salutate verbalmente e ci siamo messe a ridere per l’imbarazzo e la frustrazione per non poterci abbracciare. Siamo state a distanza e abbiamo tenuto la mascherina tutto il tempo igienizzandoci le mani quando necessario. Ho dato ad Imma il pensierino che le ho preso per Natale, la custodia per le AirPods e l’ha anche già messa. Pooooi mi ha dato il mio regalino che non mi aspettavo per niente, un piccolo gioco da tavolo di Harry Potter che ho scartato subito con le mani tremolanti. È bellissimo, lo adoro e credo di doverla ringraziare altre miiiille volte. Mi sono commossa, parte uno. Dopo aver salutato anche i gattini Cric e Croc abbiamo aperto il gioco di Harry Potter Trivial Pursuit e abbiamo giocato stando sulla scrivania.
Abbiamo iniziato a cucinare all’una e mezza stando distanti e attente a ciò che toccavamo e a disinfettare la spesa. I gattini Cric, Croc, Marroncina e Nerino ci sono stati tra i piedi e la nipotina di Imma ha giocato con loro per farci stare libere in cucina. Marti, questo il suo soprannome, mi ha raccontato dei suoi vari compagni di classe e mi ha elencato tuuutti i nomi eccetto due che proprio non riusciva a ricordare, li abbiamo ripetuti tutti tre volte dimenticandone sempre due. Ma io ero curiosa di sapere i due nomiiiii. Mi ha parlato di una bambina, Morena, che proprio non vuole esserle amica e la tratta quasi male, mentre invece con Giovanna ha un rapporto speciale e dice di essere la sua migliore amica. Abbiamo iniziato a mangiare alle tre. Abbiamo portato i piatti al piano di sopra in cameretta per non mangiare in sala da pranzo con la mamma e la nonna.
Eravamo tutte super attente e giusto un po’ esaurite, soprattutto la nipotina che voleva abbracciarci e starci vicine. Mi ha scritto una letterina Marti dove dice che non vede l’ora di abbracciarmi e baciarmi, che sono dolce e simpatica, che vuole conoscere Lola e che mi farà conoscere il suo cagnolino Rocky. Mi sono commossa, parte due. Abbiamo finito di mangiare alle quattro. Abbiamo giocato di nuovo al gioco di Harry Potter girando un video per tutto il tempo da tenere per ricordo e pooooiii abbiamo dipinto i barattoli di vetro dove metterci i bigliettini con le cose positive che accadranno a noi e nel mondo nel 2021, speriamo di riempire tutto il barattolo. È un’idea carina, a fine anno abbiamo poi intenzione di aprirlo e rileggere tutto. Nel mentre abbiamo chiacchierato, ascoltato canzoni, riso parecchio e finito Enola Holmes che abbiamo iniziato insieme a settembre e mai concluso. Abbiamo dipinto l’interno dei barattolini di azzurro e il tappo di blu. Ora dobbiamo solamente creare una targhetta da applicare sopra.
Alle sei del pomeriggio ho chiamato tre pizzerie per la cena della sera e finalmeeente dopo varie telefonate sono riuscita ad ordinare. Abbiamo continuato a fare i barattolini e ad ascoltare musica, poi Marti è andata via e io e Imma abbiamo parlato da sole. L’ho aggiornata sulle ultime novità, specialmente della mia confusione nella testa e mi ha ascoltata, mi ha dato il suo parere e mi sono sentita più libera. Credo di star facendo pian piano ordine mela mia testa e che le cose che fluttuano siano sempre più vere, me ne accordo da modo in cui ne parlo. Sorridevo da sotto la mascherina ed è sicuramente un segno. Durante il pomeriggio ho anche sentito mia mamma e mio padre al telefono. Mamma ha detto che hanno portato Lola dalla toelettatrice e questa detto che dobbiamo portarla urgentemente dal veterinario per un problema agli occhi. Papà invece voleva una mano per ordinarsi la cena, ma si è organizzato troppo tardi e alla fine ha cucinato un piatto di pasta. Alle nove meno un quarto è arrivato il fattorino delle pizze, senza mascherina tra l’altro, e aveva anche dimenticato il resto dei soldi così è tornato indietro a prenderlo e quando la seconda volta che è venuto me l’ha dato, una volta dentro casa mi sono accorta di aver ricevuto molto di più di quello che dovevo avere. L’ho richiamato quindi ed è ritornato indietro per prenderlo. Ci siamo congelate. Abbiamo cenato di nuovo in cameretta. Abbiamo preso due pizze da dividere a metà e una con la nutella che non abbiamo proprio toccato, se non una fettina piccola. Era buonissima la pizza.
Sono stata benissimo. Imma mi mancava parecchio e sinceramente anche se abbiamo passato una giornata strana e diversa dalle solite per me è stato come sentirmi a casa, normale. Non ci vedevamo da tre mesi, ma è stato come se non ci vedessimo da un giorno. La amo tantissimo e sono fiera di ciò che siamo, di ciò che è. Cucciola.
Alle nove e mezza papà è venuto a prendermi e in macchina abbiamo parlato di lavoro. Gli ho detto che dalla settimana prossima lavorerò quattro giorni alla settimana fissi dalle tre del pomeriggio per poi tornare alle dieci di sera a casa. Inizierò a lavorare con un nuovo bambino per cui già so che dovrò avere il triplo della pazienza di quella che già ho. Mi ha fatto piacere parlarne con papà. Tornata a casa ho salutato la mia Loletta, l’ho riempita di coccole e ho dato la notizia anche a mamma. Struccante, crema viso, pigiama caldo e letto. Ho un mal di testa assurdo e le mani congelate, non riesco a scrivere. Imma mi ha restituito un libro che le prestai tempo fa, si chiama Notti in bianco baci a colazione di Matteo Bussola. Insomma ho aperto la prima pagina e ho trovato un pensierino scritto da lei questa mattina. Mi sono commossa, parte tre.
Ora è arrivato il momento della poesia, Puntini in cielo. Marco Gregò, l’autore, parla del cattivo umore che all’improvviso ci coglie inaspettatamente e ci smuove tutto il corpo a partire dalle ossa per finire alla gola e salire alla testa. Quel malumore che ci fa sentire stupidi e incapaci di domarlo come lui fa con noi. Racconta di come a causa di questo porta sulla pelle e nella sua vita i segni di tali momenti di sconforto ma che nonostante questi continua a sognare in grande e continua ad aspirare a diventare come le stelle, forti e luminose. Robb ha detto che ora l’ha capita di più. L’ho sentito poco oggi, ha detto che ha iniziato la nuova stagione de L’attacco dei giganti che devo assolutamente vedere anche iiiiooooooo urlooooo.
Mi frugherei dentro entusiasta
Come un bambino
che deve scegliere
In una certa di regali,
Direi questo lo tengo
Questo lo butto,
Proverei ogni mia parte
Del mio bullo disagio,
Gli direi ehi bello
Non sei stanco?
16 Gennaio
#diario#resoconto#giornata#gennaio#amicizia#migliore amica#harry potter#gioco#Enola Holmes#regalo#abbracci#baci#lavoro#poesia#poesie#malessere#malumore#amore#volersi bene#matteo bussola
5 notes
·
View notes
Text
From Fake Lovers To Friends... - Pt. 5
Beh che direbbi follettini e follettine a volte ritornano e quindi eccomi qui a ritornare, sì, ritornare dall’oltretomba con questa au ancora in sospeso che mi tormenta da un bel po’ quindi RICAPITOLANDO: abbiamo lasciato i nostri due fake piccioncini in un bell’impiccio... per cui tempo di levarglielo! Trovate qui le vecchie parti uno due tre e quattro .
Buona lettura!
Ermal sta nervosamente seduto al tavolo del ristorante prescelto, un localino piccolo ma ben tenuto, dagli interni colorati che danno allegria, nonostante il tempo fuori dalla finestra sia quello uggioso e grigio tipico dell’inverno
Il tragitto è stato, fortunatamente, breve e privo di intoppi: non hanno avuto occasione di parlare, tutti stretti nelle loro giacche e con i baveri alzati nel tentativo di proteggersi dal vento gelido che gli sferzava il viso e questo era un vantaggio perché si erano risparmiati qualche minuto di chiacchiere per raccogliere i pensieri, ma anche uno svantaggio perché comunque lui e Fabrizio non erano riusciti a scambiarsi almeno due parole per mettersi d’accordo sulle cose
Gent e Eleni avevano fatto strada, il primo che continuava a voltarsi per sorridergli incoraggiante, gioioso ed entusiasta del suo apparente successo nella vita amorosa, mentre la seconda aveva scelto di non degnarli di uno sguardo anche se Ermal sentiva comunque la sua attenzione catalizzata sui loro movimenti
Aveva quindi stretto maggiormente la mano di Fabrizio, avvicinandosi a lui come nel tentativo di proteggersi, e anche se gli occhi gli lacrimavano per l’aria fredda era riuscito a scorgere da parte dell’altro un silenzioso “oh ma t’apposto?” che gli aveva attraversato il viso. E non in senso ironico: sembrava genuinamente preoccupato per lui. Non vi aveva però dato poi troppo peso: ora gli interessava superare indenne quel pranzo e se anche Fabrizio era carino a preoccuparsi non era lui quello che rischiava la dignità di fronte a un’intera classe universitaria o peggio, università, perché sapeva che sarebbe finita con Eleni che avrebbe diffuso la voce della sua cazzaraggine pure al polo di chimica dove non lo conosceva nessuno
Ermal Meta, il cazzone di mediazione linguistica
E non in senso buono
Solo il pensiero gli faceva venire voglia di chiedere a fabrizio il favore di metterlo sotto
Con la macchina, s’intende (anche se io al tuo cervello Ermal darei un premio per l’idea e la accetterei e non in senso della macchina)
Una volta entrati nel posto-dove grazie al cielo un piacevole tepore li aveva accolti, anche se per quanto si stava agitando ad Ermal sembrava di stare in una sauna tanto che si era tolto giacca e felpa all’immediato- e accomodatosi ognuno a un lato del tavolino quadrato, Ermal si era subito nascosto dietro al menù, cercando di rimanere calmo
Nota, mentre osserva le scritte senza vederle davvero, la mano di Fabrizio sul tavolo accanto a se. Mano che aveva lasciato andare per levarsi la giacca e che, in un impeto di panico, riprende, incastrando le dita tra le sue.
Fabrizio lo guarda, anche se non si oppone al gesto, cercando di capire se vuole o meno dire qualcosa.
Ermal apre la bocca, per poi bloccarsi: come lo deve chiamare? Tesoro? Amore? No, non lo farebbe mai. Nemmeno se lo amasse davvero. Sarebbe troppo ridicolo da parte sua. Però, di certo non lo può chiamare Fabrizio o una cosa stupida tipo “Fab”-che schifo di nomignolo gli fa proprio ribrezzo, per uno che studia l’inglese poi...Ma gli serve un soprannome però. Una cosa carina. Una cosa intima. Qualcosa di loro. Come cazzo lo abbrevia il nome Fabrizio? Dio santo e si che fa lingue dovrebbe essere capace di giocare con le parole. Fa-bri-zio. Fab. Zio. Seh va beh J-Ax. Fabbri. Stronzo-di-merda. Aiutami-cazzo. Smettila-di-fissarmi-come-se-stessi-avendo-un-embolo. Brizio. Che cazzata no è meglio-
“Bizio” dice, aprendo la bocca e dicendo la prima cosa che gli viene in mente a quel punto visto che il silenzio si stava facendo troppo lungo e pesante “Che cosa prendi tu?”
Fabrizio, per fortuna, appare perplesso ma non troppo, e non si scompone all’uso del soprannome, preferendo arricciare piano il naso facendosi venire una rughetta in mezzo agli occhi mentre guarda il menù con rinnovata concentrazione, studiandolo per qualche secondo prima di dire “la pasta con le vongole” con una scrollata di spalle mentre ripiega la carta “E tu?”
“Anche io” replica Ermal che non ha voglia di pensarci, chiudendo tutto
Osserva le dita di Fabrizio che giocherellano con le sue, il suo pollice che scorre con dolcezza e delicatezza sul dorso della sua mano
Alzando lo sguardo trova Eleni che li studia con gli occhi appena socchiusi, cercando di vedere l’inganno che è convinta che portino avanti, mentre Gent sembra più sul punto di sprizzare cuoricini e fiori da ogni poro
“Bizio” ripete lei, quasi come a dire “ma davvero Ermal?” e poi però sorride
“allora... come vi siete conosciuti voi due? Immagino che Ermal ti abbia parlato di me e Gent. Siamo suoi compagni di corso”
Ermal sente il sudore freddo iniziare a scorrergli sulla schiena ma Fabrizio sorride e annuisce appena
“M’ha accennato qualcosa sì. Noi due... ci siamo conosciuti a una festa l’anno scorso. Francesco ci ha messo in contatto poi” sorride Fabrizio e Ermal sente un’ondata di sollievo al pensiero che la versione abbozzata sembri stare in piedi e sopratutto che Fabrizio la ricordi
“Capisco...” replica lei piano “E da quant'è che state insieme, esattamente?” chiede Eleni serafica, posandosi il viso sulle mani curate ed elegantemente intrecciate
“Qualche mese” risponde Fabrizio subito, lanciatissimo
“Qualche settimana” replica Ermal all’unisono con lui
Si guardano, in panico, l’orrore dipinto nei loro occhi prima che Ermal si dia un contegno e si metta a ridacchiare nervosamente “Insomma, chi tiene il conto... saranno un paio di mesi o giù di lì...” balbetta con Fabrizio che poi lo guarda
“Io ‘o tengo il conto” replica come se fosse offeso del fatto che lui non lo faccia “so quasi tre mesi”
“Aaaaaaw che cosa dolce” dice Gent all’immediato guardando Fabrizio ormai circondato da una nuvola rosa di cuoricini e zuccherini. Questa è una di quelle sdolcinerie che, Ermal lo sa bene, a lui fanno impazzire di tenerezza. E che invece a lui disgustano quindi ha senso che sia Fabrizio a ricordarselo
“Adorabile” commenta Eleni anche se è impassibile come non mai mentre lo dice
Per fortuna la conversazione viene interrotta dal cameriere che viene a prendere i loro ordini, con gran sollievo di Ermal che così si evita qualche altre domanda.
Peccato che duri poco
Decisamente troppo poco
Perché una volta che i menù sono stati tolti dal tavolo e le bibite sono state invece servite, Eleni riprende la conversazione
“Certo che, perdonami se mi permetto, ma tu e Ermal sembrate proprio due persone completamente diverse. Insomma siete... quasi opposti. Come mai vi trovate così bene insieme? Voglio dire tu sembri molto... rilassato e gentile e romantico e Ermal è... beh, Ermal”
“Forse” la rimbecca Ermal scocciato da quella domanda e dal modo in cui è stata posta “mi piace stare con qualcuno che sia l’opposto di me perché così non devo sopportare un’altra piccola, arrogante e saccente versione di me stesso” soffia, lanciandole una palese frecciatina
“Stronzo” sibila Eleni mentre Fabrizio, stupito dal suo tono tanto stizzito e acido, gli poca delicatamente una mano sulla schiena, carezzandola per calmarlo, quasi istintivamente
Gesto a cui Ermal si trattiene dallo scostarsi ma non riesce comunque a trattenere una leggera smorfia
“Il fatto è” mormora Fabrizio dopo un istante di silenzio in cui gli altri due si squadrano in cagnesco e anche Gent guarda ermal con uno sguardo stupito e ferito “Che credo che io e Ermal ci somigliamo più di quanto si pensi a prima vista. E invece dove nun ce somigliamo proprio pe’ niente famo come ‘na sorta de equilibrio no? Quindi funziona” spiega, aggrottando appena la fronte nella concentrazione, una rughetta che gli si forma tra gli occhi mentre parla ed Ermal la guarda e la trova adorabile
“Penso che in fondo ci bilanciamo bene. Tutto qua” conclude poi scrollando serenamente le spalle e aprendosi di nuovo in un sorriso
Ermal, per quanto lo riguarda, se non fosse troppo impegnato a guardarsi brutto con Eleni e fosse un po’ più concentrato sulle sue parole potrebbe perfino baciarlo per quel che ha detto.
A noi non dispiacerebbe comunque
“A me invece sembrate proprio due persone diverse e incompatibili” replica Eleni, guardando Ermal come se fosse pronta a rubare l’insalatiera del tavolo accanto e a tirargliela in faccia “O almeno, tu Fabrizio non sembri per niente una testa di cazzo”
“Sei proprio insopportabile quando vuoi” Sbotta Ermal, alzandosi di scatto dal tavolo, innervosito anche fin troppo “Fabrizio, andiamo via!”
No, va bene tutto, ma non starà a quel tavolo a farsi insultare da quella che un tempo era la sua migliore amica
Un drama e un problema alla volta, grazie
“Ma” balbetta fabrizio, alzandosi però dal suo posto “Il pranzo... ‘a pasta...”
“Lo vedi? Sei sempre il solito bambino egoista e capriccioso! Dovevi per forza rovinare anche questa cosa, vero Ermal?” sbotta lei, alzando appena la voce, cosa che attira gli sguardi degli altri clienti, perplessi “Per dimostrare che cosa poi lo sai solo tu. Stupido!”
“Vaffanculo Eleni! E vaffanculo anche il pranzo. Ho perso l’appetito” sbotta lui, mettendosi il cappotto rabbiosamente e mancando la manica due volte mentre si dirige verso l’uscita senza nemmeno guardarsi indietro, puntando poi convinto verso la spiaggia
Alle sue spalle, sente Fabrizio scusarsi di qualcosa e poi chiamarlo, ma quando la sua voce viene attutita e rinchiusa nel locale dalla porta che si serra alle sue spalle, Ermal non ci fa caso, continuando la sua rabbiosa camminata
Il vento freddo continua a sferzargli la faccia, ma dubita che questa volta le lacrime che gli appannano gli occhi siano dovute a quello
Si sente un idiota, ora come ora
Un idiota ferito, oltretutto
Perché sì, era preparato ad Eleni che gli avrebbe rotto le palle, certo, ma non era pronto per quello. Non era pronto per un litigio subito, per gli insulti, per il rivangare quella cosa che non aveva mai capito a cosa fosse dovuta, ma di cui lei lo accusava
Rovini sempre tutto. Rovineresti qualsiasi cosa lasciandotelo fare, per questo devi stare lontano dalle cose belle, perché rovini tutto aveva detto una sera, rabbiosamente, squadrandolo mentre se ne stava mezza ubriaca ad una festa E a te nemmeno importa.
Ermal non aveva mai capito cosa volesse dire. Non le aveva nemmeno fatto nulla quella sera dal suo punto di vista
Se ne era stato quasi sempre per conto suo, scambiando poche parole con alcuni amici, e basta
E lei se ne era uscita così
Avevano litigato quella sera.
Lei non se lo ricordava nemmeno bene il giorno dopo, ma lui sì.
aveva fatto finta di niente attribuendo tutto all’alcol ma ora invece si rende conto che non doveva essere stato quello l’autore di quelle parole.
Tira su con il naso, andando rabbiosamente a sedersi sulla sabbia umida e fredda, incurante del freddo e dei propri pantaloni che si sporcheranno di sicuro così
Guarda il mare gonfiarsi, plumbeo mentre riflette il cielo invernale, senza riuscire a pensare a nulla.
Forse Eleni ha ragione
Forse ha davvero rovinato tutto
Sì, ma tutto cosa?
Ermal quello non lo sa. Si stringe solo le ginocchia al petto, rabbrividendo, cercando un modo per scacciare la famigliare sensazione delle lacrime calde sul viso, che sotto al vento gelido sono quasi dolorose sulle sue guance gelide.
Sente uno strano formicolio al petto, come se qualcuno vi stesse punzecchiando e scavando, cosa che lo fa appallottolare meglio su se stesso
Una parte di lui vorrebbe sapere ma un’altra parte ha paura di farlo.
“Ao”
Si distoglie dai suoi pensieri e da quell’ultimo litigio quando qualche altro minuto dopo una voce roca e attutita appena dal vento ma dall'inconfondibile timbro e accento romano si fa sentire alle sue spalle.
Si volta, trovandosi davanti Fabrizio che lo squadra, preoccupato
Si fissano, ed Ermal odia farsi vedere mentre piange per cui si asciuga il viso nelle maniche con foga, ignorando il grattare della sabbia
“posso?” chiede Fabrizio indicando lo spazio libero al suo fianco, cosa che gli fa guadagnare un cenno di assenso e un nuovo tirare su con il naso da parte di Ermal
“nun piangere dai” bisbiglia gentilmente mentre si lascia cadere sulla spiaggia a sua volta, tendendogli un fazzoletto che Ermal accetta di buon grado per asciugarsi il viso e soffiarsi il naso
“non sto piangendo” mugola, lamentoso, cosa a cui Fabrizio reagisce annuendo e guardando davanti a sé
“Ah avrò visto male” replica innocentemente e restando qualche minuto in silenzio prima di mormorare “stai bene, sì?”
“Benissimo” ribatte Ermal, sarcastico “Bene come una merda” precisa, lasciandosi poi sfuggire un sospiro mentre appoggia la fronte contro le ginocchia “scusa” mormora poi “non ce l’ho con te, davvero. Non così tanto almeno” balbetta stancamente, facendo poi un lungo sospiro
“Sei stato carino, prima” soffia poi “Grazie. Per aver detto quelle cose e aver.. insomma, arginato il danno” sbuffa piano cosa a cui Fabrizio-che si è ormai girato verso di lui-risponde con un leggero sorriso
“Te pare” dice scrollando appena le spalle “Però ‘o penso davvero sai. Che potremmo essere più simili di quel che credi” mormora poi dopo un istante aggrottando appena la fronte di nuovo, concentrato “’O so che ti da fastidio la mia presenza ma me dispiace se stai così e... insomma, vorrei fa qualcosa. Davvero io... me sembri na brava persona Ermal. Nun so che è successo co’ Ilenia là, ma so sicuro che nun è nulla de irresovibile e... se ne vuoi parlare, io so qua. Magari non sono bravo a dare consigli, però me farebbe piacere. E se tu non volessi parlarne... l’offerta del pranzo è ancora valida, se ti va. Ce andiamo a fa’ ‘n giro e te compro un panino. Che dici?”
Ermal lo ascolta, in silenzio, e quando finisce rivolge lo sguardo al mare, senza dire ancora nulla per qualche istante.
Sente le tracce umide sulle guance ormai fredde a quasi asciutte e dopo un altro lungo minuto annuisce, tirandosi appena su
“mi va, un panino” dice solo
Fabrizio sorride, tirandosi su a sua volta, in piedi
“Bene. Andiamo allora” gli dice
E quando gli tende la mano, Ermal esita solo un istante prima di prendergliela mentre sorride “Dai allora andiamo... Bizio”
#ermal meta#fabrizio moro#eleni foureira#eugent bushpepa#metamoro#metamoro fandom#metamoro writers#metamoro ff#metamoro fanfiction#metamoro hc#metamoro headcanon#metamoro teen au#metamoro teen#metamoro au#metamoro ship#metamoro prompt#metamoro request#metamoro anon#from fake lovers to friends to lovers#metamoro fake relationship#fake relationship#teenage love#teenager au
71 notes
·
View notes
Text
Mi sono innamorata di te dalla prima uscita, ricordo che ero rimasta in macchina con la crema della fissan in mano e ti guardavo di nascosto mentre prelevavi al bancomat e ho pensato “cazzo ti aspetto da sempre”, ecco lì in quel momento mi sono resa conto che mi avresti stravolta, che le gambe non mi erano mai tremate così forte, che non mi ero mai sentita in imbarazzo davanti a nessuno eppure con te dovevo abbassare lo sguardo per non diventare rossa, non riuscivo a guardarti in faccia da quanto eri bello, così, con i capelli messi male e quegli occhi grandi in cui sono caduta dentro con una velocità che mi ha spaventata dall’inizio. Mi ricordo ancora di quando hai cucinato per me e per la prima volta non ho messo becco, ti guardavo, era così bello che qualcuno volesse fare qualcosa per me, non avevo bisogno di dire niente i miei occhi hanno sempre parlato troppo con te, poi le risate, quante, il mio modo di pesare la pasta con le mani senza la bilancia “perché se il sacchetto è 400gr metà dovrebbe essere 200gr” e mi si era chiuso lo stomaco da quante emozioni stavo provando pur non volendo provarle; poi quella domanda “posso baciarti?”, il mio scoppiare a ridere in imbarazzo e tu che mi hai stretta forte e in un secondo eravamo noi, combaciavi perfettamente con il mio corpo. Mi fai venire voglia di stare ore dietro a un muretto a guardarti giocare perché non ho trovato l’entrata della scuola, mi fai venire voglia di fare tutte quelle pazzie che sono anni che non facevo più, venire sotto casa tua di notte nonostante ci sono 110km solo per dirti che ti ho portato la panna cotta ai frutti di bosco. È tutto travagliato, siamo uguali da far paura ma c’è una cosa che non ti ho mai detto “non so come hai fatto, ma hai dipinto il buio”.
2 notes
·
View notes
Text
Les Beaux Souvenirs
Il mio nome è Alessia.
Ho venticinque anni, e ho lasciato casa quando ne avevo ventidue. Mi ricordo bene quel giorno, dopo l’ultima litigata di troppo. Scatoloni, valigie. Mamma era arrabbiata, piangeva perché diceva che nonostante tutte le volte in cui mi aveva urlato di andarmene via da quella casa, che non mi sopportava, in fin dei conti voleva che fosse papà ad uscire una volta per tutte dalla porta della nostra casa a Cassano.
Nei bagagli ci avevo chiuso la rabbia, la tristezza, la delusione e la paura. Ricordo bene quella sensazione che avevo durante quelle due settimane che passai a cercare un posto per me. Ricordo bene che alla fine ero arrivata a non riuscire a provare più nulla.
Fortunatamente avevo un po’ di soldi da parte, papà e mio zio mi aiutarono col trasloco. Trovai una casetta in affitto, tanto minuscola quanto graziosa, quello che da sola potevo permettermi. Quello che pensavo mi avrebbe aiutata ad affrontare quella cosa troppo grande per me, quella cosa che a casa con i miei mi sfiniva. Quel vuoto gigantesco che provavo ogni volta che varcavo la porta. Un posto da chiamare “casa”, perché casa è dove stai bene e io sotto a quel tetto non riuscivo più a starci, perché il silenzio a volte riesce a fare un rumore davvero insopportabile. C’era tanto freddo quando cenavo da sola. A casa nostra le cose che anziché essere urlate per essere sistemate venivano dette di nascosto, tra gli sbuffi e gli occhi che si giravano al cielo.
… Ma io “posso fare di meglio”. Mi ripetei questa frase centinaia di volte, e mi promisi che avrei creato quella cosa che mi era venuta a mancare in modo così progressivo e forte… anche se la vita è sempre piena di sorprese, e nulla va mai, mai, mai come pianificato. Vivere da sola era tutto sommato piacevole, anche perché in fin dei conti da sola non lo ero quasi mai. L’entusiasmo mi aiutava a distrarmi dalle cose che non andavano e mi godevo il fatto di poter fare tutto quello che volevo, di non dover chiedere, di pescare sempre dal mazzo delle “probabilità” e quasi mai degli “imprevisti”.
Quasi mai.
Luglio 2016.
Una telefonata da papà, con la sua solita voce canterina, mi disse che era a Milano con mamma. Stavano mangiando una pizza insieme da Pizza Big, in viale Brianza. “Stiamo festeggiando le s-nozze!”. Erano appena stati dall’avvocato a firmare le carte per la separazione, e trovavo tanto buffo quanto delirante il pensiero che fossero a pranzo insieme a festeggiare. Quando uno pensa a una separazione pensa a tutto fuorché un pranzo di festeggiamento con il proprio ex marito o ex moglie. Ma noi le cose le abbiamo sempre fatte così, controcorrente, a modo nostro.
E quando parlavo di voi, nessuno poteva credere a quello che era successo. Nemmeno io, che ci avevo convissuto in mezzo per così tanto senza sapere che fare per aiutarci. E me ne sono sempre fatta una colpa, e per sempre me la farò, anche se chiunque dice “non dipende da te”, “i figli non c’entrano niente”, “è stato meglio così”, “vedrai che le cose miglioreranno adesso”.
Quante volte ho dovuto dare giustificazioni, quante volte ho dovuto spiegare alle persone. Alla gente. Mi è stato detto che ormai ero grande, che ormai avevo la mia vita e dovevo pensare a me. Che voi ci sareste sempre stati, ma in modo diverso. E davvero, ho pensato a lungo a che cosa cazzo potesse significare “in modo diverso”. Per me, un modo diverso non poteva esistere. Quante frasi ho sentito, e mi arrabbiavo. Ci rimanevo male. Cercavo di ascoltare, di dare un senso ai consigli e alle frasi di merda che mi si abbattevano addosso come grandine, sono arrivata a sentirmi una gran cogliona perché a quanto pareva non ero capace di camminare dritto senza voltarmi. Finché un giorno, satura, mi sono chiesta… in fondo, che ne può sapere la gente? Dall’esterno è sempre tutto semplice, tutto scontato, tutto regolare. E per far pace con l’esterno mi sono costruita un bel muro senza porte, senza finestre, e ci ho dipinto sopra una bella faccia sorridente.
Va tutto bene.
Va tutto bene un cazzo.
Ci sono cose che a parole non sono mai stata capace di esprimere, e mai ringrazierò abbastanza quei pochi che hanno percepito senza che io parlassi. Non c’è una forma per buttar fuori tutto quello che ho visto, quello che ho sentito, quello a cui ho assistito senza poter farci niente. Quello che ho assorbito. Non c’è.
In questi anni mi sono sempre chiesta se ogni tanto ci ripensate ai “beaux souvenirs”.
Ricordo ancora di quando mamma rideva per le cose buffe che faceva papà. Quel matto una sera preparò la polenta e facendo finta di inciampare la rovesciò sul tavolo di marmo e coperta di ragù, quello buono che fa lui quando è ispirato. Andrea era sconvolto. Mangiammo direttamente dal tavolo, con la regola che non si poteva arrivare a mangiare le salsicce che stavano in centre se non scavando e mangiando anche la polenta che ci stava intorno.
Ricordo quando dormivamo tutti e quattro nel lettone, nella nostra prima casa. Mamma guardava “C’è posta per Te” e papà faceva il dromedario prendendo me e Andrea sulla schiena, poi una volta sotto le coperte faceva le puzze e ci chiudeva sotto le lenzuola urlando “Sommergibile!”… Mentre la mattina invece aveva l’abitudine di rotolare da una parte all’altra del letto facendo da rullo e schiacciandoci tutti con il suo dolce peso. Insomma, andare a dormire in modo normale non era neanche lontanamente contemplato.
Nel periodo in cui papà stava iniziando davvero a perdere tutti i capelli chiedeva ad Andrea come fosse la situazione sulla sua testa… un giorno per non farlo rimanere male gli disse “Papà, hai tanti capelli pochi”.
Per le cose di scuola ci aiutava sempre mamma. Ci insegnò a leggere e a scrivere prestissimo, ancora prima di andare all’asilo, e quanti compiti ci aiutò a fare… quanti capitoli le abbiamo ripetuto la sera prima di andare a letto per le interrogazioni del giorno dopo, e la cosa divertente era che ci stava per davvero ad ascoltare… pagine e pagine e pagine noiose, ma non ricordo di una volta in cui si addormentò col libro in faccia. Ascoltava per davvero, e ci correggeva se sbagliavamo… sempre a suo modo, nei compiti come nella vita.
Le estati si passavano al mare, ad Alassio, con mamma e Andrea. Papà lavorava e nei primi anni ci veniva a trovare nei week-end e noi non aspettavamo altro che quei giorni per fare i tuffi con lui. Finché un anno smise di raggiungerci ma ci telefonava, ci telefonavamo sempre, ancora quando non c’erano i cellulari e andavamo con mamma alla cabina telefonica e lei prima di prendere in mano la cornetta disinfettava tutto con le salviettine antibatteriche e ci raccomandava di non appoggiarci comunque l’orecchio perché si prendevano le malattie. La maniaca. Un estate portammo a casa dei pulcini vinti al luna park, che nel giro di qualche mese diventarono due paperone gigantesche. Mentre eravamo al mare papà riuscì ad addestrarle e a non farle più starnazzare dalle sei del mattino come erano solite fare, ma quando tornammo mamma corse loro incontro urlando “BELLE PAPEROTTE!!!” e queste ripresero a far macello come sempre. Ci intasarono con la cacca tutto il pozzo del cortile.
Papà a volte tornava a casa con il Fiat Doblò del lavoro, e ci faceva salire nel portabagagli. Chiudeva me e Andrea dentro e iniziava a guidare a zig zag per tutta la via… e che testate che prendevamo lì dentro. Ridavamo fino a piangere. Un giorno però non tornò col Doblò. E nemmeno con la sua moto. Arrivò a casa con un camper gigantesco, a noleggio, dicendoci che avevamo un’ora per prepararci. Non avevamo mai fatto un viaggio in camper e Mamma voleva preparare la valigia. Mi disse di portare il costume per fare il bagno in mare… ma andammo in Umbria. Visitammo un milione di chiese, una gran rottura di palle. Mamma raccolse dei girasoli enormi e li mise in bagno, che già era minuscolo, e quando facevamo pipì ci graffiavamo il sedere contro. Andrea e io ce la facemmo sotto dal ridere quando papà alla prima esperienza nell’area di sosta invertì la canna dell’acqua per pulire lo scarico del wc con quella dell’acqua potabile. Ci lavammo i denti per quattro giorni con l’acqua in bottiglia. Eravamo così ben organizzati che una sera ci fermammo a una festa di paese a prendere da mangiare e quando arrivammo al camper ci ricordammo di non avere le posate; finì che mangiammo la pasta con le mani. L’ultima sera ci fermammo in un agriturismo in mezzo al nulla, ricordo il cielo di quella notte, ricordo le stelle cadenti, ricordo di averne viste tante. Ricordo che poi non riuscii a vedere più nulla perché per l’emozione mi si erano riempiti gli occhi di lacrime.
Papà oggi mi racconta di aver vissuto tre vite. La prima quando era piccolo, la seconda con noi, e la terza dopo la separazione. Si è trasferito a Milano, dove sta bene ripensando di aver fatto una vita da pendolare mentre ora impiega un quarto d’ora ad arrivare al lavoro. Ha ritrovato la sua dimensione e uno spazio dove potersi esprimere e fare quello che gli riesce meglio, accogliere le persone a cui vuole bene e farle sentire come a casa. Andrea lo ha seguito poco dopo.
Mamma oggi sta, dice sempre di non farcela ma alla fine se la cava sempre, perché è una testa dura e se si mette qualcosa in testa ci arriva, ci arriva sempre, con la sua determinazione. Ci scontriamo ancora oggi, come da sempre e per sempre, anche ora che non viviamo più insieme. E lo sa che anche se quando ci incazziamo e litighiamo e mi blocca su WhatsApp, la penso sempre. Quando eravamo piccoli faceva un sacco di foto. Noi ci lamentavamo e lei rispondeva sempre che un giorno, quando le avremmo riguardate, la avremmo ringraziata… e quanto avevi ragione mà. Mi sembra che di quella vita mi siano rimaste nient’altro che centinaia di cartelle sull’hard disk.
Chiunque ci invidiava. O almeno, invidiava quello che mostravamo quando eravamo con gli altri.
Di quel brutto male che ci stava consumando, disgregando, sgretolando non se ne accorgeva nessuno. A volte nemmeno io e forse nemmeno voi, ma è arrivato e si è portato via il nostro nido. Ha distrutto i miei pilastri e se è vero che col dolore prima o poi ci si impara a convivere, almeno mi pagasse l’affitto. Almeno quello.

53 notes
·
View notes
Text
Di quando conoscemmo Alëša
(Romania on the road - quarta puntata)

Il 2 agosto mia sorella e mia cugina si trovavano in Sardegna, beatamente spaparanzate in acqua. All’improvviso si è avvicinato un gruppo chiassoso di ragazzine, età scuole medie. “Scusate”, gli hanno detto, “ma voi la conoscete Chiara?”
“Chiara chi?”
“Chiara Ferragni!” saltellavano su e giù nell’acquetta. “Sappiamo che sta in vacanza in Sardegna…e magari chissà, è proprio lì, su una di quelle barche!” Poi la proposta: “Dai, vi va di aiutarci un secondo a gridare tutte insieme Chiaraaaaa! così se per caso è su quella barca ci sentirà?”
….
Ogni giovane che si rispetti ha i suoi idoli. E sogna di incontrarli. Di scambiarci due parole. Anche solo “Ciao come stai”. Di toccarli nella loro fisicità.
L’idolo può essere un modello da imitare, o al contrario una persona che affascina proprio perché è inimitabile, irraggiungibile, strutturalmente diversa dal giovane che la idolatra: “la nostalgia del Totalmente Altro”, direbbe Horkheimer.
Ora, incontrare dal vivo Chiara Ferragni, o persino Leonardo di Caprio o Johnny Depp, non è un’operazione facilissima, ma è pur sempre virtualmente possibile. Quelle ragazzine della Sardegna, nella loro melensa omologazione, si erano ritagliate pur sempre una minuscola possibilità di realizzare il loro sogno e di incontrare dal vivo il loro mito.
Beh…tutto questo si complica orrendamente quando hai 28 anni suonati e sei un fan dei Fratelli Karamazov.
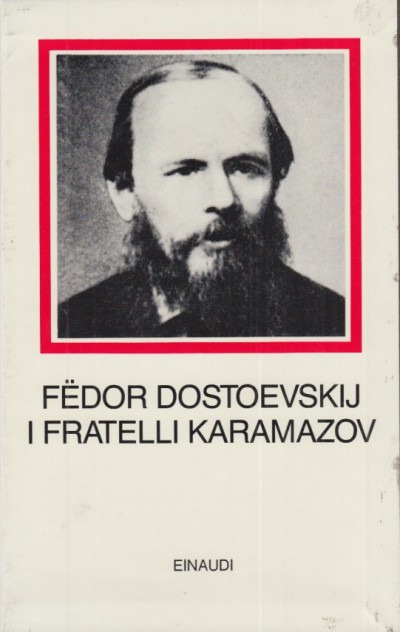
Tralasciando le specificità che distinguono i Fratelli Karamazov dagli altri romanzi del secondo ‘800, è comprensibile la sofferenza di chi, come me e Massimiliano, vorrebbe incontrare dal vivo personaggi che non solo non sono mai esistiti, ma talvolta – come nel caso di Alëša – sono volutamente idealizzati, concepiti dal loro creatore apposta per incarnare una purezza, una delicatezza, un candore che in natura non si sono mai visti. E ve lo assicuro: lo smaniare di una piccola fan di Johnny Depp non è nulla in confronto alla disperazione repressa di noi, che, sfogliando quel romanzo, ci siamo innamorati di Alëša, eppure sappiamo di non poterlo mai incontrare, poiché è non solo un personaggio fittizio, ma addirittura un personaggio idealizzato.
Ma la Storia a volte fa strani scherzi. E così, quel giorno, mentre quelle ignare ragazzine cuocevano a bagnomaria nella noia di un pomeriggio in spiaggia come gli altri, Massimiliano ed io, arrancando su un ripido sentiero cosparso di rocce aguzze, percorrevamo gli 8 km di foresta che separano il monastero di Sihla dagli ultimi scampoli della Civiltà.

FedEle non era certo una fuoristrada, anzi: era una Golf del colore di un’oliva andata a male, la city car più city car che vi possiate immaginare. Già quel mattino, al monastero di Neamţ, ci aveva dato i primi segnali di esaurimento. Al momento di ripartire, la batteria non si era più accesa. Niente di spaventoso, se la macchina fosse stata nostra, o se fosse stata affittata da qualche Europcar o da qualche Hertz della situazione, tanto rassicurante quanto avido. Ma FedEle, lo ricordiamo, ci era stata procurata da un nostro conoscente, che prima di andare in pensione aveva lavorato per anni come vigile urbano, quindi sapeva perfettamente quale macchina avesse ogni abitante del paesino. FedEle era, quindi, l’auto di un suo compare.
In Romania c’è un modo di dire molto eloquente: “Garantisco con la mia barba”. Io e Massimiliano avevamo capito all’istante. Avremmo dovuto trattare quella macchina meglio di una fidanzata, perché il minimo graffio o danno avrebbe significato una valanga di guai per lui e – di rimando – per noi.
Conoscendo questo retroscena, potete intuire quale panico ci abbia presi quando quella batteria non si è riaccesa la mattina del 2 agosto, davanti alle muraglie del monastero di Neamţ. Per fortuna il monastero, che è il più famoso della Moldavia, aveva cospicue proprietà terriere, e a differenza di tanti contadini moldavi, che avevamo visto con i nostri occhi lavorare ancora a colpi di falce, i monaci potevano permettersi il lusso di un trattore. Un monaco robusto, in tunica nera, con due larghe occhiaie e una barba spiovente, ha guidato il trattore fino alla macchina in panne, e ci ha prestato un po’ di elettricità attraverso due funi che chiamare “cavetti” sarebbe offensivo.
Al bookshop, che aveva piuttosto l’aria di un’enorme e caotica bancarella di libri usati, ho comprato una raccolta di poesie di Eminescu (volendo banalizzare, il Leopardi rumeno). Ne ho capito meno di un verso su due. Ma quel libriccino, che da allora in avanti ha avuto il posto d’onore sul cruscotto di FedEle, ci ha fatto un po’ da talismano: insieme alla targa rumena ha contribuito a farci passare per nativi, risparmiandoci un sacco di possibili noie sia con i ladri che con le guardie.
(A proposito: il padrone di FedEle, quando gli avevo chiesto se in Romania fossero frequenti i furti nelle auto, mi aveva risposto sogghignando: “Niente affatto. Qui non ci sono mica i rifugiati, come da voi”. Al di là dell’amarezza per il fatto che il razzismo non te lo lasci dietro nemmeno se cammini 5.000 km, ho ripensato con ironia a quei 10-15 anni in cui gli italiani davano ai rumeni la colpa di qualsiasi furto o aggressione. E noi, con santa pazienza, a dire “No, sono tutte stronzate…”)
C’è un’anima che piange, e col desiderio corre
Verso la dolce patria e le lucenti valli...
(Eminescu, “Dall’esilio”, 29 luglio 1866)

Abbiamo curiosato una mezz’ora anche nel convento femminile di Agapia, dipinto, stavolta, da Grigorescu, uno dei grandi nomi dell’arte rumena, formatosi alla scuola di Barbizon. Dato il curriculum, non gli rendono per niente onore quei bambingesù rosa porcello sullo sfondo di aurore pastellose, che ricordano i peggiori quadretti devozionali delle nostre bisnonne. (L’Ottocento è stato una stagione di magra per l’arte sacra ufficiale…forse perché era diventata sacra l’arte in sé?)
E finalmente attacchiamo quel sentiero accidentato che sale tra i boschi verso Sihla, l’ultimo dei nove monasteri toccati dal nostro viaggio, ma anche quello che ci segnerà di più. Conduco FedEle a passo di lumaca, studiando in anticipo ogni palmo di terreno, attentissimo a ogni pietra, ad ogni buca, ad ogni dosso, quasi presago dell’importanza che avrà per noi quell’ascesa. Dal finestrino dell’auto davanti alla nostra, una bambina sventola un orsetto.
Eccoci. Le macchine dei pochi pellegrini stanno sparse in un piazzale esterno. Dall’arco bianco d’ingresso, una strada selciata, lunga, in salita, congiunge tra loro le varie dimore dei monaci. Intorno c’è solo la quiete della foresta.
Le barbe brune dei monaci, alcuni dei quali giovanissimi, ci brulicano attorno senza far risuonare una parola.

“In certi casi si può trascorrere la notte nel monastero”, diceva la Guide du Routard. Magari! Eravamo ancora provati dalla nottata da Mihai l’Arreso, e in più morivamo dalla voglia di goderci a pieni polmoni quel totale isolamento. Così, ci presentiamo a un monaco dall’aria torva, che pare un maestro di arti marziali, e con un inchino gli chiediamo se sia possibile restare.
“Tornate alle otto”, ci risponde. “E cercate il fratello David. Lui vi farà sapere”.
Mancano ancora tre ore alle otto. Ne approfittiamo per recarci alla grotta di santa Teodora da Sihla, una mistica molto venerata nella regione, a giudicare dalle molte icone di lei che avevamo visto a valle.
“Che faremo se ci dicono di no?”
“Eh…che faremo?” alzo le spalle. “Qualcosa ci inventeremo. Come al solito”.
La grotta è angusta, umidissima, con gocce che colano in continuazione e pozze stagnanti. La santa viveva sdraiata in una fenditura, dove adesso le candele votive bruciano fra i mazzi di fiori. L’acqua la attingeva da una roccia concava poco distante, che con la pioggia si riempiva a mo’ di cisterna. Ma come riusciva a sopravvivere d’inverno, con le temperature di laggiù? E dove vagava il suo spirito, mentre il suo corpo era confinato notte e giorno in quella specie di tomba senza un filo di luce?
Dalla grotta decidiamo di scavalcare le recinzioni e di perderci un po’ nella foresta. Non c’è davvero un’anima. Le uniche voci che si sentono provengono dal monastero, e non sono dei monaci, badate, ma degli ultimi visitatori che se ne stanno andando.
L’atmosfera è perfetta per leggere a Massimiliano un certo mio racconto inedito, ambientato in una foresta russa. Gliene avevo parlato più volte, e più volte mi era capitato di citargliene a memoria qualche stralcio o qualche scambio di battute, quando la situazione si prestava. Adesso, seduti sul muschio, senza nessuno a correrci dietro, era il momento ideale per gustarcelo da cima a fondo.
Più tardi, lui ricambierà leggendomi per intero le annotazioni che aveva tenuto sul suo diario a proposito del volontariato con i pazienti psichiatrici.

“Sai cosa ho pensato, Manu?
Che è bello poter leggere qualcosa che ti riporta in una foresta, in un luogo dove il tempo è sospeso e non c’è più la società…
…credo che ognuno di noi abbia bisogno di una foresta di qualche tipo in cui rifugiarsi, e di un libro di qualche tipo che gliela faccia crescere intorno…”
Le campane. Sono le otto. Si decide il nostro destino.
Il fratello David ci accompagna da un gruppo di ragazzi in borghese. Sono seminaristi, si preparano a diventare Pope. Hanno fra i 17 e i 20 anni. Vestono con polo e calzoncini, un look anche meno austero del nostro. “Potete aggregarvi a loro”, ci dice. “Sono qui per uno stage di canto liturgico. Mangerete con loro e dormirete nella loro camerata”.
Stavamo ancora festeggiando la grande notizia, stavamo ancora facendo conoscenza con i nostri nuovi amici, stavamo ancora ficcando le mani in una grossa pagnotta appena sfornata, molle e filamentosa all’interno come pasta da impastare, quando da dietro è arrivato lui.
Lui.
Sì, proprio lui.
Aleksej Fëdorovič Karamazov.
In carne ed ossa.
Lasciate che vi spieghi, prima che mi prendiate per uno di quei pazienti psichiatrici con cui lavorava Massi.
Il giovane monaco che ci era comparso davanti aveva 25 anni, ed era entrato a Sihla quando ne aveva 19. Una vocazione precocissima, dopo la quale non si era allontanato se non due o tre volte da quelle mura. Aveva già la barba lunghissima, ispida, con qualche treccia qua e là. Occhi color nocciola, profondi, incantevoli. E il viso più innocente che avessi mai visto. Pareva un agnellino, quel ragazzo. Che dico? Un angelo. Un essere celeste, non più mortale. Trasmetteva serenità soltanto a guardarlo.
Parlava sottovoce, in tono dimesso, come il fruscìo di una foglia, ma sapeva l’inglese. Là, tra i suoi vecchi amici in polo e calzoncini, lui, con la sua tunica nera, faceva un effetto al contempo straniante e attraente.
Tra un discorso e l’altro, così, en passant, ho provato a chiedergli: “Ma come riusciva santa Teodora a sopravvivere d’inverno in quella grotta?”
Lui, cogliendo una vena scettica nelle mie parole (che in effetti c’era), si è come rabbuiato in viso, e ha risposto seccamente: “La proteggeva lo Spirito Santo”. Pausa. “Tutti noi monaci siamo protetti dallo Spirito Santo, grazie all’intercessione di san Serafino di Russia. Per questo riusciamo a fare cose impossibili per gli altri”.
Aveva venticinque anni, ma per lui non c’erano i “se”, i “ma”, non c’era da raziocinare o da adattarsi ai giovani d’oggi. “Tutti noi monaci siamo protetti dallo Spirito Santo”. Fine. Per lui era una realtà. E quel volto così tenero si era oscurato, scavato, guastato, di fronte alla mia mancanza di fede.
Non ricordo più il suo vero nome proprio perché lui, per me, in quel momento, era Alëša, e resterà per sempre Alëša. Nelle tappe successive del nostro viaggio, sia fisico che metaforico, soprattutto in certi paesi dei balocchi per turiste ubriache tipo Budapest, ci siamo spesso chiesti: “Che cosa direbbe Alëša, se fosse qui con noi? Se il suo stareţ lo mandasse nel mondo, e lui venisse in un posto come questo, che cosa farebbe?” E lo immaginavamo che piangeva, che piangeva sconsolato, non per se stesso, però, ma per noi.
Non era il vero Alëša, ovviamente, anzi, forse non è mai esistito un vero Alëša. Ma per noi importava poco. Sapete perché ai monaci ortodossi è proibito tagliarsi la barba? “Perché il nostro volto deve somigliare il più possibile al volto di Cristo”, ci ha spiegato lui. Nella cultura orientale, che è permeata di platonismo, attraverso la somiglianza visiva viene già comunicata una parte dell’essenza della persona. L’immagine contiene già un primo assaggio della realtà. Guardando quell’imitazione di Cristo che è il monaco si vede, già in parte, Cristo stesso. Così, ai nostri occhi, quel ragazzo ha riprodotto in sé Alëša, personaggio che già per Dostoevskij doveva riprodurre in sé, agli occhi dei lettori, qualcuno di ancora più puro e di ancora più santo.
Ci siamo addormentati solo dopo aver passato un’ora abbondante sotto il cielo stellato.

1 note
·
View note
Text
La tecnica della pittura a verdaccio nel ritratto secondo Adrian Gottlieb


Ritratto di Gregg (oil, 26×20), Adrian Gottlieb Adrian Gottlieb è un pittore americano molto apprezzato per i suoi ritratti ad olio e in questa sequenza dimostra come interpreta in chiave moderna questa antica tecnica, nata nel rinascimento. Secondo questo pittore, il miglior soggetto per un ritratto è una persona interessante dipinta dal vero. Dichiara che quando si dipinge da una fotografia, ci si trova di fronte a un simulacro, ad una rappresentazione statica di un essere umano. Un ritratto dal vero invece cresce e si approfondisce man mano che l'artista lavora su di esso e in questo consiste la meraviglia e l'emozione che la ritrattistica può donare. Ecco le fasi della pittura di un ritratto eseguito con questo metodo

1. dopo aver fatto alcuni studi di disegno e sul colore, si delinea la forma e si definisce usando un pennino caricato di inchiostro marrone (seppia) o un pennellino con una tinta (terra d'ombra diluita con trementina) su una imprimatura (primo strato, la vernice di fondo) di terra d'ombra bruciata diluita con trementina, in modo da avere un fondo caldo piuttosto scuro su cui lavorare. L'imprimatura consiste nello stendere della terra d'ombra diluita in essenza di trementina sulla tela per poi rimuoverla in parte sfregando leggermente con tampone di stoffa, prima in orizzontale e poi in verticale in modo da ottenere una superficie omogenea. Il valore della imprimatura deve avvicinarsi al valore medio delle ombre del soggetto principale. Subito, sul disegno tracciato, si impostano con leggerezza le ombre più scure usando ancora terra d'ombra.

2. Nel passaggio successivo, si costruisce il piambura o piombura: una base modellata con il bianco, gestita sfumando molto sottilmente. Questo stadio va curato attentamente affinché il dipinto finito abbia un effetto luminoso e traslucido. La creazione equilibrata dei rapporti fra i valori di chiaroscuro e la precisione del modellato e della struttura del soggetto sono aspetti molto importanti e richiedono molta attenzione, in modo che il lavoro risulti ben impostato fin dall'inizio.

3. La tecnica del Verdaccio, si utilizza su un nuovo livello del lavoro ed è particolarmente vantaggiosa per far risaltare il soggetto su uno sfondo relativamente scuro. Bisogna modellare completamente le forme, utilizzando variazioni nella temperatura dei colori (freddi e caldi) spaziando tra blu-verdi nelle ombre e rosati nelle parti in luce. La pittura va tenuta abbastanza chiara in termini di valore perché quando si passeranno le velature, i valori (di chiaroscuro) e i toni potranno abbassarsi di molto.

4. A sinistra, si possono vedere i risultati delle velature primarie e secondarie, eseguiti in strati sottili, con zone di colore simili come grado di trasparenza e tinta. Su questi strati è possibile stendere a mezza pasta strati semi coprenti di colore per raggiungere una esattezza della colorazione e stabilire il giusto equilibrio tra figura e sfondo. Di seguito aggiungo una galleria degli studi realizzati da un pittore sulla piombura che ho trovato su internet #colorbox_main_container_11045 .wpsm_panel { margin-bottom: 0px !important; background-color: #ffffff; border: 2px solid #cccccc; border-radius: 2px; -webkit-box-shadow:0px 0px 21px -8px #000000; box-shadow:0px 0px 21px -8px #000000; -moz-box-shadow:0px 0px 21px -8px #000000; } #colorbox_main_container_11045 .wpsm_panel-default > .wpsm_panel-heading { background-color: #ffffff !important; border-color: rgba(0,0,0,0.05); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-top-left-radius: 2px; border-top-right-radius: 2px; text-align:left !important; padding:14px 15px !important; } #colorbox_main_container_11045 .colorbox_singel_box{ margin-bottom:20px !important; padding-top: 5px; } #colorbox_main_container_11045 .wpsm_panel-title{ margin-top: 0 !important; margin-bottom: 0 !important; font-size: 18px !important; color: #000000 !important; font-family: Open Sans !important; word-wrap:break-word; text-align:left !important; padding: 0px !important; line-height:1.5 !important; } #colorbox_main_container_11045 .wpsm_panel-title span{ font-size: 18px !important; color: #000000 !important; vertical-align: middle; display:inline-block !important; } #colorbox_main_container_11045 .wpsm_panel-title a{ padding:0px !important; margin:0px !important; text-decoration:none !important; outline:none !important; border:0px !important; } #colorbox_main_container_11045 .wpsm_panel-title a:hover{ color: #000000 !important; } #colorbox_main_container_11045 .wpsm_panel-body{ color: #000000 !important; background-color:#ffffff !important; font-size:16px !important; font-family: Open Sans !important; overflow:hidden; text-align:left!important; line-height:1.5 !important; border-bottom-left-radius: 2px; border-bottom-right-radius: 2px; } #colorbox_main_container_11045 .wpsm_panel-heading { background-image: none !important; } @media (max-width: 992px){ .colorbox_singel_box{ width:50% !important; } } @media (max-width: 786px){ .colorbox_singel_box{ width:100% !important; } } Come disegnare a memoria o dal vero la testa da qualsiasi angolazione

Impara a disegnare la testa e il volto da qualsiasi angolazione visualizzando nella mente un modello che ti guidi nei ritratti dal vero o ti permetta di inventare una testa che sembri naturale anche a memoria. Oppure dai un’occhiata alla presentazione della dispensa jQuery(window).load(function(){ jQuery('#colorbox_main_container_11045').masonry({ itemSelector: '.colorbox_singel_box_11045', }); });





&webforms_id=8325204" css="on" center="off" center_margin="200"/] Read the full article
0 notes
Photo

6 ottobre 2017 Anche questo mese, per il new book club, un disegno e un racconto. - Mi sto annoiando a morte, posso venire con te? - Disse Giulia - Non sai nemmeno dove sto andando. - Ok dove stai andando? - Sto andando qui al museo a chiedere quali posti storici si possono visitare. - Non c’è bisogno. Sono preparatissima, ci sono Villa Giulia, le Cisterne Romane, il carcere dell’isola di Santo Stefano. Ci pensai un attimo: - Il carcere, voglio vedere il carcere. - Ok ti faccio io da guida, - disse Giulia guardando l’orologio - vieni, corri, c’è una barca che parte alle dieci giù al porto. # La barca ci lasciò al piccolo porto dell’isola di Santo Stefano. Era uno sputo di roccia lavica. Circolare. Del diametro di 500 metri. Ogni lato che riuscivo a vedere, era a picco sul mare. Niente spiaggia. - Vedete quella scalinata? Fatela tutta, in cima ci sarà la guida, - disse l’uomo al timone. Sulla scalinata si bolliva, sentivo il calore della pietra attraversare le suole delle scarpe. Già dopo pochi scalini i rivoli di sudore mi solleticavano la schiena. Giulia era dieci metri più in alto quando si chinò su un cespuglio. Iniziò a gesticolare indicando qualcosa. E così continuai a fingere di non far fatica su per i gradini finché la raggiunsi insieme al gruppo degli ultimi. - Guarda un cardo, - disse Giulia indicando il cespuglio. - E sì, fa caldo, molto caldo, - disse un uomo sulla sessantina mentre ci stava superando. Trattenni le risa a stento. Giulia, dopo qualche singhiozzo convulso, scoppiò a ridere in un modo sconsiderato. Misi una mano sulla sua bocca, ma non servì a niente. Quel uomo mi guardò malissimo. Mi asciugai il sudore. Giulia si tamponò le lacrime con la manica. Colse un fiore. Lo infilò nei miei capelli e disse: - Che bel ragazzo “accardato” che sei, - e riprese a ridere. - Andiamo, guarda che distacco che ci hanno già dato. Adesso quel signore mi guarderà male per tutta la gita. Poi non ho capito perché ha guardato male solo me, - mi lamentai pensando al pezzo di salita che mancava. La guida era lì, nella piazza all’ombra di grandi alberi tra un edificio rettangolare, la dimora del direttore del carcere e l’ingresso del carcere stesso. Sembrava la piazza di un paese abbandonato. Dopo una breve introduzione ricca di cenni storici, la guida ci fece entrare in quel luogo di antiche sofferenze. L’isola era disabitata da tempo. Il carcere era a forma di ferro di cavallo con celle larghe tre passi per quattro passi di lunghezza circa, disposte su tre piani. Se ci fosse stata una finestra sulla parete esterna la vista sarebbe stata incredibile. Invece c’era una sola finestra, sopra la porta, che dava sul cortile interno. Una torre posta in centro al cortile con un unico colpo d’occhio vedeva, in stile grande fratello di Orwell, tutte le celle. In realtà la torre centrale era una chiesa che simboleggiava la redenzione e l’occhio di Dio che tutto vede, ma questa era un’altra storia. Vi racconto uno spaccato di com’era la vita nel carcere nel 1957, otto anni prima che fosse definitivamente chiuso. In quel anno, Stefano di Filippo venne assunto dal ministero di grazia e giustizia come maestro. Arrivò ad ottobre con il “vapore” la barca che collegava Ventotene con Santo Stefano. C’era circa un centinaio di carcerati sull’isola. Tutti “Fine pena mai” una forma poetica per indicare la pena dell’ergastolo. Le lezioni di scuola ai carcerati iniziavano alle 7.30 fino alle 11:00 per poi proseguire nel pomeriggio. Gli appartamenti del Direttore del carcere erano riservati alle famiglie delle guardie. Le guardie scapole utilizzavano alcune celle come camera da letto. Così al nostro maestro diedero una cella vuota. Sua moglie, anche lei maestra, insegnava e viveva a Ventotene. Stefano di Filippo dava lezioni di italiano, matematica, storia e geografia. Gli alunni erano tutte persone con reati che andavano dall’omicidio alla strage. Tra questi vi erano tre componenti della banda Giuliano. Il maestro li notò subito perché erano persone “scafate” (ben istruite). Con il vice di Giuliano, Terranova e Don Pisciotta ci faceva discorsi alti. I detenuti istruiti andavano comunque a scuola per impegnare il loro tempo. Avevano materiale scolastico e giornali. Passavano ore a discutere anche su temi attuali come i russi che in quell’anno andarono in orbita con lo Sputnik 1. In classe c’era una guardia per proteggere il Maestro. Secondo Stefano non era necessario. L’ambiente era tranquillo. I detenuti giravano liberi. Ognuno aveva un compito. C’era chi lavorava nel laboratorio tessile, chi faceva opere di muratura, chi aggiustava scarpe. Altri lavoravano nella casa colonica fuori dal carcere. Coltivavano lenticchie. Per questi lavori ricevevano la “Mercede”: soldi che per buona parte spedivano alle famiglie. Un giorno un uomo della banda Giuliano chiamò la guardia usando un soprannome. Quando il Maestro gli chiese il motivo lui rispose che i carcerati venivano chiamati con un numero e lui li ripagava usando un contranome. Il segretario del direttore era un ergastolano. Tra i suoi compiti c’era quello di ricevere le persone quando il direttore era impegnato. Praticamente era il suo uomo di fiducia. Il direttore stesso lo aveva scelto. Ora vi starete chiedendo cosa ha fatto questo bravo uomo per prendere l’ergastolo. Faceva l’alunno d’ordine delle ferrovie. Una sera decise di scassinare la cassaforte della stazione dei treni e scappare con i soldi. Sfortunatamente il capostazione lo scoprì e lui lo uccise. Durante la permanenza del Maestro non c’erano detenuti politici. Anni prima durante il fascismo il carcere era pieno di uomini dell’opposizione. Antifascisti. Tra questi c’era il politico Settembrini. Il maestro, le guardie e i detenuti mangiavano insieme. Pasta e polvere di piselli o di fave. Secondo il maestro non si mangiava bene. Nemmeno allo spaccio. Le celle erano aperte. I detenuti giravano liberi. I veri carcerati erano le donne delle famiglie delle guardie che per sicurezza rimanevano chiuse in casa. I detenuti non parlavano mai dei reati commessi dagli altri, al massimo parlavano dei propri. Lo facevano quasi per giustificarsi. Quelli della banda Giuliano invece non parlavano mai dei loro reati. Lungo la passeggiata verso il cimitero c’era un’immagine, vicino al muro, detta l’incompiuta. Due detenuti, bravi a dipingere, avevano ottenuto il permesso dal direttore per fare questa opera. Il vero obiettivo era un altro. Dopo poco tempo i due scapparono. Nuotarono fino a Ventotene. Rubarono una barca e furono catturati mentre andavano verso Ischia. Peccato, il dipinto rimase incompiuto. Il cimitero era chiuso ai carcerati. sul cancello c’era la scritta “Qui finisce la giustizia umana, qui comincia la giustizia divina”. A detta del maestro il posto era bello, tranquillo. Ci si stava bene. Dopo tre mesi prese il tifo, lasciò il carcere e il suo incarico. Torniamo alla gita guidata, dopo aver visitato la cella di Sandro Pertini, uscimmo dal carcere per una passeggiata sull’altro versante dell’isola. Arrivammo su un promontorio con una dozzina di tombe, ormai niente più che cumuli di terra con una croce di legno. Mi adagiai su una roccia. Lo sguardo fisso sul mare tra le croci di legno. Giulia si mise a sedere al mio fianco: - che bella vista che c’è. Non mi ero nemmeno accorto di lei. - C’è qualcosa che non va? - Mi disse. - Tutto ok. - Dico sul serio, cosa c’è? - Vuoi veramente conoscere i miei Demoni? Giulia annuì. - Anni fa ho conosciuto questa ragazza Sara. - E com’era questa Sara? - Era incredibile. Una giraffa. Sottile. Agile, capelli lunghi e lisci. Occhi oceano. Non avevo speranza con Sara. Questo, un giorno, mi diede il coraggio di parlarle. Così diventammo amici. Amava i libri. - Tipo? - John Fante, Jerome David Salinger, Charles Bukowski. Passavamo ore a discutere su chi fosse il migliore. Non ne venivamo mai a capo. - Hai fatto anche a lei un ritratto? - Non sapevo ancora disegnare, ma Dio mio quanto avrei voluto fargliene uno. Non ero mai stato a Ventotene. Sono venuto qui con lei la prima volta. Questa è la seconda. Non sai che fatica ho fatto a ritornarci. Giulia cominciò a intuire che la storia non sarebbe finita bene. - Quella è stata anche l’ultima volta che l’ho vista viva. Non le ho mai detto quello che provavo e a volte, come sto facendo adesso, mi chiedo se le cose sarebbero potute andare diversamente. - Io penso che il destino… cazzo dov’è la guida? dove sono gli altri? Vieni corri. - Urlò Giulia Coprimmo a ritroso tutto il sentiero fino al carcere e poi giù per la scalinata che termina al porticciolo. Io arrivai per ultimo. Vidi Giulia sdraiata a pancia in su. La barca non c’era. Cedetti sulle mie ginocchia, cercando di recuperare un po’ di ossigeno, poi mi arresi indietro sulla schiena. Respiravamo tutti e due intensamente. Non c’era il fiato per parlare. Nemmeno per dirsi che eravamo rimasti da soli sull’isola. Restammo lì, per diversi minuti a guardare le nuvole e a respirare. - Secondo me è il signore del “Cardo”, - dissi. - Cosa? - Chiese Giulia. - Sì è stato lui, per vendetta ha detto alla guida di andare che non mancava più nessuno. Giulia cominciò a ridere sotto voce. Cercando di trattenersi. - Cosa ridi, cazzo, siamo probabilmente gli unici due pirla nella storia di questo posto ad aver perso la barca del rientro. - Dissi. La guardai sorpreso. E anche la mia bocca si spalancò. Ridevamo, sempre più forte. Ridevamo e guardavamo le nuvole passare sopra di noi. Sembravamo due folli.
6 notes
·
View notes
Text
Ho voglia di scrivere un po’.
Prima o poi riuscirò a dormire, anche perché inizio a dare i numeri sul serio.
Ultimamente ho tanti pensieri, anzi a dire il vero da stamattina. Forse è il pms o è il fatto che non dormo da due giorni, che tra poco saprò del mio destino lavorativo o al fatto che sono in burnout andante, che lavoro troppo e a volte trascuro molte cose.
Questo 2k18 è stato illuminante sotto molti aspetti, ha fatto male sotto altri e ha fatto molto bene sotto altri ancora. Le esperienze vissute, le porte chiuse, le delusioni, le vittorie, le scoperte, i posti nuovi, le persone lasciate indietro e quelle riprese, i nuovi amici e le nuove consapevolezze.
Sono cresciuta tanto e sono cresciuta da sola. Sono passata dall’essere in completa balia di me stessa a inizio anno ad avere un progetto, una strada, un fine all’inizio di quello nuovo.
Ho barattato le serate al leccomilano a raccattare qualche malattia sessualmente trasmissibile con un equilibrio stabile e un obiettivo prefissato.
Ho iniziato tanto e ho scelto tanto. Ho vissuto da sola per un periodo, ho aiutato tante persone, ho pianto tanto e ho visto tante di loro piangere, ho visto molti rinascere e molti altri morire, alcuni di loro sono morti esattamente davanti a me, tra le mie mani ancora sporche del loro sangue caldo in sala mentre passavo gli strumenti o medicavo o incannulavo. Ho visto un cuore vivo battere proprio davanti a me, quasi come se potessi toccarlo e prenderlo tra le mani, l’ho visto e ho pianto.
Ho visto il 24 che da crocetta mi portava in via quaranta, ho visto la fondazione prada quasi ogni settimana e ho visto il mio lucernario ogni sera regalarmi la vista migliore di sempre, ho visto le colazioni al mercato del duomo e le serate a bazzicare ai magazzini generali o a fare la spesa all’esselunga che era praticamente la stessa cosa.
Ho visto le uscite in birreria e le frequentazioni “amorose” durate un giorno, ho visto il suo calice di rosso e la mia birra in quel bar, ho visto un piattone di pasta alle vongole e ho visto le sue mani. Ho visto e accettato proposte decisamente molto allettanti, ho visto l’amore e l’impegno e ho visto me.
Mi sono vista mentre mi innamoravo di nuovo.
Mi sono innamorata della mia indipendenza per prima cosa, tanto conquistata e non sempre voluta, che ho definitivamente fatto mia solo di recente. Mi sono innamorata delle cose semplici e significative, dei miei ricordi e delle mie passioni, del mio corpo e delle mie idee, del mio orgoglio e del mio carattere. Poi mi sono innamorata di lei, del mio nuovo colore preferito, e mi ha dipinto tutto, qualsiasi cosa avessi, di lei.
Mi sono innamorata di lei come ci si innamora di un libro, di una foto o di un film. Mi ci sono innamorata lentamente e non senza difficoltà, ma anche tutto in una volta e all’improvviso. Me ne sono accorta quando guardandola ho rivisto quel cuore e ho pensato di volerla tenere tra le mani e tenerla al sicuro e al caldo. Mi sono innamorata di lei tanto tempo fa e poco allo stesso tempo, e ho voglia di continuare a farlo ogni giorno, ogni volta che mi sveglio la mattina con lei di fianco, ogni volta che si avvicina per essere scaldata un po’ durante la notte, ogni volta che mi prende tra le braccia e mi dice che è tutto ok, che mi ama e che è felice.
Io non potrei esserlo di più per quello che mi è capitato.
Non ho propositi per il nuovo anno, solo l’augurio di sentirmi così sempre, ogni giorno, di avere sempre coraggio e determinazione anche nei giorni bui, e sapere che anche dopo aver sofferto tanto sono comunque riuscita a ritrovarmi e ricostruirmi.
0 notes
Text
Viva la canna!
Mio cugino è tornato giù in paese per un breve viaggio turistico, dopo tanti anni, e mi ha portato un panetto di pasta di mandorle, come gli avevo espressamente richiesto; perché la pasta di mandorle è tra le cose che mi mancano, non tanto in sé, ma il gesto, questo fare arrivare qui un pezzo di sud. Non ho dubbi che la pasta di mandorle ormai la si possa tranquillamente trovare dietro l’angolo, ma non ci penso nemmeno a comprarla, si tratta di un’altra questione.
A dir la verità mio cugino di panetti me ne ha portato due, uno di pasta di mandorle normale (che una volta non c’era bisogno di definire normale, perché era quella e basta) e uno di pasta di mandorle al pistacchio: “minciate moterne!”, diceva zia Maria.
Poi non so perché, mio cugino mi ha portato una cavagna, che sarebbe questa cosa qui. L’ho fotografata su una salvietta adeguata per renderla più pulp, e ci ho messo una moneta da 10 centesimi per dare un’idea delle dimensioni.

Credo che me l’abbia portata come una cosa tipica, lui è fatto così, come una volta si portavano i portacenere con su scritto “Ricordo di Siracusa”, o di Roma, o di qualsiasi altro posto al mondo, anche di Pachino nel suo piccolo: ho avuto per breve tempo un portacenere con su scritto “Ricordo di Pachino”, un piattino di terracotta a forma di pala di ficodindia dipinto malamente a mano e contornato da fichidindia. Poi non so che fine abbia fatto, deve essermi freudianamente caduto di mano. In cambio di questa grave perdita, la mia amica Ada, con cui condivido le origini siciliane, mi ha fatto omaggio di un servizio da sei bicchierini sempre a forma di ficodindia, che deve essere il frutto che i siciliani ritengono più tipico di se stessi. E difatti mio cugino mi ha anche portato… dei fichidindia, che però ha comprato a Torino, me li ha portati solo per una evidente associazione di idee, per amore del tipico.

Ma dicevo della cavagna: è fatta di canna, non è un astuccio penico, ci si mettevano le ricotte. Il ricottaro passava per il paese con una bicicletta che aveva una cruvedda attaccata per lato, e a ogni incrocio declamava, ma sarebbe meglio dire cantava “Rrricotti friiischi!”, così, rinforzando la erre iniziale e tirando più che poteva la penultima i. Tu andavi col tuo piatto e lui prendeva una cavagna da una delle due cruvedde, le dava dei colpettini con due dita, ne faceva scivolare fuori la ricotta con un gesto molto simile a quello dei cuochi che mescono una prelibata pietanza sul piatto, e poi buttava la cavagna nell’altra cruvedda. Cosa sono le cruvedde? Dei grossi cesti fatti di canna.
Perché con la canna ci si faceva di tutto, e bisognava imparare fin da piccoli a lavorarla: il regalo più simbolico che un padre faceva al figlio maschio era il primo coltellino, con cui doveva imparare a lavorare la canna: per prima cosa a tagliarla in strisce regolari, non difficile ma nemmeno facile, se non hai la tecnica giusta non ci riesci. Io ce l’ho.
Parlando con mio cugino mi è venuto da dire che la canna era una benedizione di dio, un’espressione per me inusuale, ma che dà l’idea di quanto fosse importante nella cultura del profondo sud. Queste sono le cose a cui serviva la canna, dette così, a memoria sul momento: ci si facevano delle delimitazioni negli orti, delle trincee nelle spiagge per evitare che la sabbia invadesse le campagne, dei separé nelle case, dei silos per i cereali, dei cesti e dei panieri d’ogni tipo e dimensione, delle forchette e naturalmente degli spiedi, dei contenitori di vario genere per i formaggi, manici per le scope e bastoni in genere, la base portante delle tegole sul tetto di una casa, capanne vere e capanne per gioco, giocattoli vari (girandole, archi, frecce, fucili e cavalli da cavalcare), aquiloni, fischietti e zufoli, canne da pesca, ovviamente… Non mi viene in mente altro, a parte una cosa che ho riservata per ultima, la più sorprendente: se si spacca a metà una canna, all’altezza del nodo ci si trova una specie un tondino di fibra vegetale bianca, come fosse diciamo una monetina da 10 centesimi; ecco, quella roba lì è un ottimo emostatico e cicatrizzante, perfettamente sterile. Era la seconda cosa che imparavamo da bambini: la prima era lavorare la canna col coltellino, la seconda… medicarci le ferite!
Ho appeso la cavagna che mi ha regalato mio cugino a un ripiano in cucina, ma mi sa che non ci sta molto, mi fa tristezza: povera cavagna, ridotta a oggetto da vendere ai turisti assetati di tipico!

0 notes
Text
Vida de Vecindad
Una vecindad è una tipologia abitativa nata in Messico nel 18smimo secolo a seguito della crescita demografica seguita al boom economico. Si può definire come una casa di ringhiera Milanese con un tocco esotico, un condominio popolare dove numerosi appartamenti, per lo più di una stanza, condividono un patio centrale. Questo spazio condiviso è il vero cuore delle vicinades, dove si condividono risate e pettegolezzi, dove si osservano le abitudini degli inquilini, dove danzano nell’aria i panni appesi e crescono e si aggrovigliano tra loro le piante aromatiche e decorative di diversi proprietari. Il patio offre anche un luogo sicuro per i bambini per giocare, perché in realtà c’è sempre qualcuno che da dietro una tenda dai colori vivaci tende un occhio per vedere cosa succede.
Mi sono trasferita nella vecindad di Calle Napoles 84 a gennaio, ho deciso di prendere l’appartamento perché mi sono innamorata proprio del suo meraviglioso patio, dipinto di un brillante giallo e azzurro e pieno di piante di un verde intensissimo. Proprio per questo magico patio ho chiuso un occhio sul fatto di vivere al piano terra e avere un po' meno luce degli altri appartamenti. Alle prime, nel portare dentro il nuovo nido le mie cose, ho notato degli sguardi insospettiti, ma è bastato un sorriso e la curiosità di essere parte di questa buffa comunità per farmi i primi amici. Nonostante io sia un alieno, forse hipster è il termine più appropriato, il primo segno della nuova Città del Messico che si insinua in questi luoghi cristalizzati in un altro tempo, sono stata accolta con un grande calore. La vita, qui a Napoles 84, non segue gli orari di lavoro del 21simo secolo, se ti finisce la bottiglia del gas devi aspettare che arrivi, ad un orario estremamente variabile, un uomo che urla -gaaaaas- che devi braccare molto velocemente e chiedergli, sempre con un certo senso di colpa, di portarti la nuova e pesantissima bottiglia sul tetto. Stesso vale per l’immondizia che viene raccolta da un furgoncino che rende nota la sua presenza grazie a un poverumo dal bicipite potentissimo che squote con forza una campana, da quando senti il suono hai pochi minuti per raccogliere tutti i sacchi, uscire correndo dalla casa e lanciare in modo acrobatico la tua immodizia nel furgoncino. Queste due pratiche non erano assolutamente compatibili con i miei orari di lavoro di un architetto hipster del 21 secolo, ma per fortuna la vecindad mi è venuta in contro. L’adorabile signor Carlos, dal grande sorriso, mi ha aiutata con i miei pochi, ma ingombrati rifiuti, e la misteriosa signora Ofelia, che ha sempre un turbante nero e gli occhiali da sole, si è occupata di comprarmi una bottiglia del gas. Grazie a loro ho potuto vivere in modo degno i miei primi mesi qui.
E poi è arrivata la quarantena, una situazione così surreale, un evento che non prendi mai in considerazione nel scegliere dove vivere, non spesso ci si chiede “ e se scoppia una pandemia mondiale, sarei felice ad essere chiusa in questo posto per settimane?”. E così il fatto di vivere al piano terra si è trasformato nella mia salvezza, seduta a lavorare alla mia scrivania domestica osservo chi entra e chi esce, e mi immergo nei tempi dilatati e nelle dinamiche della vecindad. La mia vicina Maria è riuscita a procurasi, non si sa bene come, un grande numero di mascherine e me ne scuote una davanti alla finestra per chiedermi se ne voglio acquistare una dozzina. Un singnore, di cui ancora non so il nome, era molto incuriosito della piantina di basilico al mia finestra, presenza costante nelle case degli italiani all’estero, - che cos’è- ne prenda qualche foglia e ci condisca la pasta, vedrà che delizia, poi mi dirà se le è piaciuto. La dirimpettaia, la signora Irma dai capelli di un rosso esplosivo non propriamente naturale, è molto rispettata tra gli inquilini, spesso emerge dal suo appartamento per controllare una ad una le piante del patio per assicurarsi che tutte stiano bene. Dall’alto dei suoi 80 anni, quando l’altro giorno le ho espresso la mia volontà di trasferirmi in un piano più alto per avere più luce, mi ha indicato una signora che scendeva a fatica le scale, la signora Maria di Veracruz – Sai ha quasi 90 anni- mi ha detto strizzandomi l’occhio. Mi racconta anche di come viva qui da più di 30 anni e tutte le piante del lato destro del patio le ha piantate lei. Quelle del lato sinistro, che mi godo dalle mie finestre, sono invece del signor Pablo, uno dei primi ad avvicinarsi incuriosito a me dalla prima settimana del mio arrivo, mi aveva prontamente regalato una Madonnina per proteggermi nonostante gli avessi confessato di non essere credente. Ma non importa chi sia il proprietario, c’è sempre qualcuno che passa, toglie una foglia morta o innaffia una pianta particolarmente secca, tutti mettono un po' d’amore in questo bene prezioso e condiviso. Con l’amministratrice Araceli, da quando le avevo chiesto 2 uova che mi mancavano, si è instaurato uno scambio di cibo regolare, lei mi fa scoprire nuovi sapori della cucina messicana ed io di quella italiana. E se mi mancano degli ingredienti per sperimentare le ricette dell’Araceli, non c’è problema, la signora Fer del seconda piano smercia mole che importa dallo stato di Hidalgo, patria del mole. Ognuno, quando si ferma a fare quattro chiacchere con me attraverso la finestra si lamenta di uno o l’altro inquilino, facendo discreti gesti con le mani e rivolgendo lo sguardo scocciato al cielo, ma in realtà sento che in un modo o nell’altro,si vogliono tutti bene.
Questo senso di comunità, che è sempre più raro in un mondo ogni giorno più individualista, mi da gioia e fiducia che tutto passerà, che non ci sia aiuta solo in quarantena ma che ognuno può sempre fare qualcosa per l’altro e che insieme funzioniamo molto meglio e siamo anche molto più buffi.
0 notes
Text
MA PICCHÍ ?

Non laureatevi. È chiaro. Basta che ci si fermi, per qualche breve istante, a contemplare una laurea: essa giace lì, avvolta da un drappo color porpora impreziosito da ricami barocchi, elegantemente accomodata su di un solenne scranno decorato da intarsi raffinati, sbuffando per aria ampie volute di fumo che si arricciano mentre si pasce del suo pregiato sigaro in foglie di tabacco essiccate sotto i soli della sessione estiva. Ma, se le si strappassero di dosso tutti gli inestimabili ornamenti, il nobile trono, la regale spocchia e tutte quelle pompose ed altisonanti attribuzioni di cui essa ha la pretesa ostinata di arricchire la formazione di un individuo, non ne resterebbe che uno spaurito ed insipido formalismo nelle cui trame burocratiche si annida l’oggetto delle più recondite fobie moderne, la nemesi degli abitanti dell’Isola che non c’è, il nutrimento dei più rivoluzionari deliri dei poeti maledetti: l’annosa ed alienante ricerca del proprio posto nel mondo. La laurea dovrebbe essere come la fisica secondo Feynman, ovvero come il sesso: potrebbe avere dei risvolti pratici, ma non è mica per questo che lo si fa. Però così non è. E, come se il mondo già non cospirasse con ciascuna delle proprie fibre affinché le vite dei popoli siano dense di inquietudini, disordini e demoni sociali come il postmodernismo ed il caffè decaffeinato, accadrà in più che, qualora il frutto dell’accademica tribolazione dovesse nella fattispecie essere un laureato meridionale, allora sulla sua testa penderà spesso una tetra ed orrifica condanna, presagita sin dai più remoti tempi dell’infanzia ed ineluttabile come la coda al casello di Villafranca a Ferragosto: l’emigrazione. Il più delle volte questa constatazione rappresenta il preambolo di un’apologia accorata delle proprie origini, o di una malinconica rappresentazione della miseria e della sventura che le connotano. Ma il reale nocciolo della questione si cela dietro la tela di questo dipinto animato da pennellate nostalgiche. Se versare lacrime di sincera commozione è naturale, infiammare un dibattito apparentemente sopito è doveroso.
Come a dire: da qui si va via, sì, ma picchì? Lì dove la povertà delle circostanze prospetta in modo lampante la carenza di possibilità, la reazione più immediata è quella di preservarsi cercandole altrove, pur comportando tale altrove un grosso sacrificio. E così, quindi, si finisce per accogliere di fatto la mutilazione della possibilità, la possibilità a metà – o a tre quarti, o ad un quarto soltanto anche: ciascuno ne disponga a proprio buon cuore - l’impossibilità di contemplare un ventaglio di scelte virtuose. Il ché è certamente indotto dalla gravità del fenomeno e dall’urgenza che la generale precarietà dei tempi aggiunge a tale stato d’emergenza; ma ciò che più porta questa tendenza alle estreme conseguenze, convertendola in una spirale di esasperato depauperamento di capitale umano, è l’assenza di una soluzione praticabile: non definibile e dunque non definita, non concreta e dunque non concretizzabile. Troppo distante nello spazio e nel tempo per essere afferrata e manipolata, per essere scorta nitidamente e disegnata con tratto sicuro, e per potervi rivolgere le stesse energie destinate alla propria realizzazione, difficile già di per sé. Nelle immobilità della desertificazione industriale, tra le morse di un tasso di crescita dimezzato rispetto a quello del settentrione, sotto la minaccia di uno stato di sottosviluppo permanente, nelle ombre del malgoverno, quali forze - e con quali metodi - dovrebbero dissodare il terreno arido del Sud per predisporlo ad accogliere le sementi del progresso e dello slancio verso posizioni di nuovo avanguardistiche e competitive nella sfera delle attività umane e nel panorama mondiale? E quelle che operano già, le odierne emanazioni economiche del territorio, coltivate o per vocazione o per colmare l’esclusione da un piano di crescita nazionale, sono comunque espresse al massimo del loro potenziale? Possono, dalle attuali criticità, emergere sintesi innovative che si costituiscano in grandi e robusti modelli di sviluppo? O bisogna insistere nel cercare il principio di ripresa in politiche interventiste più efficaci? Esiste già ciò che realmente occorre? È dai canali convenzionali che bisogna attendere il balzo in avanti? Bisogna attendere? Può, questa, essere la crisi di cui Albert Einstein tesseva l’elogio, in quanto generatrice di nuove energie creatrici artefici della rinascita? Si può restituire una penna alla sofferenza dei poeti? Dalle crepe che innervano le mura sopravvissute ai terremoti non fuoriescono che polvere e domande.
Ma picchì? Ci si guardi bene dall’additare, d’istinto, questo o quel dettaglio, questo o quell’episodio, questo o quel tratto del temperamento locale. L’avventatezza nel trarre le conclusioni andrebbe rifuggita con lo stesso disprezzo che si riserva al peggiore degli incubi. La superficialità con cui troppe volte si risolve l’analisi della questione rimanda pericolosamente la conquista di una verità più profonda. E quanto più la verità si allontana nel futuro, tanto più l’ignoranza si radica nel presente. Ci si ritrova al cospetto di una questione talmente fitta di contingenze e di implicazioni politiche, sociali, culturali, economiche e antropologiche, presenti e passate, che la comprensione di un meccanismo tanto complesso non potrà che provenire da una cognizione e da una speculazione altrettanto articolate, elaborate, sconfinate. Non già passionali, bensì computazionali. O spetterà, forse, ai posteri i quali vorranno districarsi tra i fatti del tempo per comprenderne l'eredità e la portata storiche, saziando il naturale anelito dei contemporanei verso l'interpretazione della propria epoca. Eppure, i solchi che sono già stati segnati, e che vengono rimarcati tuttora, perseverano nell’opera dilaniatrice di una terra povera e imbevuta di piogge persistenti di cui lentamente si rinuncia ad indagare l’origine. Tutto questo, se da un lato soffoca ogni sforzo di controazione materiale, non deve per questo sfaldare l’ultimo dubbio inquisitore di chi, pur sconfitto, osserva e s’interroga, e non chiede che di soccombere con dignità. Ciò che si distingue nitidamente in questa nebbia di spettri è soltanto un flebile e scandito ticchettio, il ticchettio di quell'orologio, perfido come l'indifferenza, fatale come una sentenza, che annuncia ad un ragazzo che è giunto il momento di imbracciare le valigie e di salutare i propri cari. È stupefacente come una così fragile ed effimera sequenza di secondi possa assistere con tanta, inanimata serenità al consumarsi di un simile sconvolgimento emotivo senza per questo avvertire il bisogno d'arrestarsi, di riavvolgersi, di annullarsi. Tanta amarezza risiede nella differenza profonda che separa due tipologie fondamentali di percezione della partenza: quella impaziente e trepidante del viaggiatore curioso e desideroso d'avventura, e quella, deforme e maledetta, dell'esiliato, ovvero di colui che sa di partire per non far più ritorno. O che fa ritorno, sì, ma non allo stesso modo. Non compiutamente, bensì accompagnandosi di una presenza insistente: la provvisorietà, che contamina puntualmente la familiarità ritrovata e s'impossessa, subdola, di ogni momento, deprivandolo della serenità con il quale esso andrebbe vissuto. Nell’emigrante meridionale queste due percezioni coesistono fuse l’una nell’altra, si mescolano e si compenetrano e si contendono l’animo del giovane, si aggrovigliano attorno al cuore e disputano una battaglia disperata sul terreno malfermo dei suoi desideri. Il problema più grave non è la lontananza da casa, ché questa è un’esperienza foriera di un eccezionale arricchimento per chiunque la intraprendesse, quanto la condanna a dover riformulare prematuramente la concezione stessa di casa.
Ma picchì? Sembra, quasi, che ormai lo si dia per scontato. Come se fosse una sorte cui irrimediabilmente si dovrà andare incontro nella persecuzione della propria realizzazione. Il dolore si ammutolisce ed assiste, annichilito dalla prassi, ad un moto perpetuo verso il baratro di oblio che si spalanca sotto i piedi di chi percorre il proprio cammino: oblio di una felicità integra, oblio della speranza, oblio della pasta al forno la domenica. Un anestetico che sazia la fame di risposte con una generosa porzione di rassegnazione. È triste ed ingiusto. È triste come il fatto che il popolo del Sud sia stato indotto a credere che le opportunità non siano diritti, ma beni di consumo. È ingiusto che la scelta debba ricadere tra l’accorciamento delle distanze o l’accorciamento dei sogni.
Ma picchì? In questo generale ottundimento di illusioni salvifiche e di visoni chiarificatrici, in questo calderone stracolmo di confusioni e di contrasti ribollenti, si sviluppano le condizioni ideali per l’attuazione, selvaggia come un primordiale istinto di sopravvivenza, di quel vibrante protocollo sovversivo cui ogni ventenne si attiene rigorosamente in virtù della definizione stessa di ventenne, della ventenne, testarda, ostinata testa di minchia. Esso prescrive la rivolta, inneggia al sabotaggio, proclama lo stravolgimento, sospinge il cambiamento, brama la ribellione e culmina sancendo, pulsante, la speranza. Speranza di tramutare la partenza in ritorno, speranza di trovare il riscatto, speranza di determinare un nuovo, rigoglioso andamento delle cose. Speranza e volontà di ricostruire la bellezza e la grandezza originaria dei propri luoghi, di rifondarvi il centro delle proprie vite. Di riportare queste regioni tra gli allori delle terre di serie A, ovvero delle terre in cui l’Amore prevale sull’Abbandono, e l’Ambizione non preclude l’Arancino. È una speranza che si nutre della stessa, voluttuosa follia che ne rappresenta, al contempo, il fascino inesauribile, com’è d’altronde accaduto per tutte le grandi idee ed i grandi eventi del passato. Fatti legati tutti da un comune denominatore al quale prende parte, al fianco della follia, l’elemento puramente umano: sta tutto lì. È negli uomini che risiede il motore primo, la congiuntura favorevole. È lì che risiedono l’ardimento ed il coraggio. È sempre stato così: tutte le conquiste, tutto il progresso, non sono che un frutto delle menti degli uomini, delle loro teste. Delle teste di minchia.
PAOLO PINO
0 notes
Text
Incongruenze, sciatterie, banalità: analisi sistematica del romanzo di Fabio Volo (senza considerare il personaggio). Ovvero: sulla nascita di un nuovo genere letterario, il libro che devi leggere saltando le pagine
Premessa. Ogni volta che Fabio Volo pubblica un romanzo, nella bolla editoriale cresce l’agitazione. Da anni, come è uso in Italia, l’affaire Volo si è ridotto a tifoseria (metto la maglietta di Fabio nostro o vado nella curva avversaria per insultarlo?), ed è difficile leggere recensioni distaccate dal clima da stadio. Su Pangea Matteo Fais e Viviana Viviani hanno ben stroncato il nuovo romanzo, “Una gran voglia di vivere”, senza risparmiare ottime considerazioni sugli elementi culturali di un successo non solo commerciale. Per offrire una visione completa di un fenomeno non ignorabile (forzatamente?), mi è sembrato interessante impelagarmi in una analisi del testo di “Una gran voglia di vivere”. Perché è giusto che il testo puro, da solo, parli per l’autore.
La trama. Marco e Anna, entrambi architetti, vivono una crisi di coppia. Lui è molto preso dal lavoro, al contrario lei lo ha messo da parte da quando hanno avuto un figlio, Matteo. Rispetto ai primi tempi del rapporto, le differenze tra i due sono diventate pesanti; tuttavia la decisione di separarsi è difficile da prendere, considerate anche le conseguenze che ci sarebbero per Matteo. Per questo decidono di intraprendere un viaggio in Australia e in Nuova Zelanda, sperando così di risanare il loro legame. La storia è narrata da Marco. Il romanzo è una favoletta morale, durante la quale Marco e Anna incontrano persone che raccontano le loro vite, con crisi esistenziali e coniugali, fughe da lavori stressanti, fughe dalla città verso la natura e la conquista di ciò che hanno capito essere la vita vera. Al lettore potrebbe sembrare assurdo, alla lunga pesante, la facilità con la quale ognuno di questi personaggi sveli dettagli personali agli sconosciuti. Senza considerare che tutti discutono proprio delle tematiche che riguardano il protagonista. Potremmo accontentarci di definirla una esigenza narrativa colmata con molta pigrizia. Ci sono criticità più evidenti.
La struttura. La struttura è sciatta e lo stesso vedremo per lo stile. Non sempre è chiaro dove si trovino i personaggi. Gli spostamenti di narrazione tra passato e presente sono bruschi, talvolta confusi. Ci sono omissioni che definirei comodissime – l’autore fa di tutto per assecondare la pigrizia. Non mancano incongruenze logiche. Partiamo da queste ultime.
Marco racconta di quando ha conosciuto Anna. Era a una cena tra amici: “Gli uomini erano fuori, vicino alla griglia, con delle birre in mano a chiacchierare e ridere. Le donne, in cucina, preparavano insalate, tagliavano pomodori e mozzarella, stavano ai fornelli per fare la pasta”. Marco passa in cucina per un saluto e poi raggiunge gli uomini. “Mi hanno subito passato un bicchiere di vino rosso”. Bevono birra, ma offrono il vino? Strano.
Qui una svista grave, soprattutto per un editor: “le sarebbe piaciuto andare in Australia e Nuova Zelanda durante l’estate, quando qui da noi è inverno”. Partiranno a marzo.
Durante un’altra cena, narrata nel capitolo 9, Marco rivede una compagna di scuola.“Di fronte a me c’era Loredana. È sempre stata la ragazza più bella del gruppo, quella che tutti sognavamo e su cui facevamo fantasie. Era ancora una bella donna”. Dopo la cena, chiacchierano nel parcheggio. Sempre Marco: “Guardavo Loredana mentre parlavo, e c’era qualcosa in lei di diverso, attraente, che non riuscivo bene a spiegarmi, durante la cena non l’avevo notato”. Sembra il contrario.
Ancora incongruenza logica al capitolo 23. “Il colpo di grazia è stato quando mi ha detto che le sarebbe bastato anche solo un lungo abbraccio”. In realtà è dall’inizio che leggiamo di contatti fisici tra Marco e Anna, talvolta non intensi come le prime volte, ma che avvengono. Invece qui, improvvisamente, Anna si sta lamentando dell’assenza totale di contatti, non della loro sincerità.
Nel capitolo 16 Marco visita un albergo particolare. “Ogni materiale era organico, riciclato, non trattato chimicamente”. Mi permetto un inciso professorale: in natura tutto è chimica. Tornando a noi, stupisce leggere che un architetto, che sospettiamo essere esperto di design, possa definire un materiale riciclato come non trattato chimicamente. Ma torneremo presto sulla professione di Marco. Per ora ci concediamo una previsione ironica: trattandosi soprattutto di legno, se davvero il materiale non fosse trattato farei sgomberare la struttura.
Nel capitolo successivo Marco chiacchiera con una barista: “Una parte seguiva il dialogo con lei, rispondeva alle domande, cercava di dire cose interessanti e divertenti con l’intento di sembrare brillante”. Non viene riportata una sola battuta di questo dialogo dall’intento brillante. Scelta comoda per l’autore.
Riassumo una scena del capitolo 18, nella quale Anna convince Marco a comprarsi un cappello. L’acquisto viene effettuato controvoglia. Marco si sente ridicolo e lo ribadisce più di una volta. Ciò non gli impedisce successivamente di andarsene in giro con il copricapo della discordia. “Prima di uscire ho indossato il cappello nuovo. Nel tragitto, ho avuto la tentazione di togliermelo, avevo paura di sembrare ridicolo”. Né durante la scelta del cappello, né successivamente troviamo una minima descrizione. Non conosciamo il modello, neppure il colore. Perché il cappello è ridicolo? Ancora una pigrizia. Vero è che qualcosa all’immaginazione del lettore va sempre lasciato. Qui però siamo davanti al nulla.
Al capitolo 25 c’è un passaggio poco chiaro. I protagonisti entrano nel negozio di un artigiano. Marco sottolinea: “da sempre mani capaci mi affascinano, qualsiasi sia il lavoro che stanno facendo”. Con un ingiustificato e oscuro cambio di registro, mentre chiacchiera con l’artigiano Marco comincia a trovarlo ridicolo. E così pure Anna. Entrambi si trattengono dallo scoppiare a ridere. Cosa che faranno appena usciti.
“«La prima cosa che ho imparato è stato concedermi una semplice passeggiata, non per andare da qualche parte, ma per il piacere di farlo.» Anna mi ha guardato, non mi ha detto nulla, ma ho capito che si stava sforzando di non ridere. «Poi ho iniziato facendo piccole cose, cose apparentemente stupide.» «Di che tipo?» ho chiesto. «Una sedia.» Io e Anna non potevamo guardarci, ero sicuro che saremmo scoppiati”. Marco specifica: “Non diceva cose insensate, era il modo in cui lo faceva a rendere tutto ridicolo”. Quale sia il modo in cui parla, perché Marco e Anna stiano scoppiando dal ridere sono misteri che restano tali.
*
Tocca dilungarmi sull’incongruenza del capitolo 31. L’ennesimo personaggio che descrive il proprio matrimonio finito ha una figlia. Marco ha una domanda importante da porgli: “«Vai d’accordo con tua figlia?» gli ho domandato. Volevo capire se fosse possibile mantenere un buon rapporto con i figli dopo la separazione, non avrei sopportato di mettere a rischio il futuro tra me e Matteo”. Il problema è che nei due capitoli precedenti si legge che le cose stanno migliorando, e di molto. Infatti nel capitolo 29: “C’era una buona energia quella sera, tutto girava bene, in modo naturale, senza fatica”. E il capitolo si conclude con con risate, scherzi e Anna che: “Mi ha messo una mano sul petto e mi ha spinto in camera”. Azione importante, in quanto era lei a rifiutarsi di fare sesso.
Il capitolo 30 invece è dedicato – seppure con superficialità – al rapporto tra Marco e Matteo. Rapporto che, sempre da ciò che narra Marco, si solidifica. Per questi motivi leggere nel capitolo 31 che l’idea della separazione sia tornata a essere concreta è davvero illogico. Prima del lieto fine – c’è da dire poco approfondito –, la coppia vive un periodo di separazione. Nel capitolo 36 seguiamo Marco che torna al paese natio. “La verità era che del paese non ricordavo quasi nulla, solo la stanza d’albergo in cui mio padre e mia madre ridevano complici”. Poi racconta di un episodio che si conclude con il padre che ride: “Era l’unica volta in cui avevo visto mio padre ridere”. Ma nel capitolo successivo: “Mi mancava ridere con lui, le poche volte in cui era accaduto”. Un padre che ha riso più volte davanti a Marco, il quale dichiara di averlo visto ridere un’unica volta.
Proseguiamo con piccole sciatterie. Capitolo 1, ripetizione inutile: “Ho fatto un lungo respiro e, per la prima volta, le ho detto la verità, le ho detto quello che sentivo veramente”. Capitolo 18: “Quando ero piccolo, per colazione mio nonno faceva un piccolo buco in un uovo e poi lo beveva. Alla fine mi dava il guscio vuoto. Anna ha fatto lo stesso con me, mi ha svuotato ed è rimasto solo il guscio”. Il ricordo del nonno è improvviso e senza seguito; inoltre non rinforza la similitudine del guscio, che per quanto scontata avrebbe fatto il suo anche senza introduzioni. (Tranquilli, torneremo sulle similitudini).
Nel capitolo 20 Marco conosce Elias, un ragazzo che viaggia con la bici e dorme in tenda. “Scriveva su un taccuino. Ho immaginato fosse il suo diario di bordo”. “Il suo diario” sarebbe stato sufficiente. Tanto più che Elias non naviga. Se mi si volesse tacciare di pignoleria, potrei rispondere che mi aspetto altrettanta pignoleria da un libro Mondadori.
Il capitolo 24 si apre con una descrizione paesaggistica imbarazzante. Ricordiamo che a descrivere è un architetto:“un paesaggio così perfetto da sembrare un dipinto: sulla sinistra un lago blu intenso, sulla destra una montagna che passava dal verde chiaro al marrone scuro. Il cielo era attraversato da nuvole bianche e gialle. Siamo rimasti a bocca aperta, senza parole”. Senza parole.
Il capitolo 25 si apre con una nozione enciclopedica: “Petricore è un termine coniato da due ricercatori australiani e indica il profumo della pioggia sulla terra quando ha appena smesso di cadere”. Bisogna considerare che il capitolo precedente si era concluso con un acquazzone. Tuttavia questa informazione, riportata con un notevole cambio di registro, non ha un seguito. Infatti continua: “Mi sono svegliato e sono uscito subito dal camper, fare la pipì all’aperto è una delle cose che più regalano un grande senso di libertà. Passeggiavo vicino al lago, tutto era tranquillo e silenzioso, sentivo il sole tiepido sul viso, sulle braccia, l’aria tersa, vivificante”. Nessun accenno al petricore.
Altro pleonasmo al cap 32: “vedere nell’altro quello che si vuole vedere”. Fine del capitolo 34: “«Ho un lavoro da fare qui» ho risposto ingoiando le lacrime”. Peccato che Marco non stia piangendo, lo farà dopo. Il lettore dovrebbe intendere “trattenere le lacrime”? Ancora: “I bambini vivono a una velocità diversa dalla nostra, muoiono ogni volta che vanno a dormire, e ogni mattina rinascono”. Non vedo l’esclusività dei bambini in questo. Tanto che la metafora, largamente inflazionata, è possibile leggerla in molti altri testi con riferimento a personaggi adulti.
Concludo gli esempi con un passaggio simbolo della sciatteria, che introduce in parte il discorso sul personaggio di Marco. Nel capitolo 13 Marco ricorda: “lì abbiamo fatto l’amore per la prima volta. È stato intenso e coinvolgente”. La narrazione si sposta subito altrove, e difficilmente posso credere che un lettore rimanga coinvolto leggendo questo comunicato stampa.
*
Il lavoro di Marco. Sia chiaro: i personaggi non hanno spessore. I dialoghi non rivelano nulla. Le voci sono identiche tra loro. Qualcuno potrebbe obiettare che in un romanzo simile la bidimensionalità sia, addirittura, auspicabile. L’idea non mi convince. I personaggi di un romanzo risultano articolati e definiti se lo sono altrettanto le loro relazioni. Purtroppo queste ultime sono accennate. Non solo le relazioni con i personaggi secondari, ma la stessa relazione con Anna, che di conseguenza rimane impalpabile. E non parliamo del piccolo Matteo. Tale inconsistenza non risparmia Marco. All’inizio del romanzo leggiamo: “Quando Anna mi ha chiesto se la amavo ancora, ho capito che lo stava facendo in un modo diverso, voleva una risposta onesta. Non potevo risponderle come avevo sempre fatto. Sono rimasto in silenzio, dovevo decidere se essere sincero o dire una bugia che mi avrebbe permesso di rimandare ancora. Non ero sicuro di voler rendere ufficiale la nostra crisi. Se avessi dato una risposta vera, non avremmo più potuto far finta di niente”. Queste considerazioni rimarranno inalterate fino alla fine. Saranno ribadite con petulanza, con giri di parole che non hanno effetto diverso di un copia-incolla del paragrafo sopracitato. A causa di una evoluzione del personaggio inesistente, la decisione finale di rimanere insieme nasce senza cause decisive. Né da parte di Marco né, figuriamoci, di Anna. Giusto perché – ci risiamo – l’autore aveva deciso di chiudere il romanzo.
Ad avermi spiazzato è ciò che chiamo Il problema del lavoro di Marco. Sappiamo che è un architetto, che lavora in uno studio, si presume importante, certamente con professionisti di pari livello. Marco dichiara più volte di amare il lavoro e le sfide che comporta, di non poterne fare a meno, di dedicare tantissimo tempo della giornata ai progetti che gli vengono commissionati. Se tali dichiarazioni sono numerose, e mi pare inutile riportarle, purtroppo non abbiamo una sola scena nella quale Marco stia lavorando. Viene narrata una riunione nel capitolo 5, successivamente Marco incontra il capo in ufficio. Ma non sappiamo come Marco, nel concreto, trascorra le molte ore di lavoro giornaliero. Nel capitolo 6 Marco racconta di quando Anna, anche lei architetta, decise di non lavorare per stare con Matteo: “si era resa conto che rientrare a pieno regime non sarebbe stato così facile, […] lei non si sentiva di lasciarlo ad altri per dieci ore al giorno”. Volendo ipotizzare che anche Marco lavori dieci ore al giorno, mi tocca constatare che di queste non ne viene descritto un solo minuto. Tanto che è disorientante leggere al capitolo 7: “E quando era nato Matteo mi chiedeva di accompagnarla dal pediatra. Mi sembrava che spettasse a lei, al limite poteva domandarlo a sua madre. Mi stupiva che mi facesse quelle richieste, Anna conosceva bene il mio lavoro, sapeva quanto era difficile”. Anna lo sa. I lettori no.
Ultimo esempio. Nel capitolo 14 Marco descrive un hotel design nel quale aveva portato Anna. “Conoscevo lo studio che l’aveva realizzato e avevo il sospetto che avrei visto cose che mi avrebbero infastidito. Non mi sbagliavo, non era bastata la vasca in mezzo alla stanza, l’architetto aveva pensato fosse una bella idea non mettere la porta al bagno, nascondendo il water dietro un muretto. Ho dovuto usare sempre i servizi vicino alla sala colazioni”. Per quanto sia dubbioso, un insolito ottimismo mi spinge a credere che un architetto esperto capisca quale sia il problema. Sembra un tentativo di dare solidità alle conoscenze del personaggio. Tentativo fallito.
*
Similitudini. Ammetto che un discorso sulle aspettative potrebbe rendere poco efficace questa parte dell’analisi. Vorrei però ricordare che Fabio Volo non ha mai risparmiato lamentele per il fatto che non venga considerato nei premi letterari importanti. Mia modesta opinione è che una aspirazione del genere dovrebbe portare uno scrittore a evitare di scrivere come chiunque – sì, in alcuni casi mi arrendo all’idealismo. Prima di riportare alcune similitudini scontate, confesso di avere provato a contare quante volte appaia nel romanzo la parola come. Parola che non sempre introduce un paragone o una similitudine, questo è chiaro. Ma intanto in un volume di 216 pagine ho trovato la parola come più di 150 volte.
Per amore di precisione: ho smesso di contare non ricordo dove, ma sospetto possa superare le 200. Stavolta perdonate la mia, di pigrizia. Per rifarmi dichiaro di avere contato una parolina da tenere sempre d’occhio: tutto. 142 volte. E un’altra che mi ha sorpreso ritrovare così spesso, tanto da inserirla nei conteggi: momento. 45 volte.
Ora una lista delle similitudini più scontate:
“come se in quel buio stessi precipitando”
“sarebbe volata via come un palloncino a una festa di paese”
“mi sono ritrovato a vivere in una distanza densa, come una gelatina”
“come se per la prima volta ci trovassimo su due barche diverse e ognuno andasse al largo sulla propria”
“come se qualcosa dentro di me avesse preso la parola”
“Il cuore mi si è sciolto come burro”
“Le sue parole continuavano a girarmi in testa, come se avessero fatto scattare un cortocircuito”
“sembrava sereno come un lago”
“come se fossi un condannato a morte in attesa della sedia elettrica”
“ho sentito come se qualcuno mi stesse strappando il cuore dal petto”
“mi sentivo solo come un cane”
“Giravo come un animale in gabbia”
Mi ha colpito la seguente: “Come un uccello che vola e che non si cura dei muretti e delle staccionate”. Perché dovrebbe?
*
Triplette e anche di più. A rendere la lettura pesante è uno stilema che, per esperienza personale, ho riscontrato spesso in chi è alle prime armi. Posto che rifuggo le ortodossie, le triplette di Fabio Volo sono innumerevoli e ridondanti, in alcuni casi a poca distanza l’una dall’altra. Eccone alcune:
“C’era stato più trasporto, più forza, più passione”
“Ho avuto la sensazione che tra me e lei fosse finito un modo di stare insieme, una bugia sospesa, la nostra storia”
“Era una creatura rara, preziosa, sospesa”
“Amo seguire qualcuno quando ha una visione chiara, innovativa, coraggiosa”
“Un uomo intelligente, pacato, maturo avrebbe ingoiato il boccone”
“Il lavoro è fatto di disciplina, di mestiere, di regole”
“Ero uno spirito libero, rispettoso degli altri, dei loro spazi, delle loro necessità”
“alla fine si era spento tutto, l’amore per lei, l’amore per altre cose, l’amore per me stesso”
“Era difficile accettarlo, mi sembrava stupido, ingiusto, sbagliato, addirittura scorretto.” (Qui addirittura quattro! NdA)
“non ci sarebbero più state cose eccitanti, nuove, avventurose”
“Ero preso dalle mie paure, dai miei dubbi, dai miei inspiegabili umori.”
“Per uscire da quella crisi servivano forza, energia, volontà”
“ma certo sembrava ringiovanito, più sorridente, più pieno di energia.”
“Tutto era delicato, silenzioso, rilassante”
“mi desse un’aria più matura, più profonda, più intelligente”
“quando viaggio mi sento acceso, vivo, pieno di energia”
“aggravavo la situazione con nuove proiezioni, supposizioni, scenari”
“La calma, l’ordine, l’assenza di confusione mi destabilizzavano”
“la mia mente aveva smesso di tormentarmi con mille supposizioni, congetture, proiezioni, paure” (di nuovo quattro! NdA)
“la mia vita era diventata sbrigativa, veloce, superficiale”
“Non avevo bisogno di più cose, più relazioni, più persone”
*
Conclusioni. Una caratteristica nominata spesso riguardo i romanzi di Fabio Volo, e letta anche per “Una gran voglia di vivere”, è la scorrevolezza. Dato che da questa piccola analisi sono emersi problemi su più piani e diffusi, e dato che ho letto romanzi scorrevolissimi scritti meglio; verrebbe da chiedersi se un romanzo scritto malissimo possa comunque risultare scorrevole. Se tutti i romanzi scritti male siano scorrevoli, oppure se ci sono romanzi scritti male scorrevoli e romanzi scritti male non scorrevoli, e a questo punto perché. Ho un sospetto sul perché “Una gran voglia di vivere” possa essere definito scorrevole, e nasce proprio dalle criticità viste finora. Un romanzo con personaggi abbozzati, con un narratore interno alla storia che presenta una situazione uguale a se stessa in ogni capitolo, dove le differenze tra ambienti anche distanti non sono notevoli, né il tempo della storia è ben definito, è un romanzo che si può leggere saltando continuamente le pagine. Il rischio di perdersi passaggi importanti è nullo. Forse è questo il grande segreto di un romanzo scorrevole. Al di là di come sia scritto.
Marco Parlato
L'articolo Incongruenze, sciatterie, banalità: analisi sistematica del romanzo di Fabio Volo (senza considerare il personaggio). Ovvero: sulla nascita di un nuovo genere letterario, il libro che devi leggere saltando le pagine proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/32iuOAj
0 notes