#bellezza nella semplicit��
Explore tagged Tumblr posts
Text
Santarcangelo Festival 2019: dalle “sirene” alla “bombastica” Pamela Anderson, passando per una performance sulle badanti ucraine. Oggi il teatro attraversa una cupa crisi di idee…
Merman Blix ha lasciato il segno. Nell’acqua. A due anni di distanza dalla performance del “sirenetto” Santarcangelo Festival torna a strizzare l’occhio (e i costumi) all’elemento liquido per antonomasia, qui ancora una volta “tavola materica investigativa” di una rappresentazione. “Dragon, rest your head on the seabed”, performance firmata dagli spagnoli Pablo Esbert Lilienfeld e Federico Vladimir Strate Pezdirc e portata in scena – o meglio, in piscina – il 5 e il 6 luglio al Multieventi di San Marino è la moltiplicazione (con tanto altro) dell’assolo di Blix, ed unisce l’arte della danza all’attività sportiva (forse più la seconda della prima).
Al di là della potenziale e inutile discussione sulla natura dello spettacolo – è teatro quindi “teatron” nell’accezione di “luogo dello sguardo” oppure, sic e sempliciter, disciplina sportiva? – “Dragon, rest your head on the seabed” è un mosaico di sei nuotatrici che vengono frantumate in sei “pezzi” e che solamente nell’acqua ritrovano l’unità scomposta. Ad un incipit penalizzato da una lentezza narrativa e da un palcoscenico che tende a disperdere la tensione – la piscina da 50 metri annacqua il pathos – segue, negli ultimi 25 minuti, un’accelerazione più visiva che semantica: le sei nuotatrici si ricompattano e ritmo di tunz tunz e ridanno vita al “Dragon” acquatico, una creatura in sospeso tra un “Nessie” di Lochness 4.0 e un omaggio alle fantasie oniriche del Sol Levante. Più sport che teatro, probabilmente, anche se non mancano i momenti d’impatto teatrale: il rumore del microfono sbattuto sull’acqua, l’utilizzo delle torce “waterproof” che illuminano e disegnano strade subacquee, gli arazzi delle gocce che schizzano in alto quando le gambe impattano sulla superficie. C’è un aspetto più squisitamente estetico, quella dell’alternatività. Se la buona norma apparente della scena richiede attori e attrici filiformi, freak o con fisici da lottatori di Sumo, la sensualità tonica delle sei nuotatrici forgiate in vasca diventa un messaggio di straordinaria bellezza, o di moderna frizione: si può essere attori anche unendo l’esercizio mentale a quello fisico senza necessariamente doversi agghindare con colori improbabili o con vestiti che odorano di muffa.
*
Hanno messo quello che mancava, quello che oggi serve per capire: il suono. Ronin, solido gruppo musicale rock italiano attivo sulle scene da 20 anni, ha racconto e vinto la sfida, quella di creare un tessuto di note di accompagnamento al film muto “The Unknown” (1924) diretto da Tod Browning. Ed il risultato è stato piacevolmente sorprendente: arpeggiamenti incisivi e adiacenti ai dialoghi della pellicola. Peccato solo che la programmazione gratuita in piazza Ganganelli si limiti alla proiezione di alcuni film e non a qualche spettacolo di teatro vero, come è accaduto in passato: basterebbe anche un lavoro a sera per “far assaggiare” a un pubblico clementino – che per crescere numericamente si deve rinnovare – quello che viene proposto negli spazi chiusi del Festival. Eppure la piazza, in passato, ha ospitato, tra gli altri, anche Ascanio Celestini, Davide Enia, Pippo Delbono e Silvio Castiglioni. Come dimenticare il suo monologo del 2013 – quando al Festival si vedeva ancora il teatro di parola – dedicato Nino Pedretti, “L’uomo è un animale feroce”? Un lavoro che ha saputo contagiare il numeroso pubblico presente e interpretato con grinta e qualche imprò gradevole (a inizio spettacolo uno spettatore ha chiesto “voceee” e Silvio Castiglioni ha recitato per qualche secondo con un tono burrascoso e quasi urlato, tra le risate della platea).
Due pubblici quindi, quello del Festival e quello di chi sceglie la piazza per fare un giro con il cane o per degustare un gelato. Un peccato perché due gocce d’acqua, come insegna Tonino Guerra (che era di casa a Santarcangelo), potrebbe fare una goccia più grande.
*
Gli spettacoli cosiddetti “belli” (e “Italia-Brasile 3 a 2” di Davide Enia ospitato in piazza Ganganelli – e quindi per tutti – in occasione del Festival 2003 è davvero un sublime viaggio nel Belpaese pallonaro) in realtà “non hanno tempo”. Perché, nella memoria collettiva dello Stivale, “il Mondiale” è sempre e ancora quella di Spagna, 1982, l’epopea di un’Italia che lasciava gli Anni ’70 per entrare nel nuovo decennio. Ci sono motivi sociologici, dietro, più tondi e pesanti di una sfera di cuoio. Lo spettacolo muove da un breve riepilogo dei fatti accaduti quell’anno: da Vasco Rossi a Sanremo all’omicidio La Torre, dal prezzo della benzina all’avvento del colore nella tv di casa. Proprio attorno ad un nuovo, e bellissimo, Sony Black Triniton quello storico 5 luglio 1982 si raccoglie la famiglia del protagonista: ognuno con i propri riti, con le proprie scaramanzie, con i propri gesti: il padre (vestiti mai lavati, per tutte le partite della squadra nazionale), la madre (accarezzava quasi tutto il tempo la testa di piccolo Enia), le nazionali dello zio, il caffè “che quando l’Italia ha segnato il suo primo gol ai mondiali in Spagna c’era chi stava bevendo un caffè”. La scaramanzia, i numeri del lotto (1-48-90) lì dove l’1 è l’Italia, il 48 “morto che parla” (Paolo Rossi) e 90 la paura, la grande paura. Il grande Brasile. Eder, Junior, Socrates, Falcao. E qui l’omaggio: Enia cambia nome e imitando Carmelo Bene, snocciola la definizione, Falcao “Il più grande giocatore al mondo… senza mondo” (lì dove il secondo “mondo” è il pallone). Si ride, ma con la mente, e con il cuore pieno, che quando la divagazione tocca le corde del cuore, le parole si fanno sasso, lama, martello e polveriera: Garrincha, il giocatore del Brasile Anni ’50 azzoppato da una malattia che gli aveva regalato una gamba più corta dell’altra, 6 cm 6, mica uno sputo, prova te a vivere e giocare a calcio con una gamba lunga e una corta. Il passerotto Garrincha morto, dimenticato e povero, mezzo alcolizzato nel 1983, che ha avuto giusto il tempo di vedere la partita, e piangere. O l’eroica fine della squadra del Dinamo Kiev, sterminata dai nazisti nel 1942: Tusevich, mica Dino Zoff e i suoi 40 anni, che viene fucilato. Un uomo avrebbe chiuso gli occhi. Lui – ed Enia – no: l’istinto è l’istinto, e non lo puoi fermare, e Tusevich si tuffa, e para il proiettile con il cuore. E lì dall’oltretomba, il sorriso, compiaciuto e denso di tabacco, del grande Gianni Brera…
*
Quando in piazza a Santarcangelo si protestava. Pare ieri, ma sono già trascorsi 14 anni da quel meraviglioso rigurgito di anni Settanta. Piazza Ganganelli, un lunedì sera dell’anno di grazia 2005, era davvero gremita. La gente del teatro era incazzata nera per i tagli che ha subito il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo. Dal 1985, ossia da quando è stato istituito, il Fondo non solo non era stato incrementato seguendo gli aumenti del costo della vita ma anche solo rimanendo costante, senza tagli, aveva perduto il 20 anni il 51% del suo valore. Ancora più preoccupante era un altro aspetto: pur restando costante l’ammontare dell’economia del Fondo, il numero delle compagnie sovvenzionate era passato da 300 a 200. In parole povere, e per ragioni più o meno clientelari, si estendeva a dismisura l’area dei purètt, dei poveracci, costretti a spartirsi le briciole.
*
Da sempre il teatro crea una “simulazione fisica di uno stato mentale”, come afferma Derrick de Kerkhove. In Italia il punto di partenza fu quella lontanissima Ivrea 1967 quando fu promosso – da personaggi di un certo spessore, tipo Carmelo Bene, Franco Quadri, Leo De Berardinis, Luca Ronconi e altri ancora – il “Convegno del Nuovo Teatro”, che sancì, di fatto, l’avvio di un’era di sperimentazioni. Nel “Manifesto” pubblicato nel novembre del 1966 sulla rivista “Sipario” si affermava che ci si deve “servire del teatro per insinuare dubbi, per rompere delle prospettive, per togliere delle maschere, per mettere in moto qualche pensiero”.
La situazione geopolitica e artistica però era molto differente da quella di oggi. In un teatro attuale che al 90% è morto, che è fatto di routine e abitudine e un certo snobismo (specie nella Provincia di Rimini, dove gli attori non vanno mai a vedere gli spettacoli dei colleghi), accanirsi a portare in luce i difetti (che senza dubbio esistono) dei pochi, pochissimi spettacoli “vivi” ancora in circolazione, di quegli spettacoli e di quegli artisti che hanno davvero qualcosa da dire e non salgono sul palco per moda, per noi, per benessere familiare (spesso i genitori foraggiano i figli) o per sentirsi fighi, significa appiattire il proprio sguardo e quello del pubblico.
Oggi il teatro attraversa una profonda crisi di idee. Una crisi dilagante. Nel teatro, e dentro il teatro. A parole, tutti sottoscriverebbero il principio che debba essere finanziato chi osa innovare. Ma quando il teatro di innovazione (o, come mi ha detto, bene, Mariangela Gualteri del Teatro Valdoca, “il teatro contemporaneo”) diventa una categoria burocratica e massonica in cui far rientrare ogni sorta di realtà non altrimenti catalogabile, le distinzioni si complicano enormemente. Persino il concetto di “gruppi giovani” è ambiguo e piuttosto precario: tutti si sentono teenager, nonostante qualche capello bianco. Oggi chiudono le fabbriche e i lavoratori vengono mandati a casa. Non c’è nulla di così profondamente drammatico se una compagnia abbassa le saracinesche: se saprà rimboccarsi le maniche e trovare finanziamenti in maniera autonoma, allora potrà proseguire nel personale percorso drammaturgico. Altrimenti si faccia altro: i mestieri sono tanti e infiniti, e uno buono lo si troverà di certo. Questa volta non si butti via il bambino con l’acqua sporca e con la sua culla: si tagli il cordone ombelicale che lega l’infante capriccioso alla mamma-cassa, e si inizi a camminare con le proprie gambe. Il teatro non è un obbligo. È, tutt’al più, una necessità.
*
Nei giorni post mobilitazione, il Collettivo Aurora ha scritto una bella lettera. Tra le tante affermazioni contenute (e pienamente condivisibili), due meritano spazio. La prima è di carattere economico, la seconda di natura squisitamente artistica.
Il Collettivo, nella sua missiva, ha fatto due conti. “Su 803 mila euro di entrate previste per il 2005, 530 mila provengono da contributi pubblici; 141 mila dall’attività associativa; 132 mila da sponsor e simili. Queste le cifre ufficiali. Ci si chiede: Santarcangelo dei Teatri è un’associazione non lucrativa o una societ��? (…) Malgrado i tagli della Finanziaria, il Comune di Santarcangelo ha beneficiato di una discreta maggiorazione di fondi: +20 mila euro”.
Condivisibile financo la singola virgola le parole sugli spettacoli. “Lasciamo da parte i giudizi artistici: anche quelli benevoli, che d’altronde sembrano concentrarsi quasi esclusivamente nel gazzettino che gli organizzatori stessi fanno scrivere agli studenti del DAMS in cambio di appetitosi crediti formativi”.
Il Collettivo poi ha raccontato la giornata di mobilitazione. In punta di penna. “Giornata di mobilitazione nazionale: nientemeno. Scomodati istituto comizionale e Majakovskij. Che sinistra non riuscirebbe a commuoversi? Gran mossa: così i panni sporchi di casa Festival finiscono nella cesta degli orrori nazionali. Il buon Paolino (Rossi), convinto da cachet e dalle nobili intenzioni, se l’è bevuta come i santarcangiolesi e tutti gli altri. Riassumendo e rilanciando: rastrellamento aggressivo di fondi, disinteresse verso i partner, trasparenza zero, cariche, ruoli, impieghi blindati per consuetudine nepotistica e clientelare, arbitrarietà totale, impunità sulle scelte gestionali, buchi di bilancio. Anche questo è il festival”.
*
Calviniano ma non calvinista, sociologicamente contemporaneo, ibrido nella sua forma scenica, “Lighter than Woman” di Kristina Norman non è assolutamente uno spettacolo teatrale ma una “performance-documentario” sul mondo delle badanti ucraine che vivono a Bologna e a Santarcangelo. “Calviniano”, questo lavoro, lo è soprattutto nell’ouverture: l’artista di Tallinn difatti dona al pubblico, accaldato e stipato nella saletta della Collegiata come pulcini nelle gabbie, la propria teoria sulla gravità e sulla pesantezza (chiaro e cristallino il riferimento a “Le lezioni americane” di Italo Calvino), mettendo a specchio Samantha Cristoforetti e le donne dell’est che lavorano in Italia. Storie di sofferenza, di potenziali abusi, di mancanza di diritti, di nostalgia – nell’accezione di nostos greco –, di lavori di fatica fisica e di difficoltà nel farsi accettare. I numeri snocciolati con un sorriso da Kristina raccontano di un fenomeno che ha la forma dell’iceberg: 2 milioni di donne pagate, la metà in nero, quindi un “sommerso chiuso nelle case delle persone anziane, senza garanzie e senza welfare.
Se poeticamente l’operazione si può dire indovinata (l’argomento comunque, va detto, è di facile presa sul pubblico), più di qualche dubbio si instilla sulla durata (novanta minuti) e sulla messa in scena, che alterna frammenti di comicità a passaggi che smorzano la tensione. Si chiamano le badanti dell’ex Unione Sovietica, rimarca l’attrice, “così le donne italiane possono dedicarsi pienamente alla vita professionale”. Come se fossero prive di sentimenti, come se un potpourri di cliché possa dare più veridicità al lavoro, crocifiggendo i sentimenti di chi ha un parente non più autosufficiente.
Gli aghi del pietismo si conficcano nelle guance di chi è in sala e ascolta le memorie delle badanti. Così la voce e il viso di una donna a cui sono state fatte proposte indecenti, così una signora in su con l’età che sogna di ritornare a casa, così una ragazza che ha perduto un figlio in grembo, così un gruppo di ucraine che si ritrova alla Montagnola di Bologna la domenica pomeriggio e che fatica a parlare italiano dopo lustri e lustri di vita nello Stivale. Così chi ricrea un’ambientazione primordiale della propria infanzia, una composizione floreale realizzata per ingentilire un luogo.
Non ingannino i tanti applausi che hanno salutato la chiusura dello spettacolo: non dicono assolutamente nulla. Sono solo, piuttosto, un “chiedere scusa” alle accuse lanciate dalla Norman verso chi era presente, o un rito aggregativo di partecipazione, come se dietro al biglietto fosse scritto, in una scrittura che si rivela solo agli spettatori, che è un gesto che si deve compiere sempre quando il buio torna in sala e decreta la chiusa della mise en scene.
*
La bombastica Pamela Anderson? La gattosa Hally Berry? La gattina orientale Céline Tran? La lista delle bellezze feminine che negli anni Novanta hanno fatto battere il cuore a milioni di teenager è infinita e cambia da persona a persona. Marco D’Agostin – in scena al Lavatoio con “First love” – è poeticamente “anarchico” e decisamente controcorrente: per lui la prima infatuazione ha un nome, Stefania, e un cognome, Belmondo. È alla campionessa sportiva dello sci di fondo che ha deciso di dedicare i suoi 40 minuti di monologo, un assolo fatto di parole e di danza che, in scena, si traduce in una spoglia telecronaca della medaglia d’oro conquistata nella 15 km a tecnica libera ai XIXesimi Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City nel 2002. La “restituzione” delle emozioni provate dall’attore “Premio UBU 2018 come miglior performer under 35” alla Belmondo è poco altro: ottima davvero la sua voce, questo va sottolineato, specie quando sale e si fa concitata, ma complessivamente lo spettacolo – eccezion fatta per una bella chiusura con Marco che si siede ai margini del fondale mentre scende la neve e una luna si fa grande e luminosa – non brilla per incisività.
*
Anticipato da una lunga didascalia in cui vengono rimarcati i problemi di censura incontrati dagli attori nei loro lavori precedenti, con “Domínio Público” – portato per la prima volta fuori dal Brasile – Elisabete Finger, Maikon K, Renata Carvalho e Wagner Schwartz focalizzano la propria indagine drammaturgica su “La Gioconda” di Leonardo da Vinci: dal furto “firmato” da Vincenzo Peruggia (che sottrasse la tela al museo del Louvre nel 1911) alla modella (o al modello) ritratto nel quadro – Lisa Gherardini o Gian Giacomo Caprotti detto “Salaì”? – alla postura delle mani, passando per la mancanza di gioielli e un po’ di gossip (pare che Leonardo se li fosse portati a letto), lo spettacolo a quattro voci si riduce a una lezione di storia dell’arte. Certo, importante, ma nulla di più. Sarebbe curioso avere l’opinione di Vittorio Sgarbi…
Alessandro Carli
*In copertina: immagine tratta dallo spettacolo “Dragon, rest your head on the seabed” (photo Enrique Escorza); nel servizio immagini dal progetto di Marco D’Agostin e di Kristina Norman
L'articolo Santarcangelo Festival 2019: dalle “sirene” alla “bombastica” Pamela Anderson, passando per una performance sulle badanti ucraine. Oggi il teatro attraversa una cupa crisi di idee… proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2YOo788
1 note
·
View note
Text
Metamorphoseon
Per motivi di studio, che ultimamente trovo più un diletto che un dovere, sto attualmente dedicandomi alle “Metamorphoseon” o “Asinus aureus” di Apuleio, in particolare ai tre celeberrimi libri centrali dedicati alla favola di Amore e Psiche. Il libro in questione lo lessi già tempo fa nella sua versione tradotta ma, questo confronto diretto con la versione latina originaria (comunque frutto di un lavoro filologico e, in alcuni punti, ricostruita/interpretata), mi ha dato la conferma che, per meglio assaporare la favola in sé, così come succede per la poesia o per qualsivoglia altro testo letterario o, ancora, per le opere cinematografiche, è consigliabile, anzi, necessario, reperire l’opera nella sua forma originaria. Ora, se fossimo tutti poliglotti sic et sempliciter, ciò sarebbe in ogni caso meravigliosamente possibile, ma -ahimè- comprendo che così non è e non può essere, perciò il mio modesto consiglio è: se conoscete una lingua, qualsiasi essa sia, sfruttate al meglio questa conoscenza.
Digressioni a parte, il motivo di questo post nasce dall’esigenza di condividere coi nostri attuali e futuri lettori, un estratto di questa favola che, per la grazia delle parole minuziosamente selezionate e l’eleganza con la quale è stato reso questo cruciale momento, mi è rimasto particolarmente a cuore.
Ora, non sto qui a riassumere il racconto tutto, ma si tratta tout court del momento in cui Psiche vede per la prima volta l’amato coniuge creduto fino a poco prima, a causa dei moniti delle sorelle invidiose, un orribile mostro.
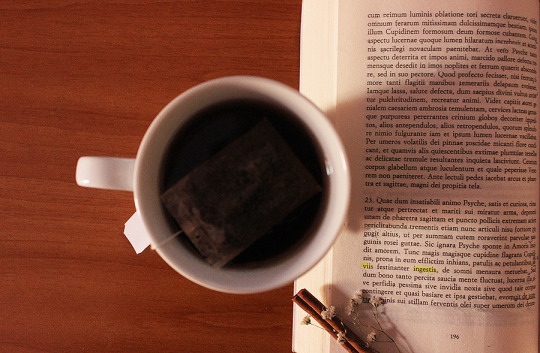
“[...] ma non appena la luce rischiarò i segreti del suo talamo, ecco che vide la bestia più dolce e mite di tutte, Cupido in persona, il dolce dio che graziosamente dormiva. Psiche tremante, con incontrollabile animo, abbandonata in un appassito pallore, cadde in ginocchio [...] sfinita, quasi vicina a morire, fissava la bellezza del volto divino [...] E scrutava la nobile chioma aurea madida d’ambrosia, le spalle bianche come il latte, le guance purpuree attraversate da riccioli inanellati armoniosamente fin sul petto. E, sugli omeri dell’aligero dio, le rugiadose ali piumate brillavano di fulgido splendore e, benché quiete, le piccole piume, tenere e delicate, sulle estremità, vacillanti si abbandonavano ad un inquieto tremore. Il resto del corpo era liscio e splendente, tale che Venere non dovette pentirsi d’averlo partorito.”
Traduzione semi-libera
E, qui, vi lascio sorseggiando il mio tè nero.
Serena.
Apuleio, le Metamorfosi o L’asino d’Oro
#apuleio#latino#latin#books#libri#le metamorfosi#l'asino d'oro#amore e psiche#canova#psiche#mito#favola#favola di amore e psiche#tea#book#literature#letteratura#teneo te#meum lumen#tenebre#V libro metamorfosi
1 note
·
View note