#Inghilterra anni Sessanta
Explore tagged Tumblr posts
Text
La Custode dell’Ambra: Un Viaggio tra Passato e Presente nel Cuore della Russia Rivoluzionaria
Freda Lightfoot ci regala una storia di famiglia, amore e redenzione, ambientata tra l'Inghilterra degli anni Sessanta e la Russia pre-rivoluzionaria.
Freda Lightfoot ci regala una storia di famiglia, amore e redenzione, ambientata tra l’Inghilterra degli anni Sessanta e la Russia pre-rivoluzionaria. Recensione:La Custode dell’Ambra di Freda Lightfoot è un romanzo che affascina per la sua capacità di intrecciare epoche e culture diverse, portando il lettore in un viaggio emozionante che abbraccia il Lake District dell’Inghilterra e la Russia…
#Abbie Myers#bambinaia in Russia#eredità familiare#Freda Lightfoot#Inghilterra anni Sessanta#intrecci famigliari#La Custode dell’Ambra#Lake District#legami intergenerazionali#LETTERATURA CONTEMPORANEA#Millie#narrativa inglese#narrativa internazionale#Narrativa storica#narrativa sulla rivoluzione#narrazione evocativa#perdono e redenzione#Relazioni Familiari#Riconciliazione#Ritorno al passato#romanzi ambientati in Russia#romanzi di Freda Lightfoot#romanzi di suspense#romanzi su famiglia#romanzi su memorie#romanzi sul perdono#Romanzo storico#Russia imperiale#Russia rivoluzionaria#Seconda Possibilità
0 notes
Text
Quando Freddie Mercury incontrò per la prima volta Mary Austin, lui aveva 24 anni e lei 19. All'epoca, nessuno dei due poteva immaginare cosa avrebbe riservato loro il futuro, sia come coppia che come amici legati da un profondo amore. La loro vera relazione è esplorata in Bohemian Rhapsody, con Rami Malek nei panni di Mercury e Lucy Boynton in Mary Austin.
"Tutti i miei amanti mi hanno chiesto perché non potevano sostituire Mary, ma è semplicemente impossibile", ha detto Mercurio di Austin. "L'unica amica che ho è Mary, e non voglio nessun altro. "Per me, lei era davvero mia moglie. Per me era un matrimonio. "
Quando Mercurio morì nel 1991, all'età di 45 anni, di polmonite bronchiale legata all'AIDS, Mary era al suo fianco, come lo era stata per gran parte della sua vita adulta. Le aveva persino chiesto di sposarlo ad un certo punto della loro relazione e, dopo la sua morte, le ha lasciato metà della sua fortuna stimata 75 milioni di dollari, compresa la sua villa di Londra in 28 stanze dove lui morì e Mary vive ancora oggi.
Oggi Mary Austin conduce una vita discreta, lontana dai riflettori che ha spesso conosciuto come parte della cerchia intima di Mercurio. Vissero insieme, a intermittenza, per quasi vent'anni, quando la fama di Mercury cresceva e i Queen divennero uno dei gruppi rock più iconici del XX secolo. Grazie al successo del film Bohemian Rhapsody, Mary sarebbe sul punto di ereditare più di 50 milioni di dollari, ora detiene il 75% dell'eredità di Mercury.
Un incontro indimenticabile
Freddie Mercury e Mary Austin si incontrarono nel 1969, un anno prima che Mercury formasse i Queen con Brian May, Roger Taylor e poi John Deacon. Nato Farrokh Bulsara nel 1946 a Zanzibar, Tanzania, Mercurio si trasferì in Inghilterra con i suoi genitori negli anni sessanta. Da parte sua, Mary Austin è nata nel 1951 da una modesta famiglia a Battersea, nel sud di Londra. Suo padre era un tappezziere e sua madre lavorava come domestica per una piccola impresa. Erano entrambi sordi.
Austin e Mercury si sono incontrati per la prima volta mentre lei lavorava presso la famosa boutique di moda di Londra Biba e Mercury, appena laureata in una scuola d'arte, stava lavorando in una cabina di abbigliamento a Kensington. All'inizio titubante ad affrontare la sua personalità esuberante, lei alla fine cade sotto il suo fascino e diventano una coppia, vivendo in un piccolo e costoso appartamento mentre lui persegue la sua carriera musicale. "Era come nessuno che avessi mai incontrato prima", ha detto Mary Austin OK! Riviste nel 2000. "Lui era molto sicuro di se stesso, e io non lo sono mai stato. " Siamo cresciuti insieme. Mi piaceva - e tutto è iniziato da lì. "
Una proposta di matrimonio inaspettata
La coppia si trasferì poi in un appartamento più grande a Londra su Holland Road. Nel 1973, l'anno in cui i Queen pubblicarono il suo album di debutto, Merc "Quando avevo 23 anni, mi ha regalato una grande scatola il giorno di Natale", ha detto Austin al Daily Mail nel 2013. "Dentro c'era un'altra scatola, poi un'altra, e così via. Era come uno dei suoi giochi cattivi. Finalmente ho trovato un bellissimo anello di giada nell'ultima scatola. "Confusa, Mary gli chiese su quale mano avrebbe dovuto portarla. Lui rispose "mancino" prima di chiederle di sposarla. "Ero sotto shock. Non era proprio quello che mi aspettavo. Ho appena sussurrato "sì, lo voglio". ' '"
Un amore messo a dura prova
Mentre i Queen divennero famosi con album come Sheer Heart Attack (1974) e A Night at the Opera (1975), che conteneva la ballata Love of My Life scritta per Mary, Mercury stava crescendo sempre più come icona del rock. Il loro rapporto, tuttavia, iniziò a cambiare.
Dopo sei anni insieme, il matrimonio non era più un argomento di discussione, e Mary sentiva che qualcosa non andava. "Le ho detto: 'Qualcosa non va. Mi sento come una palla al tuo collo credo sia ora che me ne vada. '"Mercurio inizialmente negò qualsiasi problema, ma nel 1976 le rivelò di essere attratto dagli uomini.
"Non dimenticherò mai questo momento", ha detto Austin. "Ero un po' ingenuo, mi ci è voluto un po' per capire la verità. " Dopo avermi detto che era bisessuale, sembrava sollevato. Ma ricordo di aver risposto: 'No Freddie, non penso che tu sia bisessuale. Penso che tu sia gay '"
Questa rivelazione pose fine alla loro relazione amorosa e Mary si trasferì in un appartamento vicino che Mercury le comprò. Eppure il loro legame rimane indistruttibile. Ha continuato a far parte dell'entourage della band e dei Mercury, apparendo nel backstage dei concerti fino agli anni '80.
Un amicizia incrollabile fino alla fine
Mentre Mercurio conduceva una vita da rock star, tra eccessi e molte avventure, Mary rimase un punto di riferimento costante nella sua vita. Ha avuto due figli con il pittore Piers Cameron, tra cui Richard, il cui padrino Mercury era, e Jamie, nato poco dopo la morte di Freddie. Sposò poi un uomo d'affari, ma il loro matrimonio terminò dopo cinque anni.
Quando Mercury ha scoperto di avere l'HIV nel 1987, Mary è sempre stata lì per lui. Fino al suo ultimo respiro, lei gli ha coperto le spalle. "L'ha tenuta vicina quando si è ammalato", ha spiegato il suo biografo Blake. "Gli lasciò la casa e parte della sua eredità, come se fosse sua moglie. Mary lo conosceva prima della fama e lei era lì alla fine. "
Amore eterno
"Quando è morto, mi sono sentito come se avessimo un matrimonio", ha detto Mary Austin OK! "Abbiamo vissuto insieme nel bene e nel male, in ricchezza e in povertà, in salute e in malattia. Non ci saremmo mai potuti separarci... eccetto dalla morte. E anche dopo, è stata dura. "
Rispettando gli ultimi desideri di Freddie, lei ha tenuto segreto il luogo di dispersione delle sue ceneri. "Non voleva che venisse scovato, come è successo ad altre celebrità", ha spiegato. "I fan possono essere molto ossessivi. Voleva che rimanesse un segreto, e così rimarrà. "
fonte: Anima Rock

6 notes
·
View notes
Text

Storia di Musica #330 - Lucio Battisti, Don Giovanni, 1986
Questo disco ha "provenienza" certa: lo ha comprato all'epoca mio papà, che ha sempre avuto una grande passione per il ragazzo di Poggio Bustone. E spesso, negli ultimi anni, qualche volta abbiamo discusso di come, nella lunghissima carriera di Lucio Battisti, la parentesi del decennio '80, per certi versi davvero sorprendente, sia molto meno famosa, al limite dell'inesistenza, del periodo precedente. Un po' perché dopo il 1980 decise di concentrarsi solo sull'aspetto musicale abbandonando le apparizioni televisive, le interviste radiofoniche e dei giornali (ultima rilasciata alla Tv Svizzera Italiana nel 1979), e un po' perché decise di fare tutto da solo, abbandonando il sodalizio con il paroliere Mogol. I primi indizi si hanno nel 1978, quando va in Inghilterra per registrare Una Donna Per Amico: tentativi precedenti di sfondare nel mercato internazionale fallirono, ma Battisti cercava un bisogno di internazionalizzare la proprio musica. Il disco fu prodotto da Geoff Westley, già con i Bee Gees, e con aggiunta di contaminazioni folk, un piccolo valzer (la canzone Perché No) diviene un disco memorabile, e vende 800 mila copie solo in Italia. Il soggiorno inglese sforna un altro lavoro, Una Giornata Uggiosa (1979), ancora con Westley che raduna un gruppo di sessionisti che avevano lavorato con Simple Minds, Cockney Rebels e addirittura il sassofonista dei King Crimson Mel Collins. Il disco, altro successo clamoroso, attinge stavolta al funk e ai ritmi primigeni della new wave. Uscito nel 1980, il disco è l'ultimo lavoro a firma Battisti-Mogol. Sulla separazione ci sono decine di storie sui motivi mai chiariti della decisione. Questo episodio fu l'inizio della reclusione mediatica di Battisti. Che aspetta due anni per ritornare con un disco, E Già, che spiazza completamente il pubblico e la critica. Prodotto da Greg Walsh, già assistente di Westley, è un freddo disco di musica elettronica (non c'è un solo strumento acustico, solo tastiere elettroniche programmate da Walsh) dove Battisti canta i testi scritti da Velezia, pseudonimo della moglie Grazia Letizia Veronese. Un disco che segna un cambiamento profondo, che verrà in parte accolto dal suo pubblico (il disco arriverà al numero 4 in classifica). Nel 1983 aiutando a scrivere le musiche del disco del suo amico Adriano Pappalardo, Battisti incontra Pasquale Panella, poeta romano dalla vena sperimentale e dadaista, con il quale la sintonia è subito interessante, fino a creare un sodalizio, unico e per certi versi irripetibile, che porterà a 5 dischi, descritti poi dalla critica come il "periodo bianco" di Battisti, per via delle copertina di questo colore. In verità, il primo disco della loro collaborazione, ha la copertina beige. Forse quasi a sottolineare il graduale e ulteriore passaggio di concezione musicale.
Don Giovanni (1986) è un disco che musicalmente riesce a coniugare la nuova passione elettronica con il caro, e fortissimo, senso melodico di Battisti, che stavolta è accompagnato da un gruppo di musicisti di respiro internazionale, producendo una musica che è perfettamente inserita nel periodo (a me ricorda certi passaggi dei sofisticati e bravissimi Talk Talk di Mark David Hollis). Ma la dimensione completamente innovativa, e che fece discutere moltissimo, sono i testi di Panella. Infarciti all'inverosimili di figure retoriche, doppisensi, metrica estemporanea e che hanno l'incredibile pregio di sembrare perfetti nella loro assurdità. Esempio classico è Le Cose Che Pensano, diventato suo malgrado un classico: Su un dolce tedio a sdraio\Amore, ti ignorai\E invece costeggiai\I lungomai\M'estasiai, ti spensierai\M'estasiai, e si spostò\La tua testa estranea\Che rotolò (...) Cadere la guardai\Riflessa tra ghiacciai\Sessanta volte che\Cacciava fuori\La lingua e t'abbracciai\Di sangue m'inguaiai\Tu quindi come stai?. Ma si può continuare: E ne parlò, certo che ne parlò\E che saziò i gusti di chi\Vide o intuì, non visto\Gli opposti su un ponte e brume\Su un fiume con molte schiume (Il Doppio Del Gioco); la lista di nomi fantasiosi di Equivoci Amici (Cassiodoro Vicinetti, Olindo Brodi, Ugo Strappi, Sofio Bulino, Armando Pende, Andriei Francisco Poimò, Tristo Fato e così via). Due canzoni spiccano: Il Diluvio, dal bellissimo tappeto sonoro, che nei suoi sognanti 6 minuti ci regala perle come "Dopo di noi diluvierà\Non spioverà, va bene\Noi la fortuna degli ombrellai\Chili di liquidi dopo di noi\Va bene, come vuoi, dopo di noi" oppure "Piove con ghiaccia semplicità\Con truci gocce dal bel luccichio\E piove, piove, piove, siamo annaffiatoi\Dopo di noi il bello verrà\Finché terrà l'ombrello. E poi Don Giovanni, che i più maliziosi vedono come una risposta di Battisti a Mogol che gli aveva rivolto parole pungenti dopo la conclusione del loro rapporto professionale, nel brano La Massa Indistinguibile, interpretato da Mango nell'album Australia (1985): lì Mogol scrive "Cos’è successo al tuo successo\Era un miraggio, un messaggio vuoto\Tu ci hai creduto ed hai perduto\L’autoritratto adesso è scolorito" e Battisti-Panella rispondono così:
Non penso quindi tu sei
Questo mi conquista
L’artista non sono io
Sono il suo fumista
Son santo, mi illumino
Ho tanto di stimmate
Segna e depenna Ben-Hur
Sono Don Giovanni
Rivesto quello che vuoi
Son l’attaccapanni
Poi penso che t’amo
No anzi che strazio
Che ozio nella tournee
Di mai più tornare
Nell’intronata routine
Del cantar leggero
L’amore sul serio
E scrivi
Che non esisto quaggiù
Che sono
L’inganno
Sinceramente non tuo
(Sinceramente non tuo)
Qui Don Giovanni ma tu
Dimmi chi ti paga
Una chiara e credo definitiva concessione alla libertà di non inseguire più il successo, e della libera scelta di scrivere e cantare di altro dal cantar leggero a l'amore sul serio. E l'attaccapanni del testo è il disegno, stilizzato, della copertina, da cui scende uno sciarpone felliniano.
Il disco nonostante la sua natura così strana e straniante ottenne un successo notevole, continuando la serie lunghissima di Numeri Uno di Battisti (che terminerà solo nel 1990 con La Sposa Occidentale, un altro disco stupendo). Rimarrà sempre il dubbio di quando e quanto fosse provocazione e quando e quanto no, Panella dichiarò: Il difetto della canzone e’ quello di avere un senso. Quando sarà insensata sarà vera poesia (…) a me piace portare la canzone all’estenuazione, cercarne il limite estremo, dare alle parole e al loro susseguirsi una strana configurazione. Mettere a rischio le parole, provare a confonderle, prima che loro e la noia abbiano il sopravvento. Lui continuerà anche con altri, regalando delle perle pop che ricordiamo tutti, tipo il Trottolino Amoroso per Minghi e Mietta di Vattene Amore, Dindondio di Zucchero (“Quindi non io, ma una canzone, ti parlerà. Un’emozione, cosa cos’è? È questa qua) e persino In Amore per Gianni Morandi e Barbara Cola (“Ti supererò, in amore andrò molto più lontano dove tu stupore sei, con le mani andrò dove sento il cuore che mi fa capire come stai aspettando me”). Rimane l'inizio di un percorso geniale, a tratti forse anche troppo, che segna l'ultimo periodo di un artista unico come Lucio Battisti. In effetti però capisco che al falò della spiaggia è più facile cantare di bionde trecce, occhi azzurri e poi piuttosto che di:
Con tante madri e il tempo un laghetto
Coi pesci dei giorni
È il gamberetto del mio compleanno che torna lì
Fu molto dopo che dentro la pioggia
Vidi tra mille la goccia d'acqua mia
Prigionia
da Madre Pennuta, 1986.
15 notes
·
View notes
Text
Petina Gappah

Ci sono fatti storici ancora avvolti dal silenzio, in qualche modo anche dalla vergogna. La letteratura serve anche a questo, a interrompere il silenzio.
Petina Gappah, pluripremiata avvocata e scrittrice, definita la voce dello Zimbabwe, scrive in inglese libri ambientati nel suo paese d’origine mentre esercita brillantemente la sua professione di avvocata internazionalista. È la figura legale di riferimento per l’area araba allargata di libero scambio (GAFTA) ad Accra.
La passione per il suo lavoro rimane forte mentre narra dei fallimenti e delle ingiustizie dello Zimbabwe nella speranza che, nonostante l’oscurità, si possa ottenere un cambiamento.
Ha anche scritto per diverse testate internazionali come The Financial Times, The New York Times, The Guardian e Süddeutsche Zeitung, ed è stata editorialista per OmVärlden, la rivista svedese sullo sviluppo e gli affari globali.
È nata in Zambia il 16 giugno 1971, da genitori emigrati dallo Zimbabwe, dove è ritornata quando aveva nove mesi. Dopo l’indipendenza del paese, la sua famiglia si era trasferita a Harare, in una zona prevalentemente abitata da persone bianche bianca, tanto che è stata una delle prime alunne nere della sua scuola elementare. Ha iniziato a scrivere quando aveva dieci anni, il suo primo racconto è stato pubblicato sulla rivista della scuola che frequentava.
Dopo la laurea in giurisprudenza in Zimbabwe, ha conseguito un dottorato in diritto internazionale all’Università di Graz e un master a Cambridge. Successivamente si è trasferita a Ginevra, dove ha iniziato a lavorare come avvocata specializzata in diritto internazionale.
Nel 2009 ha pubblicato il suo primo libro, la raccolta di racconti An Elegy for Easterly, tradotto in diverse lingue, che le è valso diverse prestigiose candidature come opera prima e ha vinto il Guardian First Book Award.
Nel 2010 è tornata ad Harare per tre anni per lavorare al suo primo romanzo, Il libro della memoria che, pubblicato nel 2015, è il testamento immaginario di una donna albina imprigionata nel braccio della morte, che spera in una tregua presidenziale. Il libro ha vinto il Premio McKitterick dalla Society of Authors.
La seconda raccolta di racconti Rotten Row, pubblicata nel 2016, è stata scelta come “Libro del giorno” da The Guardian.
Dal 2017 è stata DAAD Fellow e Writer-in-Residence a Berlino.
Nel giugno dello stesso anno ha tenuto la conferenza annuale del Journal of Southern African Studies, intitolata Looking for Dr Livingstone’s African Companions, presso la School of Advanced Study dell’Università di Londra.
Out of Darkness, Shining Light, del 2019, che in italiano è stato tradotto con il titolo Oltre le tenebre, ha vinto i National Arts Merit Awards 2020 per Outstanding fiction book.
Il libro si apre a Chitambo, nell’attuale Zambia, dove David Livingstone è morto nel 1873 e si chiude in riva al mare, a Bagamoyo, di fronte all’isola di Zanzibar. In mezzo ci sono i sessanta giorni di un Cuore di tenebra a rovescio, il racconto di come i suoi attendenti e la cuoca Halima, sfidando la fame e i pericoli, gli sono rimasti fedeli fino all’ultimo, cercando pace per quello strano uomo bianco e una vita migliore per se stessi.
“La storia di David Livingstone, il grande esploratore dell’Africa, ossessionato dalla ricerca delle sorgenti del Nilo, è cosa nota. Ciò che pochi sanno è che il viaggio più incredibile lo ha fatto da morto, quando il suo corpo imbalsamato è stato trasportato per oltre duemila chilometri dall’interno del continente africano fino alla costa, per poter essere sepolto in Inghilterra. Chi erano gli uomini e le donne che lo accompagnarono? Perché lo fecero? Il mio romanzo è nato per restituire un volto e un destino a queste figure dimenticate”.
Petina Gappah ha lavorato con il David Livingstone Birthplace Museum per reinterpretare i Tableaux Pilkington Jackson di Charles d’Orville.
Con la sua scrittura riesce nel difficile compito di rendere luoghi per lo più sconosciuti, con tale intimità e vitalità da farli sentire subito familiari. E dotata di una speciale sensibilità verso la tragedia umana e anche verso la commedia, insita nell’esistenza. Spalanca le porte di un milione di case illuminate e ci permette di guardarci dentro. In ognuna troviamo qualcosa di meraviglioso e strano, compreso un riflesso di ciò che siamo.
0 notes
Text
Il grande attore britannico, interprete di film quali Gandhi di Richard Attenborough, Tradimenti di David Hugh Jones, L’isola di Pascali di James Dearden, Bugsy di Barry Levinson, Schindler’s List e A.I. Intelligenza artificiale di Steven Spielberg, Oliver Twist di Roman Polanski e molti altri, compie ottant’anni. Nato nello Yorkshire - in Inghilterra - nel 1943, Krishna Pandit Bhanji - meglio noto come Ben Kingsley -, studia al Pendetlon College e si avvicina giovanissimo al teatro debuttando all’Aldwych Theatre, per poi entrare a far parte della Royal Shakespeare Company con la quale, dalla fine degli anni Sessanta e poi per i quindici anni successivi, sarà interprete prevalentemente shakespeariano. Nello stesso periodo lavorerà anche in film e serie tv. Esordisce al cinema in un ruolo secondario all’inizio degli anni Settanta in Gli ultimi sei minuti (1972) di Michael Tuchner, per poi tornare, per circa un decennio, sul palcoscenico e in televisione. Il suo vero esordio cinematografico avviene all’inizio degli anni Ottanta, quando è superlativo protagonista di Gandhi (1982) di Richard Attenborough, con cui vince un meritatissimo Oscar come Miglior Attore Protagonista. Uno di quei casi in cui, anche al di là della bravura dell’attore, la fusione fra personaggio e interprete è tale che lo spettatore/spettatrice, pensando al personaggio, automaticamente pensa anche al suo interprete (come avviene nel caso di Vincent Van Gogh/Kirk Douglas in Brama di vivere di Vincente Minnelli, Onassis/Anthony Quinn in Il magnate greco di Jack Lee Thompson, Nelson Mandela/Morgan Freeman in Invictus di Clint Eastwood, Daniel Day-Lewis/Abramo Lincoln in Lincoln di Steven Spielberg). Seguono numerosi ruoli cinematografici e televisivi, che dimostrano abbondantemente l’inesauribile talento di uno fra i più grandi attori della sua generazione. Fra le pellicole più significative Tradimenti (1983) di David Hugh Jones, L’isola di Pascali (1988) di James Dearden, in cui offre una prova di grande magnetismo nel ruolo di un inascoltato informatore dell’impero ottomano alla vigilia della guerra, la commedia gialla Senza indizio (1988) di Thom Eberhardt, Bugsy (1991) di Barry Levinson, con Annette Bening. Negli anni Novanta due fra le sue migliori performances, ovverosia il contabile Stern in Schindler’s List (1993) di Steven Spielberg, con Liam Neeson e Ralph Fiennes, e il misterioso dottor Miranda in La morte e la fanciulla (1995), tratto dal dramma teatrale omonimo di Ariel Dorfman e diretto da Roman Polanski, in cui esprime perfettamente l’ambiguità di un personaggio che oscilla fra vittimismo e spietatezza. Molto significative anche le sue apparizioni in A.I. Intelligenza artificiale (2001) di S. Spielberg, Il trionfo dell’amore (2001) di Clare Peploe, Oliver Twist (2005), tratto dal romanzo omonimo di Charles Dickens e diretto da Roman Polanski, in cui, con barba rossa e semisdentato, interpreta il vecchio usuraio Fagin, e nel ruolo di un gangster in Slevin - Patto criminale (2006) di Paul McGuigan. Fra gli altri film ricordiamo Tartaruga ti amerò (1985) di John Irvin, Harem (1985) di Arthur Joffé, Maurice (1987) di James Ivory, Testimony (1988) e The Children (1990) di Tony Palmer, Slipstream (1989) di Steven Lisberger, Una vita scellerata (1990), Quinto macaco (1990) di Eric Rochat, I signori della truffa (1992) di Phil Alden Robinson, con Robert Redford e Sidney Poitier, Dave - Presidente per un giorno (1993) di Ivan Reitman, In cerca di Bobby Fischer (1993) di Steven Zaillian, Specie mortale (1995) di Roger Donaldson, La dodicesima notte (1996) di Trevor Dunn, The Assignment – L’incarico (1997) di Christian Duguay, Fotografando i fantasmi (1997) di Nick Willing, The Confession (1998) di David Hugh Jones, Da che pianeta vieni? (2000) di Mike Nichols, Regole d’onore (2000) di William Friedkin, La casa stregata (2002) di William Sachs, Tuck Everlasting - Vivere per sempre (2002) di Jay Russell, La casa di sabbia e nebbia (2003) di
Vadim Perelman, con cui ottiene una nomination all’Oscar come Miglior Attore non Protagonista, Thunderbirds (2004) di Jonathan Frakes, Il risveglio del tuono (2005) di Peter Hyams, L’ultima legione (2007) di Doug Lefler, Transsiberian (2008) di Brad Anderson, Fifty Dead Men Walking (2008) di Kari Skogland, Shutter Island (2010) e Hugo Cabret (2011) di Martin Scorsese, Il dittatore (2012) di Larry Charles, Walking With the Enemy (2013) di Mark Schmidt, Medicus (2013) di Phillip Stoltz, War Story (2014) di Mark Jackson, Exodus - dei e re (2014) di Ridley Scott, e il cortometraggio All Hell he King (2014) di Louis Esposito. In epoche più recenti è apparso in film come The Walk (2015) di Robert Zemeckis, Autobahn - Fuori controllo (2016) di Eran Creevy, Il tenente ottomano (2017) di Joseph Ruben, War Machine (2017) di David Michod, Giochi di potere (2018) di Per Fly, Shang-Ci - La leggenda dei dieci anelli (2021) di Destin Daniel Cretton, ispirato al personaggio omonimo dei fumetti Marvel Comics, Dalìland (2022) di Mary Harron , ispirato alla vita di Salvator Dalì, Jules (2023) di Marc Turtletaub, e nei cortometraggi La meravigliosa storia di Sugar (2023) e Veleno (2023) di Wes Anderson, con Ralph Fiennes. Molto attivo anche in televisione, a partire da fine degli anni Sessanta/inizio Settanta appare in numerosi film tv - A Misfortune (1973) di Ken Loach, Antonio e Cleopatra (1974) di Jon Scoffield, Thank You, Comrades (1978) e The War That Never Ends (1991) di Jack Gold, Le allegre comari di Windsor (1982) di David Hugh Jones, Kean (1982) di Raymund FitzSimons, Camille (1984) di Desmond Davis, Silas Marner: the Weaver of Raveloe (1985) di Giles Foster, Il treno di Lenin (1988) di Damiano Damiani, Murderers Among Us: the Simon Wiesenthal Story (1989) di Brian Gibson, Giuseppe (1995) e Mosè (1995) di Roger Young, Weaponof Mass Distraction (1997) di Stephen Surjik, La bottega degli orrori di Sweeney Todd (1997) di John Schlesinger, Delitto e castigo (1998) di Joseph Sargent, Alice nel paese delle meraviglie (1998) di Nick Willing, Mrs. Harris (2005) di Phyllis Nagy - ed in alcuni episodi di serie e miniserie.
1 note
·
View note
Text
Trieste Science Fiction Festival 2023

Trieste Science Fiction Festival, il grande evento italiano su tutte le sfumature del genere fantastico, si terrà dal 27 ottobre al 1 novembre nel capoluogo del Friuli, con la sua 23° edizione. L’attrice Claudia Gerini, insieme al regista Federico Zampaglione, saranno presenti alla manifestazione triestina per presentare il film The Well in anteprima italiana, dopo quella al Sitges Film Festival 2023. Diretto da Zampaglione e interpretato dalla Gerini, The Well segna il ritorno del cineasta al cinema di genere dopo Shadow – L’ombra e Tulpa – Perdizioni mortali, e ha come protagonista l’attrice Lauren LaVera, star di Terrifier 2, in una storia di maledizioni legate a un misterioso dipinto. Al centro della storia c’è Lisa Gray, una restauratrice d’arte in erba che si reca nel borgo italiano di Sambuci per riportare un dipinto medievale all’antico splendore e li incontrerà l’enigmatica duchessa Emma Malvisi e sua figlia Giulia, affetta da gravi disturbi della personalità, finendo per mettere la sua vita in pericolo a causa di una maledizione e di un mostro nato dal mito e dal dolore. Trieste Science Fiction Festival vedrà altri nuovi titoli in concorso e in anteprima italiana, tra storie nel multiverso e fantascienza dalle sfumature romantiche, passando per un imperdibile sci-fi coreano e storie infernali dai toni danteschi. In programma ci sono anche tre documentari, Scala!!!” di Ali Caterall e Jane Giles, che racconta la tumultuosa storia del famigerato ex cinema Scala di Londra, The Longest Goodbye di Ido Mizrahy, che riflette sul tema dell’isolamento sociale che colpisce milioni di persone, oltre ad essere la grande sfida degli astronauti impegnati nelle missioni spaziali verso Marte, e Plastic Fantastic Isa Willinger, un’indagine a largo spettro sulla minaccia ambientale rappresentata dall’uso della plastica. Torna anche la sezione Sci-Fi Classix dedicata ai grandi classici rimasterizzati, con L’uomo dagli occhi a raggi X, di Roger Corman, pietra miliare della fantascienza degli anni Sessanta e premiato al Festival Internazionale del film di Fantascienza nel 1963, e A.I di Steven Spielberg del 2001 realizzato a partire da un progetto di Kubrick in cui un robot di ultima generazione desidera diventare un bambino vero per riconquistare l’amore della sua madre umana, la cui versione restaurata del film verrà introdotta da Linda Ruth Williams, docente della University of Exeter in Inghilterra e autrice del libro Steven Spielberg’s Children. Read the full article
1 note
·
View note
Photo
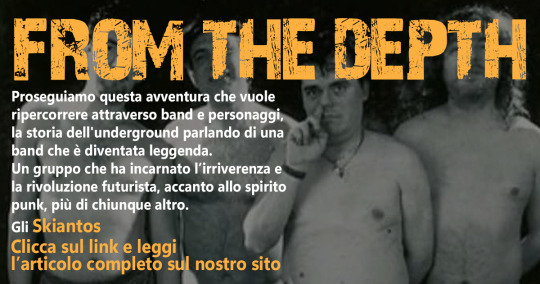
New Post has been published on https://www.tempi-dispari.it/2023/09/04/skiantos-rivoluzione-punk-futurista/
Skiantos: rivoluzione punk/futurista
Contesto storico e sociale
Il 1975 è un anno di guerra civile latente. Molti scontri fisici tra estrema sinistra e neofascisti, in cui il numero di neofascisti uccisi superava quello dei morti di sinistra: un altro segno dell’evoluzione di una linea armata e organizzata nell’area su cui dominavano le Brigate rosse.
Fu l’anno in cui Pierpaolo Pasolini morì ucciso barbaramente a Ostia dal Rana che gli passò su e giù con la macchina sfigurandone il cadavere nel fango della più tenebrosa periferia romana. È anche l’anno in cui i Khmer Rossi del dittatore comunista Pol Pot prendono il potere in Cambogia e scatenano un genocidio che fa concorrenza per mostruosità a quelli di Hitler e di Stalin, ma anche l’anno in cui i Pink Floyd raggiungono l’apice del successo e in cui la Soka Gakkai internazionale, la versione giapponese del buddismo organizzato, viene fondata ufficialmente. È ancora l’anno in cui seguita a trascinarsi l’eterno processo per la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 in cui adesso sono imputati sia estremisti di destra che di sinistra.
In Inghilterra accadono grandi cose: Charlie Chaplin viene insignito col titolo di baronetto dalla regina Elisabetta. Margaret Thatcher viene eletta leader del partito conservatore inglese e dunque candidata a diventare Prime Minister quando i tories vinceranno le elezioni. A marzo si apre il quattordicesimo congresso del partito comunista che Enrico Berlinguer vince largamente con la sua idea del Compromesso Storico contro l’ala filosovietica di Armando Cossutta.
La guerra del Libano metteva in crisi un paese occupato dall’Olp di Yasser Arafat che vagava nel Medio Oriente senza trovare pace né patria. Partiva la prima attività di uno sconosciuto ragazzo intraprendente di nome Bill Gates che aveva impiantato una azienda informatica in un garage da cui sarebbe uscita Microsoft e il personal computer.
In Spagna muore il dittatore Francisco Franco che aveva tenuto il potere per trentasei anni dopo essersi ribellato alla Repubblica spagnola e aver vinto quella guerra con l’aiuto di Hitler e Mussolini, mentre la parte opposta aveva ricevuto armi e istruttori dell’Unione sovietica. La guerra di Spagna aveva lasciato una grande piaga aperta che seguitava a produrre dolore e nostalgie ancora durante gli anni Sessanta e Settanta.
La Spagna voltava pagina senza avere risolto i suoi problemi ideologici.
La sua azione in quella guerra aveva prodotto un conflitto sempre più violento fra comunisti e sinistra non comunista, le cui conseguenze si riverberavano ancora nella politica italiana del dopoguerra, provocando la crescita di quell’anticomunismo di sinistra che fu una componente genetica dei socialisti italiani, fra loro spaccati tra frontisti e autonomisti, come gli anni di Craxi mostreranno subito dopo quel 1975.
Nasce il Fondo per l’Ambiente Italiano: Storia, arte e natura da salvare e restituire ai cittadini italiani, rinverdendo in questi ultimi la consapevolezza e l’orgoglio di avere a pochi passi da casa un patrimonio inestimabile da preservare per le future generazioni. Un merito che da decenni viene riconosciuto agli attivisti del Fondo per l’Ambiente Italiano, il cui atto di nascita venne sottoscritto il 28 aprile del 1975, a Milano.
Finisce la guerra in Vietnam: «Questa è un sporca guerra crudele ma spero che voi a casa riusciate a capire perché la combattiamo». Furono le ultime parole indirizzate da un soldato americano alla sua famiglia, prima di morire in battaglia nel 1969. Sei anni dopo terminava uno dei conflitti più sanguinosi del Novecento, che avrebbe lasciato sul terreno i corpi straziati di milioni di innocenti e di giovani soldati mandati a morire senza un perché.
Inaugurata Gardaland: Catturato dalle meraviglie di Disneyland, l’imprenditore Livio Furini decide di trasporre quell’esperienza nel suo Paese, dando vita a Gardaland, il primo parco di divertimenti stabile in Italia. Un investimento da 200 milioni di lire che coinvolge altri soci e che dopo l’acquisto di terreni in località Ronchi (nel comune di Castelnuovo del Garda, in Veneto), vede iniziare i lavori nel febbraio del 1975.
Nasce il videogioco domestico: I giochi elettronici entrano nel quotidiano di milioni di ragazzi con la prima versione domestica di un videogioco. Si tratta di Pong, simulatore di ping-pong sviluppato da Atari, già noto ai giovanissimi frequentatori di sale giochi nella versione coin-op (lanciata nel 1972).
Esce “A Night at the Opera” dei Queen: Con A Night at the Opera i Queen sfornano il loro quarto album, che consacra la band britannica nel panorama del rock mondiale.
Prodotto da Roy Thomas Baker e finito di registrare a luglio del 1975, il disco era stato inizialmente concepito come parte di un doppio album, che avrebbe dovuto contenere anche il successivo “A Day at the Races” (uscito a distanza di un anno); questo perché entrambi i titoli richiamano due omonimi film dei fratelli Marx, alla cui geniale comicità Freddie Mercury e company volevano rendere omaggio.
In questo contesto muovono i primi passi gli Skiantos!
Va subito chiarito che gli Skiantos hanno avuto la fortuna di trovarsi nel posto giusto (Bologna) al momento giusto (il 1977), visto che il cosiddetto “Movimento del ’77”, partito da un’occupazione dell’Università di Roma per protestare contro il progetto di riforma del ministro dell’Istruzione, si era diffuso velocemente in tutt’Italia attecchendo rapidamente soprattutto nel capoluogo emiliano.
Il gruppo nasce in forma embrionale nel 1975 a Bologna, quando un gruppo di ragazzi del DAMS si ritrova per suonare nella cantina del futuro cantante Roberto Antoni, poi conosciuto come Freak Antoni. Nel 1976 Freak Antoni faceva parte anche di un gruppo chiamato Demenza Precoce. Il progetto Skiantos prese maggiore concretezza nel 1977 con Inascoltable, inciso in «una notte di improvvisazione per una decina di persone innamorate della musica» (Freak Antoni), molte delle quali non si conoscevano fra loro.
Alle registrazioni, che furono pubblicate su musicassetta da Oderso Rubini della Harpo’s Bazaar (in seguito Italian Records), parteciparono 5 cantanti, 6 musicisti. I concerti del gruppo, soprattutto agli inizi, sono caratterizzati da performance provocatorie con riferimenti all’avanguardia futurista e dadaista, che includono il lancio di ortaggi sul pubblico da parte dei musicisti.
Oltre a sfidare la politica e il modello tradizionale di musica (gli Skiantos hanno sempre dichiarato con orgoglio di non saper suonare), la band propone anche concerti assurdi, dove i membri del gruppo si presentano talvolta vestiti con impermeabili e scolapasta in testa, altre volte in abiti eleganti che verranno poi sporcati dal lancio di oggetti e sostanze varie dalla platea.
In questo senso, le esibizioni degli Skiantos sono una sfida al pubblico e un ribaltamento del rapporto star-pubblico, che viene spesso insultato e provocato, con tanto di lancio di ortaggi verso gli spettatori (poi prontamente rilanciati dagli stessi sul palco).
1978-1982: dalla Cramps Records allo scioglimento Nel 1978 gli Skiantos realizzano per la Cramps Records di Gianni Sassi il loro secondo LP dal titolo MONO tono, a detta del leader Freak Antoni un disco punk, con cui si affermano grazie anche all’anticonformismo di rottura sociale tipico del Movimento del ’77, di cui il gruppo stesso diventa ben presto uno dei portavoce.
Il disco fu preceduto dal singolo Karabigniere Blues/Io sono un autonomo, sempre pubblicato dalla Cramps Records. Il disco inizia con un dialogo accelerato in gergo giovanile dell’epoca. Ma tutti i brani sono straordinari, con il puro nonsense che raggiunge livelli stellari (“Io me la meno/ ogni notte mi dimeno/ domani prendo il treno/ e vado fino a San Remo”), anche se i testi toccano il vertice assoluto nel brano-manifesto “Largo all’avanguardia” (“Siete un pubblico di merda/ applaudite per inerzia” .
“Compran tutti i cantautori/ come fanno i rematori/ quando voglion fare i cori/ che profumano di fiori/ Me mi piace scoreggiare/ non mi devo vergognare”). Con questo brano si comprende con certezza che gli Skiantos adottano programmaticamente la scelta di usare termini “bassi”, allo scopo di porsi come dicotomica alternativa anti-colta all’imperante cultura alta, sfruttando la loro più grande trovata: la demenzialità.
Il 2 aprile 1979 partecipano al Bologna Rock, un festival che si svolse nel palasport locale e che vedeva sul palco i migliori gruppi dell’allora scena punk rock e new wave cittadina. Fra questi vi erano i Windopen, Luti Chroma, Gaznevada, Bieki, Naphta, Confusional Quartet, Andy J. Forest, Frigos e Cheaters.
Gli Skiantos portarono sul palco una cucina, un tavolo, un televisore e un frigo, misero a bollire gli spaghetti e poi li mangiarono, senza suonare nulla; alle proteste del pubblico Antoni avrebbe risposto “Non capite un cazzo: questa è avanguardia, pubblico di merda”. L’esibizione, definita una fuga dall’immagine stereotipata del gruppo rock in cui la band cominciava a sentirsi intrappolata, fu però fraintesa e disprezzata da molti dei precedenti estimatori.
Freak Antoni a tale proposito ha commentato: “La nostra provocazione aveva toccato, a seconda dei punti di vista, il fondo e l’apice nello stesso momento”.
Nel 1979 danno alle stampe l’LP Kinotto, a detta di Freak Antoni un LP new wave. Nello stesso anno partecipano al concerto Omaggio a Demetrio Stratos organizzato dalla Cramps Records.
Dalle registrazioni del concerto fu realizzato l’album 1979 Il concerto – Omaggio a Demetrio Stratos che, oltre all’inedita Ehi Bubba Loris degli Skiantos, raccoglie i brani di altri autori presenti, tra cui gli Area, Francesco Guccini, Eugenio Finardi, Roberto Ciotti, Angelo Branduardi, Antonello Venditti e Kaos Rock.
Lo stesso anno Freak Antoni si separa dagli Skiantos, che si presentano alla selezione per il Festival di Sanremo con “Fagioli”, ma vengono scartati.
Il 6 febbraio 1980 il gruppo viene invitato dalla Cramps Records al festival musicale Rock ’80. I brani del concerto vengono pubblicati nella compilation dall’omonimo titolo, in cui compaiono anche altri gruppi tra cui i Kaos Rock, gli Windopen, i Take Four Doses, gli X Rated, le Kandeggina Gang e i Dirty Actions. In seguito, Rock ’80 sarebbe stato ristampato più volte in Italia e in Germania.
Sempre nel 1980 esce una delle loro canzoni più famose, Mi piaccion le sbarbine, già brano di apertura di Kinotto, inserita come lato B del singolo Fagioli. Fu la scelta di presentare Fagioli alle selezioni del Festival di Sanremo 1980 a determinare la fuoriuscita del cantante dal gruppo, che negli anni successivi si dedicò ad altri progetti tra i quali Beppe Starnazza e i Vortici, L’incontentabile Freak Antoni e ad esprimere il suo lato più squisitamente satirico e letterario.
Dopo questa opera, all’apice del successo, arrivò nel 1980 l’LP Pesissimo! dove nel retro-copertina appariva la signora Matilde, mamma del batterista del gruppo Leo Tormento Pestoduro. Fu anche il primo e unico LP che non vide la partecipazione dello storico leader Freak Antoni.
Al suo posto debuttò Linda Linetti, la prima voce femminile degli Skiantos. Nel 1981-1982 gli Skiantos furono coinvolti in un’improbabile e curiosa pubblicità delle patatine Good Pai, con la manipolazione del brano “Eptadone”. Le critiche ricevute per l’album “Pesissimo!” porteranno poi il gruppo allo scioglimento nel 1982.
Nel 1981 Freak Antoni pubblica il box L’incontenibile Freak Antoni, composto da cinque singoli di altrettante denominazioni fasulle (I Nuovi ’68, gli Hot funkers, Astro Vitelli & i Cosmoz, i Genuine Rockers e i Recidivi).
1987-2009: rinascita e riscoperta della band Il gruppo si ricompone temporaneamente nella formazione a 3 (Freak Antoni, Dandy Bestia e Stefano Sbarbo) nel 1984 con la pubblicazione di Ti spalmo la crema, prologo della riunione definitiva che avverrà nel 1987 con l’album Non c’è gusto in Italia ad essere intelligenti.
Dei componenti del nucleo storico rimangono il cantante Roberto “Freak” Antoni e il chitarrista/compositore delle musiche Fabio “Dandy Bestia” Testoni a cui si aggiunge nel 1990 il bassista Marco Nanni (ex Stadio, ex Lucio Dalla) detto “Marmo”. La formazione originale, tranne il bassista Frankie Grossolani, si riunisce occasionalmente nel 1999 per registrare l’album Doppia dose.
Nel 1992 gli Skiantos pubblicano Signore dei dischi e nel 1993 Saluti da Cortina che ottengono un buon successo.
Agli Skiantos viene attribuito il merito di avere inventato il rock demenziale[1], basato su testi ironici e apparentemente banali dai quali emerge spesso una satira intelligente, graffiante e surreale. Il gruppo definisce il termine “demenziale” come «un cocktail di ironia, improvvisazione, poesia quasi surreale, cretinerie, paradossi e colpi di genio».
Nel gennaio 2008, Freak Antoni ha raccontato le origini e il percorso degli Skiantos nel programma Fahrenheit di Radio 3, nella sezione Storyville, in cinque puntate di circa mezz’ora; l’audio e le trascrizioni sono reperibili qui.
Gli Skiantos hanno avuto una certa influenza su diversi artisti dell’area bolognese, tra cui Vasco Rossi (che li vorrà come gruppo di spalla al tour del 1990), Luca Carboni e altri. A testimonianza della conquistata rispettabilità artistica, nell’album Doppia dose gli Skiantos si avvalgono della collaborazione di vari artisti di fama come Lucio Dalla, Luca Carboni, Enzo Iacchetti e Samuele Bersani. Ha collaborato alla registrazione di alcuni album anche il batterista Vincenzo Restuccia.
Nel 2004 e 2005 sono ospiti musicali fissi di Colorado Cafè, programma di cabaret trasmesso da Italia 1 e ideato da Diego Abatantuono.
Nel 2007 al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti grazie al lavoro comune di Freak Antoni e Giordano Sangiorgi, patron del Mei, gli Skiantos festeggiano i 30 anni di carriera dall’uscita del primo disco. Nello stesso anno Giordano Sangiorgi con Benedetto Zacchiroli dello staff del Sindaco del Comune di Bologna Sergio Cofferati premia Freak Antoni in Comune a Bologna per i 30 anni di carriera con un premio legato a Bologna Città Creativa della Musica Unesco.
All’inizio del 2009 esce Dio ci deve delle spiegazioni (“possibilmente convincenti” è il sottotitolo), un album che nella biografia ufficiale viene definito “ad alto tentativo d’introspezione e che si fa carico di alcune domande a carattere umano-esistenziale”. Nel dicembre del 2009 esce Phogna – The Dark Side of the Skiantos, EP con quattro brani.
2012-oggi: abbandono e morte di Freak Antoni, fatti recenti Nell’aprile del 2012 Roberto “Freak” Antoni comunica la sua volontà di lasciare il gruppo. Il cantante ha affermato di aver preso tale decisione per lo scarso spazio destinato al gruppo nell’odierna scena musicale, preferendo concentrarsi su nuovi progetti artistici, tra i quali la Freak Antoni Band e alcune collaborazioni musicali.
Il 27 giugno del 2013 sulla pagina Facebook degli Skiantos appare il messaggio «E se si ripartisse senza Freak?? Apriamo il dibattito…», che segnala che gli Skiantos rimasti stanno valutando di tornare sul palco anche senza il loro leader storico.
Freak Antoni muore nel febbraio 2014, dopo un lungo periodo di malattia.
Per ricordarlo gli Skiantos organizzano il 16 aprile, giorno del suo compleanno, un concerto a Bologna a cui partecipano gruppi e solisti sia demenziali, come Lino e i Mistoterital, Marco Carena, i Powerillusi, i Belli Fulminati nel Bosco, sia di altri generi ma a lui legati come Eugenio Finardi, Ricky Gianco, Gli Avvoltoi, Claudio Lolli, Omar Pedrini, Luca Carboni, Johnson Righeira, Maurizio Solieri, Ricky Portera e Altera.
Nel novembre 2014 gli Skiantos pubblicano il nuovo singolo “Evacuazioni”, l’ultimo inciso con Freak Antoni.
L’anno successivo il gruppo riprende l’attività live, esibendosi in varie occasioni tra cui alla rassegna “Imola in musica” il primo giugno 2016, al “Festival della Canapa” di Forlì il 17 e 18 giugno 2016 e al “Festival dell’Unità” di Ravenna il 9 settembre 2016.
Nel 2018 gli Skiantos partecipano all’album Powerillusi & Friends dei Powerillusi; nel disco interpretano il brano Il superpezzo[18]. Dal 2019 inizia una collaborazione con il cantante Nevruz.
Gli Skiantos hanno generato numerosi stuoli di imitatori: i primi sono stati i Sorella Maldestra, che pubblicarono l’lp “Cadavere” nel 1979. Più punk, più duri e più volgari, e decisamente in competizione: nel loro brano più celebre, “Io sono un fric”, un verso è decisamente esplicativo (“Degli Skiantos me ne frego/ non li vedo né li cago”). Devono qualcosa agli Skiantos anche i gruppi che parteciparono al progetto Rock 80 della Cramps, come i Windopen (“Sei in banana dura”) e le Kandeggina Gang (“Sono cattiva”).
youtube
0 notes
Text
BELFAST
Nonostante i fatti cruenti che sconvolsero l'Irlanda del Nord, tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, i film sull'argomento sono relativamente pochi. Si potrebbero ricordare il bellissimo "Nel nome del padre" di Jim Sheridan del 1993 (che vinse l'Orso d'oro al Festival di Berlino), "Le ceneri di Angelica" dI Alan Parker del 1999, "Bloody Sunday" di Paul Greengrass del 2002 e pochissimi altri. Eppure la vicenda dell'Ira e le gesta di Bobby Sands e dei suoi compagni di lotta, occuparono per anni le pagine dei giornali e dei telegiornali e furono il soggetto per centinaia di saggi e libri d'ogni sorta. E' anche per questo che saluto con piacere l'uscita nelle sale di "Belfast" di Kenneth Branagh, indubbiamente un bel film che avrebbe potuto essere bellissimo, e sarebbe bastato poco, magari una ricostruzione delle strade di Belfast meno algida e posticcia, magari un'immagine più "sporca", magari un’accortezza maggiore per la colonna sonora che, benché composta da brani di Van Morrison, sembra un po' monocorde e prevedibile (perché non pescare anche nell'enorme serbatoio della musica irlandese?). Ma direi che ci si possa accontentare della vicenda semplice e lineare di Buddy, un bambino di nove anni, dei suoi genitori e dei suoi nonni, famiglia protestante della periferia di Belfast, in balia degli scontri tra protestanti e cattolici e della loro necessità di trovare altrove (in Inghilterra) una vita migliore. E' una storia del passato, ma che ha tutti i connotati della contemporaneità, con una tematica ormai universale, quella delle migrazioni causate da povertà, lotte politiche e guerre. Il film è certamente ben raccontato e ben sceneggiato, con dialoghi essenziali, lineari, scevri da retoriche scioviniste o manichee e tutti concentrati sul dramma individuale che, come sempre accade, va oltre gli accadimenti che poi entreranno nelle categorie della storia politica. Non so se è un caso, e forse sicuramente lo è, ma "Belfast" arriva in un momento difficile per tutti, addirittura catastrofico per alcuni, e sicuramente non sarà certo un film a far cambiare idea a questo o a quel dittatore, a questo o a quel guerrafondaio, però può far riflettere noi, spettatori inermi (e non solo al cinema), di quanto l'odio e la sopraffazione siano ancora il veleno del mondo. "Belfast sarà ancora qui, quando tornerete", dice il nonno di Buddy al momento della partenza del nipotino e dei genitori per l'Inghilterra; "E tu?" chiede il bambino al nonno . Il nonno dà una risposta che è piena di una saggezza e di una malinconia tutta irlandese: "Non andrò in un posto dove non potrai trovarmi".

2 notes
·
View notes
Text
CENT'ANNI DI COMUNISMO
Nessuno, il 24 febbraio scorso, ha festeggiato il centenario del partito nazista di Hitler, così come nessuno, il 21 gennaio prossimo, celebrerà propriamente il centenario del Partito Comunista, sezione italiana dell’Internazionale comunista legata alla Rivoluzione d’ottobre. Il paragone ci sta tutto: sono stati, entrambi, due partiti totalitari e corresponsabili delle peggiori atrocità del Novecento. Sul centenario comunista uscirà qualche libro: uno l’hanno già scritto Ezio Mauro e Mario Pendinelli per Marsilio («Quando c’erano i comunisti», titolo che infatti parla al passato) e un altro sta per pubblicarlo Emanuele Macaluso, che ha 97 anni. Le ombre di morte e atrocità che accompagnano questi totalitarismi sono le stesse per cui in Italia un serio partito fascista non esiste più (sarebbe fuorilegge) ma è anche la ragione per cui in Italia anche i comunisti non esistono più (sono assenti dal Parlamento) e non si trova quasi più nessuno disposto ad ammettere di essere stato comunista. Restano le accuse incrociate di essere «fascista» o «comunista» intese come insulti: ma la prima è la proiezione di un’ombra di settant’anni fa, la seconda è un’eredità di ieri che pesa ancora sulla società italiana, anche perché, come insegna una nota legge fisica, nulla si distrugge ma tutto si trasforma. In che cosa?La maggior parte degli ex comunisti ha optato per la versione di Walter Veltroni: «Eravamo solo i ragazzi di Berlinguer», cognome che ancor oggi suscita applausi per mera ignoranza o perché molti, in realtà, applaudono solo alla loro giovinezza. Peccato che anche qui - detto senza acrimonia - i più ignorino o rimuovano ciò che Berlinguer effettivamente disse e fece, tanto che certe «operazioni nostalgia» funzionano ancora benché recitino un copione surreale. Uno può rimpiangere chi vuole: ma la sinistra di Berlinguer, storicamente, è quella che perse il referendum sulla scala mobile, che scelse di non schierarsi con gli Stati Uniti, che flirtò ancora con i sovietici che intanto puntavano missili nucleari contro di noi, è la sinistra che non volle trattare durante il rapimento di Aldo Moro e che rifiutò ogni riformismo che era invece cavallo di battaglia di Craxi. Il quale fu odiato per molte ragioni, ma la principale fu che l’Occidente guardava a lui come una sinistra schierata dalla parte giusta, come diverse interviste fatte a Massimo D’Alema hanno ricordato. Purtroppo, nella recita generale, persino Matteo Renzi è riuscito a sostenere che Berlinguer «è stato il leader che per primo ha portato la sinistra italiana dalla parte giusta della storia»: il contrario perfetto della verità, perché le posizioni di Berlinguer su mercato e imprese e liberalismo erano da suicidio; ancora negli anni Settanta, a congresso, sosteneva che «è universalmente riconosciuto che nell’Urss esiste un clima morale superiore, mentre le società capitalistiche vengono sempre più colpite da un decadimento di idealità e valori etici e da un processo di corruzione e degrado». Il partito della «questione morale» berlingueriana, ricordiamo, prendeva segretamente rubli dall'Unione Sovietica, e il famoso il famoso «strappo da Mosca» non impedì al Partito di incamerare rubli sino a 1989 inoltrato, quando crollò tutto l'Est e il Pci dovette umiliarsi a cambiare nome. Saranno stati solo i ragazzi di Berlinguer, ma Berlinguer si schierò contro gli euromissili in risposta alla minaccia dell'Urss, cercò di salvaguardare lo zoccolo duro comunista e perse di vista i ceti emergenti, rimase assolutamente comunista («l’eguaglianza è molto più importante della libertà») e per lustri la sua sinistra bloccò ogni opera e infrastruttura pubblica che fosse più grande di una capocchia di spillo. Il 21 gennaio prossimo, a ben pensarci, si finirebbe per festeggiare la nascita di un partito che bloccò il nucleare (non da solo) ma che era anche contro la televisione (quella a colori in particolare) e contro l’automobile, contro l’Autostrada del Sole, contro la metropolitana, contro i grattacieli, contro i ponti e i sottopassaggi, contro l’alta velocità in ogni sua forma, contro i computer, contro l’automazione del lavoro, contro il part-time, contro tutto ciò che si è rivelato causa e conseguenza della modernizzazione di un Paese che oggi ci si lamenta non sia sufficientemente modernizzato: chissà come mai. I figli di Berlinguer erano comunque parte di una sinistra che condannava la famosa società dei consumi, e ricordarlo non è preistoria. L’Unità del 3 ottobre 1964: «Abbiamo l’autostrada, ma non sappiamo a che serve». L’Unità dell’8 gennaio 1977: «Gli investimenti in autostrade hanno aperto una falla difficilmente colmabile, a detrimento di investimenti la cui mancanza determina continui danni economici ed ecologici». Avevano già requisito la questione ecologica. Il 1977 del resto è l’anno in cui Berlinguer – alla vigilia di una straordinaria fase di espansione mondiale dell’Italia – dettava un’altra parola d’ordine: «Austerità… il mezzo per porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale».Non è un articolo storicheggiante, questo, non stiamo urlando «100 milioni di morti» e arrivederci: ricordiamo solo che negli anni Sessanta il tram era definito di sinistra e la metropolitana di destra, che la sinistra progressista si oppose a ogni sviluppo urbanistico verticale, a tutti i progetti di Alta velocità ferroviaria, alla variante di valico Firenze-Bologna, all’aeroporto della Malpensa, al progetto Mose per salvare Venezia, persino, come detto, alla televisione a colori che secondo l’Unità, nel 1977, era «caldeggiata dagli industriali» ma c’erano dubbi su «quando introdurla… chiarire se il Paese può sopportare questa spesa». La tv a colori ce l’aveva da decenni tutto il mondo occidentale. E non stiamo neanche a citare l’opposizione alle prime tv commerciali e a «un pluralismo televisivo illegale, incostituzionale e tecnicamente impossibile» (l’Unità). Già. Chi applaudiva ai pretori che spegnevano le tv di Berlusconi? chi si battè contro gli spot televisivi perché «non si interrompe un’emozione», come disse proprio Walter Veltroni?Rimosso tutto questo, dimenticata o falsificata la Storia, si riciccia allora il famoso «eurocomunismo» berlingueriano, oggetto misterioso che si rivolse ai partiti comunisti di Francia e Spagna e a un certo punto anche Inghilterra: sappiamo che doveva essere un progetto marxista intermedio al leninismo e al socialismo, e che, insomma, voleva reinventare il comunismo. Ma in realtà non sappiamo altro, a parte che una vera rottura con l'Unione Sovietica alla fine non vi fu, e che non fu mai sviluppata una strategia politica chiara e riconoscibile. L’unica cosa certa, e realizzata a livello europeo solo oggi, è che al posto del comitato centrale c'è un comitato economico e finanziario, e al posto dei proletari ci sono milioni di correntisti.Oggi dicono che «se ne occuperanno gli storici», ma forse è proprio questo a terrorizzare: che gli storici, com'è già accaduto, possano farsi soffocare da un conformismo il quale, per diradarsi, ha bisogno di decenni. Dicono «la Storia»: ma basta guardare a quanti poveracci, ancora, liquidino certi governi della Prima Repubblica come una fabbrica di debito pubblico e non (anche) come un motore della modernizzazione italiana dal Dopoguerra, quella che ci fece raggiungere il quinto posto tra i paesi industrializzati; basta guardare a quanti «ragazzi di Berlinguer» celebrino ancora Berlinguer che non ebbe ragione su niente. Basta guardare, chiediamo scusa, persino a questo governo: è composto in massima parte da ex comunisti o postcomunisti oltreché da grillini, una somma che, con la stessa e ipocrita aura di superiorità, favorì quell'antipolitica e quel qualunquismo che non si riversarono in una pulsione rivoluzionaria: si riversarono prima nel giustizialismo e poi nell’antipolitica. Insomma: i comunisti non esistono più, però sono al governo. E li riconosci anche con la mascherina.
Filippo Facci
10 notes
·
View notes
Text
Qualcuno si è dimenticato di lui: è ora di rileggere Luigi Meneghello e il suo capolavoro, “Libera nos a Malo”
“Pater noster qui es in caelis/ santificetur nomen tuum/ adveniat regnum tuum/ fiat voluntas tua/ sicut in caelo et in terra/ panem nostrum quotidianum da nobis hodie/ et dimitte nobis debita nostra/ sicut et nos dimittimus debitoribus nostris/ et ne nos inducas in tentationem/ sed libera nos a malo”.
*
Lì dove finisce la preghiera in latino inizia la storia. L’invito non è sfuggito all’acume veneto-british-veneto di Luigi Meneghello, nato in provincia di Vicenza e poi professore all’Università di Reading . Colpevolmente l’intellighenzia italiana e la sua cricca di critici si è dimenticata di lui. Molto colpevolmente: se non fosse stato per l’illuminato Daniele Luchetti, il regista che nel 1998 ha girato I piccoli maestri, se non fosse stato per due attori veneti eccezionali, Natalino Balasso e Marco Paolini, e un altrettanto illuminato regista piemontese, Gabriele Vacis che insieme – era il 2005 – hanno portato in tournée teatrale Libera nos, spettacolo creato dai testi di Meneghello, il velo dell’oblio sarebbe calato (ancora colpevolmente) sulla sua scrittura terrigna e dialettale, sulla sua capacità straordinaria di raccontare un paesino de màgnagàti, aggrappato inconsapevolmente alla coda del Pater noster.
*
L’invocazione del Pater noster viene ovviamente travisata dai compaesani in una più goliardica “Libera nos amaluàmen”. Sembra di sentirli recitare assieme, tra un bianchèto e una graspèta, come una formula quasi magica, uno scongiuro contro le brutture e gli orrori della vita: di più, contro l’incombenza della morte, non solo o non tanto fisica quanto morale. “Liberaci dal luàme, dalle perigliose cadute nei luamàri, così frequenti per i tuoi figlioli, e così spiacevoli: liberaci da ciò che il luàme significa, i negri spruzzi della morte, la bocca del leone, il profondo lago! Liberaci dalla morte ingrata: del gatto nel sacco che l’uomo sbatte a due mani sul muro; del cane in Piazzola a cui la sfera d’acciaio arroventata fuoriesce fumando dal sottopancia; del maiale svenato che urla in cima al cortile; del coniglio muto, del topo di chiavica che stride tra il muro e il portone nel feroce trambusto dei rastrellatori. Libera Signore i tuoi figli da questo luàme, dalla sudicia porta dell’Inferno”.
*
“Le cose andavano così: c’era il mondo della lingua, delle convenzioni, degli Arditi, delle Creole, di Perbenito Mosulini, dei Vibralani; e c’era il mondo del dialetto, quello della realtà pratica, dei bisogni fisiologici, delle cose grossolane”.
*
Libera nos a Malo apparve in un momento letterario che non poteva non provocare equivoci poiché da pochi anni erano usciti i romanzi di Pasolini I ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta (1959), quest’ultimo contemporaneo al Calzolaio di Vigevano di Mastronardi, secondo Segre “esperimenti in cui il dialetto aveva un ruolo centrale ma funzioni molto diverse, tra realismo espressionistico e mimesi appassionata del parlato, tra critica della società e deformazione fantastica”.
*
Libera nos a Malo è stato pubblicato nel 1963. Il titolo è un gioco di parole tra l’espressione evangelica “liberaci dal male” e il suo paese natale, Malo. Meneghello qui propone, in una sorta di rivisitazione autobiografica, gli usi, i costumi, le figure tipiche, la vita sociale che ha conosciuto nel corso della sua infanzia e giovinezza e traccia un ritratto della provincia vicentina, della sua gente e della sua cultura dagli anni Trenta agli anni Sessanta. Dunque un passato incavicchiato nel presente, raccontato in un’opera che è un libro della memoria e insieme un libro della realtà.
*
Il fil rouge della vicenda è la vita dell’autore, in particolare la sua infanzia. Fanno da sfondo il Fascismo, la vita della famiglia, l’istruzione, la religione cattolica. Gli stessi elementi che emergono nella pellicola Amarcord di Federico Fellini, a pensarci bene.
*
“Il primo nucleo del libro si è formato a Malo nel corso di due estati (le mie vacanze accademiche che passavamo appunto al mio paese, nella casa di mio padre). Tre mesi circa nel 1960 e altri tre nel 1961. Mi ero messo a scrivere su certi fogli sciolti, alla sera quando si tornava dal caffè, le conversazioni e le chiacchiere che avevamo fatto con gli amici, o anche le cose sentite in paese durante il giorno. Uno, due, tre fogli per sera, in tutto saranno stati un centinaio. Non avevo intenti esplicitamente letterari. Volevo fermare qualcosa che mi era piaciuto, fatti o discorsi, per lo più cose senza importanza. Qualche scossa di terremoto durante la notte, e la gente raccontava le sue impressioni: l’Annamaria aveva immaginato, per un attimo, che ci fosse un toro (Annamaria! un toro?) sotto il letto… Mio papa si era svegliato, e aveva pensato: ‘Orcocàn, tenporale n’altra volta’… Ho scritto questi fogli in due serie nelle due estati che ho detto. Nell’intervallo, in Inghilterra o altrove, ogni tanto mi veniva in mente uno spunto e aggiungevo qualche altra cosetta dello stesso tipo. È stato soltanto nell’autunno del 1961, tornando in Inghilterra per l’inizio dell’anno accademico che mi è venuta l’idea di utilizzare questo materiale: sentivo (credo per la prima volta in vita mia, e non senza sorpresa, essendo io abituato a scrivere cose che poi non mi piacciono), sentivo che quegli appunti mi piacevano, non nel senso che li credessi molto belli, ma nel senso che corrispondevano a ciò che c’era davvero dentro di me, io ero così, non qualcos’altro”. Luigi Meneghello.
*
Meneghello è uno scrittore veneto quanto Verga uno scrittore siciliano e Dante uno scrittore fiorentino. La sua terra – e il cielo e tutto lo spazio di confusione e ispirazione e disperazione tra questo e quella – è l’invenzione del linguaggio. C’è una ricercatezza formale e musicale dissimulata nell’ambientazione più modesta possibile, c’è la costruzione di una lingua non nuova ma rinnovata, riscaldata, rampicante, potentissima.
*
“Attraverso il microcosmo di Malo viene fissata e trasmessa compiutamente al futuro la vicenda di tutta la nostra società, nel breve periodo in cui passa da una statica e secolare civiltà contadina alle forme più avanzate della modernità, la vicenda addirittura di tutto il nostro mondo con le fratture che hanno segnato la sua precipitosa evoluzione”. Lo ha scritto Giulio Lepschy.
*
Un libro fondamentale della cultura paesana e della lingua della prima metà del Novecento: unisce umorismo leggero a sensibilità e cultura linguistica. Spassoso, certo, ma anche dissacrante e tenero. Il dialetto diventa così l’ultimo veicolo identitario e riporta il lettore in un Veneto che in parte esiste ancora, soprattutto nei paesini di provincia, e che continua a vivere grazie anche alla sua lingua.
*
Libera nos a Malo è una “cronaca del ritorno” di Meneghello nel paese (e nella comunità) di Malo. All’incipit – “Si comincia con un temporale. Siamo arrivati ieri sera e ci hanno messi a dormire come sempre nella camera grande” – corrisponde simmetricamente una didascalia finale, “Abbiamo riso a lungo imbarazzati, e poi siamo andati via. Volta la carta la ze finia”.
*
“Il motivo della liberazione, di quel ‘libera nos’ da parte mia non corrisponde affatto a un desiderio di evadere dal paese, di essere liberato: non ne ho mai sentito il bisogno o la voglia, se non in un senso molto largo, che riguarda specialmente il paese, […] il doppio aspetto della mia relazione di fondo con Malo: da un lato essere (e sentirsi) all’interno della materia e parlare con l’autorità di chi vede le cose dall’interno; dall’altro la condizione opposta, il distacco senza del quale non c’è prospettiva in ciò che sai e che dici. Sono due aspetti ugualmente essenziali”.
Alessandro Carli
L'articolo Qualcuno si è dimenticato di lui: è ora di rileggere Luigi Meneghello e il suo capolavoro, “Libera nos a Malo” proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2LmRgm5
12 notes
·
View notes
Text
«Se sfogliate qualche libro di storia dell’architettura o delle riviste di architettura degli anni Sessanta, troverete pubblicato il quartiere di Scampia prima che fosse costruito. Scampia copia puntualmente una città giardino costruita in Inghilterra che si chiama Cumbernauld. Quando la vedrete, direte che quella è Scampia. C’è una spina centrale e tutte le case intorno, scuole, attrezzature, servizi e verde. C’è però un elemento diverso da Scampia: nella spina centrale, che è circa un chilometro, ci sono tutte le attrezzature, i servizi e le attività direzionali, c’è una spina direzionale. Poi si sono fatte le case. Voi invece avete realizzato le case senza la spina direzionale, cioè siete una città senza cuore, non c’è un’anima centrale. Questo vi dovrebbe far capire una cosa importante. Se volete uscire dal labirinto del sottosviluppo in cui state, dovete capire qual è la patologia. La patologia principale è che, quando si sono accorti che hanno fatto le case e non avevano i soldi per fare la spina dorsale, hanno fatto un po’ di verde, sbagliando clamorosamente. Perché le case sono intorno? Se c’è il centro direzionale a metà, io esco di casa e sono nel centro direzionale. Che cosa ci trovo? Una serie di parcheggi sotterranei, attrezzature, servizi, negozi, ristoranti, alberghi, tutto. Allora, faccio cento metri e sono nel centro. Voi, invece, uscite di casa, fate tre chilometri e non trovate niente.
Aldo Loris Rossi
3 notes
·
View notes
Text
Antichi mestieri: Il Carbonaio


Una delle attività scomparse a fine degli anni Sessanta, è quella dei carbonai. I carbonai vendevano sia carbone che legna da ardere, in tempi in cui il riscaldamento domestico era affidato ai caminetti e alle stufe e solo in minima parte ai termosifoni.

Le rivendite di legna e carbone erano antri oscuri, varcare la soglia di quei magazzini impregnati di polvere nera era un po’ come fare un immaginario viaggio nelle viscere della terra, un po’ come immergersi nella Commedia dantesca, entrare nella “Città dolente”, ovviamente solo per il colore cupo dell’ambiente.

All’interno, vi erano appositi scomparti in cui venivano ammucchiati i vari tipi di carbone. C’era la “brace”, ricavata da arbusti del sottobosco, che veniva utilizzata per avviare i fornelli a carbone e gli scaldini, c’era il carbone ricavato da legno di quercia, castagno, faggio etc. ed il “carbon coke”, un residuo del carbon fossile che veniva distillato a secco per la produzione del gas di città, che serviva per le stufe e per le caldaie dei rari impianti di riscaldamento. La legna veniva solitamente accatastata sul fondo della bottega, già tagliata in pezzi a misura per l’uso domestico.

In moltissime abitazioni era presente l’impianto del gas, ma ben poche erano quelle che potevano vantare un impianto di riscaldamento; nella stragrande maggioranza delle case, si potevano trovare la cucina economica, alimentata da legna. Venne inventata in Inghilterra nella prima metà dell’Ottocento, e venne chiamata così perché era provvista di moltissimi accessori, che ne consentivano l’uso per diverse attività domestiche, quali cucinare e al contempo riscaldare la casa. Di solito ha uno sportellino nel quale si brucia la legna, al di sotto del quale c’è un cassettino estraibile che raccoglie la cenere che si forma nella combustione. Accanto c’è un altro sportello che funge da forno, e ancora un altro vano per tenere in caldo le vivande. Il piano superiore, una piastra in ghisa, ha la stessa funzione dei nostri fornelli, vi si appoggiano le pentole e si cuociono i cibi direttamente sul fuoco. Ci sono dei cerchi di ghisa asportabili, di diverse misure, che permettono di avere un fuoco più vivace o più contenuto, proprio come i nostri fornelli. Sulla piastra si trova anche un contenitore con coperchio nel quale viene messa l’acqua da riscaldare. Ricordo che i miei nonni ne avevano una, e che io mi incantavo a guardarla, affascinata dallo scoppiettare della legna che veniva inserita nello sportello, e ricordo la nonna che con un’asta di ferro uncinata metteva o toglieva i cerchi dalla piastra per regolare il fuoco… ricordi d’infanzia!

E un altro ricordo legato alla cucina economica erano i ditali da sarta riempiti di farina di castagne, che veniva messa a cuocere nel forno… un piccolo innocuo dolcetto che sprigionava un profumo delizioso. Un altro utilizzo del carbone era quello per gli scaldini, i trabiccoli ed i “preti”, che venivano messi sotto le coperte nelle fredde notti invernali per rendere il letto caldo ed accogliente. Il carbonaio portava il carbone e la legna a casa delle persone: aveva un carretto, su cui caricava dei cesti con la legna e sacchi pieni di carbone e faceva il giro della sua zona, rifornendo le famiglie di questi beni, all’epoca preziosi ed indispensabili.

Gabriella Bazzani Read the full article
0 notes
Text
The Who
(1964, Londra, Inghilterra, Regno Unito)
La band più rock della storia del rock, escludendo quelli della categoria “hard” rock. Avevano Pete Townshend, che sapeva fare di tutto con le chitarre (spaccarle sul palco, soprattutto) e con le tastiere, e scriveva quasi tutti i pezzi. Avevano Keith Moon, che era un batterista da urlo e un pazzo formidabile. Avevano Roger Daltrey, per la parte cantante-biondo-capellone incazzato. Avevano John Entwistle, che suonava il basso come se stesse passando di lì per caso. Tutto il rock britannico dagli anni Sessanta a oggi è venuto giù da lì. vedi anche: The Rolling Stones - The Kinks - Led Zeppelin - Pink Floyd - The Doors
Top 10 Spotify
0 notes
Text
Chioma Nnadi

Chioma Nnadi è la prima donna nera a ricoprire il ruolo di Responsabile dei contenuti editoriali di British Vogue.
È nata a Londra nel 1979, da madre svizzero-tedesca e padre nigeriano arrivato in Inghilterra per studiare, negli anni sessanta.
L’illustre carriera nel giornalismo di moda è iniziata alla redazione dell’Evening Standard Magazine prima di trasferirsi a New York per scrivere per la rivista di stile indipendente Trace.
Successivamente si è dedicata alla moda e alle sue intersezioni con la musica, ha scritto per Fader prima di unirsi a Vogue nel 2010.
In tredici anni, con dedizione, talento e passione per la narrazione attraverso il costume, iniziando come scrittrice di notizie è diventata una voce potente e influente in materia di diversità e inclusività, fino ad arrivare ad assumere la direzione di Vogue.com, nomina arrivata in settembre 2023 è stata. Il suo focus, ha raccontato, verterà sul digital storytelling.
Cura il podcast The Run-Through with Vogue in cui racconta il dietro le quinte di alcuni articoli apparsi sul sito e intervista personaggi del mondo della moda e della cultura.
«Quando ho iniziato, c’era solo un’altra persona nera che lavorava nell’edificio e andavamo alla stessa università. Non era il luogo che è ora. Ovviamente le questioni di diversità e inclusione dovrebbero sempre essere all’ordine del giorno, ma ora sembra essere più una conversazione aperta, e per me questo è un progresso. In quanto donna nera, ma anche birazziale, il modo in cui vedo il mondo corrisponde a come lo guardo, ovvero attraverso lenti influenzate dal mio background, da dove vivo, dall’avere genitori di diverse culture e dovermi muovere tra queste culture», ha raccontato al Guardian.
Sotto la sua guida, Vogue ha registrato un’enorme crescita del pubblico, con un coinvolgimento da record sul sito e sui social. Ha supervisionato la copertura digitale degli eventi più importanti del marchio, dal Met Gala a Forces of Fashion e Vogue World. Le sue recenti storie di copertina su Rihanna, Cara Delevigne e Erykah Badu sono state tra le più riuscite di Vogue.
Congratulazioni al suo nuovo incarico e, attenderemo di vedere le sue brillanti intuizioni in materia di moda e intersezionalità.
0 notes
Text
Joshua Reynolds, raccontare la campagna inglese

Uno dei pittori simbolo del Settecento europeo… Joshua Reynolds nacque il 16 luglio 1723 a Plympton, nel Devonshire, figlio di un pastore protestante ed di un insegnante di scuola. La sua famiglia, che aveva forti legami con la chiesa e l'aristocrazia locale, lo incoraggiò a disegnare e a dipingere fin dalla prima giovinezza, inoltre Joshua lesse gli autori classici, Plutarco, Seneca e Ovidio ma anche Shakespeare, Milton e Pope, poi studiò gli scritti sull'arte di Leonardo da Vinci, di Charles Alphonse Du Fresnoy e di André Félibien. Ma il testo che influì di più sulla sua formazione fu An Essay on the Theory of Painting, del pittore inglese Jonathan Richardson, pubblicato nel 1715. Reynolds nel 1740 fu mandato a bottega presso il pittore Thomas Hudson, anch'egli originario del Devonshire, che lavorava a Londra come ritrattista, dove affinò la sua tecnica. Nell'estate 1743 il pittore lasciò improvvisamente lo studio di Hudson, pare per un litigio di poco conto, ma alla fine tutto si sistemò e i due rimasero in buoni rapporti, tanto che Hudson invitò Reynolds a entrare nel club da lui fondato, con appassionati e collezionisti di disegni degli antichi maestri. Reynolds cominciò a lavorare come ritrattista, dividendosi tra Londra e il Devonshire e guadagnandosi da vivere con i ritratti della piccola nobiltà locale e degli ufficiali di marina di stanza al porto di Plymouth, poi partì per l’Italia passando per il Portogallo, la Spagna e Minorca; Nel gennaio del 1750 Minorca per proseguire verso l'Italia e a Pasqua giunse a Roma, nella primavera 1752 si recò prima a Napoli e poi a Firenze passando per Assisi, Perugia e Arezzo. Da Firenze il pittore passò a Bologna, poi si recò a Venezia, passando per Modena, Parma, Mantova e Ferrara ed iniziò il viaggio di ritorno in Inghilterra nell'estate del 1752, accompagnato da un giovane allievo italiano, Giuseppe Marchi, che aveva conosciuto a Roma. Rientrato in Inghilterra, Reynolds volle dimostrare l’impatto del suo soggiorno in Italia sulla sua arte, infatti dipinse il ritratto esotico di Marchi e quello eroico di Augustus Keppel, dove la posa si ispirava alla statuaria antica mentre il colore richiama la pittura del Tintoretto. Nel 1760 l'artista si trasferì in Leicester Square, dove visse per il resto della sua vita, installando nello stesso edificio l'abitazione, lo studio e la galleria di dipinti. Nei primi anni Sessanta, oltre a esporre presso la Society of Artists, Reynolds ne diresse gli affari; ma attorno alla metà del decennio la società fu turbata da un clima di rivalità scatenatosi tra i suoi membri e il comitato direttivo Alla fine i contrasti portarono all'abbandono dell'istituzione da parte dei principali artisti, che, nel 1768, fondarono la Royal Academy of Arts, con il patronato di re Giorgio III, poi Reynolds accettò la carica di presidente della nuova Academy e ricevette la nomina a cavaliere nel palazzo di St. James. Quando divenne presidente dell'Academy, Reynolds ebbe il compito di tenere in quella sede una conferenza annuale, poi biennale, sulla teoria dell'arte. Negli anni Settanta il pittore espose circa cento dipinti alla Royal Academy, tra cui i ritratti di amici, attori, scienziati, uomini di chiesa, aristocratici e bambini. Quando nel 1780 la Royal Academy tenne la sua prima esposizione a Somerset House, edificio da poco costruito su progetto di sir William Chambers. Reynolds presentò sette quadri, tra cui uno ritratto a figura intera di Lady Worsley in abbigliamento militare da cavallerizza, un ritratto di Edward Gibbon e una figura allegorica della Giustizia che era una delle sue composizioni per una vetrata del New College di Oxford. Negli anni Ottanta Reynolds si ispirò all'arte fiamminga e olandese, soprattutto dopo avere visitato quelle regioni nella tarda estate del 1781. Il 1 ottobre 1784 Reynolds fu nominato primo pittore del re, in seguito alla morte di Allan Ramsay. Negli anni che seguirono, il pittore dovette affrontare un'opposizione sempre più aspra all'interno dell'Academy, dalla quale uscirono alcuni artisti importanti, tra cui Thomas Gainsborough e, per rilanciare l'immagine pubblica dell'Academy, espose novantasei quadri tra il 1784 e il 1790, anno in cui si ritirò a vita privata. Reynolds morì il 23 febbraio 1792 ed è sepolto nella cattedrale di St Paul. Nel 1813, la British Institution allestì a Londra la prima retrospettiva delle sue opere e, nello stesso anno, venne pubblicata la prima biografia del maestro, scritta dal suo allievo James Northcote. Read the full article
0 notes
Photo

New Post has been published on https://www.tempi-dispari.it/2022/10/13/letatlin-esce-il-21-ottobre-seaside-quinto-lavoro-del-combo/
Letatlin, esce il 21 ottobre “Seaside” quinto lavoro del combo
Anticipato dal singolo “Don’t wink at me”, esce in cd ed in digitale, il 21 ottobre 2022, il quinto lavoro discografico “seaside” dei Letatlin, distribuito da (R)esisto.
Così la band presenta il nuovo lavoro:
“seaside” è stato concepito in un periodo relativamente dilatato (2018-2021). Ogni pezzo nasce in maniera veloce e successivamente, mentre si lavora agli arrangiamenti nascono altri pezzi che a loro volta vengono sviluppati.
È un ciclo per noi molto importante che alterna velocità e lentezza e che ci dà modo di capire a fondo cosa vogliamo senza perdere spontaneità e freschezza. Ogni singolo strumento è stato suonato e arrangiato da noi due ed ogni brano rappresenta una sorta di landscape.
Normalmente si associa alla parola “sound landscape” la musica ambient. I nostri pezzi invece vogliono essere landscape post-punk con venature krautrock. La title-track ad esempio ci ha sempre fatto pensare ad una nostalgica località di mare che in realtà esiste solo nel nostro immaginario.
C’è poi il landscape messicano animato da cowboys perversi e pallottole (Mexican serenade). C’è il landscape dei sentimenti freddi e ghiacciati (the return of the Yeti), quello psichico (psych) ed ancora il paesaggio del dolore di un ospedale (don’t wink at me) o quello di una inverosimile spiaggia degli anni sessanta dove il trucco delle attrici si squaglia al sole (la mouche).
E’ presente anche un landscape alieno popolato di strani personaggi che fanno picnic alla luce di soli sconosciuti e gufi scappati chissà da dove (picnic in the sun). “Seaside” è un viaggio nei vari paesaggi mentali e fisici che abbiamo attraversato durante IL periodo di composizione e di cui secondo noi valeva la pena parlare.
Track by track
Tracklist: 01 la mouche, 02 don’t wink at me, 03 seaside, 04 Mexican serenade, 05 the return of the Yeti, 06 psych, 07 picnic in the sun, 08 a body with two heads
Bio
Letatlin nasce a Roma alla fine degli anni 90 dalla collaborazione di Marc Mal de Vivre e Hans Plasma a cui si uniscono presto Orsonero al basso e MF alla batteria.
I primi tre demo “Tatlin”, “Fossili di Piccolo Calibro” e “Detriti” hanno un’impronta post-rock/noise. Nel 2002 la band autoproduce il primo album “Missili sul Giappone” che riceve ottime critiche da parte del pubblico e della stampa underground.
Nel 2003 è la volta del mini album “1919: naissance du robot” cruciale per l’evoluzione tecnica e creativa: per la prima volta Letatlin (ridotto a chitarre basso e voce) fa uso di drum-machines, sintetizzatori e samples. Il sound inizia ad evolversi verso una personale versione di post-punk.
“1919: naissance du robot” riceve ottime critiche ed il gruppo è contattato dalla neonata etichetta indipendente Ark Records per la realizzazione del primo album ufficiale “La Sepoltura delle Farfalle”. Il disco viene interamente registrato e prodotto dai Letatlin, stampato dalla Ark Records e distribuito da Masterpiece.
L’album pubblicato nel 2006, riceve ottime recensioni in Inghilterra, Germania, Olanda, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Francia ed ovviamente in Italia. Il giornalista inglese Mick Mercer inserisce la band nel libro “Music to Die For” (pubblicato dalla Cherry Red Books, 2009).
Nel frattempo Marc Mal de Vivre e Hans Plasma si trasferiscono ad Amsterdam portando avanti il progetto Letatlin con concerti e l’uscita di numerosi singoli. Nel 2012 Hans e Marc iniziano a registrare il materiale per il nuovo album “Natsuko: the 11th story”.
Esso viene prodotto e mixato insieme a Idan K (Sophya) presso lo studio “Out Of Print” di Amsterdam e stampato nel 2014 in numero limitato di 400 copie ecopack.
Nel 2016-17 Letatlin registra il quarto album “Reaching for the Moonlight” disponibile al momento solo in formato digitale. Tra il 2018 e il 2021 i Letatlin compongono il quinto album “seaside” missato a Roma.
youtube
0 notes