Appassionata di fantastico. Volevo diventare una mahō shōjo ma non ho più l'età. Ogni tanto segnalo narrativa curiosa.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Actually, second time's the charm: Fantastic Parasuicides e The World of Us
Trovo abbastanza buffo che nel primo consiglio dedicato ai film io mi sia prodigata nello specificare che si tratta della forma di narrativa per cui ho i gusti più mainstream di tutti, che conosco poco del linguaggio del cinema e che dunque vedrete pochi post a tema ecc ecc., per poi finire a scrivere due dei quattro articoli di quest’anno su dei film... D’altra parte non ho mai preteso di essere una persona coerente. Mi rendo conto che mi mancano delle basi importanti per parlare di cinematografia in maniera completa e interessante, ma d’altra parte ci tengo talmente tanto a questa segnalazione, visto che mi permette (finalmente!) di parlare di cinema che mi è davvero tanto caro, che preferisco mettere in piedi un consiglio un po’ didascalico e poco brillante ma che potrebbe permettere a qualcuno di muovere i primi passi del cinema coreano meno famoso. Proprio così, è un sacrificio bello e buono quello che faccio, ma d'altronde ho invece la pretesa di essere una persona altruista, tipo uh... scrivendo articoli che mi divertono sul mio blog personale? No?
Giustificazioni non richieste a parte, ci tengo a fare questa segnalazione perché se negli ultimi anni il cinema della Corea del Sud ha ricevuto rinnovate attenzioni e interesse anche da parte della stampa generalista, il tipo di film che arrivano ai giornali, alle testate cinematografiche più popolari o ai portali di aggregazione di recensioni sono spesso e volentieri un po’ monotematici – insomma, quando si parla di cinema dalla Corea o si parla di horror o si parla di thriller. Mi sento di dire tutto sommato anche a ragione: i thriller coreani fanno spesso e volentieri le scarpe a quelli anglofoni per qualità della recitazione, intreccio e sequenze d’azione (guardatevi The Chase, The City of Violence o perché no, A Bittersweet Life e poi ne riparliamo) e non c’è dubbio che la popolarità di Parasite renda più facile che sia questo tipo di titoli ad essere distribuito dignitosamente anche in occidente. Sarebbe però estremamente scorretto – e piuttosto razzista – pensare che allontanandosi da questi generi e da qualche grande Regista-Camaleontico-con-la-R-e-la-C-maiuscole (Kim Ki-duk, Lee Chang-dong ecc.) la Corea abbia poco o nulla da offrire. Dunque per le segnalazioni di oggi mi sembra giusto presentarvi due film relativamente atipici se paragonati ai titoli che hanno avuto più fortuna presso la distribuzione nostrana: Fantastic Parasuicides e The World of Us, completamente differenti come struttura, intreccio e tematiche ma entrambi assai competenti in quello che si propongono di fare.
Fantastic Parasuicides
Il primo film del consiglietto di oggi è in realtà una raccolta di corti, ciascuno girato da un regista diverso, a tema, beh... para-suicidi fantastici. Para- perché come potrete immediatamente notare già dal primo corto, ciascuno dei protagonisti incontrerà più difficoltà del previsto nel tentare di togliersi la vita, e fantastici perché ciò che capiterà nel corso di questi tentativi difficilmente potrà essere descritto in altro modo; dalle situazioni apertamente sovrannaturali fino a quelle semplicemente bizzarre, ciascuno dei corti sceglierà un angolazione diversa da cui esplorare che cosa passa per la mente di una persona che vuole morire e che cosa può succedere attorno a lei per farle cambiare idea.

Il poster non mi dispiace, ma forse è solo perché ho un debole per questa palette.
Tra i tre, il primo corto è quello che adotta la prospettiva più surreale e votata allo strambo per il gusto dello strambo: la protagonista è una studentessa che dopo essersi presentata troppo in ritardo per sostenere un esame decide di buttarsi dal tetto della scuola; anziché morire, però, si risveglia in una realtà simile alla nostra, ma che si rivelerà lungo lo snodarsi della vicenda decisamente più peculiare. Come accennavo, il suicidio in questo corto è poco più che un pretesto per dare inizio alle avventure carrolliane in cui la protagonista sarà impantanata per tutta la durata della storia: non c’è alcuna pretesa di parlare delle modalità e delle motivazioni dietro al gesto che vadano oltre al pretesto di trama o alla stucchevole banalità del finale. Il film è però piuttosto conscio di questa superficialità, poiché il fascino del corto risiede nel domandarsi ad ogni momento quanto la situazione potrà ancora farsi più assurda: da un ragazzo con una bomba nella macchina ad un insegnante paranoico, passando per una serie atroce di effetti speciali che verso il finale diventeranno alquanto buffi, il motivo principe per completare la visione di questa prima parte del film sta proprio nella sequenza onirica in cui la protagonista verrà sballottata. Di certo il corto più debole di questa raccolta, ma ugualmente divertente se si ha un certo gusto per il surreale a basso budget.
Il secondo corto, intitolato Fly Chicken, sceglie modalità più sobrie (ma non per questo meno peculiari) per esplorare il tema della raccolta. La premessa infatti è quella di un agente segreto che trova rifugio in una casa sul mare, dove inizia a pianificare il suo suicidio per sfuggire al suo terribile passato; in teoria tutto ciò che deve fare è premere il grilletto, ma una serie di eventi bizzarri ritardano il momento fatidico. E con “una serie di eventi bizzarri” mi riferisco principalmente al pollo che compare in riva al mare, con cui il nostro protagonista avrà una serie di dialoghi intensi e drammatici, appropriatamente sottotitolati in coreano e in inglese vista l'impossibilità dell'uccello di esprimersi in lingua umana. Il contrasto tra la serietà dei momenti in cui l’agente segreto rimane da solo a confrontarsi con gli oscuri meandri della sua psiche, e quelli in cui interagisce con il pennuto nel tentativo di aiutarlo a liberarsi dalla rete in cui è invischiato suscita una certa ilarità – anche se il regista è molto bravo a mantenere una certa serietà e tensione circa il destino finale del protagonista, camminando sulla linea sottile che separa la commedia nera dal dramma; complice anche la durata ridotta, questo tono ibrido e l’azzeccata scelta di ridurre i dialoghi all’osso – le uniche interazioni verbali saranno proprio quelle con la gallina – permettono allo spettatore di lasciarsi catturare da quest’atmosfera così peculiare fino ad un finale ambiguo ma abbastanza spiazzante da risultare una degna conclusione del film.

Come vedete non mento mai. Solo segnalazioni di qualità su questo blog.
Ok, arrivati al terzo corto – che è, per inciso, di gran lunga il migliore nonché il mio preferito della raccolta – mi sento di specificare che il mio punto debole quando leggo/guardo/ascolto fiction sono i vecchi tristi. Potrete sparare tranquillamente ad una dozzina di bambini senza vedermi battere ciglio (… sì, dicevo, nella fiction), ma mostratemi un signore anziano che mangia una minestrina patetica nel suo appartamento vuoto e sarò costretta a tastare se sul comodino sono rimasti dei fazzoletti con cui asciugarmi il moccio che mi starà già colando giù per il naso. Dunque partivo già disposta ad accogliere come si deve questo corto su un anziano signore che un giorno si sveglia e si rende conto che nessuno si ricorda più che è il suo compleanno. Non il partner – morto anni prima – e non i pochi amici che gli sono rimasti; messo di fronte alla desolazione e alla noia in cui si consumano le sue giornate, il protagonista decide che è arrivato il momento di lasciarsi la vita alle spalle, e decide di sdraiarsi sulle rotaie in attesa del treno poco distante dalla città in cui abita. Piano che viene scombussolato dalla presenza di un’altra persona sulle rotaie, che sembra ugualmente in pericolo ma meno desiderosa di morire… Quale miglior occasione per dare un senso alla propria vita prima di compiere l’estremo gesto? A partire da questo inizio si dipanerà un intreccio rocambolesco che tiene con il fiato sospeso fino alla fine: proprio perché il corto è così abile nel farci provare empatia nei confronti del nostro anziano protagonista ogni minuto sarà speso a “tifare” per lui, oltre che a domandarci che cosa succederà: innanzitutto, riuscirà a salvare dai gangster che lo inseguono il giovane incontrato sulle rotaie? E secondariamente, riuscirà a farlo senza divenire lui stesso una vittima o rimarrà rassegnato fino alla fine all'idea del suicidio?
A questa storia appassionante si aggiunge anche un finale davvero brillante: un paio di colpi di scena perfettamente giustificati anche all’interno di un corto così breve, e l’abilità del regista di dosare le rivelazioni sul passato e sul presente nei momenti più opportuni, permettono a questo film di finire meglio di come è iniziato – e non era un’impresa facile. Emozionante, divertente e capace di suscitare genuina preoccupazione per le sorti dei personaggi coinvolti, si tratta del corto migliore della raccolta e quello che permette a Fantastic Parasuicides di fare un decisivo salto di qualità. Se siete ancora indecisi se dare una possibilità all'intero film, vi consiglio di guardare almeno questo.

Sì, il ragazzo necessita di una mano. Immaginatevelo un po' come il povero Jessie Pinkman ma senza la dipendenza.
The World of Us
Nel momento in cui ho iniziato a buttare giù la struttura della recensione mi sono resa conto di quanto The World of Us risultasse un’anomalia rispetto al genere di storia di cui parlo di solito sul blog. Si tratta infatti di una vicenda senza alcuna traccia di fantastico, incentrata sul rapporto tra due bambine alla fine delle elementari che fanno amicizia nel corso di un’estate e che vedono il loro rapporto messo a dura prova al ritorno sui banchi di scuola. Sembra un genere di storia lontanissimo sia dalle mie corde sia da quello che scelgo di recensire su questo spazio, ma la verità è che il film è riuscito a colpirmi per la precisione mimetica con cui dipinge quel tipo di amicizie intense che si formano tra giovani emarginati, senza per questo idealizzarle o spogliarle dei loro lati più vulnerabili e crudeli (oltre ad essere del tutto sconosciuto al grande pubblico); dunque ho deciso che meritava uno spazio su questo blog, nonostante si tratti di un film che lavora per tutto il tempo con archetipi più che consolidati e che abbia ben poco di stravagante o bizzarro.

Già dalla locandina è facile capire quale sarà la palette del film,
Sun è un bambina che frequenta gli ultimi anni delle elementari, ed è molto sola. A scuola è presa di mira dalle compagne e non ha nemmeno un’amica con cui passare del tempo assieme durante l’intervallo; quando torna a casa si trova a dover curare il pestifero fratellino, a cui sua madre presta molte più attenzioni di quante non ne abbia mai prestate a lei, mentre suo padre beve troppo spesso e quando beve diventa sgradevole. Quindi quando durante la pausa estiva incontra per caso Jia, una ragazzina appena trasferitasi da un’altra scuola che non conosce ancora nessuno, Sun decide che dovrà fare di tutto per conquistarla: il suo piano funziona a meraviglia, ma quando le due bambine tornano a scuola per l’ultimo anno iniziano i problemi… Ecco, leggendo questo rapido riassunto penso che la maggior parte di voi non avranno difficoltà ad immaginare che cosa succede in questo film. L’intera storia si muove infatti su strade ben tracciate e soffre di un certo disinteresse a parlare di temi come il bullismo, l’isolamento e l’amicizia intensa e totalizzante dei bambini in maniere meno convenzionali rispetto agli archetipi già visti e rivisti nella fiction. Quello che distingue questa pellicola dai suddetti archetipi (la cui visione mi è onestamente di solito indigesta) è la qualità della scrittura dei personaggi e la bravura di tutte le interpreti.
Per elaborare il secondo punto, le due attrici principali sono molto naturali nel loro ruolo; è difficile trovare attrici o attori così giovani con una certa abilità (come penso dimostri bene il film recensito nello scorso consiglio), ma entrambe sono bravissime nel rendere ciascuna sfumatura del proprio personaggio. Sun desidera disperatamente piacere a qualcuno, tanto che in ogni scena ogni suo movimento, dall’imbarazzo con cui si muove vicino ad altri fino al suo prodigarsi in mille gesti fin troppo gentili, tradisce la necessità di sembrare piacevole, disponibile, amabile: l’amica perfetta; di contro, Jia appare assai più sicura di sé – eppure anche Jia nasconde più di un segreto, e la sua incapacità di affrontare la solitudine avrà conseguenze molto crudeli. Insomma, la regista Yoon Ga-eun è al suo meglio quando si tratta di rendere con accuratezza le mille sfumature di un’amicizia così ricca di fragilità, tra un’emarginata disposta a smussare ogni lato potenzialmente sgradevole della sua personalità per scappare dalla sua solitudine e una bambina spavalda che nasconde i propri difetti e la propria codardia dietro una facciata cool e patinata.

tipregoamamitipregotipregoTIPREGO – il monologo interiore di Sun in ogni momento del film.
Entrambe le protagoniste – e anche il gruppo di bulle che rende la vita impossibile a Sun – interagiscono poi su uno sfondo molto abile nel riprodurre con mimetica precisione le attività e i giochi più comuni a quell’età: la telecamera indugia spesso sulle unghie dipinte (ma anche nude, scheggiate e morsicate) delle protagoniste, o sul telefono pieno di giochi, sulle matite colorate di marca e così via. In senso più ampio, si tratta di un film che non avrebbe affatto stonato inserito nel mio post precedente: l’atmosfera estiva che permea la maggior parte del film è costruita grazie alle strade semideserte, ai parchi abbandonati dagli studenti in vacanza, ai colori pastello desaturati in cui è avvolta tutta la pellicola. Sono rimasta piuttosto impressionata dall’abilità della regista di catturare quelle sensazioni specifiche che si provano durante la pausa estiva quando si è bambini, nonché di ancorarle ad elementi fisici così azzeccati.
Ammetto di essere ancora incerta su quanto mi siano piaciute le battute finali di questo film, che forse soffrono di una certa convenzionalità, ma mi sento di dire che per la maggior parte del film Yoon evita di cadere in facili buonismi sulla natura dei bambini e su quanto siano più “puri” degli adulti; trovo che ciò sia vero anche sul finale, anche se non faticherei a capire il punto di vista di chi si sarebbe aspettato qualcosa di più radicale e meno vicino ai canoni del genere. In ogni caso, se il tema non vi repelle istintivamente consiglio caldamente la visione! Non sono molti i film che parlano di bullismo che riescono a non farmi alzare gli occhi al cielo durante la visione, ma questo c’è riuscito.

Il fratellino di Sun è adorabile, nonostante sia una peste. Devono essere le guanciotte.
Anche la segnalazione di oggi giunge al termine: sono assai soddisfatta di aver potuto finalmente dedicare un intero post al mio amato cinema coreano, peraltro segnalando titoli un po’ lontani anche dal “suo” mainstream. E dico così perché so quanto siano irreperibili i due titoli segnalati: se aveste difficoltà a recuperarli non esitate a mandarmi un messaggio sul blog e vedrò di farvi avere il materiale necessario. Dunque spero vivamente che almeno uno di questi film abbia catturato la vostra attenzione – e davvero, se seguite questo blog per il bizzarro non potete non dare una chance a Fantastic Parasuicides.
#ita#movie#fantastic parasuicides#the world of us#sung-ho kim#chang-ho cho#soo-young park#yoon ga-eun#recensione
2 notes
·
View notes
Text
Unrestrained summer fun: Boku no Natsuyasumi 2: Umi no Bouken-hen e Summer Vacation 1999
L’estate è la mia stagione preferita! Mi rendo conto che l’incessante aumento delle temperature potrebbe contribuire in un immediato futuro ad un rimescolamento della classifica, ma per ora i gelati, le cicale e la possibilità di adagiarmi settimanalmente sul fondo di un fiume le permettono di guadagnarsi il primo posto senza troppa fatica; mi sembrava dunque interessante segnalare in questo periodo un paio di cosine interessanti per chi ha un debole per l’atmosfera calda, inebriante e statica di certe giornate estive cittadine ma non solo. Anzi, in realtà la mia idea originaria sarebbe stata di confinare il tema del consiglio di oggi all’affascinante microgenere dei summer timeloops, del quale l’iconico Kagerou Daze è un esempio perfetto, ma alla fine mi sono presentate nel corso di questi mesi due esperienze così radicate nella stagione in cui si ambientano le loro rispettive narrative – e soprattutto così belle! – che non ho potuto fare a meno di raccoglierle in questo post.
Ma di quali esperienze sto parlando esattamente [domanda retorica che mi permette di spezzare un paragrafo vicino ad acquisire lo status di wall of text]? Beh, intanto di un videogioco per Playstation 2 che può vantare un’importante fanbase giapponese e una piccola fetta di appassionati occidentali (nonché giuoco apparso regolarmente sul mio blog principale per i Veri Fan che mi seguono anche lì), ma anche di un film ambientato in un futuro alternativo degli anni ottanta in cui tutti i protagonisti sono interpretati da ragazze e scrivere molto velocemente su un computer a schermo verde è considerato C Y B E R P U N K. Che cosa state aspettando? Iniziamo!
Boku no Natsuyasumi 2: Umi no Bouken-hen
Nel 1975 Boku ha nove anni e sua madre decide di spedirlo dai suoi zii per tutto il mese di agosto in previsione del suo parto imminente per non avere pargoli tra i piedi; la destinazione è la campagna della prefettura di Yamanashi, ricca di possibilità per un bambino appassionato di battaglie tra insetti, esplorazione e soprattutto la proficua attività dell’immischiarsi negli affari degli adulti che è com'è giusto e sacrosanto tanto cara a tutti i più piccoli
Solo che la destinazione non è davvero la prefettura di Yamanashi, bensì un villaggio di mare sulla costa ovest del Giappone, perché questo non è il primo Boku no Natsuyasumi, ma uno dei quattro sequel spirituali che l’hanno succeduto dopo il suo significativo successo in Giappone (e oltreoceano, almeno per i pochi appassionati in grado di masticare un po’ di giapponese): per la precisione il secondo, Umi no Bouken-hen, salito alla ribalta nel mondo dell’emulazione occidentale grazie alla minuziosa traduzione di Hilltop Works, resa pubblica alla fine dell’anno scorso, che ha permesso anche a chi parla soltanto l’inglese di provare per la prima volta un titolo di questa saga discretamente popolare nella sua terra natale. Saga abbastanza conservatrice, considerando che tra tutti i titoli le variazioni sono minime e consistono nella scelta dell’area del Giappone in cui Boku passerà l’agosto del ‘75, alcuni cambiamenti nei personaggi ricorrenti e nelle migliorie tecniche dovute alla console di uscita di ciascun titolo. Insomma, una saga peculiare già a partire dalla sua direzione artistica, che rimane tale anche quando si considera il tipo di gameplay che propone e che ha contribuito a renderla abbastanza unica nel suo genere.

La copertina del videogioco. Trovo lo stile cartoon 2d del materiale promozionale adorabile.
Infatti una volta approdati nella cittadina marittima in compagnia di Yasuko, una ragazza di quattordici anni che torna a casa per le vacanze, per Boku si spalancheranno le porte di un intero mese di completa libertà: i suoi zii si assicureranno che mangi due volte al giorno e che non affoghi scandagliando i fondali marittimi, ma tutto il resto del suo tempo potrà essere speso come meglio gli aggrada. Durante l’intera giornata di Boku infatti il giocatore potrà scegliere in completa libertà quale zona della mappa esplorare, con quali personaggi interagire e in che attività impiegare il proprio tempo – attività di cui non c’è certo penuria, considerando che avrete a disposizione una canna da pesca, dell’acqua zuccherata per attrarre giganteschi scarafaggi da utilizzare nei combattimenti contro quelli dei vostri cuginetti, e l’intero fondale marittimo da esplorare alla ricerca di tesori e passaggi segreti! Senza considerare l’ingente quantità di persone che faranno avanti e indietro dalla casa dei vostri zii, che funge anche da B&B per i turisti; dal pacato turista americano Simon fino allo schivo Taniguchi, prono ad alzare il gomito anche di prima mattina. Ma sarà possibile conoscere bene anche le sorelle Yasuko e Hikari, un po’ sole e con una famiglia particolare alle spalle… Insomma, la vera domanda non è che cosa mai potrete fare per i trentun giorni di agosto in cui sarete lontani dai vostri genitori, ma se riuscirete a sfruttare al meglio tutto ciò che la città ha da offrire prima di essere costretti a tornare a casa.
Piano piano, mentre vi acclimatate alla routine della giornata tipo della vacanza estiva di Boku, scoprirete almeno un paio di cose che vi sorprenderanno assai in positivo. La prima è che Boku no Natsuyasumi non è solo una bella esperienza, ma è anche un bel gioco. Sì ok, storia e gameplay non sono elementi narrativi distinti, un gioco è un’esperienza a tutto tondo in cui ciascun singolo elemento è inestricabilmente coinvolto nella formazione del suo senso ultimo, la dissonanza ludonarrativa è vera e può farti del male ecc. ecc., ma è innegabile che chiunque sia abituato a fare del retrogaming spesso e volentieri per accedere ad una storia affascinante si debba abituare ad un’esperienza legnosa, ad un’interfaccia confusa e a delle convenzioni di gioco obsolete che possono rendere le sessioni di gioco complessive decisamente meno appassionanti di quello che potrebbero essere. Non è però il caso di Boku no Natsuyasumi, che nonostante faccia la scelta poco felice di far muovere il personaggio con una strana combinazione di tasto x per avanzare e le quattro frecce per direzionare (… sì, è fastidioso come state pensando), costruisce ciascuna attività di ciascuna giornata con la massima attenzione a renderla meno intrusiva e faticosa possibile per il giocatore. Non c’è il rischio che gli eventi diventino troppo dispersivi grazie ad un efficace guida giornaliera sugli eventi più salienti che prende forma grazie alle predizioni di Hikari, la luce ci farà sempre capire a che punto della giornata siamo e quanto tempo ci rimane, la pesca è un semplicissimo minigioco d’attesa in cui si preme un solo tasto e la maggior parte delle attività, anche in virtù della loro semplicità, sono godibili senza risultare del tutto casuali; un ottimo esempio è la lotta degli scarafaggi, determinata dalle caratteristiche degli stessi, da quanto abbiamo dosato la loro aggressività e dalla fortuna, elementi che premiano un certo coinvolgimento emotivo senza suscitare troppa frustrazione.

Davanti al B&B degli zii di Boku, nonché un ottimo punto per tuffarsi a scandagliare il fondale in cerca di tappi di bottiglia.
Il gameplay di Boku no Natsuyasumi però ha meritato una menzione speciale solo per la sua abilità di mettersi al servizio dell’esperienza chiave del titolo, che non fa certo perno sulla complessità dei suoi sistemi. Il gioco propone un’esperienza marcatamente nostalgica, se non altro per via della minuzia con cui ricostruisce ciascuna interazione che un bambino di otto anni può avere con l’ambiente, gli adulti e i coetanei attorno a lui; esperienza ulteriormente calata in uno specifico contesto culturale di cui non mi sento di giudicare l’”accuratezza storica”, ma che di sicuro fa un ottimo lavoro nel vendere al giocatore perlomeno un’ottima illusione di come poteva essere il mese di agosto del 1975 in una cittadina marittima del Giappone. La malinconia di cui è impregnata ogni giornata di cui si ha esperienza nel gioco è ben sostenuta nella sua profondità e autenticità anche dalla complessità dei dialoghi che si hanno con gli adulti nel gioco; sebbene il paragone più ovvio che possa venire in mente dalla mia descrizione finora per questa saga possa essere Animal Crossing, il gioco non potrebbe essere più distante da quello specifico e melenso filone del cozy gaming che costruisce una fantasia zuccherosa dietro la quale si cela poca carne al fuoco nel senso narrativo del termine (conflitto, evoluzione e così via), ma si tratta chiaramente di un gioco da adulti per adulti. Nel corso dei giorni Boku potrà parlare con un anziano che si sente spaesato e inutile dopo la morte della moglie e del figlio, con una madre che fugge dai suoi figli perché si sente soffocare dal villaggio in cui è cresciuta e con un uomo che passa il tempo sulle montagne piuttosto che stare con il figlio appena quattordicenne – e ciascuno di questi incontri non ci permetterà di aprire il menù delle quest per risolvere la vita dell'NPC di turno che ci ha appena aperto il cuore, ma si risolverà in dialoghi fugaci che lasceranno il protagonista spesso confuso, e il giocatore più conscio della complessità delle dinamiche del villaggio in cui Boku è stato catapultato.
Quello che rimane al momento di salire sul traghetto del ritorno è proprio la sicurezza di aver parlato con persone con una vita più grande, misteriosa e complessa degli scorci che Boku ha visto e sentito, proprio come succedeva spesso a noi da bambini e come certamente capita anche agli adulti; e questa esperienza formativa per Boku ben si riflette nel corso delle giornate che passano, in cui il nostro protagonista imparerà a fare considerazioni un po' più complesse di prima sulle persone che lo circondano. Insomma, quello che davvero Boku no Natsuyasumi 2 è capace di regalare ad un giocatore adulto è proprio il ritorno a quella scoperta totalizzante e straordinaria che si provava sia di fronte alle scoperte provenienti dal mondo adulto che all’esplorazione della natura e dell’ambiente attorno a noi. Il mio consiglio è di provare sulla vostra pelle almeno un paio di queste giornate di agosto, per scoprire se è l’esperienza che state cercando.

Il diario che Boku compila a fine giornata con gli avvenimenti più rilevanti è credo nella mia top ten di cose belle che ho visto quest'anno.
Summer Vacation 1999
Sarebbe l’estate più noiosa di sempre nella scuola di Kazuhiko, Naoto e Norio, visto che sono loro gli unici tre ragazzi che hanno scelto di non tornare a casa per le vacanze e invece di passare le giornate a fare i compiti al computer, a cucinare e a giocare nei campi che circondano l’edificio deserto; se non fosse che la tensione nell’aria si taglia con un coltello e ogni scusa è buona per litigare, perché pochi mesi prima l’intera scuola è stata scossa dal suicidio di Yu, un ragazzo dello stesso anno di Kazuhiko e Naoto che si è lanciato dalla scogliera a due passi dall’edificio scolastico. Norio è convinto che la causa della sua infelicità fosse Kazuhiko, che dal canto suo passa le giornate in compagnia di Naoto, l’unico ragazzo che sembra in grado di rasserenarlo e di fargli allontanare dalla mente quel tragico evento… Almeno finché alla fermata del treno non scende Kaoru, copia perfetta di Yu che si presenta come un nuovo studente che condividerà le settimane successive con i tre; e nel tentativo di comprendere che cosa si cela dietro questo ritorno fantasma, ciascuno dei tre ragazzi aprirà la porta a tutte le pulsioni inconsce che fino a quel momento erano rimaste saldamente chiuse dietro un lucchetto a diverse mandate. E sì, sto naturalmente parlando del sesso gay.

Le uniformi hanno ovviamente lanciato una moda, e ci mancherebbe altro.
Ora che l’elefante nella stanza è stato finalmente svelato, mi pare giusto notare le due peculiarità del film che me l’hanno fatto immediatamente guardare la sera stessa in cui sono capitata sulla pagina del suo regista, Shusuke Kaneko. In primo luogo, se la trama di questo film vi sembra anche solo vagamente familiare, c’è una buona possibilità che abbiate letto Il cuore di Thomas, il manga di Moto Hagio da cui il film è liberamente ispirato; per quanto le differenze siano moltissime, dall’ambientazione fino al destino di molti personaggi, i temi trattati sono simili – fatto che non dovrebbe sorprendere nessuno che già conosce Hagio, di cui io ho letto solo l’etereo Il clan dei Poe, pioniera e maestra dei boys’ love. La seconda cosa che ha immediatamente fatto rizzare le mie antennine sensibili al bizzarro è che in questo film non c’è un solo ragazzo: ciascuno degli adolescenti è interpretato da giovani attrici, fatto che in nessun modo viene mai rimarcato all’interno della narrativa stessa ma che sicuramente dona un ulteriore fascino ad una storia che ruota attorno alle pulsioni proibite, dirompenti e totalizzanti dell’adolescenza, esasperate dalla solitudine estiva e dal quieto scorrere di giorni sempre uguali.
Purtroppo la scelta di interpreti così giovani si fa sentire: nessuna di loro era all’epoca particolarmente talentuosa nell’arte della recitazione e la mancanza di esperienza è molto evidente. Moltissime scene sono legnose, recitate da attrici che imbastiscono monologhi esitanti e spesso poco convinti, tanto che è molto facile immaginarsele con il copione in mano che cercano di mandarsi a mente il discorso che dovranno recitare di fronte ad una telecamera. Non sono una persona che soffre particolarmente attori mediocri o scadenti – altro vero marchio che sancisce la mia esclusione dalla cinefilia dura e pura – ma è innegabile che il film a tratti ne soffra parecchio; ad essere però particolarmente generosi, mi sento di notare che questa recitazione così artificiosa s’incastra piuttosto bene con il resto dell’ambiente che i personaggi navigano.

In questa scena viene citato Demian con i suoi pulcini nel guscio, riprova del fatto che Ikuhara si sarà visto questo film più e più volte.
Infatti la scuola semideserta è costruita con grande maestria per indurre un fortissimo senso di straniamento nello spettatore, che si trova ad osservare un ambiente a volte ai limiti del plausibile e dal look plasticoso e retrofuturistico (che la pagina Wikipedia italiana insiste a definire cyberpunk). Dai monitor verdi che i quattro studenti fissano ogni mattina, digitando una serie di parole inintelligibili ad altissima velocità, presumibilmente per completare improbabili esercizi, fino agli strani giochi presenti in camera di Norio, ciascun elemento dell’ambientazione e ciascuna scelta di regia aiutano a sottolineare il carattere artificioso e favolistico dello spazio in cui i ragazzi interagiscono, come a puntare il dito sul fatto che si tratta di una storia universale, trascendente qualsiasi specificità poiché incentrata su pulsioni ed emozioni che ciascun adolescente prova nel corso della vita. L’effetto complessivo non è dissimile da quello della strana scuola che frequenta Utena, anche se l’ispirazione estetica �� piuttosto diversa: un ambiente dominato dalla routine, dal lento incedere di giorni sempre uguali, che lentamente soffoca chi vive al suo interno finché qualcosa non appare a cambiare le carte in tavola.
Ed è questa cura minuziosa per l’atmosfera in cui il film ci deve immergere che mi ha fatto apprezzare Summer Vacation 1999 così tanto. Al netto delle performance meno che brillanti e di una narrazione lineare fino alla banalità che segue lo scombussolamento che Kaoru provoca nella psiche di tutti gli altri, si tratta di un film che ben cattura quelle estati topiche dell’adolescenza in cui avvengono ogni sorta di rimescolamenti emotivi, in cui ciascuna emozione è volatile, esplosiva e pronta a prendere il sopravvento; Kaneko preme a fondo il pedale sulla repressione che l’ambiente instilla in ciascuno dei ragazzi, e lo fa senza mai mostrare nessun elemento apertamente coercitivo, fatto che di certo fa onore alla sua abilità registica e che permette di mantere un filo di non detto in un film che è tutto tranne che sottile nella messa in scena dei turbamenti adolescenziali di fronte al taboo. Che ok, è il desiderio omosessuale ma anche l’attaccamento morboso, l’isolamento, la paura dell’apertura all’altro e tutta una serie di altre emozioni complicate che facilmente portano a ferire gli altri, sia in senso puramente psicologico ma anche e soprattutto in quello fisico, pericolo ben presentato nel film dalla scogliera dalla quale Yu si è buttato, che ricompare ancora e ancora nel corso delle scene fino al finale carico di tensione che la vede indubbia protagonista, in cui ogni frame di ogni inquadratura suggerisce ai quattro ragazzi un modo semplice e rapido per porre fine ai loro tormenti.

Tutti assieme in una scena senza alcun significato allegorico legato allo strumento suonato. Boys will be boys no homo <3
Non si tratta di un film che piacerà a tutti, vuoi per l’artificiosità della messa in scena, vuoi per la recitazione poco ispirata, o vuoi perché dalla prima scena del film è tutto sommato assai semplice dipanare la matassa della narrativa e leggere in anticipo ciascun movimento di trama, come in qualunque boys’ love degli anni ottanta che si rispetti; ma se anche solo una delle cose che questo film fa bene vi ha catturato vi consiglio caldamente di prendervi una sera per guardarlo e scoprire se l’atmosfera estiva (nel senso più opprimente del termine) di questo film fa per voi.
Detto ciò, questo consiglietto giunge al termine! Anzi, consiglio a pieno titolo, vista la lunghezza – in qualche modo dovevo farmi perdonare l’assenza prolungata. Va detto che all'inizio avevo pensato di imbastire un post fatto come si deve su qualche perla del cinema coreano, ma la seduzione del clima estivo ha ben presto preso il sopravvento e mi sono ritrovata a scartabellare nei miei cassetti mentali per poter parlare di qualcosa adatto al periodo; sono convinta di aver trovato proprio le cose giuste di cui parlare e spero che queste mie essenziali considerazioni possano aver stuzzicato la curiosità di qualcuno. Adesso torno a riascoltarmi tutto Kagerou Project però.
2 notes
·
View notes
Text
Giudice, vittima e carnefice: Broken Minds
Dice il saggio: i guilty pleasures sono una trappola poiché non c’è motivo di provare imbarazzo per ciò che piace. Dunque non sono particolarmente a disagio nel mettere nero su bianco che due delle mie serie di videogiochi preferite in assoluto sono Danganronpa e Zero Escape. Certo, probabilmente lo sono anche perché riescono a grattare un prurito che quasi nessun altro videogioco mi ha mai sopito, ma sono convinta che al di là dei misteri macchinosi e al limite del sensato, per non parlare dei personaggi stereotipati quando non direttamente cretini, si celi un delizioso piacere nel comporre i pezzi di un puzzle incredibilmente complicato o nel vederlo semplicemente sistemarsi con l’avanzare della trama – oltre alla mia goduria personale nel fare esperienza di quei twist finali anche un po’ nonsense che ho coltivato da quando a otto anni mi sono data la missione di leggere tutti i Piccoli Brividi. Che è poi anche il motivo per cui dalle medie in poi mi sono affrettata a divorare l’intera bibliografia di Hercule Poirot, che pur essendo assai meglio costruita presenta spesso e volentieri lo stesso problema di artificiosità che è facile da segnalare nelle avventure sopracitate (niente colpi di scena stupidi, grazie a dio).
Dicevo poc’anzi però che difficilmente i videogiochi riescono a regalarmi questa specifica soddisfazione – le due saghe citate, assieme ad Ace Attorney che sta prendendo polvere nella mia lista di Steam ormai da un decennio, sono diventate così popolari anche per la peculiarità del loro gameplay nel panorama odierno, che fonde puzzle, visual novel e a volte anche inusuali minigiochi. Sono quindi sempre contenta di poter testare e segnalare altri giochi che scavano a piene mani nel mystery strambo per regalarci la gioia di un pazzo pazzissimo giallo interattivo di serie B, siano essi giochi su piccioni avvocati ambientati nella Francia del 1800 (consigliato) o visual novel ambientate nel Giappone degli anni Novanta: è proprio di quest’ultimo videogioco, intitolato Broken Minds e pubblicato da LockedOn nel 2018, che voglio scrivere oggi.
Noa Karada vive da sola, non ha nessun amico e pochi conoscenti, ma i suoi genitori sono un’ingombrante presenza nella sua vita, specialmente quando si autoinvitano a casa sua per cenare a sbafo, giudicare le sue scelte lavorative e chiederle denaro in prestito; è perciò con un certo sollievo che Noa è costretta a lanciarsi dalla finestra per scappare da un incendio che sembra scoppiare durante la cena, preceduto da un’inquietante presenza mascherata da coniglio che aveva bussato sul vetro appena prima che scoppiasse l’allarme. Le indagini però devono partire in ogni caso, dunque Noa decide di affidarsi alla Yamagata Private Detective Agency, nonostante i loro modi sgradevoli ed eccentrici e la loro professionalità assai dubbia… La situazione però non tarda a precipitare quando numerosi cadaveri si aggiungono al mistero, mentre la nostra protagonista deve fare i conti con l’ingombrante presenza dei detective che sembrano più interessati a battibeccare e a compromettere la scena del crimine anziché a risolvere il caso a loro assegnato.
Questo setup un filo peculiare per un’indagine – se non altro perché i detective sono fin da subito presentati come individui non solo strambi ma anche piuttosto svogliati e incompetenti – viene supportato da un sistema di gioco che alterna dialoghi con sprite a schermo in cui occasionalmente potremo scegliere che risposta dare, sequenze di minigiochi che ci permetteranno di unire i puntini sulle dinamiche e le motivazioni del (dei?) misterioso criminale, e momenti in cui potremo selezionare lo stato emotivo di Noa. Quest’ultima fase di gioco è cruciale, poiché in base al mood selezionato con le prime scelte ci imbarcheremo in route drasticamente differenti, in cui molte conversazioni e soprattutto diverse opzioni saranno sbloccate o al contrario rese impraticabili a causa del drastico cambiamento di Noa, aprendo un totale di ben sei route diverse, ciascuna con più finali; è vero che tale varietà è in alcuni casi poco significativa, modificando solo il tono di certi dialoghi, ma rimangono comunque tutte abbastanza interessanti da essere portate a termine, complice il magico pulsante skip seen text, specialmente quando il giocatore riesce a farsi un’idea più precisa di che cosa sta succedendo nella vita di Noa e delle motivazioni del misterioso criminale.

Quando si esplora l’ambiente si guarda praticamente uno slideshow, ma funziona abbastanza bene.
Questa varietà a livello di meccaniche, per quanto si possa sostanzialmente ricondurre a delle variazioni su tema sul formato visual novel, è ben incorniciata da uno stile grafico altrettanto vario: gli sprite dei personaggi sono cartooneschi, spigolosi e dalle proporzioni esagerate, a metà tra una serie di Cartoon Network e quelle illustrazioni piatte tipiche di certe graphic novel, ma si muovono in un ambiente finto-3D molto realistico e pensato per colpire per il suo contrasto nel momento in cui il giocatore si trova a navigarlo per cercare indizi o per scegliere il personaggio con cui parlare. Si tratta oltretutto di un gioco con un livello di attenzione al dettaglio e di rifinitura davvero sorprendente, considerando il suo stato di super-indie (ha nove recensioni su Steam, al momento!): oltre alle sequenze in cui Noa esplora l’ambiente attorno sé ci sono un paio di animatic piuttosto complesse, menù personalizzati per tutti i minigiochi, musiche originali composte per il gioco e sprite creati appositamente per la risoluzione finale del caso; anche le opzioni di accessibilità e le quality of life features sono tante, ben pensate e rendono l’esperienza di gioco piuttosto rilassante. Senza conoscere la storia del gioco sarebbe difficile sospettare che tutto questo sia il lavoro di un singolo, ma LockedOn specifica che l’unica persona coinvolta in maniera significativa nel progetto è proprio ləi. Ciò dota oltretutto Broken Minds di un’estetica generale molto riconoscibile e soprattutto molto schizofrenica, che ben si adatta al mondo e ai personaggi pensati dallo sviluppatore, che restituiscono un quadro di generica nevrastenia e di interazioni fortemente sopra le righe.
Ciascun personaggio con cui avremo la possibilità di interagire, infatti, sarà o marcatamente stereotipato fino a rasentare la parodia – come i genitori di Noa, talmente sgradevoli da risultare comici – o affetto da ogni sorta di tic, paturnie o instabilità: il capo dell’agenzia YPDA, Takuma Karashi, è un detective che maschera la sua inefficienza con un comportamento tipico dei detective dei gialli, arroganti e capaci di collegare gli indizi più sottili per arrivare ad una conclusione inaspettata, che in Broken Minds però porta solo a connessioni bislacche e insensate; la patologa Yuzuki Hiiro è insicura e morbosa, nonché straordinariamente incompetente, mentre Ume Hakase, l’esperta di tecnologia, si ritiene anche fine psicologa e cerca di scavare nelle improbabili motivazioni dei criminali senza alcuna pretesa di appellarsi ai fatti. Nonostante la profonda introversione e insicurezza, Noa sembra di primo acchito l’unica persona con una parvenza di normalità, fatto che favorisce assai bene l’immedesimazione del giocatore in ogni scena in cui la ragazza si trova costretta ad interagire con i personaggi che la aiuteranno (o la intralceranno) nelle indagini; certo, più il giocatore scava nei possibili scenari di gioco più la facciata di normalità di Noa inizia ad incrinarsi, fino ad arrivare ai veri finali della VN che saranno in grado di fare chiarezza sugli eventi che accadono nel corso della vicenda.

I detective come raffigurati in un’illustrazione. La mia preferita è la patetica Yuzuki, che però nasconde un segreto...
Eventi che effettivamente si ricompongono in un puzzle piuttosto intrigante: per quanto LockedOn stessə abbia ammesso che iniziare certe route può rovinare in parte la sorpresa che il giocatore dovrebbe provare completando i due True Ending (sconsiglio in particolare la route del Puppet da giocare tra le prime), in generale il mistero è in grado di lanciare al giocatore una quantità importante di domande interessanti, e anche solo la curiosità di vedere i quattro finali principali di ciascuna route spinge a cercare di completare il gioco. Per quanto trovi che la storia manchi di un colpo di scena super incisivo o di un twist che cambi radicalmente le carte in tavola al livello del mio amato Zero Escape, fatto che si soffre particolarmente sul finale, la qualità della narrazione e dei passaggi logici rimane piuttosto alta e permette alla VN di collocarsi tranquillamente in un ottimo posto nell’immaginaria classifica della qualità della scrittura delle sue colleghe di genere (il fatto che questa classifica sia estremamente povera in termini di qualità assoluta è un dettaglio in questo caso secondario). La vera nota dolente di questa visual novel risiede invece nel modo in cui si arriva a ricomporre i pezzi del puzzle.
Già, perché sebbene ritenga che le idee alla base dei minigiochi che costituiranno il modo principale per risolvere i misteri che circondano Noa siano originali e interessanti, la loro realizzazione lascia parecchio a desiderare. I cosiddetti Logic Train sono composti da una ruota delle fallacie, in cui sarà necessario associare ad ogni frase la fallacia logica che la contraddistingue per costruire un’argomentazione, un puppet theatre per ricostruire la scena del delitto e un minigioco in cui si dovranno selezionare le aree cerebrali… rilevanti… per l’affermazione fatta da qualcuno. Sì, l’ultimo è davvero tremendo, soprattutto perché siccome le aree del cervello si palleggiano compiti molto simili ci si troverà a cliccare tutte le aree simili per capire quale coppia è quella giusta, ma anche la ruota è composta da moltissime fallacie che si sovrappongono almeno parzialmente, e il fatto che sia possibile girare la ruota per ottenere un indizio o una penalità in maniera del tutto casuale non fa che contribuire alla frustrazione.

Lo schermo da cui selezionare le main mood. Non ho screen dei minigiochi perché li ho odiati troppo, ma concederò che sono belli da vedere.
Il teatro dei burattini è invece abbastanza funzionale, anche perché è stato significativamente migliorato dalle build precedenti, almeno a giudicare dai commenti su Steam e itch.io. Si tratterebbe di un’esperienza molto frustrante, se lə sviluppatorə non avesse inserito sia l’opzione di giocare tutti i minigiochi in modalità facile sia quella di saltarli a piè pari, scegliendo invece tra diverse opzioni quella più logica per proseguire con la ricostruzione del caso o con l’obiezione di Noa – presumo che LockedOn si sia resə conto di quanto i minigame stessero impattando negativamente l’esperienza di gioco e in più di una nota alle patch ha reiterato che i Logic Train sono molto difficili (verissimo, anche se per le ragioni sbagliate). L’unico lato positivo di questi segmenti è che i loro tutorial sono accompagnati da uno sprite chibi della stessa Noa davvero adorabile.
Non posso lamentare però molto altro a questo gioco, se non il fatto che all’occasione l’elemento mystery e quello parodistico cozzano tra loro rendendo difficile al giocatore da una parte sentirsi abbastanza coinvolto nel mistero da provare a svelarlo route dopo route, o dall’altra di ridere liberamente delle interazioni disturbanti che si vengono a creare tra questo cast disturbato; per la maggior parte del gioco però ho trovato che Broken Minds riuscisse piuttosto bene ad amalgamare questi generi per tessere una storia in uguale parte appassionante e canzonatoria: il fatto che la personalità frammentata ma seria di Noa sia a messa a confronto con l’assurdità parodistica degli altri personaggi e che ne esca spesso e volentieri perdente (o additata come quella “strana”) indubbiamente è la chiave di volta su cui si regge questo precario equilibrio di genere che tanto amo in giochi come questo – e pazienza se ogni tanto una crepa si allarga in questa costruzione pericolante.

Sì, Ume, immaginavo. Questa sarà l’interazione più gentile che avrete con lei.
Beyond Broken Minds: due racconti, Prison of Lies e molto altro
Nonostante Broken Minds non abbia raggiunto purtroppo alcuna notorietà, LockedOn è abbastanza affezionatə alla sua ambientazione da aver prodotto, oltre che numerosi fix per il gioco e diversi update nel corso del tempo, anche altri pezzettini del puzzle che rimangono inesplorati nel gioco principale; sono nati così due racconti inclusi nel gioco base, Broken Egg e Broken Spiral, accompagnati dalle adorabili illustrazioni che ho inserito anche nel consiglio, che svelano qualche retroscena del gioco principale e che seguono i detective della YPDA oltre il caso di Broken Minds. La prima di queste infatti narra di una misteriosa sparizione che ha come tema ricorrente le uova, tutta raccontata dal punto di vista della persona scomparsa, mentre la seconda si incentra sul lavoro del misterioso quarto membro della YPDA in incognito, infiltrata nella polizia giapponese. Si tratta di storie scritte proprio come graphic novel, dunque in prima persona e dallo stile parco di descrizioni e ricco di dialoghi colloquiali, che permettono di aggiungere a questo mosaico di personaggi bizzarri almeno un paio di divertenti new entry e di fare luce su alcune delle vicende che erano rimaste in ombra durante il gioco principale, nonostante sia stato annunciato a questo proposito anche un seguito (Broken Spirits) che non ha ancora visto la luce.

Reiwa compare nel gioco principale come assistente dello psicologo di Noa. Ha una cantilena? Tipo troppo irritante?
LockedOn non è però una one-hit wonder, nonostante il secondo capitolo di Broken tardi ad arrivare: la sua pagina itch conta diversi giochi all’attivo, tra cui Prison of Lies, scritto nel corso di una VN jam e quindi abbastanza corto, ma che costruisce un mistero molto interessante pescando a piene mani proprio dagli Zero Escape, con un cast più serio e meno nevrotico di quello di BM e tanta tanta tensione. Si tratta dell’unico altro gioco dellə sviluppatorə che ho provato, ma anche i due capitoli della saga di Methods sembrano essere dei gialli interessanti e ben rifiniti, giustificando anche il prezzo un po’ più importante – se questo Broken Minds riesce ad appassionarvi, consiglio di tentare l’acquisto.
Sono sempre felice di scoprire sviluppatori che hanno una chiara idea di che cosa vogliono scrivere e che hanno anche le capacità per farlo bene; che poi questi sviluppatori seguano il solco di alcune delle mie serie videoludiche preferite è solo la ciliegina sulla torta; spero dunque di avervi incuriosito abbastanza da dare una chance a questa VN, o perlomeno a giocare Prison of Lies per convincervi che LockedOn merita il vostro danaro. Che poi sono tipo sei euro, eh, intendiamoci.
3 notes
·
View notes
Text
Ritagli di menare: Dance & Bleed
Adoro i giochi di ruolo pensati per essere giocati in coppia. Hanno una vendibilità che rasenta lo zero, sono impensabili da portare in un’associazione e possono essere alquanto imbarazzanti da giocare con una persona che non si conosce abbastanza bene, ma quando si ha la possibilità di provarli con un partner, con un amico intimo o con qualcuno che è capace di prendere il gioco di ruolo abbastanza sul serio da non spezzare l’atmosfera intima che si crea è possibile portare a termine sessioni memorabili. Moltissimi giochi di questo genere sono molto semplici dal punto di vista delle meccaniche di gioco: io sono un morto appena resuscitato, tu l’assassino che mi ha ucciso (Dead Friend: A Game of Necromancy); tu sei il mio più grande amico, io sono il tuo attuale rivale che ha giurato di ucciderti (Clash!); io sono la Macchina, tu sei il Mortale (Haecceity), e le nostre libere interazioni decideranno buona parte della storia che vogliamo giocare.
In questo senso, il consiglio di oggi è un’interessante eccezione, perché se Dance & Bleed si definisce al 50% un Narrative Engine, pensato per mettere personaggi in situazioni interessanti e vedere come va a finire, per il restante 50% si classifica come Fighting Game – cioè un ttrpg dotato di un combat system di tutto rispetto, con complessità e varietà significative, specialmente data la natura indie del progetto. E una volta testato a dovere non ho potuto non parlarne sul blog, visto quanto ci siamo divertiti io e miei compagni di gioco!
Ma partiamo dalle cose importanti: Dance & Bleed sarà anche un gioco sul picchiarsi molto forte con una serie di armamenti bizzarri, ma è soprattutto un gioco in cui vestire il tuo cartonato per massimizzarne letalità o potenziale kawaii! Possibilmente entrambi, anche se l’impresa non mi è ancora riuscita. Infatti il gioco, oltre alle istruzioni per mettere in piedi una partita, che durerà sulla mezz’oretta la prima volta e un po’ meno le successive, include anche due cartonati che rappresentano le due Animulae che si scontreranno sul campo di battaglia, assieme ad una copia di ciascuna arma, protezione e pattino che si può utilizzare durante l’azzuffata. La fase di preparazione dunque consisterà nello scegliere due armi, un’armatura e un paio di pattini per ciascun personaggio e fissarli al cartonato con delle pratiche graffette già incluse per ottenere il proprio omino da battaglia; dopo avergli fornito un nome, dei pronomi e una personalità più o meno approssimativa sarete pronti a farlo scontrare con il suo avversario.
Scontro che si basa sul togliere tutti gli Style Points (SP, nome in nessun modo equivocabile dagli appassionati di RPG) all’avversario, sia colpendolo o infilzandolo con armi a contatto, sia sparandogli a distanza di sicurezza con armi che generalmente costano Energia (altro nome fraintendibile), che rappresenta sia il carburante per attaccare attaccare con certe armi, sia il pool di dadi che ciascuna Animula avrà a disposizione ad ogni turno. Infatti attaccare, muoversi e attivare l’abilità speciale del proprio oggetto sono tutte azioni che costeranno un tipo specifico di dado: nell’ordine, sei, uno e tre; ciascuno di essi avrà anche un costo diverso a seconda della sua natura (es. da uno a quattro dadi da sei per le armi) e avrà effetti diversi per quanto riguarda perdita di SP, Energia o altro (c’è un oggetto che blocca un avversario, una altro che impedisce di perdere SP quando si viene colpiti e così via), incoraggiando ciascun giocatore a testare la strategia elaborata in fase di selezione dell’equipaggiamento e a cambiarla al volo nel momento in cui smette di funzionare. Questa varietà, assieme al fatto che moltissime armi colpiscono solo fino ad una certa distanza e che non tutti i pattini sono egualmente veloci, conferisce una profondità al gioco che gli permette di rimanere longevo per moltissime partite senza neppure tirare in ballo l’aspetto puramente narrativo, che merita indubbiamente qualche considerazione in più.

L'occorrente per giocare a Dance & Bleed, armamenti esclusi, tutto presente nella confezione con cui mi è arrivato.
Ho definito i due sfidanti Animulae: parola che nel gioco indica le anime appena arrivate in Purgatorio, un luogo di attesa da cui è possibile scappare solo ottenendo il favore e le preghiere di un numero spropositato di residenti dell’aldilà; per riuscire in questa impresa l’unico modo è quello di farsi aiutare da un patrono angelico, che è in grado di fornire alle anime appena nate armi e artefatti necessari a lottare tra loro per guadagnare la fama necessaria affinché le preghiere dei loro fan siano tanto numerose da permettere loro di reincarnarsi. È possibile dunque seguire il cammino della propria Animula dai primi giorni nelle Isole di Arruolamento prima del Lete fino alle battaglie decisive nello Stige, viste da milioni di spettatori in tutto il Purgatorio; battaglie all’ultimo sangue, naturalmente: tutto, pur di evitare la Full Qualia Dissolution che attende le anime che non riescono ad accumulare abbastanza fan che preghino per loro.
Insomma, un’ambientazione a cui è facile ancorare un personaggio, delineata nelle sue linee guida principali e poi lasciata ai giocatori per tratteggiarla nelle sue minuzie, che inevitabilmente andranno ad intrecciarsi con il proprio omino, il motivo per cui si trova in Purgatorio e la ragione per cui imbraccia la pistola (o la falce, o lo yo-yo gigante o… beh, ci siamo capiti); le uniche altre informazioni che abbiamo su questo luogo ultraterreno ci vengono dalle descrizioni e dalle tagline dell’equipaggiamento: una frase ad effetto, alcune davvero molto carine – sapevate che silence is sexy/ so sexy/ as sexy as death? – e qualche riga che descrive le proprietà magiche dell’arma, o il ritrovamento di uno specifico oggetto, o ancora un log del precedente proprietario. Nulla che scalfisca il mistero che ammanta queste armi mistiche o quello della gerarchia angelica che le fornisce agli sfidanti dell’aldilà, ma abbastanza da fornire possibili agganci alla storia pregressa del proprio personaggio o anche solo a strappare un sorriso.

Due delle molteplici combinazioni di armi, armature e oggetti creabili con il manuale. Quella a destra ha anche stile da vendere.
Finora ho usato toni piuttosto entusiastici per parlare di questo ttrpg e giammai me li rimangerò; tuttavia, mi sembra corretto parlare dei limiti del sistema e di qualche problema che sul lungo periodo impatta le partite e il sistema – abbastanza fisiologici, per un gioco di ruolo indie o non testato a sufficienza o non pensato per essere del tutto bilanciato, ma nondimeno presenti.
In primo luogo, in certi punti le spiegazioni avrebbero beneficiato di meno vaghezza; in diversi momenti io e gli altri giocatori siamo rimasti interdetti di fronte ad alcune istruzioni, e uno sguardo poco attento farebbe fatica a cogliere chi e cosa perde o guadagna Energia e/o SP; logicamente è possibile sbrogliare ogni dubbio, tranne forse quello sul fatto che esista un cap per entrambe le statistiche, ma ad un primo sguardo il manuale può risultare un po’ opaco. Fatto ahimè un po’ più grave, ci sono oggetti semplicemente troppo potenti e armi che sono copie deboli di altre senza nessun beneficio aggiuntivo: che una protezione curi di 1 SP con un dado da tre (fino a cinque volte a turno!) significa che il giocatore che la usa ha un vantaggio enorme ad un costo ridottissimo, mentre un’arma che toglie 1 SP con un dado da sei sarà sempre più forte di una che ne toglie 2 con due dadi, proprio perché quasi ciascuna di esse si può usare quante volte a turno si vuole purché si siano tirati i dadi giusti.
Questo significa che tendenzialmente le build full contact sono avvantaggiate rispetto a quelle a distanza, specialmente quando fanno uso delle gambe da satiro che permettono un movimento rapidissimo ad un costo irrisorio (1 metro per un dado da uno); al primo test un giocatore ha creato un personaggio quasi imbattibile proprio perché usava questi specifici oggetti – per quanto sia indice di profondità poter creare personaggi più forti di altri, qualche armamento è evidentemente troppo utile rispetto ad altri. Anche le build che fanno largo uso di energia sono a lungo termine probabilmente meno performanti, considerando il costo in termini di dadi, ma ci sono diversi oggetti che lo bilanciano permettendo comunque una vasta scelta nella fase di selezione e dunque non mi sento di classificarlo come un problema.

La build semi-invulnerabile incriminata. Difficilmente colpirà gli spettatori del Purgatorio per lo stile, ma credetemi, non ne ha bisogno.
Mi preme sottolineare però che questo bilanciamento un po’ bislacco non impatterà la maggior parte delle sessioni dei giocatori a cui interessa soprattutto l’aspetto narrativo e che sono disposti a mettersi d’accordo sulle armi e gli oggetti da utilizzare per concedere ad entrambi una possibilità di vittoria; Dance & Bleed è un gioco a cui interessa soprattutto mettere in scena un conflitto in cui ogni attacco e ogni mossa sul campo di battaglia sono minuziosamente razionalizzati e descritti dagli sfidanti – la specifica sul manuale è addirittura che nessuna azione avrà effetto a meno che non sarà descritta dal giocatore. Anche il fatto che l’esito dell’incontro in caso di pareggio sia interamente deciso dai due giocatori, o che il vincitore possa scegliere se risparmiare o meno il proprio avversario, è una libertà affidata al giocatore in grado di cogliere il senso in cui si è sviluppata la narrativa creata nel corso della battaglia e prova evidente del fatto che il Narrative Engine del gioco è in realtà un po’ più del cinquanta per cento della sua anima.
L’ultimo tasto dolente che mi preme sottolineare è che questo gioco è assai difficile da reperire. L’editore Ultravioletto è introvabile sul web (tant’è che la mia copia è stata un regalo comprato ad una fiera di fumettisti indipendenti) e temo che le poche occasioni per acquistare questo titolo siano gli stand dedicati a qualche fiera organizzata – dunque se qualcuno avesse curiosità di giocarlo scriva pure alla posta del cuore del blog e vedrò di mandarvi il materiale necessario. Cosa che spero vivamente: Dance & Bleed è un sistema di gioco sorprendentemente complesso e intrigante, dalle ottime potenzialità narrative e con un’estetica e un’ambientazione abbastanza peculiari da permettere di creare personaggi sfaccettati… che durino almeno il tempo di una battaglia angelica.
3 notes
·
View notes
Text
Un consiglietto corto per dei fumettini a tempo: ShortBox Comics Fair 2023
Ciao cari. Un blog meno discontinuo e raffazzonato dedicherebbe diversi paragrafi a scusarsi per l’assenza prolungata, spiegherebbe nel dettaglio ciascuno dei motivi che hanno portato ad un completo stop di pubblicazione e perché no, darebbe succosi aggiornamenti sulla vita privata del suo curatore, ma come è chiaro ed evidente questo è proprio un blog discontinuo e raffazzonato: un post ogni tanto, quando a) mi capita sotto il naso qualcosa di interessante (frequenza: alta) e b) la vita mi permette di trovare le energie per scrivere della suddetta cosa interessante (frequenza: beh, lo vedete da voi). Dunque senza perdere ulteriori energie a spiegare i motivi dei miei dilatati tempi di postaggio, passiamo all’argomento del microconsiglio di oggi: la ShortBox Comic Fair, edizione 2023.
Come specificato nelle succinte ma esaustive FAQ del sito, l’evento funziona come una classica fiera del fumetto, semplicemente in formato virtuale: gli artisti selezionati hanno diversi mesi per sceneggiare, disegnare ed eventualmente colorare un fumetto completo, che sarà poi ospitato nella bacheca virtuale del sito e venduto esclusivamente in PDF per cifre piuttosto modiche (si va dalle 2 £ alle 10 £ per i fumetti più lunghi); l’artista può eventualmente decidere di rendere disponibile il suo fumetto anche al di fuori delle tempistiche della fiera, che dura fino all’ultimo giorno di Ottobre, ma le regole stabilite dal sito prevedono che i diritti di pubblicazione della ShortBox cessino con la fine del mese – si tratta dunque in buona parte di fumetti a tempo, disponibili per poche settimane ad un costo modico. Ho scelto dunque di comprarne tre per farmi un’idea del genere di materiale ospitato, degli artisti coinvolti e certo, anche perché sospettavo che ci sarebbe potuto scappare un consiglietto (guarda un po’, sempre a pensare al lavoro) – e non ho avuto torto, perlomeno nel caso di due dei tre fumetti acquistati.
Iron (Alissa Sallah)

Sfortunatamente la fiera non offre tavole dei fumetti da usare per recensioni e segnalazioni, quindi mi limiterò a postare altri lavori degli artisti citati. Notare che Sallah ha uno stile molto variegato.
Or, leader di Ferrum Magalo e attualmente impegnato in una guerra che sembra destinato a perdere, ha una speranza: convincere uno dei principi dell’Argntum, nazione notoriamente (anzi, “violentemente”, come ci viene segnalato nel testo) neutrale, ad entrare in battaglia e ad uscirne vincitore per compiere la profezia che viene annunciata ormai da anni dai profeti – che godono di ben poca fiducia presso la popolazione, considerando quanto poco azzeccano previsioni semplici come quelle del tempo. Tuttavia la situazione è talmente disperata che Or decide di partire alla volta della montagna sulla vetta della quale dovrebbe risiedere il principe Vrgl; vetta piena di pericoli nonché pattugliata da mistici uomini-angelo dalle straordinarie abilità, che testeranno il coraggio e la risolutezza del nostro protagonista, anche perché ad attenderlo non ci sarà certo una persona particolarmente collaborativa...
Sarò onesta: la storia è davvero tutta qui. Complice il numero di pagine davvero esiguo (27, includendo titolo e bio dell’autrice) la vicenda raccontata è estremamente essenziale, priva di ribaltamenti, sviluppi nelle relazioni tra i due personaggi rilevanti che non vadano oltre l’ovvio e in generale poco incisiva nei momenti cardine che dovrebbero avere un certo impatto emotivo – come quello del rituale che lega Or a Vrgl. Quello che davvero spicca di questo fumetto è lo stile di disegno: fin dalla copertina è davvero semplice riconoscere in quei corpi slanciati, nei visi delicati e nelle proporzioni una chiara ispirazione agli shōnen-ai/yaoi di qualche decennio fa, o, per andare a pescare manga un filo più recenti, alla produzione delle CLAMP; l’intero fumetto combina questa cifra stilistica con una certa originalità nel design dell���armatura del protagonista e nelle armi utilizzate, nonché nella fauna incontrata nel corso del viaggio – con design che non sfigurerebbero troppo di fronte al bestiario di uno Shin Megami Tensei qualsiasi.
Tuttavia, qualsiasi carica sensuale ed erotica promessa dalla copertina piuttosto suggestiva nonché dal content warning viene del tutto abbandonata con il passare delle pagine, privando quindi il fumetto del nocciolo essenziale alla base dello stile a cui si ispira senza però rimpiazzarlo con delle ritualità o dei gesti altrettanto forti; la storia fatica a compensare il suo formato estremamente ridotto con immagini dalla potenza tale da coinvolgerci in una vicenda così breve, mancando oltretutto di arguzie particolari nello storytelling e anzi spesso e volentieri ricorrendo a dialoghi piatti e occasionalmente in un inglese un po’ stentato. Insomma, se vi interessa per studiare uno stile così particolare non è una brutta idea acquistarlo, ma il mio consiglio è che a fronte di un budget limitato conviene tuffarsi su altro.
Ocean (Lucie Bryon)
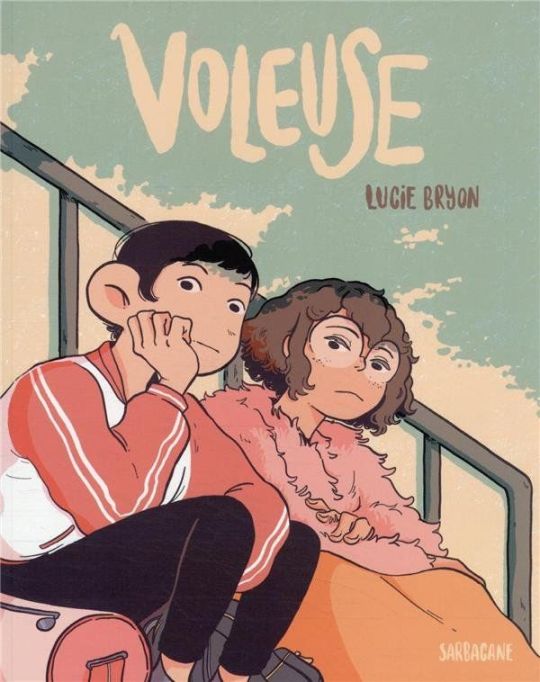
I character design con gli orecchioni sono una mia debolezza.
Toots & Boots sono due agenti segreti della continuità spazio-temporale (smaccatamente inseribili in quel filone di film che ha come capostipite Men in Black) a cui è stata affidata l’ennesima missione di routine: tornare negli anni duemila, trovare il bersaglio colpevole degli smottamenti sulla linea temporale e riportarlo alla base; l’unica peculiarità della missione sembra essere nella natura del suddetto bersaglio – un adorabile gattino – almeno fino a quando il trasmettitore dal design appropriatamente didascalico smette di funzionare, bloccandoli nel ventunesimo secolo senza un soldo e senza la maggior parte delle competenze che permetterebbero loro di trovarsi un lavoro, una casa in affitto o anche solo un pasto caldo… Inizia così la lunga vacanza di Toots & Boots, che vedremo ritagliarsi il loro spazio nella ridente cittadina marittima di Châtelaillon grazie ad un inaspettato colpo di fortuna che permette loro di diventare parrucchieri improvvisati nonostante la loro inesistente competenza in materia di tagli di capelli (come evincerete facilmente dalle loro assurde pettinature).
Per quanto la vicenda sia facilmente prevedibile nei suoi sviluppi, i siparietti che vedono i nostri protagonisti alle prese con la vita quotidiana della cittadina sono divertenti e strappano più di un sorriso; ciascun personaggio ha una fisionomia riconoscibile ed espressiva che permette di affezionarsi facilmente al ristretto cast e di seguirne le vicende con trasporto. Oltretutto, il tratto semplice e netto delle prime vignette, assieme alla palette essenziale nera, bianca e blu, fa spazio man mano che passano i giorni – scanditi dal diario di Toots – a delle linee più morbide e soffici, e a colori pastello che accompagnano il rilassarsi dei due protagonisti, che piano piano iniziano a dimenticare la loro missione originaria per scoprire che una vita tranquilla fatta di appuntamenti, gelati e giri in motocicletta potrebbe essere migliore di quella che hanno vissuto fino a quel momento. È anche questo accorgimento che ci avvicina emotivamente ai due agenti e ci tiene almeno un po’ con il fiato sospeso fino alla fine, curiosi di sapere se entrambi decideranno di tornare alla loro vita precedente o se invece almeno uno dei due farà una scelta differente… Sempre che la loro organizzazione lo permetta.
Insomma, un fumetto assai simpatico che utilizza bene lo spazio a disposizione per raccontare una storia prevedibile ma ben narrata nei suoi elementi essenziali, nonché disegnata in maniera adorabile. Approvato!
When Death Comes, I Will Follow (Val Wise)

Full disclosure: ucciderei un numero significativo di persone per imparare a disegnare come Wise.
In ordine di gradimento crescente, ecco il mio fumetto preferito tra i tre che ho avuto l’opportunità di leggere. Lady Elaine, nobildonna e cavaliere, siede alla tavola della sorella Charlotte, unica suora che rimane ad abitare un monastero ormai deserto; sono entrambe sopravvissute alla morte per mano di quelle che Charlotte chiama le Donne Piangenti (Lamenting Ladies) – misteriose entità attratte dalla morte che uccidono chiunque si trovi vicino ad una persona che esala l’ultimo respiro – per tenacia o per puro caso, ma si trovano in quel momento ad un bivio: rimanere assieme rischiando che la morte accidentale dell’una condanni anche l’altra, o Lady Elaine dovrebbe ripartire immediatamente, continuando ad errare in totale solitudine? Come se non bastasse, Charlotte non ha detto tutta la verità circa la strage avvenuta nel monastero…
La prima cosa che salta all’occhio di When Death Comes è indubbiamente la struttura delle tavole: lo sfondo delle vignette, inchiostrate in bianco e nero, è infatti decorato in maniera coerente rispetto ai dialoghi o agli avvenimenti, talvolta rappresentando un nesso logico fondamentale – ad esempio, quando Charlotte offre della carne ad Elaine che ricorda il cavallo morto, accasciato sullo sfondo, di cui si è probabilmente cibata; assieme alla gestualità e alla forte componente non-verbale presente in tutte le tavole, che anziché venire soffocate da enormi balloon pieni di spiegazioni sono caratterizzate da dialoghi brevi, secchi ma perfettamente comprensibili, questi espedienti aiutano ad immergere il lettore nella cupa atmosfera di queste sessantaquattro pagine. La scelta assai felice di non mostrare mai le cosiddette Donne Piangenti fino alla fine, e anzi di alludervi solo in termini vaghi e criptici, risulta particolarmente azzeccata per aumentare il senso di tensione che trasuda da ogni interazione tra i personaggi, tragicamente consci della fragilità del loro corpo (e soprattutto di quello altrui) che potrebbe in qualsiasi momento portare a conseguenze disastrose.
Altro punto di forza che mi preme sottolineare sono i dialoghi: se la prosa di Iron era a tratti un po’ rigida e sgradevole, ciascuna delle interazioni tra Elaine, Charlotte e un terzo personaggio di cui non dirò nulla di più sono curate, realistiche e decisamente abili nel restituire le dinamiche che si possono creare tra persone che vivono una situazione di costante attesa per qualcosa che potrebbe come non potrebbe avvenire. Tensione che esplode nel finale, in maniera del tutto coerente con gli avvenimenti precedenti e lasciando un senso di smarrimento non solo nei personaggi sopravvissuti, ma anche nello stesso lettore. Insomma, fatico a trovare qualche pecca in questa storia che raggiunge esattamente l’obbiettivo che si prefigge in così poche pagine; spero solo che un’ambientazione così promettente possa essere riutilizzata dall’autore anche per un fumetto più lungo, visto che spulciando il resto della sua produzione mi pare di capire che questi temi siano particolarmente nelle sue corde.
… And more!
Le mie risorse mi hanno permesso di acquistare solo tre dei fumetti esposti, ma spulciando il catalogo è molto facile trovare altre opere accattivanti: c’è Pearl Hunter, della bravissima Hana Chatani di cui ho avuto l’occasione di leggere Love Condemns Me (se lo trovate in giro, lettura super consigliata a chiunque interessi La sirenetta in tutte le sue varianti), c’è Pinball Wizard, che accompagna una descrizione da shōnen manga con uno stile di disegno incasinato ma buffissimo, e c’è History Grows Like a Tumor, dalla palette essenziale e dalla premessa assai intrigante… E molti altri titoli che vuoi per il prezzo irrisorio, vuoi per lo stile peculiare o per l’idea alla base sembrano meritare una lettura. Di certo dal cestone della ShortBox Comic Fair è possibile pescare anche roba noiosa o deludente (come nel caso di Iron), ma se volete fare una prova e destinare una parte del vostro budget mensile all’acquisto di qualche fumetto di artisti contemporanei non posso che consigliare questa fiera.
4 notes
·
View notes
Text
Qualcuno ha detto Ghost: Signor Mardi-Gras Delle Ceneri
Alzi la mano chi non apprezza le storie sull’aldilà. Ecco, sì, tu lì in fondo che ti aggiri per questo blogghino semideserto, clicca pure sulla x rossa in alto a destra, perché oggi si parla di quanto è bella tutta quella narrativa che parla di che cosa succede dopo che la nostra anima esala l’ultimo respiro e lascia le nostre spoglie mortali. SIGLA!
OK, scemenze a parte, ho sempre trovato il fantastico che si propone di immaginare la vita dopo la morte particolarmente intrigante proprio perché si dà un compito difficilissimo: sciogliere in maniera soddisfacente il mistero cruciale con cui passiamo tutta la vita a venire a patti, cercando sì di non dipingere un’immagine dell’aldilà trita e banale che non sia capace di rispondere alle esigenze di complessità che la domanda “che cosa succede dopo?” necessariamente pone, ma allo stesso tempo di non raccontare in maniera eccessivamente criptica e incomprensibile, con un linguaggio vago e privo di specificità che permettano la narrazione di una storia soddisfacente, quel post-vita che tanto ci sta a cuore e di cui vogliamo leggere un’interpretazione coerente e tangibile. E quando qualche autore riesce a trovare il perfetto bilanciamento tra queste due esigenze, la storia che racconta è capace di toccare un sacco di temi che ci stanno molto a cuore: il fascino dello svelamento dell’ultimo mistero che non abbiamo alcuna possibilità di penetrare mentre siamo in vita, l’angoscia terribile nello scoprire che è davvero “tutto qui” e che il resto dell’eternità sarà passato a fare quello che stai leggendo e nient’altro – specialmente quando quello che ci accoglie non è l’equivalente del paradiso dantesco ma qualcosa di molto più sinistro, bizzarro e terrificante. Che è poi il caso del consiglio di oggi, il fumetto sceneggiato e disegnato da Éric Liberge dal titolo Signor Mardi-Gras Delleceneri, edito con mia sorpresa anche in Italia, che s’immagina un aldilà a tinte cristiane deliziosamente blasfemo che ha catturato la mia attenzione senza alcuna difficoltà.
Infatti il signor Mardi-Gras Delleceneri che dà il titolo all’opera altri non è che un cartografo recentemente deceduto proprio in quei giorni che compongono il patronimico che gli viene assegnato una volta arrivato nell’aldilà; il fu Victor Tourterelle viene dunque scortato da un misterioso postino via dal deserto angosciante in cui si è risvegliato fino alla città di Santa Cecilia, pur con qualche pezzo mancante: infatti tutto ciò che rimane ai defunti che approdano in questo luogo è il loro scheletro, epurato di organi, carne e tutto ciò che non sia tessuto osseo, ed è dunque un mondo in cui ogni singolo metatarso è prezioso, poiché perdere pezzi per strada può facilmente risultare nell’impossibilità di muoversi, parlare o di fare alcunché che non sia attendere in agonia per l’eternità. Victor non è in grado di rassegnarsi allo squallore della vita dopo la morte, in cui orde di scheletri ciondolano senza meta e si svuotano in gola (... o qualcosa del genere) ogni sorta di sostanze tossiche per imitare le bevande che erano in grado di ingerire in vita, ma proprio per questo viene immediatamente preso di mira dall’organizzazione clericale della Salamandra, che governa Santa Cecilia con il pugno di ferro e che non esita a spedire i dissidenti nelle segrete di San Luca per impedire qualsiasi cambiamento nelle regole dell’oltretomba.

La copertina italiana del primo volume. Notare che Liberge ha voluto complicarsi il lavoro con una bici, nella top ten delle cose difficili da disegnare assieme agli scheletri.
C’è però un’altra setta misteriosa che vorrebbe accaparrarsi Victor per le sue abilità di cartografo: la Cornice, ribelli e dissidenti che mirano a tracciare, contro il volere della Salamandra per cui la conoscenza è eresia, una mappa di Santa Cecilia e poi dell’intero regno dei morti… Victor potrà fidarsi almeno di loro, o anche i postulanti della Cornice hanno piani scomodi in serbo per lui? Nel corso dei due volumi che compongono l’opera seguiremo il suo viaggio disperato ai confini del tempo e dello spazio per conoscere la verità che si cela dietro questi lugubri inferi, accompagnato da una pletora di scheletri più o meno inquietanti, un’aeronave dal design assai vintage e soprattutto litri e litri di caffè. Ebbene sì, in questo fumetto il caffè è la bevanda dell’oltretomba per eccellenza, capace di indurre potenti visioni – o allucinazioni? – nei deceduti e di risvegliare loro ricordi delle loro incarnazioni passate; questo punto cruciale di worldbuilding dovrebbe farvi facilmente intuire il primo motivo per cui ho trovato Signor Mardi-Gras così interessante: Liberge riesce a costruire in soli due volumi un aldilà ricco di trovate affascinanti, di architettura folle e ammantato da un’estetica curatissima e se non originale, perlomeno molto riconoscibile e dettagliata. Come avrete già ampiamente avuto modo di notare dalle tavole che vi ho mostrato finora, sono piuttosto sicura che se anche l’autore non è un fan sfegatato dei Ghost, perlomeno ha assorbito un certo tipo di immaginario cattolico fatto di reliquie, ossa e mix audaci di pietra e metalli preziosi per creare edifici tanto elaborati quanto maestosi; è un vero peccato che ci siano poche splash page nel corso dei volumi, ma nonostante ciò la tentazione di fermarsi ad ammirare ogni pagina per diversi minuti accompagna costantemente la lettura e scaturisce chiaramente dall’abilità di Liberge non solo nel disegno dei fondamentali (anatomia check: superato), ma anche nel creare un’estetica coerente con sé stessa e con i temi che la serie tratta. Infatti, al di là delle splendide tavole che di certo costituiscono un motivo a sé stante per procurarsi la serie, il fascino dell’aldilà che l’autore narra si estende anche e soprattutto alle modalità con cui l’oltretomba viene narrato: fin da subito è evidente quanto l’influenza cristiana non sia un mero fatto estetico ma abbia radici profonde nel setting in cui Victor si trova catapultato. L’aldilà come luogo di espiazione, di attesa senza scopo come penitenza per i peccati commessi in vita si intreccia con la possibilità di una reincarnazione di stampo tutt’altro che cristiano, in cui le vite precedenti dei residenti degli inferi hanno accumulato peccati e infrazioni che devono essere espiati in un luogo privo di colori, odori, sapori e tutto ciò che rende la vita umana degna di essere vissuta.
Infatti, al di là del fascino razionalizzabile che permea questo aldilà dall’architettura intricata e dai motivi religiosi sovrapposti ma mai incoerenti, la forza viva e pulsante de Signor Mardi-Gras Delleceneri sta in quell’intimo e doloroso scavare nella vacuità della vita dopo la morte. Ogni tavola è soffocata da mucchi di scheletri, ingombranti casse toraciche, pile di femori e ulne accatastate le une sulle altre che si trascinano stancamente dalla piazza di Santa Caterina al mercato della città gonfio di guardie della Salamandra, fino alla totale solitudine del penitenziario di San Luca; l’ossessione ricorrente delle anime per il caffè, unica bevanda dei vivi penetrata nel mondo dei morti che causa violente crisi nonché una morbosa dipendenza poiché è l’unica ancora alle vite passate di quei defunti che sono stati privati persino persino della lingua per sentirne il vero sapore. Quanto sia schiacciante l’ingiustizia di questo mondo oltre la Terra e le motivazioni che possono aver portato alla creazione di un luogo così pieno di sofferenza sono le domande che premono sul lettore e che lo incoraggiano a seguire il viaggio di Victor, primo portavoce di queste istanze e che fin dal primo momento della sua permanenza a Santa Cecilia appare il solo a rifiutare la crudeltà senza scopo di un tale sistema. Liberge ha ben chiari quali sono i temi che desidera affrontare nel corso della storia, e non ha nessuna difficoltà a far emergere prepotentemente quelle caratteristiche degli inferi che ci suscitano più angoscia e terrore ma allo stesso tempo anche morbosa curiosità circa i misteri che li circondano.

Una pagina dell’originale francese. Purtroppo i caratteri scritti a mano sono molto più belli del font utilizzato per l’edizione italiana.
Quando però il focus si allontana da quello che è chiaramente il punto di forza del fumetto – l’esplorazione della cosmogonia celeste e delle leggi assolute che regolano questo oltretomba bizzarro e angoscioso – la qualità complessiva della narrazione perde colpi. Di tutta la carrellata di personaggi che viene messa in scena per aiutare o ostacolare Victor nei suoi viaggi (di solito entrambe le cose, talvolta anche in contemporanea) solo un paio vengono caratterizzati in maniera meno bidimensionale: il misterioso postino che sembra avere bene in mente il ruolo che Victor dovrebbe giocare nel destino di tutte le anime, e Petronilla, la psicopompa e contrabbandiere di caffè della Cornice che offre a Victor un posto nella sua nave in cambio di risposte sulla struttura dell’aldilà; anch’essi rimangono tuttavia saldamente ancorati ai loro archetipi fondamentali, senza presentare un’evoluzione significativa in linea con quella del protagonista. Victor Tourterelle stesso, che pure nel corso del suo viaggio attraverso i cerchi dell’aldilà scoprirà tutto del suo passato da vivo e dovrà fare i conti con verità molto spiacevoli circa la persona che era stato prima di scivolare su quella fatidica macchinina giocattolo nel suo bagno, fatica all’inizio a catturare l’empatia del lettore pur essendo gettato in un contesto per cui dovrebbe essere facile provarla nei suoi confronti a causa della sua petulanza e generica sgradevolezza, fastidio che fatica ad essere compensato dalle rivelazioni successive sul suo passato e da un percorso di crescita che verso l’ultima parte della storia viene scavalcato dal pressante sfaldamento politico e sociale dell’oltretomba. Non si tratta di un fumetto che brilla per caratterizzazione dei personaggi o per la loro evoluzione, complice anche lo spazio ridotto con cui Liberge deve raccontare una storia densissima di concetti, nomi e avvenimenti.
La densità della storia si riflette anche nelle pagine estremamente affollate di scritte, balloon e frasi. Al di là della mia personale crociata contro i balloon quadrati che sospetto sia semplicemente una delle mie tante idiosincrasie senza importanza, le tavole di Liberge sono piene di frasi lunghissime in cui i personaggi riversano fiumi di spiegazioni statiche che rendono la lettura talvolta inutilmente faticosa; è difficile far immergere il lettore in mondo così alieno dandogli anche tutti gli strumenti per comprenderne gli elementi fondamentali, ma un medium così visivo avrebbe senz’altro beneficiato di più show e meno tell soprattutto nelle sue fasi conclusive, permettendo anche una maggiore comprensibilità del senso di lettura, che in molte pagine è poco lineare e costringe a tornare sui propri passi per seguire il filo di un discorso già di per sé tortuoso.

Buongiornissimo, merkurio???? (Scusate.)
In ultima analisi, però, Signor Mardi-Gras Delleceneri è un fumetto che potrebbe interessare a chiunque ami le storie che vogliono parlare di quello che succede dopo la morte. Se siete stati tra quelli che si sono divorati Queste oscure materie da piccoli o da meno piccoli e non faticate di fronte a narrazioni a cui interessa poco l’approfondimento psicologico dei personaggi coinvolti vi direi di spararvi questa roba direttamente in vena, ma se anche solo uno degli elementi che ho citato vi suona vagamente intrigante – caffè allucinogeno, cattolicesimo, i Ghost – il fumetto vale di certo una lettura.
(Nota dolente: il recupero non dev’essere facilissimo. Ho letto l’edizione cartacea grazie ad un prestito fortuito e mi pare di capire che almeno un volume non sia disponibile in italiano – confido che ci sia la possibilità di leggerlo almeno virtualmente attraverso canali legali ma non solo, ma non posso confermarlo con certezza.)
3 notes
·
View notes
Text
Non intitolerò questo post “Dall’Oriente con furore”: The Red Shoes e Incantation
Se qualcuno si prendesse la briga di scorrersi tutte le segnalazioni presenti fino ad ora sul blog, si accorgerebbe ben presto che c’è un medium specifico la cui assenza spicca particolarmente. Vorrei poter fornire a questo ipotetico lettore una spiegazione del tutto legittima di questa mancanza, tipo che la mia religione mi impone alcune costrizioni inaggirabili, ma la verità è molto più piana e soprattutto meno lusinghiera: guardo quasi solo film che hanno visto tutti. Il cinema è sicuramente la forma d’arte mainstream con cui ho meno dimestichezza, se non altro perché è quella in cui sono stata meno immersa sia nella mia infanzia che nella mia adolescenza; so pochissimo di regia, composizione cinematografica e recitazione e quando decido di guardare qualcosa finisco sempre a recuperare un grande classico piuttosto che una produzione sconosciuta girata con due euro e tanta voglia di innovare che potrebbe meritare un posto su questo blog. In questo triste appiattimento dei miei gusti cinematografici verso quello che mi propinano le liste top 50 movies of all time o, più raramente, il cinema della mia città, spicca però una lodevole eccezione nata ai tempi delle superiori: il cinema coreano.
Per nessun’altra ragione al mondo se non quella di aver visto Save the Green Planet! ad un’età formativa e aver immediatamente dopo sturato i miei dotti lacrimali a dovere con Mr. Vendetta, in questi anni ho visto un bel po’ di quello che il cinema coreano degli ultimi due decenni aveva da offrire – rimanendo piuttosto impressionata. Mi pareva dunque interessante dedicare un articolo a tutte quelle persone che si sono viste Parasite quando ha vinto l’Oscar, hanno recuperato Oldboy e Pietà sull’onda dell’entusiasmo e ora vorrebbero qualche consiglio che non si possa trovare semplicemente cercando 10 korean movies you should be watching right now (sì, consulto spesso le liste sull’internet, fight me), ma l’impresa è riuscita solo a metà: per quanto uno dei due film della segnalazione di oggi sia davvero coreano, il secondo è diretto da Kevin Ko, regista taiwanese che ha collaborato addirittura con Netflix per la distribuzione della pellicola. Perché cambiare piani all’ultimo minuto? Be’, uno, perché Man in High Heels si è rivelato una delusione, e due, perché The Red Shoes e Incantation hanno qualcosa in comune che li rende perfetti per condividere lo stesso spazio sul blog: sono entrambi horror paranormali che si focalizzano sul rapporto tra una madre single e una figlia a cui, per non essere troppo specifici, succedono cose. Cose sovrannaturali, terrificanti e a dirla tutta anche un po’ schifose.
The Red Shoes

Questo poster sta gridando con tutte le sue forze “sono un mediocre horror orientale dei primi anni duemila”, ma voi non credetegli.
Il primo dei due film che si sono meritati uno spazio sul blog è il meno recente – uscito nelle sale coreane nel 2005 – e anche il meno conosciuto dei due. Anche se dovrebbe prendere ispirazione dalla famosa fiaba di Andersen Le scarpette rosse, in pratica condivide con la fiaba giusto l���ispirazione per l’oggetto al centro della trama: un bel paio di scarpe che la protagonista del film, Sun-jae, trova abbandonate in un vagone della metropolitana in un periodo della sua vita particolarmente difficile; ha appena divorziato dal marito, colto in flagrante mentre la tradiva, e si è ritrovata a dover prendere in affitto un orribile appartamentino a basso costo per rientrare nelle spese che devono affrontare lei e la figlia, Tae-su, appassionata di danza classica. Il fortunato ritrovamento sembra davvero l’unica cosa ad andare per il verso giusto negli ultimi mesi – tranne forse l’interesse che In-cheol, designer giovane e carino, dimostra nei confronti di Sun-jae – ma forse proprio per questo anche Tae-su s’invaghisce subito di quel bel paio di scarpe, provocando una serie di incidenti che ben presto mettono Sun-jae in allarme… Da dove vengono quelle scarpe, ed è stato un caso che siano finite proprio nelle sue mani?
Indubbiamente la prima cosa che colpisce di The Red Shoes è l’utilizzo brillante che il regista fa dei colori: come i più perspicaci di voi avranno avuto modo di notare, infatti, le scarpe al centro della storia non sono affatto rosse, bensì di un rosa acceso un filo pacchiano; è rossa però la traccia di sangue che queste scarpe si tirano dietro, una scia di piedi mozzati, cascate sanguinolente e ossa tranciate che pur non essendo particolarmente esplicita per gli standard degli horror di questi decenni è assai ben girata e permette a tutte le scene che dovrebbero suscitare tensione di raggiungere perfettamente lo scopo prefissatesi. Più in generale, si tratta di un film dai toni spenti e grigi, che pur essendo sempre ben leggibile anche nelle scene più buie ha come unico elemento di forte contrasto proprio tutte quelle scene in cui è il sangue a farla da padrone – assieme naturalmente alle scarpe, che accendono tutte le inquadrature in cui sono presenti e catturano l’occhio dello spettatore, esattamente come succede a tutti i personaggi che vi entrano in contatto.
Infatti il canovaccio che segue il film è piuttosto solido ma relativamente convenzionale, almeno fino a tre quarti del film: un oggetto su cui grava un qualche tipo di maledizione viene acquisito da un’ignara protagonista causando danni a non finire a causa della spirale di ossessione in cui precipitano tutti coloro che vi posano gli occhi sopra; è infatti nelle scelte di sceneggiatura e di regia un po’ più peculiari che The Red Shoes riesce a ritagliarsi uno spazio in un genere già piuttosto ricco nel suo anno di uscita, che oggi è tragicamente saturo. In primo luogo, la scelta di una protagonista femminile che ha un rapporto ben lontano dalla zuccherosa perfezione di cui certi film ammantano la relazione madre-figlia e che in un horror del 2005 era quantomeno inusuale (lo stupendo The Babadook è del 2014, per intenderci); Tae-su è pestifera e seccante, come ci si aspetterebbe da una bambina che vive una situazione famigliare complessa, mentre Sun-jae è tesa, irritabile e sotto l’influsso delle scarpe diventa sempre meno paziente nei confronti della figlia. Per quanto si tratti un film che non è capace di scavare a fondo nella relazione familiare disfunzionale come è stato in grado di fare il sopracitato film di Kent, rimane comunque abbastanza abile da mettere in scena una protagonista con cui è facile empatizzare e per cui ci viene naturale fare il tifo, pur rendendo fin da subito chiaro quanto complessa e sfaccettata sia la realtà della sua situazione – e quando alla fine del film abbiamo il quadro completo della situazione, nulla di ciò che accade è inaspettato o costruito dal nulla: riguardandolo per la recensione mi sono divertita a notare tutti i piccoli pezzi del puzzle che possono condurre alla conclusione naturale del film prima che si arrivi ad essa. Anzi, forse un rimprovero che si può muovere al film è proprio quello di essere un po’ troppo didascalico; sarà che l’ho visto di recente ricordandomi molto bene il finale, ma mi è sembrato che in certi punti il film calcasse un po’ troppo la mano sugli indizi che possono portare lo spettatore a svelare l’intreccio prima della fine.

Tae-su, interpretata da un’attrice piuttosto abile per la sua giovane età.
Insomma, pur essendo un film assai godibile, specialmente per gli appassionati del genere, The Red Shoes ha qualche limite: pochissimo interesse per la sottigliezza (… quando i personaggi afferrano le scarpe parte una melodia inquietante di poche note), qualche nodo logico e spazio-temporale poco credibile per permettere inquadrature e scene più d’impatto – come nel caso di quelle girate in metropolitana – e in generale il poco interesse ad innovare, specialmente sul lato del sovrannaturale. Complici anche gli anni che si porta sulle spalle che hanno visto fiorire ogni sorta di paranormal horror con approccio molto simile, difficilmente quello che si vede in scena sorprenderà, sia per livello di brutalità che raggiunge sia per concept innovativi: rimane in ogni caso un buon film che è un ottimo modo per iniziare a guardare produzioni coreane un po’ diverse da quelle dei soliti noti.
Incantation
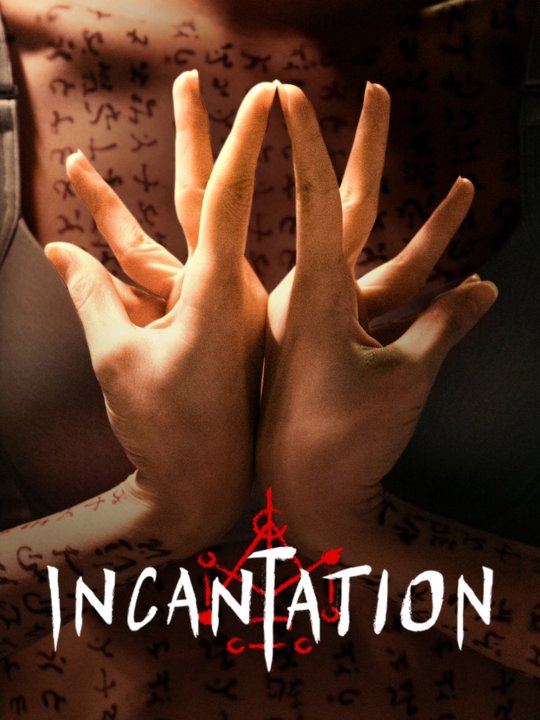
Rassicurante. Fun fact, il regista si è ispirato sia ad alcune correnti buddiste sia all’induismo per creare i simboli e gli oggetti associati al culto al centro del film.
Il dubbio che continuerà a perseguitarmi ben dopo la pubblicazione di questo post sarà: ma c’è bisogno che io scriva di Incantation? Wikipedia mi informa che è stato l’horror taiwanese con gli incassi più alti mai registrati, è stato distribuito da Netflix ed è tutt’ora disponibile sulla piattaforma… Eppure io l’ho visto per puro caso spulciando i consigli di una scrittrice che apprezzo, i400calci, il mio personale riferimento per il cinema soprannaturale e di menare (cit.), non l’ha recensito e in generale la stampa italiana non è rimasta particolarmente colpita da questo film che si è invece guadagnato immediatamente un posto tra i miei horror preferiti. Quindi, sempre per la legge per cui alla fine su questo benedetto blog scrivo un po’ di quello che mi capita sottomano, ho deciso che se anche fuori dalla mia bolla personale l’hanno visto tutti e parlandone faccio come l’utente che entra in un forum di videogame indie e spaccia Undertale per l’equivalente del libro dello scrittore polacco morto suicida, io ne voglio parlare lo stesso perché l’ho adorato.
E il fatto che io abbia adorato un film found footage, categoria di pellicole che in circostanze normali mi irrita terribilmente quando non mi induce direttamente il sonno, è già di per sé un ottimo termometro di quanto Incantation sia abile nel gestire questo formato e nell’utilizzarlo per aumentare ulteriormente la tensione in un film che fin dal minuto uno è già teso come una corda di violino: Li Ronan, una giovane donna di fronte ad una telecamera, implora chiunque stia vedendo il girato di recitare con lei una preghiera per salvare la figlia Dodo. Apprendiamo infatti che Ronan aveva in passato fatto qualcosa che la aveva convinta di essersi attirata addosso una maledizione dalle conseguenze nefaste per chi le stava intorno, costringendola a dare in adozione la figlia appena nata; dopo un percorso psichiatrico e la ferma sicurezza che le sue convinzioni erano dettate dalle esperienze traumatiche vissute in precedenza, decide di riprendere con sé la bambina iniziando un percorso di affidamento. Ma quello che sembrava essere solo un residuo della sua paranoia inizia a manifestarsi in maniera sempre più reale attorno a Dodo, portando Ronan a fare scelte sempre più disperate per salvare la figlia dalla condanna che sembra incombere su di lei – e svelando allo spettatore a poco a poco ciò che le è successo davvero sei anni prima, quando il suo cammino si è incrociato con quello di un bizzarro culto rurale dalle usanze stravaganti ma pericolose.
Anche la premessa di questo film è piuttosto convenzionale e non è difficile immaginare la piega che prenderà la vicenda: Ko è però abilissimo a suscitare curiosità circa l’incidente scatenante dell’intera storia e a dosare i flashback che ce lo raccontano con millimetrica precisione, alternandoli a scene che sono già da sole terribilmente inquietanti poiché scavano a piene mani in quel terrore che si prova nel non sentirsi al sicuro a casa propria, nel proprio stesso letto e soprattutto nel non avere un posto dove fuggire; la maledizione che insegue Ronan è pervasiva, letale e senza volto, esattamente come il culto in cui si è ritrovata invischiata prima di avere Dodo. Indubbiamente il livello di attenzione per i dettagli delle cerimonie, dei vestiti e delle sculture che sono al centro della misteriosa religione è l’altro grandissimo punto di forza dell’intera pellicola, che comprende benissimo quali sono le dinamiche davvero spaventose su cui vale la pena calcare la mano e si avvale quindi di un’estetica che rinforza l’atmosfera grottesca e oppressiva di cui si nutrono questo tipo di movimenti religiosi. Rituali intricati e violenti pur nella loro tetra sacralità, che in ultima istanza pretendono la totale sottomissione di tutti i loro adepti e sono famelici di nuovi proseliti; pur senza addentrarmi eccessivamente nelle vicende del film, che vale la pena di essere visto senza spoiler, è evidente che tutto, fino alla rivelazione finale che spazza via ogni dubbio sulla reale natura della maledizione, è orchestrato in maniera perfettamente coerente rispetto a ciò di cui il regista vuole parlare: lo schiacciante potere che conferiamo all’adorazione del divino che mastica, consuma e sputa intere vite solo per estendere il suo dominio sullo spirito umano.

Avrei potuto scegliere frame più interessanti, ma a) sono pigra e b) il programma che uso di solito per fare screenshot avuto qualche problema. Giuro che il film è bello da vedere.
Certo, per quanto Ko sia abile ad utilizzare il found footage per calcare la mano sulla natura ubiqua e pervasiva della disgrazia che segue la protagonista, si tratta di una modalità narrativa che per sua natura si presta più di altre a rompere la sospensione dell’incredulità (quante telecamere accese potranno mai esserci in queste situazioni al limite?); è anche vero che il ruolo del filmato è fondamentale per la rivelazione che ci verrà fornita sul finale, nonché essenziale per supportare il tema portante della narrazione, ed è dunque stata indubbiamente una scelta vincente e non un mero vezzo stilistico che molti registi contemporanei adottano giusto per riscaldare una vecchia minestra in un nuovo microonde. Ed è davvero l’unico appunto che mi sento di fare ad Incantation – tranne forse una mancanza di spazio data alla relazione tra Ronan e l’assistente sociale che verrà coinvolto nelle vicende, che porta ad una decisione un filo improbabile – poiché per il resto si tratta di un film capace di utilizzare elementi orrorifici per nulla rivoluzionari per raccontare una storia carica di tensione che lima lo spettatore fino ad arrivare ad un finale capace di mettere a nudo il cuore pulsante dell’orrore che la protagonista deve sfidare.
Anche questo consiglietto giunge al termine! Forse con un film un po’ più mainstream rispetto alle storie segnalate di solito sul blog, ma la verità è che ho visto Incantation a febbraio e ci sto ancora pensando, quindi ho dovuto esorcizzare il tarlo in qualche modo; confido comunque che almeno uno di questi due film abbia stuzzicato il vostro interesse, se non altro per la curiosità di conoscere il destino delle due protagoniste e delle loro rispettive figlie.
2 notes
·
View notes
Text
Charlie Brown meets the cryptids: Blind Alley
Quando nel consiglio dedicato a what happens next ho fatto il mio cappello vagamente nostalgico sui webcomic, ho citato anche una delle categorie più influenti che oggi traina il genere: fumetti – o graphic novel o qualsiasi altro modo in cui vengono chiamati nel tentativo di ottenere il rispetto della critica letteraria ok la pianto – disegnati da illustratori professionisti pensati per essere rilasciati in formato cartaceo dopo un certo numero di tavole pubblicate e una fanbase sufficientemente ampia da assicurare delle vendite che permettano di coprire i costi di stampa. Intendiamoci, non è affatto l’unico formato di pubblicazione che oggi va per la maggiore (basti guardare Webtoon e i suoi peculiari formati di impaginazione), ma di sicuro le tavole super dettagliate pensate anche e soprattutto per il formato fisico sono molto più comuni rispetto ad anni fa. Ecco, Blind Alley, scritto e disegnato da Adam De Souza, è sicuramente uno di quei fumetti che nasce per essere stampato in formato fisico e a cui il digitale aggiunge poco o nulla, ma per tutt’altri motivi rispetto a quelli delle pubblicazioni appena citate: giusto per farvi capire senza bisogno di spiegare nulla di più, ecco una delle prime strisce.

Se vi si è affacciata alla mente una certa Lucy Van Pelt, avete centrato il punto.
Il formato è identico a quei classici fumetti – Peanuts, Calvin & Hobbes, Mafalda, Sturmtruppen e potrei citarne ancora un bel po’ – pubblicati come strisce singole su quotidiani, riviste specializzate come il mio amato Linus o altre pubblicazioni regolari che avevano sezioni dedicate. Tratto minimale, tavole in bianco e nero con le occasionali pagine a colori inserite appositamente per le raccolte delle strip più belle, buildup e punchline esauriti nello spazio di quattro vignette (qualcuno ha detto yonkoma?) e personaggi ricorrenti dal design distintivo e dalla personalità semplice e ben definita; ad una prima occhiata, tutto sembra identico a quei fumetti che hanno segnato in maniera indelebile il panorama del genere fin quasi all’omaggio spudorato. Eppure, striscia dopo striscia, appare evidente che Blind Alley vuole fare anche qualcos’altro: dalla sintetica descrizione del webcomic, che recita “This comic strip is about growing up in the strange and lonely neighborhood of Blind Alley”, ai piccoli elementi lontani dal tono degli scambi tra Lucy e Charlie Brown che compaiono man mano che le strisce aumentano di numero. Infatti per ogni conversazione tra bambini che cercano di capire il mondo degli adulti o che riscoprono accidentalmente qualcosa di universale nel mondano, abbiamo una striscia in cui il genietto dell’informatica scopre telecamere nascoste negli uccelli, o una in cui un bebè manifesta all’improvviso poteri telepatici; nonostante Blind Alley non rinneghi mai la sua anima schultziana, è evidente che si tratta anche di un fumetto che vuole usare tutti quegli archetipi degli urban horror per costruire un’atmosfera a metà tra una striscia di Watterson e un episodio di Welcome to the Nightvale – e sono convinta che fino ad ora ci stia riuscendo piuttosto bene.

Sì, Oliver assomiglia a Charlie Brown. C’è anche una gag che lo associa esplicitamente al nostro pelato preferito, ma questa vignetta mi faceva più ridere.
Questo tipo di pubblicazione funziona molto bene quando funzionano i suoi protagonisti: l’intero formato si regge sulla loro abilità di suonare a tratti più saggi di quello che dovrebbero essere i bambini, e a tratti dei normalissimi ragazzini che parlano di cose da ragazzini e che soprattutto si comportano come tali, anche nei loro modi di fare più insensibili ed egocentrici, in cui si ritrova anche un certo acume che rende gli scambi godibili anche da un pubblico adulto. Sicuramente Souza è molto abile nello scrivere esattamente questo tipo di personaggi, che appaiono insospettabilmente maturi nelle strisce che richiedono una riflessione adulta – pur filtrata da occhi giovani – e adorabilmente (o più spesso, insopportabilmente) infantili nelle loro dinamiche di gruppo; Kay, il maschiaccio che è capace di tenere testa a Ten, il bulletto del gruppo, rappresenta forse il personaggio più riuscito in questo senso, passando in poche strisce da una ragazzina che sfiora con tono ironico alcune verità del diventare adulti e della vita famigliare, ad una bambina che ama giocare a calcio e disegnare piccoli fumettini che vende in un banchetto che di sicuro ve ne ricorderà uno più famoso. Quasi tutti i personaggi, pur nella bidimensionalità della loro personalità richiesta dal formato, con il passare delle strip si evolvono e fanno scoprire al lettore ulteriori lati della loro personalità che sono coerenti con quello visto in precedenza senza rimanere costantemente uguali a sé stessi; si tratta oltretutto di bambini chiaramente cresciuti negli anni duemila, poiché Souza non si limita a riproporre archetipi di ragazzini degli anni ottanta per un fattore nostalgico, ma scrive personaggi che sono chiaramente figli del nostro tempo: ad esempio, Red è un informatico recluso che preferisce i computer agli amici in carne ed ossa, mentreTen e Oliver si scambiano spesso carte Pokémon. I riferimenti alla contemporaneità sono sporadici e molto vaghi, anche per massimizzare sia l’effetto di straniamento che quello di universalità delle dinamiche infantili, ma di certo siamo stati risparmiati dall’effetto di strangerthingificazione di alcuni media contemporanei.

Pokémon! E una April prima del makeover: è l’unico personaggio a cambiare aspetto in modo significativo nel corso delle strisce.
Anche il character design contribuisce alla naturalezza con cui impariamo a conoscere tutti gli abitanti di Blind Alley: ciascun bambino ha una forma stilizzata immediatamente riconoscibile – con la possibile eccezione di Pip e Red, almeno all’inizio – che con pochi tratti fornisce una rapida impressione della personalità di ciascuno senza scadere in stereotipi triti. Sweetpea e Pod, le gemelle inquietanti con un legame psichico, sembrano uscite da Midsommar; Red indossa una felpa da cui spunta solo il viso perennemente preoccupato, mentre Crane (forse il mio preferito!) se ne va in giro con una costume da scheletro che ricorda un adolescente nel pieno della sua fase goth. Questi personaggi interagiscono in ambienti minimali, strade deserte e nella totale assenza di adulti o altre figure di riferimento – compresi bambini che non facciano parte del loro solitario gruppetto; si tratta evidentemente di un espediente narrativo molto vicino a quello che adottò Schultz nel disegnare le avventure di Charlie Brown, ma in Blind Alley quest’aspetto è utilizzato per creare un’atmosfera lievemente inquietante che aumenta con il passare delle strip, avvolgendo l’intero vicinato in cui i bambini abitano, giocano e passano tutta la loro vita.
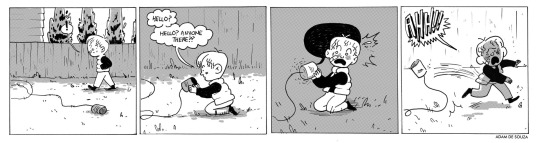
Blind Alley è un posto un po’ particolare.
Già, perché come accennato poco sopra, questo webcomic sovrappone alle battute fulminanti e alla presentazione retrò ben congegnata un’ambientazione misteriosa, a tratti un filo disturbante, e una pervasiva sensazione che nel vicinato non tutto stia andando come dovrebbe. Accanto alle strip autoconclusive si aggiungono una serie di trame orizzontali che sconfinano nel paranormale: se la prima storia a durare più di una striscia concerne la sparizione di Penny, il cane di Crane, convinta di averlo deluso a causa della sua eccessiva irruenza, quelle successive vedono Red alle prese con un sistema di sorveglianza un po’ troppo invasivo, una misteriosa presenza che si aggira per le fogne e che accetta il cibo che il piccolo Pip gli porge dai tombini, nefasti sogni premonitori che le due gemelle condividono ogni notte… Insomma, per quanto non si tratti certo di un horror pensato per spaventare o scioccare il lettore, lentamente il fumetto tratteggia un mondo ricco di segreti ed entità sovrannaturali con i quali i bambini dovranno fare i conti – con quella naturale accettazione del paranormale e dell’assurdo che accomuna i ragazzini cresciuti in un ambiente tanto bislacco, probabilmente. Mi duole segnalare, ancora una volta, che il webcomic è in corso e che non mi sento di fare predizioni circa quanto gli aspetti più orrorifici e inquietanti prenderanno il sopravvento e quanto la striscia si allontanerà dal canovaccio rodato delle gag wattersoniane per scoprire che cosa c’è sotto (ma anche sopra, negli anfratti polverosi, nel bosco misterioso di) Blind Alley, ma sono convinta che Souza padroneggi il formato abbastanza bene da non deludere le mie aspettative a prescindere dalla direzione che prenderà la storia.

... Un posto molto particolare. Il povero Red non era preparato a scoprire gli orrori del surveillance state a otto anni.
Sì, si tratta di un consiglio più corto del solito, ma giurin giurello che il motivo non è la mia pigrizia (... via, diciamo non il principale): Blind Alley racconta una storia che funziona talmente bene, al momento, che non ci sono difetti o magagne particolari da segnalare. A differenza di altre segnalazioni in cui ho presentato narrativa insolita e spesso ricca di problemi strutturali, mancanze tecniche o imperfezioni di altro tipo, questo è un fumetto estremamente curato nella presentazione e in tutti i suoi elementi fondamentali; anche per questo la scelta è caduta proprio su di esso, nonostante non ami segnalare prodotti ancora in corso. Insomma, se siete mai stati lettori accaniti di almeno una strip tra quelle con cui vi ho martellato fino ad adesso, o siete affascinati dalle cittadine descritte dagli urban horror senza avere bisogno di sangue e budella a volontà per divertirvi, sono sicura che lo adorerete, quindi buttatevi!
8 notes
·
View notes
Text
Appunti di genere I: Wraeththu
(Sì, il blog vive ancora. Il ritmo è calato molto per un mix di mancanza di cose da segnalare e vicende nella vita vera.)
Come ho già segnalato in altri post, sono una grande appassionata di New Weird. È stata in effetti questa passione piuttosto precoce che mi ha convinto a dare una chance alla lettura in inglese durante i primi anni delle superiori, visto che la probabilità di trovare qualche libro appartenente ad un sottogenere del fantasy diverso dagli high fantasy di stampo tolkeniano (stampo di qualità perlomeno altalenante, mi tocca aggiungere) in una qualunque libreria in Italia era molto bassa: il primo libro che lessi così fu The Year of Our War di Swainston, che cementò la sicurezza che questo genere fosse stato pensato proprio per chi come me era ossessionata dal leggere di cose che non avrebbe mai potuto immaginare da sola e vederle prendere vita con una minuzia e una precisione straordinarie. Poi Swainston scrisse, ahimè, anche altri libri, ma ormai lanciatissima iniziai a leggere quasi tutta la narrativa fantastica che mi interessava in inglese.
Vabbè, momento nostalgia a parte, anche se tra la Trilogia dell’Area X e qualche libro del Bas-Lag di Miéville qualcosa si è mosso, ci sono ancora tantissimi autori recenti che rimangono lontani dal fare il loro debutto sugli scaffali delle librerie nostrane, ma per il consiglio di oggi ci tenevo a segnalare la serie di un’autrice che è a tutti gli effetti una delle madrine (se non LA madrina) di questo sottogenere e che ha ancora meno chance di altri di arrivare anche qua in Italia: la trilogia Wraeththu di Storm Constantine, pubblicata tra il 1987 e il 1989 e tutt’ora inedita in Italia. Nonostante non mi informi spesso sul background di un autore prima di dargli una chance, qualche notizia su Storm Constantine mi ha convinto che si trattava di un tipo interessante: intanto perché quello è il suo vero nome, cambiato all’anagrafe dopo anni di pubblicazioni sotto pseudonimo, e poi perché da tutto quello che ha fatto in vita, dal sostegno alle fanfiction delle sue opere alla gestione di siti e wiki dedicati ai suoi mondi fantastici, traspare un genuino amore per i fan e un’idea della scrittura come atto comunitario che è relativamente peculiare tra gli autori che leggo. La stessa premessa della serie di cui volevo scrivere oggi – che una razza priva di genere, bellissima e letale, rimpiazzi a poco a poco gli umani – deriva dai look androgini delle band che frequentava in gioventù; senza ulteriori indugi, dunque, le mie impressioni su una serie che fa tante cose in modo mediocre o addirittura pessimo, ma che ne fa almeno altrettante in maniera interessante.
Come specificavo appena sopra, la trilogia di Wraeththu parte dall’idea che alle periferie di una civiltà umana ormai in lento declino si sviluppi una mutazione, inizialmente circoscritta a pochi individui, che ne modifichi il corpo e i sensi in maniera talmente radicale da creare una nuova specie: i Wraeththu, persone dotate di organi femminili e maschili, androgini d’aspetto e incredibilmente forti e resistenti, con abilità magiche e occulte che permettono loro di utilizzare telepatia, piromanzia e altri incantesimi molto più oscuri; l’intera trilogia è incentrata sul lento percorso che i Wraeththu compiono per ereditare la Terra – dai rapimenti di adolescenti dalle famiglie nelle periferie per trasformarli, alle guerre brutali condotte sotto il segno della conquista, fino ai tentativi di convivenza con quegli umani che si ostinano a non voler cedere il passo a questa razza che è chiaramente migliore di loro sotto tutti gli aspetti. Giusto?
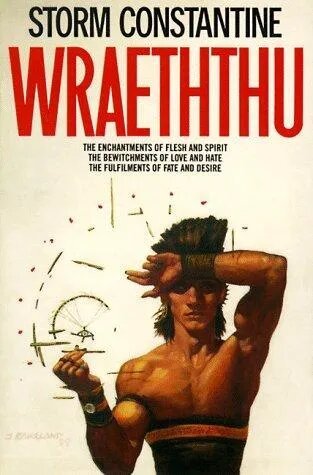
La copertina della raccolta di tutti e tre i libri. L’influenza punk è piuttosto evidente.
È rimarchevole il fatto che tutti e tre i libri si svolgano in momenti dell’avanzata molto diversi tra loro, e che lascino impressioni assai differenti sui Wraeththu coinvolti nelle vicende raccontate: il primo libro, The Enchantments of Flesh and Spirit, segue i viaggi di Pellaz, ragazzo fuggito assieme al Wraeththu Cal e iniziato rapidamente in un mondo fatto di piccole tribù sparse, che sono tutte più o meno apertamente ostili agli uomini ma che raramente hanno la forza di opporsi alle città più grandi e ben organizzate; sopravvivono grazie a fragili reti commerciali, furti e saccheggi e l’occasionale zuffa con gli abitanti delle zone isolate in cui gli uomini stanno iniziando a temere questa massa di guerrieri che hanno al loro fianco sciamani con strani poteri e una resistenza sovrumana. L’ultimo libro, che ha per protagonista Cal e il suo compagno di viaggi Panthera, dettaglia invece grandi insediamenti con culti, tradizioni e strutture sociali proprie e una società largamente abituata a considerare normalità tutte quelle caratteristiche Wraeththu che erano aliene o disturbanti ai Wraeththu stessi durante i primi anni delle loro trasformazioni; il risultato è effettivamente una cronaca dell’ascesa al potere di una nuova specie, che si trova a confrontarsi con due quesiti fondamentali che ne segnano l’intero percorso: che cosa dobbiamo fare dei nostri corpi ora che non esiste più alcuna differenza tra uomini e donne? E se siamo davvero così superiori agli uomini, saremo in grado di costruire qualcosa di meglio di quello che hanno fatto loro?
La risposta – anzi, le risposte – alla prima domanda è sicuramente uno dei motivi per cui ho deciso di parlare sul blog di questa trilogia, nonostante i suoi numerosi difetti. I Wraeththu sono a tutti gli effetti descritti come una razza che nasce dall’unione di aspetti maschili e femminili: senza peli, privi di seno e con genitali sia maschili che femminili (espressione imprecisa ma comprensibile, data l’età del testo), sono il ritratto di una bellezza androgina, a tratti anche un po’ patinata e occasionalmente perfino un filo ridicola, considerando quanto tempo i personaggi indugiano ad ammirarsi allo specchio e reciprocamente. Ma se si scrosta un po’ la patina da belli maledetti che evoca il minaccioso spettro di Twilight è evidente che l’interesse di Constantine è ben distante da quello di creare una nuova specie di Gary Stu (si dice ancora Gary Stu? Mi sento anziana) su cui far beare inesistenti schiere di fangirl, ma è piuttosto un modo di esplorare la psiche di un mucchio di giovani adolescenti che si trovano di punto in bianco in un corpo che è molto lontano dalla mascolinità che avrebbero dovuto raggiungere con la fine della pubertà.
Sì, perché la particolarità della mutazione che tramuta gli umani in Wraeththu è che sembra essere una mutazione esclusivamente maschile: i tentativi di trasmutare le donne falliscono tutti, e non incontriamo un solo Wraeththu che dichiari di essere stata una ragazza; il risultato è che, sebbene i Wraeththu siano a tutti gli effetti “l’unione di principi maschili e femminili”, il risultato della trasformazione che inizia a infettare le periferie è quello di un branco di giovani confusi che ragionano esattamente come ragionavano da ragazzi e faticano a lasciar andare quelle dinamiche di genere che caratterizzavano tutti i loro rapporti, compresi quelli sessuali. L’esempio più evidente fin dal primo libro è quello di Cal: un ragazzo gay spaventato dalle donne che da Wraeththu non riesce a scrollarsi di dosso quei rigidi ruoli che avevano caratterizzato le sue relazioni fino al momento della trasformazione e che ripropone in tutte le sue relazioni le stesse dinamiche di sottomissione e dominazione che aveva vissuto durante la sua vita umana.
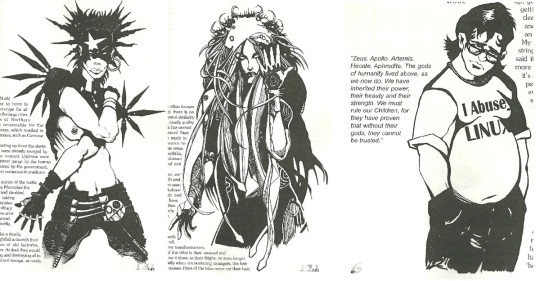
C’è anche un ttrpg! Non l’ho provato, anche perché credo sia quasi impossibile da reperire, ma giocare con quest’ambientazione dev’essere molto divertente.
Alcune delle pagine più belle sono dedicate ai rapporti tra i Wraeththu e le donne. Alcune di loro, affascinate dai Wraeththu e spesso un po’ invidiose di quella trasformazione che ha cambiato gli uomini da loro signori e padroni nella società maschilista in cui avevano vissuto fino a quel momento a entità a cui riconoscono una sorellanza precaria, vivono affiancando i Wraeththu aspettando che l’umanità sparisca lentamente dalla terra, convinte di rinascere nel principio femminile che costituisce la metà della nuova specie; altre però sperimentano subito la brutalità di alcune tribù Wraeththu, che non appare affatto diversa da quella umana: le donne nelle zone raggiunte dalla tribù dei Varr vengono uccise o schiavizzate, considerate poco più che animali incapaci di ascendere allo stadio successivo dell’evoluzione dell’umanità, e trattate con modalità per nulla diverse, se non peggiori, da quelle della società patriarcale in cui avevano vissuto fino a quel momento. È anche e soprattutto da questi scorci di inaspettata violenza e crudeltà che l’immagine perfetta dei Wraeththu inizia ad incrinarsi e qualche crepa inizia ad insinuare il sospetto che per essere una razza perfetta, al di sopra di ogni meschinità umana, molti Wraeththu si stiano comportando come tutti i conquistatori umani prima di loro.
L’incapacità Wraeththu di lasciar andare le emozioni, le passioni e i temperamenti umani ancora e ancora produce società, costumi e dinamiche identiche a quelle che avevano giurato di lasciarsi alle spalle: queste ipocrisie sono descritte molto bene da Constantine, ed è dunque sorprendente che non sia capace di risolverle in maniera soddisfacente. Il terzo libro della trilogia è sicuramente il più debole per tanti motivi (vedi i paragrafi successivi), ma uno di essi è la mancanza di una costruzione coerente che leghi assieme tutti questi momenti molto belli in cui il percorso dei Wraeththu per diventare qualcosa di più degli umani viene sfidato dalla loro incapacità di far funzionare in armonia quel loro nuovo corpo intriso di magia e nuove potenzialità e la loro mente ancora saldamente ancorata agli schemi del vecchio mondo. Forse uno degli esempi più lampanti in questo senso è l’utilizzo dei pronomi in questa serie: tutti i Wraeththu parlano di sé al maschile, ma pionieristicamente una donna di nome Kate suggerisce a Pellaz che non sembra il modo giusto di parlare di una creatura che non è né uomo né donna; questa idea viene ripresa ancora un paio di volte e avrebbe potuto avere conseguenze interessanti all’interno delle dinamiche di genere della storia, ma viene poi persa definitivamente con il passare delle pagine e nel terzo libro non viene mai più menzionata.
Insomma, la trilogia è al suo meglio quando i suoi personaggi si immergono a fondo nelle contraddizioni di una specie che dovrebbe esistere al di là di tutto ciò che è umano ma che continua a vivere come se fosse tale – anzi, a ben vedere, spesso e volentieri (ma non sempre) come se fosse ancora maschio. Non c’è dubbio, dunque, che i personaggi migliori siano quelli in cui tali contraddizioni brillano particolarmente: la maggior parte del secondo libro, cioè The Bewitchments of Love and Hate, è dedicata alla famiglia della nobiltà Varr da cui Pellaz e Cal avevano soggiornato brevemente durante il libro precedente; è composta da Terzian, il capo della tribù, il suo compagno Cobweb, salvato da Pellaz e Cal da una ferita mortale e riportato alla corte dei Varr, e il figlio Swift, uno dei primi Wraeththu di seconda generazione. Ma la relazione tra i primi due personaggi, che dovrebbe essere uno dei fulgidi esempi di perfezione Wraeththu, immune da gelosie, dinamiche di potere patriarcali o debolezze umane che privano i rapporti della loro bellezza e li trasformano in catene con cui legarsi a vicenda, sono invece l’esempio perfetto di come questi ex-uomini fatichino a lasciar andare la binarietà che ha caratterizzato tutta la loro vita precedente: Cobweb, dai capelli fluenti alla “maternità” imposta, è in una posizione sociale e politica che fatichiamo a distinguere da quella di tutte le donne del “vecchio mondo” e nel momento in cui cerca di ricavare a corte un potere e una posizione al di là del proprio ruolo i sussurri dei Varr lo bollano come un mistico – anzi, come una strega. In maniera del tutto speculare, Terzian è l’archetipo perfetto del barbaro conquistatore: virile al massimo grado, con capelli corti e fisico scolpito, incapace anche solo di considerare la gravidanza o anche solo il ruolo di soume (chi utilizza le parti “femminili” durante il sesso), si comporta esattamente come farebbe un qualsiasi signore di un feudo con sudditi da da sfamare, terre da conquistare e popoli da sottomettere. Il lento ma inesorabile disfacimento di queste dinamiche di potere, grazie alle scelte di Swift e agli influssi destabilizzanti di Cal, di cui Terzian si innamora perdutamente, costituisce forse le pagine più belle dell’intera trilogia e un altro motivo per cui, se non tutti e tre i libri, almeno i primi due meritano l’attenzione di chiunque sia interessato alle tematiche appena descritte.

Storm Constantine in the flesh. Specifico che questa è una delle sue foto più sobrie, ma purtroppo le altre avevano una pessima risoluzione.
Purtroppo, come ripetutamente accennato, la trilogia è ben lontana dall’essere perfetta. Non mi soffermerò troppo sullo stile di scrittura, che pur cadendo troppo spesso in un lirismo fine a sé stesso e a tratti anche un po’ patetico, mostra quello che deve mostrare e non ostacola attivamente la lettura – non un gran complimento, me ne rendo conto, ma non mi sento di dire nulla di più positivo; tuttavia, i veri problemi che squalificano questa trilogia dall’essere godibile per una fetta non indifferente degli appassionati di fantasy sono quelli di worldbuilding e di scelte narrative della seconda metà dell’ultimo libro, The Fulfilments of Fate and Desire. È evidente che Storm Constantine ha scritto delle vicende dei Wraeththu per parlare di sesso, di relazioni e d’amore, non certo per dettagliare con cura minuziosa una mappa di una civiltà perfettamente coerente, e sono dunque disposta a perdonare una certa quantità di vaghezza e di imprecisione relativamente alle modalità con cui avviene la conquista Wraeththu. Tuttavia, questa quantità viene ampiamente superata in molte parti della trilogia, in cui non è affatto chiaro a che livello di avanzamento tecnologico siano gli esseri umani per non resistere all’avanzata Wraeththu, quanto della tecnologia del vecchio mondo venga perso con la loro presa di potere (e soprattutto perché), o anche solo in che modo funzioni la magia Wraeththu in modalità più specifiche di “perché la trama vuole così”, che spesso conduce ad apparenti incoerenze circa quello che i personaggi sono in grado di fare in qualsiasi momento della storia. Oltretutto, quando Constantine entra più nello specifico circa i dettagli dell’ambientazione fornisce elementi spesso poco coerenti con quello che abbiamo visto fino a quel momento (vedi: le armi nucleari), problema che stride molto con la minuzia con cui è invece in grado di creare religioni, mitologie e usanze, nelle poche occasioni in cui sceglie di focalizzarsi su di esse.
A questi problemi si aggiunge un terzo libro – incentrato sul viaggio di Cal verso un destino mistico che sembra chiaramente fondamentale per l’ascesa dell’intera specie ad un livello superiore di esistenza – che si conclude con una risoluzione anticlimatica e colma di una spiritualità vuota di contenuto che viene invece spacciata come una trasformazione epocale, come se fosse cambiato tutto quando a conti fatti non è cambiato proprio un bel niente; nemmeno le interessanti (seppur limitate nello spazio che occupano) descrizioni delle tribù dello Jaddayoth formatesi a seguito della caduta dei vecchi insediamenti Wraeththu, che alludono a nuove modalità di comprendere l’unione Wraeththu dei principi maschili e femminili, o la ripresa di punti di vista femminili in una chiave assai promettente bastano a salvare quest’ultimo libro dalla mediocrità.
La conclusione inevitabile di questo mio consiglio è quella che ormai accompagna buona parte dei miei post: se il New Weird vi appassiona e volete scoprire uno tra i libri fondanti di questo genere, o se vi affascina l’idea di leggere una delle prime storie fantasy che racconta di genere e di sesso in maniera meno binaria rispetto alla norma del tempo (peggio di LeGuin, d’accordo, ma il confronto è crudele) buttatevi! Magari vi interesseranno solo i primi due libri, che sono comunque abbastanza completi da non lasciare l’amaro in bocca anche se deciderete di fermarvi lì: anche così, buona lettura.
7 notes
·
View notes
Text
Su tumblr, per tumblr, con tumblr: what happens next
Vi ricordate i webcomic? No, non parlo di cose tipo Stand Still Stay Silent o Kill Six Billion Demons, fumetti pubblicati online che hanno come scopo ultimo quello di essere stampati in una bella edizione con copertina rigida e tavole immacolate. Pensavo più a roba tipo questa. O questa. O in generale tutte quelle serie nate dalla penna di un solo autore che partiva dal presupposto di non saper disegnare, spesso pure di non saper sceneggiare e in casi più gravi manco di saper fare lo spelling di parole oltre le tre sillabe; sì, c’era naturalmente un mucchio di robaccia di questo genere in giro per l’internet, ma il fascino di poter prendere carta e penna (o pennino e tavoletta grafica, ma siamo lì) e poter creare un prodotto finito da poter postare sul web che veniva letto e commentato da un mucchio di persone è qualcosa che è sempre più difficile da ricreare al giorno d’oggi – e in mezzo a questa pila gigante di spazzatura non mancavano i piccoli tesori che riuscivano a raccontare una storia che nei medium più tradizionali non avrebbe trovato spazio. Non che oggi i webcomic di questo tipo siano spariti per mancanza di mezzi o di piattaforme, sia chiaro, ma quando chi compete per l’attenzione del tuo pubblico è un illustratore con una laurea in arti figurative che ha pure fatto qualche corso di sceneggiatura è quasi impossibile costruirsi un pubblico che vada oltre lo stile incerto e l’iniziale mancanza di coerenza e continuità invece di scegliere qualcosa di più accattivante.
Il mondo dei webcomic così come si intendeva dieci-quindici anni fa è stato largamente sorpassato: ogni tanto però spunta fuori un’eccezione. Eccezione che, per essersi fatta largo in questo mercato ipercompetitivo e frenetico, deve avere qualche qualità che non la faccia istantaneamente ricondurre alla satura categoria dei three dudes talking about videogames (storico antenato dei three dudes with a podcast che oggi piagano la rete): è proprio il caso di what happens next, disegnato e sceneggiato da Max Graves, che si prefigge di narrare una storia che parte da un episodio di cronaca nera che cambia per sempre le vite dei protagonisti, per esplorare in che modo filtrare questi avvenimenti attraverso la rete può peggiorarli, distorcerli, o creare nuovi mostri che sarebbero stati impossibili da immaginare prima dell’avvento dei social. E già vi sento, come una sola voce, pensare: che due maroni. Che due gargantueschi, flaccidi maroni. Fermi, prometto che questo webcomic merita almeno il tempo che spenderete a leggere questo consiglio; anzi, per rientrare nelle vostre grazie, lancio l’amo: è un webcomic su tumblr. Proprio così, una parte significativa delle interazioni tra i personaggi avverranno tramite una versione di tumblr molto simile a quella attuale – l’autore ha specificato l’ambientazione è un mondo parallelo molto simile al nostro – con interfacce ricreate minuziosamente e dinamiche così vicine a quelle reali da essere chiaramente state oggetto di uno studio accurato. A questo punto potrei avervi perso definitivamente, ma per chi di voi si è sentito intrigato alla menzione del tumblero, ecco di che cosa parla il consiglio di oggi.
Vikki, assistente in uno studio di pompe funebri e proprietaria di un canale YouTube dedicato al true crime, decide di chiedere assieme alla sua amica Xandra un’intervista a Milo Holliday, ragazzo trans coinvolto anni prima in un omicidio particolarmente efferato assieme al suo migliore amico-slash-fidanzato-slash cotta pre-eggcracking (Griffin Petty – uhm, è complicato) che ha portato alla morte di due ragazze. Pur essendo rimasto diversi anni in un istituto di igiene mentale a seguito della sentenza del processo, è attualmente in libertà e vive con suo padre e con sua nonna, cercando di mantenere il più possibile l’anonimato per lasciarsi il passato alle spalle. Oh, tranne per il fatto che ha un account su tumblr con il suo vero nome a cui arrivano ogni giorno messaggi crudeli, transfobici o semplicemente scioccati all’idea che un tizio coinvolto in un evento tanto traumatico scelga di passare diverse ore al giorno a discutere su che cosa dovrebbe o non dovrebbe meritarsi per il resto della sua vita. Su tumblr è però attivo anche Gage, attuale fidanzato di Griffin e proprietario di un account pieno di contenuti grafici e disturbanti che insiste per contattare Milo per avere più informazioni sull’omicidio in cui è stato coinvolto e sul rapporto che aveva con Griffin prima del tragico evento: come è facile immaginare, questo mix letale di riflettori sulla vita di Milo e di traumi passati che bussano alla porta innescherà una spirale che lo porterà a dover ripensare radicalmente come ha vissuto fino a quel momento e in che modo dovrebbe gestire le responsabilità di ciò che ha fatto. Spoiler: nulla andrà come dovrebbe.
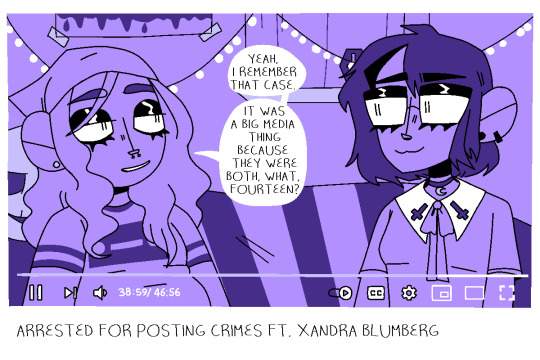
La prima tavola del primo capitolo, featuring Vikki che è ovviamente la mia preferita perché è la mean goth del cast.
La prima caratteristica di what happens next che salta subito all’occhio è l’estremo realismo della componente social che costituisce uno dei motori principali della vicenda. Ogni interfaccia è resa graficamente con un notevole livello di cura e dettaglio, e il modo in cui ciascuno dei personaggi interagisce con la rete è molto vicino alla realtà – nonché chiaramente basato sulle esperienze dell’autore: non mancano i riferimenti a meme, dinamiche e nerderie di vario genere che hanno fatto la storia di tumblr e di altre sottoculture online, ma non sono mai buttati nella storia fini a loro stessi, giusto per strappare una risata al lettore o per fargli un occhiolino come a dirgli “so che tu sai che io so”. Il fatto che Milo riguardi ossessivamente le prime stagioni di My Little Pony: Friendship is Magic e che non sia in grado di impegnarsi nella visione o nella lettura di alcuna narrativa che si allontani da ciò che guarderebbe un ragazzino di seconda media, o l’interesse che Vikki prova per il true crime, o ancora quei contenuti morbosi e talmente gore da risultare ridicoli che Gage posta sul blog sono tutti riflessi del modo in cui i personaggi hanno scelto di gestire i traumi e le difficoltà che li hanno accompagnati fino a quel momento. Ulteriormente significativo è il fatto che queste dinamiche sono presentate in modo molto realistico: persino io, che ai social propriamente detti mi sono avvicinata abbastanza tardi e che sono su tumblr da meno di un anno, non ho avuto nessuna difficoltà a riconoscere quanto le interazioni online presentate nel corso delle tavole rispecchino fedelmente moltissime situazioni che si evolvono tutti i giorni nella realtà – dai comportamenti più macroscopici, come bullismo o stalking, fino alla complessità dei comportamenti di persone depresse, terminally online e incapaci di gestire le proprie responsabilità in maniera diversa da come gestivano a tredici anni le liti tra fandom.
Va sottolineato come questo realismo non si limiti a permeare le relazioni che si costruiscono online tra i personaggi, che soprattutto nella prima parte del webcomic tendono a dominare la narrazione, ma anche a quelle che vediamo offline. Se vi aspettavate una storia con buoni e cattivi, o perzone tossike e brava gente, be’, what happens next non ha nessuna intenzione di raccontarvela; persino i personaggi più sgradevoli e con cui è più difficile empatizzare, come il padre di Milo, che non esita a ridicolizzare il figlio e si rifiuta di comprendere o di accettare la sua transizione, sono protagonisti di dialoghi rivelatori e credibili che riescono a farci percepire tutta la complessità racchiusa in una storia così dolorosa come quella che Graves vuole raccontare. In questo webcomic non ci sono persone “moralmente giuste”, e uno dei focus centrali della serie è proprio sul ruolo della vittima, che può essere indubbiamente liberatorio da vestire, ma che se cucito addosso troppo stretto impedisce di diventare qualsiasi altra cosa e porta a liberarsi di qualsiasi percezione di responsabilità, rifiutando la crescita e il cambiamento necessari per diventare adulti; quasi tutti i personaggi hanno comportamenti infantili e bizzarri, spesso esasperati da spazi online incapaci di rispondere alle loro esigenze ma più che felici di intrappolarli in dinamiche adolescenziali e prive di complessità: tu sei una persona moralmente corretta (hai rispettato il mio dni), tu un mostro che farebbe meglio ad ammazzarsi appena possibile (hai postato un contenuto con una ship incestuosa).

Sì, Milo sta guardando una puntata di MLP. Grave che io sappia qual è anche se non l’ho mai visto in vita mia.
Persino la giustapposizione tra elementi comici e grotteschi ed eventi traumatici e violenti, che in altre mani avrebbe rischiato di risultare in un pastrocchio incoerente e privo di qualsiasi carica drammatica, in questo webcomic è dosata in modo da fornire sufficiente realismo alle interazioni senza per questo scadere in sterile citazionismo o nell’illusione che citare la realtà permetta di dare spessore alla finzione. Insomma, se siete arrivati fin qui è evidente il mio entusiasmo per questo webcomic, ma proprio in virtù del suo status indie presenta qualche limite. Il più evidente è il disegno: se le interfacce sono assai realistiche e i mezzibusti dei protagonisti molto espressivi nella loro semplicità, quando il tratto è costretto a rappresentare persone in movimento, composizioni complesse o gestualità peculiari viene messa in evidenza la sua inadeguatezza; è perlopiù abbastanza chiaro nel rappresentare ciò che sta succedendo, ma difficilmente è gradevole alla vista o bello in senso tecnico. Anche la colorazione è piatta e priva di ombre e luci, stratagemma che funziona nel primo capitolo che utilizza una palette molto limitata ma molto meno in quello successivo. Non dovrebbe sorprendere, considerando che si tratta di un webcomic vecchia scuola che è evidentemente frutto di anni di lavoro da autodidatta, ma contribuirà sicuramente ad allontanare qualche potenziale lettore abituato a standard grafici molto superiori.

Ecco, appunto. Anche se hobbit!Milo ha il suo appeal.
Come già feci per Romulus, inoltre, sono costretta a segnalare che il webcomic è ancora in corso: il primo capitolo – dog names – è completo ed è leggibile anche come una storia a sé stante, com’era nelle intenzioni originarie dell’autore, mentre il secondo è ancora incompleto; viene aggiornato regolarmente e fino ad ora non ha dato segni di peggioramento qualitativo: sembra che l’autore sappia quello che fa e che non si stia affidando al caso o a una prima geniale intuizione per scriverlo, dunque mi sento di consigliarlo caldamente anche con questi caveat (e poi volevo ricominciare a scrivere sul blog, okay?). Se i temi citati vi interessano e avete almeno una qualche curiosità di vedere in che modo le dinamiche dell’Internet possono essere sfruttate per scrivere una storia complessa, competente e conscia dei medium di cui vuole parlare – o se vi è piaciuto Bokura no Hentai – what happens next potrebbe rivelarsi una lettura interessante.
7 notes
·
View notes
Text
Stand-up comedy, femminismo e eviscerazioni rituali: Deconstructeam
Non è facile lavorare nell’industria dei videogiochi. Se appena ci si informa un po’ sulle offerte lavorative delle grandi case videoludiche si viene investiti da inchieste sul permacrunch, accuse di molestie, ambienti di lavoro sgradevoli e posizioni precarie (niente link, ci mettete esattamente mezzo secondo a scoprire di che cosa parlo); ma, al contrario di quello che si potrebbe pensare, se si lascia scivolare l’occhio verso il panorama indie la situazione non migliora particolarmente. Nuovi studi aprono e chiudono dopo aver pubblicato un singolo gioco, alcuni implodono per le stesse identiche motivazioni delle grandi aziende, e la precarietà è se possibile persino più diffusa. Uno su mille ce la fa, e potrebbe essere una stima ottimistica: proprio avendo in mente questa situazione meno che confortante sono assai contenta di poter segnalare un’apparente eccezione a questa instabilità cronica che difficilmente incoraggia nuovi sviluppatori e narrative designer a buttarsi in questo campo: Deconstructeam è attivo dal 2012, e nonostante al mondo indie più mainstream sia arrivato un solo titolo – l’ottimo The Red Strings Club, portato anche su Switch – ha continuato negli anni successivi a produrre diversi giochi davvero interessanti.
In primo luogo perché si tratta di giochi piccoli, dalle meccaniche essenziali e di durata compresa tra la mezz’ora e l’ora e mezza, che mettono in campo un’idea intrigante e la sviluppano fino alla sua inevitabile conclusione: apprezzo l’elegante brevità di queste esperienze indie e mi paiono un ottimo contraltare a quei giochi soffocati da icone, missioni e content for the content god che mancano del tutto di temi narrativi, di senso dello storytelling o anche solo di un qualsiasi afflato emotivo. In secondo luogo, sono gratis! Tutti i videogiochi che presenterò qui sono disponibili alla modica cifra di zero euro su itch.io, anche se è possibile pagare quello che si ritiene giusto prima o dopo averli giocati o acquistare su Steam Essays on Empathy, una raccolta curata dagli stessi sviluppatori di alcuni di questi giochi usciti post-Red Strings Club con qualche spiegazione sul processo creativo abituale del team, qualche sketch preliminare e un mini-documentario sulla realizzazione di ciascuna esperienza videoludica. Senza ulteriori indugi, dunque, ecco una selezione di sei giochi che mi sono piaciuti abbastanza da volerne parlare qua sul blog.
11.45 A Vivid Life

Secondo me agli Scout ‘sta roba non la insegnano mica.
Laynie ha diciassette anni, un’automobile e una macchina per i raggi X rubata. Destinazione: un posto abbastanza lontano da casa per poter condurre in pace qualche sperimentazione sul suo scheletro anomalo; non è possibile che una ragazza così giovane abbia un occhio di vetro, un proiettile piantato nella coscia e una massa di pus incastrata nello stomaco... Ma è davvero pus, poi? E se fosse qualcosa di molto meno umano? E che dire di quegli strani codici che ogni tanto le tornano alla mente, o quei flash di un passato da soldato, o del fatto che uno dei suoi piedi è almeno due misure più grande dell’altro? Urge un’investigazione accurata, e così, armato di bisturi e garze, starà al giocatore scoprire i segreti dello scheletro della protagonista, cercando di volta in volta di riempire i vuoti di memoria, le suggestioni paranoidi o i ricordi confusi che Laynie riporta alla luce.
Il gioco si svolge interamente in una singola schermata: il giocatore individuerà tramite raggi-X le porzioni dello scheletro di Laynie che presentano anomalie più o meno marcate, e sarà poi lei stessa a cercare di estrarle quando possibile, o almeno a fornire una prima spiegazione a cui seguiranno dei prompt attraverso i quali potremo ricostruire una possibile versione del passato della protagonista. Le scene di estrazione, seppur in pixel art e molto parche in termini di gore e interiora a schermo, sono comunque piuttosto crude: vedere una ragazza aprirsi il braccio, cavarsi un dente o indursi il vomito senza quasi batter ciglio evoca piuttosto bene il senso di alienazione dal proprio corpo che emerge prepotentemente come il tema centrale di questo esperimento. Laynie ha chiaramente avuto un passato traumatico e violento, ma il modo in cui sceglie di interpretare i segni di esso sul proprio corpo determinerà la conclusione a cui giungerà a seguito di sconclusionati semi-monologhi con una persona sconosciuta attraverso una radio, che parlerà solo per intimarle (o pregarla?) di tornare a casa.
La ritualità delle estrazioni e le spiegazioni di Laynie sono molto interessanti, e riflettono assai bene quel misto di paranoia, dolore e cinica curiosità di una persona che deve raccogliere i cocci di una vita che a poco a poco si è appropriata del suo corpo fino a non lasciarle più spazio; il punto debole che priva l’esperienza di quella catarsi che avrebbe potuto qualificare A Vivid Life come il migliore della raccolta è la completa ambiguità di tutti le possibili conclusioni, che nega al giocatore qualsiasi possibilità di interpretazione al di là del “mi piace pensare che…” – una gerarchia tra i finali che stabilisse almeno alcuni percorsi interpretativi preferibili o più suggerimenti sull’identità della misteriosa persona alla radio ne avrebbero probabilmente fatto il mio preferito.
The Bookshelf Limbo

Il fumetto che avrei comprato io. Troppo prevedibile.
Questo è sicuramente il videogioco meno “gioco” della raccolta – si tratta sostanzialmente di una vetrina di fumetti curiosi di cui potremo esaminare quarta di copertina, recensioni online e trama prima di decidere quale di questi sarà il regalo perfetto per nostro padre. I titoli nel loro insieme rappresentano un’affettuosa parodia di certi generi del fumetto indie, dallo spokon poliamoroso fino al libro dei tarocchi illustrato, ed è divertente leggere le opinioni di certi utenti che ricorrono nelle recensioni online; anche il fatto che di primo acchito il nostro personaggio scarterà tutti i fumetti che gli proponiamo è una bella trovata per farci esplorare un po’ il tipo di rapporto che abbiamo con nostro padre, ma arrivati alla cassa con il fumetto scelto sappiamo davvero poco sul loro legame: il tema centrale del gioco non è questo. Lo consiglio se piace l’idea di sfogliare per una mezz’ora scarsa fumetti in una libreria virtuale e se si ha la dimestichezza sufficiente con l’ambiente per sorridere a certe caricature (siamo sempre su tumblr.com, quindi immagino di sì).
Eternal Home Floristry

Fun fact: questo gioco è stato creato per la Ludum Dare 43, a cui ha partecipato anche Mullins (sì, quello di Pony Island) con un prototipo di Inscryption.
Gordon è un sicario a cui è andato male l’ultimo lavoro. Talmente male che ha bisogno di sparire per un po’ – perché quindi non rifugiarsi nel negozio dell’anziano fiorista Sebastian, che può fargli da tramite con il mondo esterno e nasconderlo da occhi indiscreti? Sebastian però vuole fare del sicario il suo apprendista: quando per il funerale di una vecchia conoscenza di Gordon viene richiesto un bouquet, sarà proprio Gordon a doverlo assemblare e a doversi caricare delle conseguenze. Infatti nel linguaggio dei fiori si possono dire tante cose, ma non tutte avranno l’effetto sperato su coloro che li ricevono; la possibilità di influenzare il modo in cui le persone coinvolte gestiranno il lutto aprirà a Gordon nuove possibilità circa la vita che potrebbe vivere al di là del crimine, fino ad appassionarlo gradualmente all’arte della composizione floreale.
Nella mezz’ora che passeremo all’interno del negozio di Sebastian dovremo comporre tre bouquet più uno, strappando i fiori con un pop molto soddisfacente e disponendo quelli prescelti in un vaso che potremo anche ulteriormente decorare per un effetto più piacevole alla vista; è un rituale semplice ma piuttosto rilassante, almeno finché non ci rendiamo conto di quale impatto può avere sulla vita dei nostri clienti. L’implausibilità della premessa (siamo sicuri che basti un bouquet ad alterare le sorti di una guerra finanziaria tra fratelli?) viene stemperata da dei dialoghi gradevoli e interessanti che ruotano attorno alle cesure nei rapporti, agli ultimi addii e alle scelte definitive che siamo costretti a fare; il rapporto tra Gordon e Sebastian è ben sviluppato pur nella rapidità del gioco, e anche se non è qui che tutta la brillantezza della scrittura di Deconstructeam si palesa al meglio, le scene che si susseguono sono abbastanza interessanti da convincere il giocatore ad arrivare fino al finale, se non altro per scoprire quali saranno tutti i bouquet che potremo comporre. Non il gioco migliore tra quelli presentati in questo post, complice anche il fatto che è uno dei pochi ad essere effettivamente stato sviluppato in 72 ore per una competizione, ma sicuramente un’esperienza interessante da giocare.
Dear Substance of Kin
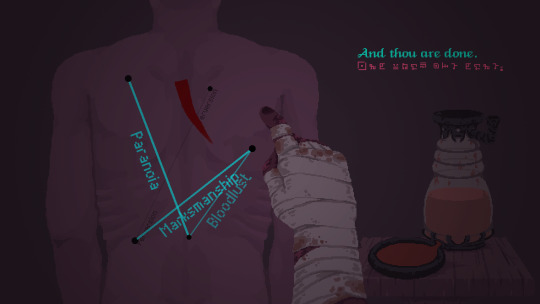
Ammetto di averci messo un attimo a capire che non dovevo tracciare le linee col sangue ma solo sbarrarle.
Arriviamo invece al mio gioco preferito della raccolta! Un calderaio arriva alle porte di un villaggio per offrire i suoi servigi; tuttavia, al monatto che lo accoglie chiede se ha qualche cadavere da vendergli, e quando bussa alla prima porta appare chiaro che i servigi che si fa pagare a caro prezzo non sono affatto quelli che ci si potrebbe aspettare dalla sua professione… In cambio di viscere, sangue e budella il calderaio può alterare la forma e l’anima delle persone, ma come tutti i migliori patti col diavolo i prezzi sono proibitivi e le conseguenze imprevedibili. Man mano che ci addentriamo nel villaggio, tutti coloro che sono abbastanza disperati o non abbastanza rassegnati ci chiederanno di esaudire i loro desideri, ma starà a noi scegliere in che modo essi si avvereranno – e qualcun altro potrebbe invece volere da noi qualcosa di diverso dal previsto. Una domanda però tormenta il giocatore che si approccia a questo sanguinoso rituale: chi siamo e perché stiamo facendo tutto ciò?
Non è un segreto che come si parla di fantasy strambo mi si drizzano le orecchie, ma questo gioco è davvero un esempio eccellente di worldbuilding che riesce a bilanciare assai bene i misteri di un’ambientazione complessa e non immediatamente leggibile con le spiegazioni fornite nel corso delle interazioni con i locali; durante le nostre visite alle case dei postulanti avremo modo di apprendere gradualmente come funziona il rituale, di che cosa abbiamo bisogno e che tipo di scelte possiamo compiere: è giusto far avverare tutti i desideri così come sono stati espressi? Quanto (poco) sangue posso versare per aiutare gli abitanti del villaggio? Una vita per una vita è uno scambio equo? Nel corso di una mezz’ora scarsa ci troveremo di fronte a situazioni variegate e complesse che il gioco ci permette di affrontare con una gradualità didattica ma mai eccessivamente generosa, permettendoci di calarci nella parte del demoniaco calderaio con una facilità insospettabile. Lo stesso rituale, semplice ma potente nelle sue gestualità primarie, ci permette di compiere scelte anche piuttosto radicali circa la forma che prenderà il desiderio espresso dal cliente, che avrà effetti significativi su di lui e spesso sull’intera famiglia; effetti che potremo osservare verso la fine del gioco, quando una camminata a ritroso lenta e carica di pathos ci metterà a confronto con le conseguenze delle nostre azioni.
Anche qualche mistero circa la natura del calderaio verrà svelato, pur mantenendo quell’aura di mistero e di irrealtà che circonda le figure più oscure delle favole: il quadro che si delinea una volta vista la schermata conclusiva è abbastanza comprensibile da permetterci di apprezzare tutti i momenti precedenti, ma abbastanza vago da mantenere in vita quell’aura folkloristica che ammanta l’intera narrazione. Insomma, complici il fascino del concept iniziale, la visceralità del rituale che ci toccherà compiere ripetutamente, e la potenza delle scelte che potremo fare all’interno del gioco, Dear Substance of Kin è il gioco di Deconstructeam che mi ha colpito di più e che ho rigiocato più volte in assoluto.
(E se vi chiedete il perché dei maiali, assicuratevi di aver parlato con tutti. Sì, proprio tutti.)
De Tres al Cuarto
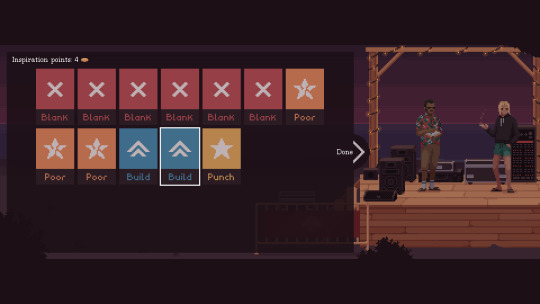
Se vi state domandando come è possibile fare uno spettacolo divertente con queste carte, la risposta giusta è: non lo è. Buona fortuna.
Garza e Bonachera sono un duo comico appena formatosi; Bonachera è nel mestiere da anni, reduce da una partnership insoddisfacente, mentre Garza è ancora un principiante e deve imparare come adattarsi alle tempistiche e all’umorismo della stand up comedy: decidono dunque di fare un’intera settimana di tour nei locali di un’isoletta per capire quanto questo duo improvvisato possa funzionare a lungo termine. Tra uno spettacolo, un drink al bar e una nuotata in riva al mare, entrambi si confronteranno con il proprio partner circa lo spettro dell’insuccesso, la mancanza cronica di denaro e ciò che li ha portati a fare la “vita da creativo” che avevano sognato fino a quel momento.
Di tutti i giochi presentati finora, mi sento di dire che De Tres al Cuarto è quello con il gameplay più efficace nel far immergere il giocatore nella situazione messa in scena. Saremo infatti nei panni di Garza, comico inesperto e dal repertorio limitato, quando dovremo andare in scena per far divertire il pubblico ad ogni serata: dovremo fornire una punchline o un build-up ad ogni frase di Bonachera, intuitivamente rappresentati come carte da gioco, per guadagnare punti ispirazione che nelle serate successive serviranno ad aumentare il numero di carte presente nel nostro mazzo o a migliorare quelle già presenti – una battutina insipida può trasformarsi in un buffissimo gioco di parole con la giusta dose di riflessione. La peculiarità che eleva questo sistema piuttosto semplice sta nel fatto che il nostro mazzo non solo sarà inizialmente davvero pessimo, ma avrà anche possibilità di miglioramento molto limitate: dopotutto seguiamo il nostro fantastico duo per una sola settimana, quante sono le possibilità di diventare il nuovo James Acaster in così poco tempo? Una scelta che avrebbe generato frustrazione in un gioco più lungo e articolato si rivela perfetta per un’esperienza di durata così limitata, facendoci ben percepire i limiti di una comicità ancora acerba e spesso mediocre, nonché la tensione che si prova in un ambiente così competitivo in cui se non si brilla subito di luce fulgida si rischia di venire immediatamente dimenticati. Non si è mai abbastanza bravi, e ad ogni colpo di tosse del pubblico o risatina forzata mi sono sentita sempre più in ansia circa il futuro dei nostri due protagonisti.
Anche le scene che esplorano il rapporto tra Garza e Bonachera sono assai godibili, complice anche un piccolo box chiamato The Hidden and The Unknown, che a lato del dialogo esplicito renderanno leggibili anche i pensieri più intimi dei due protagonisti: talvolta divertenti, più spesso complicati e un po’ dolorosi, forniscono ulteriori chiavi di lettura alle conversazioni tra due comici dai background diversissimi e con ambizioni e convinzioni che in certi casi non potrebbero essere più distanti. Il finale, ottimista nonostante tutto, è la degna conclusione per il gioco più quieto e ricco di quotidiana introspezione della raccolta; nonostante un inglese occasionalmente un po’ zoppicante, De Tres al Cuarto è una bellissima esplorazione dei sacrifici che si fanno per l’arte e i dubbi che si affrontano durante il cammino, trattati senza retorica melensa o facili soluzioni.
Behind Every Great One

Not pictured: Gabriel che sbrocca per l’Arte™ mentre noi puliamo la merda che lascia in giro.
Ho volute lasciare per ultima l’esperienza che più di tutte le altre può risuonare anche con il giocatore casual: se i titoli citati finora non vi ispirano più di tanto, vuoi perché non siete videogiocatori, vuoi perché il gameplay vi appare ostico e poco comprensibile, consiglio comunque di dare un’occhiata a questo, anche perché è tra i giochi più puramente narrativi della raccolta – i controlli sono essenziali, il gameplay minimale e ripetitivo, la storia raccontata un pugno nello stomaco.
Come recita la pagina itch corrispondente, “Gabriel è un artista di successo molto devoto alla sua arte. Victorine non ha particolari hobby, ma supporta Gabriel come casalinga. Si amano molto.” Nulla di più semplice! Nei panni di Victorine dovremo pulire la casa, preparare pranzo e cena, stirare, e occasionalmente, perché no, rilassarci con un libro o qualche sigaretta (poche, perché a Gabriel non piace che fumiamo) – lo studio dell’artista è off-limits, naturalmente: come ogni musa che si rispetti, se dovessimo vedere le opere prima che fossero finite le rovineremmo. Eppure, passati i primi giorni di routine ci accorgiamo che c’è qualcosa di strano. Non riusciamo mai a fare tutto quello che dovremmo fare nel corso della giornata, e Gabriel, con rara gentilezza, non manca di farcelo notare, per il nostro bene; siamo sempre più stressate, e l’arrivo di qualche ospite imprevisto potrebbe peggiorare la situazione… Quello che segue è una toccante ma chirurgica esplorazione di quel rapporto tra l’artista e la sua compagna che è stato fino a poco tempo fa una delle lenti più naturali entro cui si pensava lo svolgersi dell’attività artistica: l’uomo crea, la donna supporta. Ma quando si entra nei panni di Victorine e si segue passo dopo passo il monotono svolgersi della sua giornata, l’infinità di piccole seccature quotidiane che sono per loro natura eterne e ricorrenti, e soprattutto la completa mancanza di stimoli che vadano oltre la porta di casa, ecco che la situazione appare molto meno “naturale” di prima e riusciamo a percepire la profonda alienazione di una vita devota interamente a qualcun altro.
La routine dei lavori domestici diviene sempre più precaria man mano che passano i giorni e si aggiungono inconvenienti, ospiti indesiderati e pressioni da ogni lato; è sempre più semplice portare Victorine sull’orlo di una crisi di pianto, rigorosamente in un punto solitario della casa, e di arrivare comunque a sera senza aver finito di sistemare la casa come previsto. Behind Every Great One è molto abile ad alternare allo stress crescente della gestione della casa i momenti di quiete apparente, in cui riuniti di fronte ad un tavolo i personaggi riuniti a cena come le migliori famiglie del Mulino Bianco proseguono, con crudeltà, indifferenza o un miscuglio delle due, la lenta erosione di Victorine, che viene man mano risucchiata in una spirale di impotenza, frustrazione e incapacità di dare un taglio netto a tutto ciò che la rende infelice, fino ad un finale che è una perfetta sintesi di tutti quei sentimenti covati fino a quel momento dal giocatore e dalla protagonista. I videogiochi sono per loro natura un medium profondamente immersivo, ma questo supera le aspettative già alte che avevo prima di iniziarlo e permette anche a chi vive una vita davvero lontana da quella narrata lungo la mezz’ora abbondante che servirà per completare la storia di immedesimarsi nella vita di Victorine e, credo, di leggere un certo punto di vista femminile sotto una luce diversa.

The Red Strings Club è troppo famoso per meritare un articolo a parte, ma se ancora non l’avete giocato affrettatevi: merita tutti i soldi che chiede.
Fine della carrellata! Con questo post un po’ diverso dal solito spero di aver reso un buon servizio ad uno studio che mi pare davvero promettente, capace di combinare una pixel art gradevole e in generale delle scelte grafiche azzeccate con una chiara comprensione dei meccanismi narrativi che rendono una storia degna di essere raccontata. Non tutto quello che ho provato mi ha lasciato un’impressione altrettanto positiva – Engolasters è stato impossibile da completare per via dei controlli atroci, Interview with the Whisperer è ingiocabile perché basato su dei server ormai offline – ma la maggior parte delle creazioni di questo team mi hanno lasciato piuttosto fiduciosa circa il loro prossimo progetto commerciale.
#ita#videogame#videogame studio#deconstructeam#11.45 a vivid life#substance of kin#eternal home floristry#behind every great one#the bookshelf limbo#de tres al cuarto#recensione
1 note
·
View note
Text
Non si studia fuori catalogo: The Library at Mount Char
Chiariamo subito una cosa: evviva le etichette. Tutte le etichette in generale, sante patrone della reciproca comprensione e della categorizzazione ontologica, ma soprattutto quelle di genere letterario: la comodità di poter sfogliare comodi elenchi di libri già suddivisi in categorie assai specifiche non ha prezzo, nonché sapere dove andare a pescare il libro con la premessa ideale, la dinamica tra protagonisti più intrigante, l’ambientazione più in linea con i propri gusti… La categorizzazione capillare e l’efficienza dell’Internet sono uno degli strumenti per cui non posso che ringraziare la contemporaneità e che mi hanno permesso di frugare in ogni meandro della narrativa pubblicata (e non) e di riemergere trionfante con scatoloni virtuali di libri in mano pronti per essere divorati; murder mystery con ragazzine detective? Check. Science-fantasy sui vampiri? Check. Sex magic dai toni BDSM? Uh, check. Quante volte sono stata in grado di chiedere libri dai concept ultra-specifici e soprattutto di ricevere consigli in risposta, e quante volte sono riuscita ad esplorare nicchie del fantastico che senza questa attenta suddivisione sarebbero scivolate tra le maglie troppo larghe delle mie ricerche: i generi letterari sono una gran comodità.
Chiariamo subito un’altra cosa: che seccatura le etichette. I perversi meccanismi dell’editoria meriterebbero un articolo a parte scritto da gente più competente di me, ma mi sembra di parlare di ovvietà quando sottolineo il fatto che il marketing dietro le etichette, i generi e gli archetipi è tanto pervasivo quanto del tutto scollegato dalla qualità effettiva del prodotto; giusto per citare l’elefante nella stanza, il genere young adult è diventato immediatamente un calderone in cui buttare cretinate scritte dal “genio ventenne” di turno, retelling della mitologia (oggi va quella greca, domani chissà) o altra robaccia informe che cavalca i trend del momento – vi ricordate le distopie YA? Se siete su tumblr naturalmente sì, quindi direi che possiamo passare oltre senza indugio. Insomma, un certo tipo di etichetta di genere è becero marketing, senza contare il fatto che l’incasellamento costante in comodi scompartimenti favorisce un’omogeneizzazione del mercato attorno alla moda del momento che di sicuro non incontra né il mio favore né quello di altri fan del bizzarro, dello strano e di tutto ciò che nasce fuori dalle comode barriere precostituite dell’editoria. Quando dunque sono venuta a sapere dell’esistenza di The Library at Mount Char, inclassificabile in una branca del fantasy più specifica del vago contemporary, privo di ulteriori etichette o blurb accattivanti, e con una premessa indubbiamente più intrigante della media dei quarti di copertina, la spia del mio modesto ma ossessivo cervellino si è accesa di colpo.
Carolyn vive da molti anni con suo Padre in una grande biblioteca, assieme a tanti fratelli e sorelle adottivi. Nulla di troppo strano, maiuscole a parte, finché non si pensa al fatto che la biblioteca in questione contiene tutti i segreti dell’universo, faticosamente accumulati proprio dal loro Padre, un essere onnipotente e millenario che ha preso tutti loro sotto la sua tutela dopo un misterioso incidente per addestrarli alle arti della sapienza, della manipolazione e del combattimento; le lezioni sono brutali, i maestri inflessibili, il Padre sadico e crudele – l’unica regola è “non studiare fuori dal proprio catalogo”, pena un destino peggiore della morte. Tuttavia, proprio quando gli apprendisti sembrano dimostrare una padronanza assoluta dei loro cataloghi, il Padre scompare; il sollievo viene presto sostituito dal terrore quando anche la biblioteca diviene inaccessibile: come faranno Carolyn e i suoi fratelli a ritornare in possesso della conoscenza che potrebbe salvarli dai numerosi nemici del maestro scomparso? E come faranno a collaborare tra loro senza che qualcuno decida di tradire gli altri per diventare il vero successore del loro tirannico genitore? Carolyn ha un piano, ma quando questo si intreccia con vecchie conoscenze e nuovi problemi ecco che non tutto andrà come previsto…

Questa segnalazione sarà accompagnata da immagini out of context di quello che succede nel libro. Partiamo abbastanza tranquilli con un pacioccoso leone.
Se il concept alla base della vicenda vi sembra curioso, aspettate di finire il resto del libro. Nelle trecento pagine circa che leggerete per arrivare alla conclusione verranno coinvolti il presidente degli Stati Uniti, un assassino perfetto in tutù da ballerina, almeno un paio di soli e un barbecue davvero speciale: la totale mancanza di freni nell’immaginare lo snodarsi delle vicende porta questo libro a prendere strade inaspettate e difficilmente classificabili in categorie di genere predefinite, nonostante si tratti per la maggior parte di sviluppi assolutamente coerenti con le scelte dei personaggi e gli eventi precedenti. Difficile se non impossibile capire dove andrà a parare il libro, ma quando tutti i pezzi si ricompongono è difficile notare sbavature o imperfezioni nel tessuto della trama: tutto accade per un motivo, anche gli sviluppi più bizzarri e la violenza più esagerata hanno un loro posto nel mosaico che il lettore è chiamato a ricomporre, seguendo (quasi sempre) tre punti di vista principali che si alternano nel narrare la storia raccontata. Tra di loro spicca senz’altro Carolyn, protagonista indiscussa del romanzo e l’apprendista a cui è stato assegnato lo studio delle lingue: è anche l’unica tra i fratelli che ha dovuto imparare qualcosa di più sul mondo umano al di là della biblioteca, ed è dunque un ottimo filtro tra l’infantile amoralità degli altri apprendisti, a tratti ridicola ma più spesso spaventosa, e la normalità delle interazioni umane a cui siamo abituati. È piuttosto semplice provare simpatia per questa giovane donna che si deve destreggiare tra un passato traumatico di abusi e violenze che le chiede insistentemente il conto e la precaria situazione in cui lei e la sua famiglia si trovano alla scomparsa del Padre: sono liberi, certo, ma quanto saranno in grado di sopravvivere senza le conoscenze della biblioteca, e soprattutto, senza doversi guardare continuamente le spalle per evitare di essere traditi dai loro stessi fratelli?
Purtroppo gli altri due punti di vista non sono all’altezza di quello di Carolyn. Seguiamo infatti anche le vicende di Steve, ex ladruncolo in pensionamento anticipato che verrà reclutato proprio da Carolyn per un “ultimo lavoretto” che lo porterà ad immischiarsi con le lotte di potere degli esseri soprannaturali, e di Erwin, ex veterano che verrà suo malgrado coinvolto nel lavoretto di Steve e in qualcosa di molto più grande di lui, degli Stati Uniti ma anche del mondo intero. Steve è un personaggio simpatico, certo, ed è il tipo di persona per cui è facile fare il tifo, nonostante un passato da criminale incallito, ma manca di quello spessore che le pagine dedicate a Carolyn riescono ad infonderle, finendo per risultare il simpatico ragazzo della porta accanto o poco di più; Erwin è invece chiaramente un personaggio nato per mostrare allo spettatore certe scene che gli altri due punti di vista non possono narrare, e si sente molto: la sua personalità è riassumibile in “burbero ex veterano”, la sua evoluzione inesistente, il poco background che abbiamo su di lui ci viene infodumpato con rara malagrazia nel primo capitolo a lui dedicato. E qui mi tocca sottolineare un altro punto dolente del romanzo che non gli permette di far brillare la storia che vuole raccontare come dovrebbe: il ritmo della narrazione.

Qualcosa contro gli scaldamuscoli? A parte essere uno dei tanti crimini perpetrati dagli anni ottanta, intendo.
The Library at Mount Char è l’opera prima di Hawkins, e mi dispiace dire che si vede. In diversi punti del romanzo l’azione si interrompe bruscamente per rigurgitare informazioni non richieste al lettore che vede svelato il passato di certi personaggi senza nessuna catarsi, ci sono scene intere che andrebbero elise e rimpiazzate con interazioni tra altri personaggi più rilevanti ai fini della storia che invece vengono liquidati con una rapidità disarmante, e in generale il romanzo avrebbe avuto bisogno di un editing più radicale che tenesse quello che davvero era importante per il cuore pulsante della vicenda (che è, sostanzialmente, una revenge story, anche se non vi dirò di più) e scartasse quelle parti che possono risultare più o meno godibili ma che di sicuro non sono pertinenti.
—————————————————— ANGOLO SPOILER ————————————————————–
La scena più ovvia di questo tipo è quella in cui vengono liberati i due leoni. Tutta percepita da due punti di vista usa-e-getta che non rivedremo mai più per mostrarci un evento del tutto secondario: che c’importa di come Michael riesce a reclutare i leoni? Non ci serve certo un intero capitolo dedicato a spiegarcelo! Sarebbe stato molto meglio avere più scene dedicate al rapporto tra Carolyn e i suoi fratelli, che sono per la maggior parte più piatti di quello che dovrebbero per suscitarci la giusta dose di empatia al momento del loro decesso.
—————————————————- FINE ANGOLO SPOILER ———————————————————–
Certo, quando Hawkins sceglie di mostrare, anziché di raccontarci una storiella, le scene sono ben mostrate, scritte in modo piano e proprio per questo accattivanti, perché riescono piuttosto bene nella loro impresa di narrare le cose più assurde – un attacco di piccolissimi cani inferociti, un rituale per tornare dal mondo dei morti, dei bambini-zombie-tuttofare – senza infiocchettarle di aggettivi altisonanti o di un’aura metaforica del tutto fuori luogo; va detto che l’autore ci riesce per la maggior parte delle pagine, e anche le scene più fuori luogo sono compensate da una prosa godibile che rimane abbastanza trasparente da non rallentare la lettura in alcun modo. Insomma, è un peccato che invece questo ritmo sincopato e confuso giochi a sfavore del pathos della storia, che risulta fin troppo spesso compromesso dalla scelta di mostrarci meno del dovuto certi rapporti tra personaggi che avrebbero meritato più spazio all’interno dell’economia della trama, perché è evidente che quando Hawkins mette le sue capacità al servizio di scene davvero meritevoli il risultato finale è buono.

Alcune immagini potrebbero essere più disturbanti con il contesto. Chissà quali.
Credo però che quello che leggeremo compensi ampiamente le difficoltà di storytelling in cui si incappa nel corso della storia per i weird aficionados che leggeranno questo blog. Anche se le pagine dedicate alla vita dei fratelli prima della scomparsa del Padre non sono mai abbastanza, quello che viene raccontato è un mix di fantascienza, fantasy e horror grottesco davvero riuscito; ci sono scene piuttosto crude (sì, è un libro sconsigliato a chi non stomaca la tortura, lo stupro e in generale la violenza esplicita), altre tremendamente assurde e in generale un’atmosfera stramba che permea l’intero romanzo. Leggere delle straordinarie capacità che i fratelli hanno accumulato nel corso degli anni di apprendistato significa passare dallo studio delle lingue a quello del futuro, degli universi paralleli, e del regno dei morti; ancora, è un peccato che il numero di pagine più consistente sia dedicato a quelle aree di studio più convenzionali – come quella dell’omicidio, appannaggio dello psicopatico ma intrigante David – ma l’impressione generale è quella di assistere ad una fusione tra tecnologia avanzatissima e magia molto antica, in cui i confini tra l’una e l’altra sono collassati molto tempo fa. Nessuno dei fratelli è onnipotente, e non appena si muovono attirano l’attenzione di cose con cui potranno e dovranno lottare ad armi pari, ma ciascuno di loro possiede capacità straordinarie molto difficili da gestire nel mondo alieno degli “Americani” (cit.) in cui sono gettati dopo che la biblioteca diventa inaccessibile; e quando tutto attorno a loro collassa, Hawkins non ha difficoltà a far arrivare il romanzo alla sua naturale conclusione, per quanto disturbante e definitiva possa essere. Anche l’apprendistato, nei suoi momenti più crudeli, viene descritto come un susseguirsi di esperienze mistiche e terrificanti, e il modo in cui Hawkins descrive le reazioni dei fratelli ad esso è parecchio riuscito, pur nello spazio limitato che gli viene riservato.

Finiamo col botto. Già citato nella recensione, ma se volete scoprire che succede non vi rimane che leggere il libro.
Nonostante dei punti vista dalla qualità altalenante e una struttura irregolare che spesso minaccia di crollare su sé stessa, le brillanti idee e l’intreccio alla base (nonché il finale col botto) di The Library at Mount Char ne fanno un consiglio perfetto per questo blogghino: una gemma un po’ difettosa che potrebbe diventare uno dei libri a cui penserete di più in questi mesi dopo la lettura a seconda di quanto vi garbano temi e concetti descritti finora. Da grande fan delle storie di apprendistato in salsa fantasy e di immortali superpotenti che non sanno trovarsi il culo con le mani, il mio consiglio spassionato è: buttatevi!
3 notes
·
View notes
Text
Che cosa si sacrifica agli dèi: ROMVLVS
Mi rendo conto che iniziare questa segnalazione con la solita sbrodolata su quanto sono brutte le serie italiane, e su quanto sono brutte in maniera triste, convenzionale e un po’ da soap opera è francamente noioso: lo so io, lo sai tu e lo sa chiunque sia entrato in contatto con il palinsesto Rai in qualche momento della sua vita; a parte qualche lodevole eccezione – Boris su tutte, s’intende – le produzioni italiane televisive si distinguono per la loro rara mediocrità e per la continua riproposizione di stanchi cliché riproposti talvolta in salsa medical, talvolta come poliziesco di terza categoria, o perché no, entrambe le cose. Il perché lo spiega proprio Boris con lucidità e precisione invidiabili, e appunto per questo non è il caso di soffermarcisi troppo: basti sapere che di fronte a questo panorama deprimente non ho potuto non incuriosirmi quando mi è cascato l’occhio sul progetto di Matteo Rovere.
Infatti Rovere ha girato nel 2019 Il primo re, lungometraggio che racconta la storia di Romolo e Remo e della fondazione di Roma tra storia e mito (be’, soprattutto mito); il mio interesse era a dire il vero abbastanza contenuto, finché non ho letto che il film è stato girato interamente in protolatino, ricostruito con l’aiuto di un team di professionisti che si sono occupati anche dell’ambientazione, dei vestiti e in generale dell’atmosfera del film. Decisamente intrigata, scopro però che c’è qualcosa di più grosso ancora in cantiere: un’intera serie televisiva di dieci puntate che dovrebbe ripercorrere la storia già narrata nel film, ampliandola e modificandola significativamente, mantenendo però intatta la cura per l’ambientazione e per la lingua con cui dovranno recitare gli attori: Romulus, o ROMVLVS per il team grafico. Mi decido quindi a mettere la serie in lista d’attesa e, con il mio consueto ritardo, perfino a guardarla, visto che tanto per cambiare non mi arriva all’orecchio uno straccio di pubblicità per un progetto così peculiare, nemmeno considerando il budget stanziato o il fatto che non ci sono poi così tante produzioni italiane da promuovere; per intenderci, ho sentito parlare più di Bianca (sigh) che di questa serie. Ora, io Bianca non l’ho vista e magari è un capolavoro, eh, ma posso dire che sono uscita dalla visione delle dieci puntate di Romulus un pochino più speranzosa di prima circa il futuro della fiction italiana.
La serie è ambientata nell’ottavo secolo avanti Cristo, tra i trenta popoli che risiedono nel Lazio uniti sotto il nome di Lega Latina; l’esilio di Numitor (sì, quel Numitore) decretato dai sacerdoti a seguito di una lunga carestia permette ai suoi due figli, Yemos ed Enitos, di salire al trono di Alba Longa come suoi legittimi successori – finché rivalità e gelosie, ma soprattutto un’oscura profezia che parla di fratricidio non faranno capitolare la Lega sull’orlo di una guerra sanguinosa… A questa premessa sicuramente familiare a chiunque abbia ascoltato qualche fugace brandello di storia romana tra elementari e superiori, si aggiungono altri personaggi del tutto inventati, come Wiros, schiavo costretto con i suoi compagni a partecipare ad un periodo di esilio forzato in una foresta ricca di pericoli, e Ilia, vestale innamorata di Enitos a cui arriverà la visione che contribuirà a mettere in modo gli eventi narrati dalla serie, oltre ad una serie di comprimari provenienti da diversi popoli e culture che permettono di tratteggiare un quadro piuttosto completo dell’ambientazione ricostruita dal team responsabile della serie.

Post pieno di immagini perché la serie è davvero bella da vedere. E perché ho potuto fare screenshot in santa pace grazie alle magie del torrente *wink wink*.
L’elemento che salta subito all’occhio fin dai primissimi episodi è l’interesse che la serie ha per il mito. Sono ben tre gli dèi che dominano la scena: Marte, feroce e vendicativo signore della guerra a cui i soldati pregano prima di ogni battaglia, Vesta, dea del fuoco eterno che deve essere ravvivato periodicamente dalle vestali, e Rumia, oscura divinità della foresta che è temuta da tutti coloro che vivono all’interno delle mura della città; quanto essi siano strumenti politici nelle mani dei potenti e quanto invece siano forze reali che plasmano il destino degli uomini è lasciato interamente all’intuizione dello spettatore fino alla fine, offrendo una doppia interpretazione a tutto ciò che vediamo: Ilia ha davvero visto il dio Marte tra le fiamme o ha avuto un’allucinazione indotta dalle circostanze? È Rumia a mutilare i cadaveri degli schiavi trovati nella foresta, o qualcosa di più umano ma ugualmente sinistro? Sebbene la serie verso il finale propenda per una specifica interpretazione degli eventi, lo spettatore si trova per la maggior parte del tempo libero di comprendere le interazioni tra le divinità e gli umani come meglio crede. Notevole anche il fatto che il mito stesso venga gestito in maniera più originale del previsto: se dalla mia sinossi credete di aver capito chiaramente dove andrà a parare la serie, consiglio di vedere almeno il primo episodio per convincervi che non tutto andrà nella direzione che appare ovvia ad un fan della storia preromana; la maggior parte delle interazioni tra la mitologia (sia quella reale sia quella interna alla serie) e i personaggi offrono spunti di riflessione che non si limitano a ricalcare la “storia ufficiale” della nascita di Roma, ma la ampliano, la sfidano e spesso la contraddicono apertamente. Insomma, la serie è al suo meglio quando al centro della vicenda ci sono rituali, tradizioni, sacrifici e tutte quelle modalità di confronto con il divino e il trascendente, anche se non è il suo unico punto di forza.

Quei tranquilli rituali senza spargimenti di sangue tipici dell’antichità. “Sorridi, pa’, sei su Candid Camera!”
Infatti tra i protagonisti di cui seguiremo le vicende spicca in particolare Wiros, uno tra i tanti schiavi costretti a partecipare ai Lupercalia, riti che prevedono l’abbandono di diversi servi nella foresta per alcuni mesi, lasciati liberi di dare sfogo ai loro istinti più bassi o di instaurare una collaborazione per aiutarsi a sopravvivere a vicenda in un ambiente ostile e minaccioso. Wiros è quanto di più distante si possa immaginare dall’eroe epico per eccellenza: smunto e magro, incapace di combattere e terrorizzato dalle leggende che si raccontano sulla foresta; sembra destinato a passare il suo tempo nelle selve sotto il giogo del re-schiavo Cnaeus che guida il gruppo con sadica crudeltà, ma l’intreccio della vicenda lo costringerà a cambiare per non essere travolto dagli eventi. Quanto sarà in grado di farlo e soprattutto che cosa comporterà questa trasformazione, legata a doppio filo alle sorti della dea Rumia, sono i motori principali della suspense dello spettatore e sicuramente una delle componenti della serie in cui brilla la maggior cura per la sceneggiatura, assieme a quelle di Ilia. Anche la giovane vestale, sospesa tra il culto pacifico ma rassegnato del focolare e la sete di vendetta di Marte, è scritta in maniera piuttosto interessante, e complice anche una performance davvero notevole di Marianna Fontana che parla in latino con una naturalezza impressionante, è forse il personaggio al quale è più facile legarsi emotivamente, e a cui si perdonano anche certe scelte di scrittura che appaiono più dettate dal desiderio di spettacolarità che dalla coerenza con il resto (senza spoiler: imparare a combattere è difficile, molto difficile, di sicuro più difficile di così).

La bravissima Marianna Fontana che si è appena presa un fracco di spadate in faccia.
Ho meno parole di lode da spendere sulla scrittura di Yemos, uno dei due eredi di Alba Longa e terzo protagonista della serie: pur essendo il perno al quale ruota intorno l’intera storia e al centro dell’incidente scatenante che mette in moto quasi tutti gli eventi, la sua evoluzione appare poco interessante, prima messa in ombra da quella di Wiros, con cui condivide l’avvicinamento ad una divinità oscura e nemica della civiltà in cui non solo lui è cresciuto, ma di cui è nato per essere a capo, e poi eccessivamente rapida e dall’impatto emotivo meno significativo rispetto alle altre che seguiamo nel corso delle puntate. È un vero peccato, considerando che Yemos nasce per essere la figura centrale attorno al quale presumiamo che si svilupperà la civiltà romana, ma dopo un inizio davvero promettente le scene dedicate a lui sono quelle in cui la scrittura perde più mordente e si affida a dialoghi banali e scelte fin troppo ovvie che suonano spesso anche un po’ artificiose. Arcangeli (l’attore che lo interpreta) lavora comunque egregiamente con il materiale assegnatogli, e in generale non ho rilievi da fare al cast: sono volti diversi dai soliti noti, spesso legati all’ambito teatrale, che gestiscono molto bene la recitazione in lingua e salvo qualche comparsa in difficoltà rendono i dialoghi estremamente credibili.
Oltre alla scrittura di Yemos, mi sento di specificare che la serie in toto soffre un po’ di una certa convenzionalità, soprattutto al di fuori di quelle scene incentrate sul rapporto uomo/divino, che non le permette di raggiungere quei picchi che me l’avrebbero altrimenti fatta divorare in pochi giorni; la narrativa è generalmente ben intrecciata ai protagonisti e permette di appassionarsi ai loro destini, ma nessuno dei personaggi è mai spinto al limite naturale del proprio arco evolutivo, e molte scelte di trama appaiono o troppo comode per tutti i coinvolti, oppure eccessivamente legate ad un retelling del mito che non rende giustizia ad un’ambientazione così interessante e sviluppata. Nulla che comprometta l’intera visione o che faccia crollare la trama su sé stessa, ma tanti piccoli momenti in cui la narrativa poteva osare e ha invece scelto di rimanere su binari saldamente ancorati ad un percorso dell’eroe di stampo mitico e tradizionale.

Sì, anch’io mi sono ovviamente innamorata di Silvia Calderoni, specialmente dopo averla vista anche in Riccardo va all’inferno.
—————————————————— ANGOLO SPOILER ————————————————————–
Uno degli esempi più evidenti è il dilemma che coinvolge Wiros verso la fine della serie: condannare una dei suoi guerrieri alla morte per dimostrare la sua lealtà alla Lega, tradendo i valori di Rumia, o rinnegare l’alleanza con le divinità tradizionali e muovere guerra alla “civilità” da solo? Wiros sceglie di farsi fustigare al suo posto e dopo poche frustate Silvia si intromette e gli assicura la sua lealtà: nulla di troppo improbabile, ma il pathos è notevolmente minore di fronte a questa terza via di comodo che consente a Wiros di non scegliere davvero in che campo schierarsi. La stessa “morte” di Amulius ne è un altro esempio, anche se in previsione della prossima stagione non mi sento di ancora di pronunciarmi.
—————————————————- FINE ANGOLO SPOILER ———————————————————–
Segnalo inoltre che la serie, ahimè, non è completa. Per quanto l’ultimo episodio finisca su una nota soddisfacente, è chiaro che il viaggio per fondare Roma è appena all’inizio: se volete una garanzia di qualità per il proseguo della narrazione temo che dovrete fidarvi delle abilità di Rovere; finora non posso davvero dirmi delusa, ma ho visto più prime stagioni promettenti che ultime stagioni soddisfacenti, quindi… Cautela. In ogni caso, se a leggere il concept di queste prime dieci puntate avete sentito il bisogno fisico di cercare un dizionario di latino per seguire i dialoghi anche senza sottotitoli, o siete semplicemente curiosi di vedere un adattamento di vicende storiche che non arrivano tanto spesso sul piccolo schermo, la visione è decisamente consigliata.
1 note
·
View note
Text
Tutti i motivi per cui mi vesto da donna: Bokura no Hentai
Come penso sia ovvio a chiunque lanci anche solo un’occhiata fugace a questo blog, la sacra trinità della speculative fiction è il mio genere letterario preferito; un po’ quindi per inclinazione personale, un po’ perché nella definizione di “narrativa curiosa” la parte delle “curiosità” finisce spesso per essere in qualche maniera legata al soprannaturale, finora ho segnalato solamente opere appartenenti a questa ampissima categoria. Non che manchi varietà al suo interno, ma sono comunque contenta di uscire sporadicamente dai suoi confini per fare pubblicità a qualcosa di diverso dal solito consiglio: Bokura no Hentai (Our Abnormalities o Our Perversion in traduzione inglese) è un manga che merita uno spazio in questa vetrina di storie insolite, senza aver bisogno di kaijuu carnivori o di intricato worldbuilding fantascientifico.
Pubblicato dal 2012 al 2015 da Fumiko Fumi e mai tradotto ufficialmente né in inglese né in italiano (ma molto semplice da trovare online, wink wink), i dieci volumi di cui è composta la serie seguono le vicende di Osamu Tamura, Marika Aoki e Ryousuke Kijima, che dopo essersi conosciuti online su un forum per crossdresser decidono di incontrarsi per la prima volta nella vita vera; tuttavia, ciascuno ha un motivo diverso per presentarsi in abiti femminili, e il loro primo appuntamento in un caffè darà inizio ad un precario sodalizio che darà loro la possibilità di confrontarsi con il passato e i loro reali desideri – ma anche di ferirsi a vicenda e di seppellire la verità sotto comode illusioni pur di non soffrire ancora. Infatti pur presentandosi alla lettura con un tratto soffice e delicato, senza scene particolarmente grafiche o violente, il manga parla di identità di genere in maniera spesso cruda, dolorosa e senza nascondere le parti più sgradevoli della non-conformità, del trauma o dell’abuso: siamo abituati a molte opere queer con un taglio chiaramente pedagogico e destinate ad un pubblico molto giovane, ma Bokura no Hentai non rientra affatto in questa categoria. La domanda che sorge spontanea è: ma la storia che racconta riesce davvero a parlare di questioni così intime senza cadere in sensazionalismi da quattro soldi, feticizzazioni pornografiche o stucchevoli banalità? Questo spazio che ho voluto ritagliarle sul mio blogghino dovrebbe essere già una risposta sufficiente.

Il primo incontro, all’insegna del fashion per fare una prima buona impressione. Non durerà molto.
La relazione tra Osamu (“Parou”), Ryousuke (“Yui”) e Marika (che per molto tempo si fa chiamare Yuuta) è il cardine su cui si impernia tutta la storia e attorno alla quale orbitano anche tutti i personaggi secondari, dall’amica di Marika (Akane) fino a Satoshi, compagno di scuola di Marika che pratica crossdressing nella vita di tutti i giorni senza nasconderlo ai coetanei. Ciascuno dei tre co-protagonisti è tratteggiato con una cura certosina per la loro psicologia e il modo in cui interagiscono con gli altri due, necessariamente intrecciato ai loro personali sentimenti circa gli abiti femminili che si trovano per un motivo o per l’altro ad indossare: Osamu Tamura diventa Parou quando ha un appuntamento con il suo senpai, che accetta di fare sesso con lui solo quando è vestito da donna, mentre Ryousuke veste i panni di Yui, la sorella morta in giovane età che alla madre manca disperatamente, nel tentativo di farla stare meglio; Marika si presenta come donna transgender, anche se è ancora un segreto per tutti quelli che la conoscono, tranne per la sua cara amica, che fatica a comprendere che cosa significhi davvero e le parla ancora come se fosse un maschio. Sembrerebbe naturale pensare che l’incontro di questo trio possa dare inizio ad una cura reciproca che permetta finalmente ai traumi passati e alle difficoltà personali di emergere e di essere superate, ma la verità è che Bokura no Hentai non esita a mostrarci il lato sgradevole delle interazioni tra persone emarginate e sofferenti, che non esitano a tuffarsi negli stessi meccanismi crudeli che hanno visto riproporsi ancora e ancora nella loro vita di tutti i giorni: Ryousuke è disgustato da Parou e Marika, che bolla immediatamente come pervertiti, Osamu riscopre con Marika la stessa dinamica tra vittima e carnefice che già viveva nella sua quotidianità, mentre Marika continua a rifugiarsi in un mondo illusorio e zuccheroso in cui Osamu diventa il suo principe azzurro – appropriatamente disegnato come uno shōjo anni ’70 – per non confrontarsi con le crude verità che vive quotidianamente tra disforia e bullismo scolastico.
L’onestà che il manga ha nel tratteggiare la violenza, verbale ma non solo, a cui il trauma e il dolore possono spingere, e il rifiuto di accettare facili soluzioni in cui il confronto e la relazione con il simile portano facilmente alla salvezza e ad un immediato sollievo (“qualcun altro come me!”) lo fa brillare su moltissime altre opere che parlano di trauma; ciascuno dei tre protagonisti, pur soffrendo l’emarginazione e la propria percepita anormalità, non esita a ferire gli altri proprio lì dove sono stati feriti a loro volta, ancora e ancora rifiutandosi di percepire le peculiarità e la storia degli altri due per poter tendere una mano amica e spezzare la crudele routine in cui tutti e tre sono incasellati. Naturalmente con il passare dei volumi Marika, Ryousuke e perfino Osamu impareranno piano piano a occupare lo stesso spazio senza farsi (troppo) male a vicenda e persino a supportarsi reciprocamente nel proprio faticoso cammino verso il superamento di quelle situazioni drammatiche che pesano sul loro vissuto e soprattutto sul loro presente, ma nessun passo in avanti è mai scontato e non ci sono soluzioni facili: la strada per fare pace con il dolore è lunga e faticosa, e non è affatto detto che ci si riesca mai del tutto.

Uno dei momenti in cui entriamo nella testa di Osamu. Non è un posto tanto confortevole in cui ritrovarsi, nemmeno per lui.
È anche vero che se nella prima parte del manga questi temi sono egregiamente gestiti per costruire un mix di tensione, terrore e genuino coinvolgimento emotivo, nella seconda parte l’atmosfera si distende in maniera significativa, complici una serie di cambiamenti: tutti e tre i protagonisti superano scogli importanti sul loro cammino e imparano finalmente a convivere con sé stessi e con gli altri in maniera un po’ più funzionale di prima; questo significa però che il resto della serie manca di quella fortissima carica empatica che aveva caratterizzato la prima parte, visto che le poste in gioco si abbassano parecchio, i problemi si fanno più gestibili, gli scambi tra personaggi meno cruciali e perciò anche meno interessanti. La scelta di collocare il climax della vicenda a metà è davvero poco felice e porta facilmente ad una delusione il lettore che si aspetta una seconda metà che espanda e costruisca sul coinvolgimento costruito fino a quel momento, mentre si trova a leggere una storia che vira dolcemente su temi meno d’impatto e che a volte sfiorano persino lo slice-of-life. Non che manchino momenti genuinamente commoventi o dialoghi che offrano spunti di riflessione, ma nel complesso la seconda parte manca di quella carica potente e un po’ disperata che mi aveva costretto a divorare i primi cinque-sei volumi in pochi giorni.
Indubbiamente infatti un altro notevole punto di forza della serie sono i dialoghi tra i personaggi, protagonisti ma non solo. Se è naturale che il trio principale abbia ampio respiro per esplorare la propria identità di genere e i propri desideri sessuali attraverso il confronto con gli altri, anche diversi comprimari hanno diverse interazioni che esplorano l’essere a-normali in modi nient’affatto banali. Una delle mie conversazioni preferite è proprio quella tra Osamu e Satoshi, l’amico di Marika, che mettono in scena un confronto stupendo sul significato del crossdressing senza demonizzarlo né accomunarlo all’essere transgender, ma esplorandolo attraverso le esperienze, i dubbi e i sentimenti che li guidano quando sono vestiti con abiti femminili. Anche appiattiti da una traduzione chiaramente amatoriale, gli scambi di Bokura no Hentai brillano per la capacità di confrontarsi onestamente con modalità di presentazioni non conformi alla quotidianità sociale senza ricercare quella immediata chiarezza che le etichette queer offrono; il non-binarismo, la transessualità e l’orientamento sessuale sono presentati come il risultato di interazioni complesse, incasinate e in cui è facile non riuscire più a districarsi, e i dubbi che ciascuno dei personaggi deve affrontare nel corso della serie circa la sua identità sono vivi e reali, facilmente comprensibili da chiunque li abbia mai percepiti sulla sua pelle (ma, sono convinta, non solo da loro). Leggere di persone che scelgono come presentarsi, cambiano idea, poi però forse tornano indietro, scelgono un’altra parola, poi altri vestiti, altri nomi e così via, in un vortice di incertezza che ha poco a che vedere con quei ritratti edulcorati che vediamo spesso nei media mainstream che parlano di identità queer, mi ha scaldato un po’ la pietra che mi ritrovo al posto del cuore.

Una tavola tratta dal mio dialogo preferito. As an aside, i pronomi che utilizzo qui sono quelli che i personaggi usano per la maggior parte del tempo, ma tutti quanti oscillano tra lui e lei a seconda della circostanza, almeno in traduzione.
Ci sono alcuni dialoghi e alcune scelte narrative che lasciano un po’ perplessi, come il dilemma di Marika nel capitolo 40 che viene gestito in maniera un po’ perplimente e all’opposto dell’evoluzione del suo personaggio fino a quel momento, o la conclusione del rapporto tra Osamu e Marika, che forse gli perdona più di quello che sarebbe credibile, e mi preme sottolineare di nuovo che questo è un manga che non risparmia niente: bullismo, transfobia, stupro e crudeltà involontarie o meno sono spesso presenti e al centro della storia che vuole raccontare, ed è facile trovarsi a disagio di fronte ad alcune scene mostrate o addirittura non riuscire ad andare avanti; se volete una lettura leggera e tranquilla la serie non fa per voi.
Ci tengo anche a spendere qualche parola per il disegno, che cela dietro un’apparenza zuccherosa e tenera una storia chiaramente pensata per un pubblico maturo. I corpi tratteggiati nei dieci volumi sono assai androgini, e cambiano facilmente aspetto con un po’ di trucco e una parrucca appropriata; nonostante questa scelta faccia perdere un po’ di realismo di fronte a certi problemi effettivi con cui i personaggi devono fare i conti (la crescita improvvisa, i peli, i muscoli…), far percepire la fluidità della presentazione di genere ad ogni tavola e ad ogni cambiamento improvviso permette di rendere conto appieno della fragilità (ma anche della malleabilità!) dell’identità che tutti i coinvolti si costruiscono nel corso della vicenda, in un gioco di maschere frenetico che però solo raramente sfocia nella confusione tra personaggi, grazie a qualche accorgimento di character design che permette distinzioni abbastanza immediate. Il tratto ha anche un’evoluzione significativa nel corso della serie, che stempera un po’ le forme eccessivamente stilizzate e bambinesche in favore di volti e gestualità più espressive, sacrificando un po’ l’originalità dello stile; una menzione speciale ad alcune cover, disegnate con stili differenti che ricalcano quelli di altri generi, dal BL allo spokon, e alle tavole che aprono i capitoli, a volte particolarmente ispirate nell’accostamento di certe immagini.

Ryousuke nei panni di Yui, in un remix androgino piuttosto azzeccato.
Credo di aver già speso troppe lodi per questa serie, ma davvero non posso che consigliarla di cuore a chiunque cerchi una storia che tratti la gestione del trauma in maniera così onesta nella sua brutalità, o a chi voglia leggere di storie queer meno incasellabili in una narrativa mainstream sempre “pulita” e perfetta di etichette ordinatamente divise e mai problematiche, dolorose o semplicemente difficili da indossare. Al netto dei difetti segnalati, è davvero una bella lettura: se anche i temi citati finora vi toccano solo marginalmente potreste trovare in queste pagine qualcosa di universale.
2 notes
·
View notes
Text
Bava, peli e agopuntura, ma anche tanto cuore: The School Nurse Files
Quando hanno annunciato l’uscita di The School Nurse Files su Netflix ho subito drizzato le orecchie. Ho visto esattamente zero k-drama fino ad oggi – romance e thriller non sono esattamente i miei generi preferiti – ma leggendo la premessa mi sono immediatamente convinta che potesse trattarsi di qualcosa molto più nelle mie corde; mi piacciono le storie che seguono un guardiano della soglia tra il quotidiano e il soprannaturale (vedi Mushishi), adoro i monster of the week e la pessima CGI, e soprattutto mi cattura subito quell’atmosfera a metà tra il ridicolo e la serietà che riesce a trasmettere il trailer. Mi sono quindi decisa a salvarlo nella lista dei desideri e ad aspettare l’uscita per decidere se vale la pena vederlo, visto l’entusiasmo con cui ho accolto il primo annuncio. Fin qua, storia terribilmente noiosa, tant’è che quando ho iniziato la visione non stavo nemmeno meditando di farlo diventare materiale per il blog, considerando che si tratta di una serie uscita su una delle più grandi piattaforme di streaming, con premesse tutto sommato riconducibili ad un filone del fantasy abbastanza popolare.
Tuttavia, non appena la serie esce succedono due cose. Uno, questi sei episodi non se li fila nessuno. Al mio radar internettiano non arriva un singolo parere sulla serie, positivo o negativo che sia, e rimane quindi in un limbo da cui non si schioda perché ho sempre qualcosa di più promettente da guardare, se non altro perché ho letto recensioni positive in merito. Probabilmente qualche blog specializzato in k-drama ne ha parlato, ma essendo fuori dal giro il silenzio è stato assordante, anche in confronto ad altri usciti nello stesso periodo. Due, quando finalmente mi decido a guardare la serie scopro il motivo per cui non l’ha vista nessuno: è completamente fuori di testa. Non potevo dunque certo esimermi dal segnalarla!

Uno dei poster promo della serie. Ecco, se vi sembra un filo strano sappiate che è solo l’inizio.
Nel corso di questi sei episodi seguiremo le vicende di Ahn Eun-young, che sin da piccola possiede la capacità di vedere “la bava”, una sostanza gelatinosa che si appiccica agli esseri umani e cresce in presenza di emozioni forti, positive o negative che siano; la nostra protagonista si renderà presto conto che essa può diventare dannosa o addirittura mortale se non controllata, e deciderà di dedicare la sua vita a combatterla. Per fare ciò, inizierà a lavorare in una scuola superiore come infermiera, cercando di gestire contemporaneamente il lavoro quotidiano e le sue attività da esorcista-guerriera – non tutta la bava è così semplice da eliminare come sembra. Tuttavia la scuola in cui lavora non è certo un edificio normale, e per fare fronte ai pericoli che minacceranno gli studenti Ahn Eun-young avrà bisogno di nuovi alleati… Come il professore di caratteri cinesi reduce da un misterioso incidente, che è anche il nipote del fondatore della scuola e potrebbe conoscerne i segreti più reconditi. A questa premessa interessante ma non particolarmente originale si aggiungono però una miriade di personaggi, spunti narrativi e bizzarrie assortite: in sei episodi avremo a che fare con un culto à la Scientology, un insolito triangolo amoroso, agopunturiste magiche, peli di tutti i generi e mostriciattoli dai poteri nefasti! Verrebbe da chiedersi se questa carrellata di cose non rischi di diventare un amalgama informe di avvenimenti senza capo né coda, ma la ragione che mi ha spinto a scrivere questa segnalazione è proprio il fatto che la storia che si riesce a ricostruire alla fine di tutto è sorprendentemente coerente e intelligibile, nonché spesso piuttosto divertente.
Sicuramente il punto di forza principale della serie risiede in come gestisce tutto questo ammasso di roba che ci si para davanti nel corso degli episodi. Ci troviamo improvvisamente gettati in questo marasma di creature sovrannaturali che funzionano in maniera piuttosto opaca, ma è molto facile rimanere rapiti proprio perché le spiegazioni sono comprensibili ma ridotte all’osso. Abbiamo quasi sempre abbastanza informazioni per interessarci alla buona riuscita delle azioni della protagonista, ma allo stesso tempo siamo incalzati dai numerosi dubbi che ci sovvengono ad ogni episodio: che cosa sta facendo ora Eun-young? Come funzionano i suoi rituali? Perché ci sono piccoli polipi chibi ovunque? The School Nurse Files è molto abile nel non trattare lo spettatore come un cretino che necessita di spiegazioni ad ogni piè sospinto, offrendo quel tanto di chiarimenti che bastano per entrare nel vivo della vicenda e del conflitto tra la nostra protagonista e gli eventi assurdi che le capiteranno; difficilissimo annoiarsi, proprio per la quantità di problemi aperti in ogni momento della serie, e soprattutto per le stranezze che divertiranno qualunque amante della narrativa fantastica meno tradizionale che si rispetti.

Una tranquilla lezione in una scuola coreana. Circolare, circolare, non c’è niente da vedere.
Ad un ottimo ritmo che rende la visione dei sei episodi davvero leggera si aggiungono anche una regia e dei dialoghi assai curati. Spulciando la pagina Wikipedia per cercare le informazioni di rito (tipo come diamine si scrivono i nomi dei protagonisti) ho immediatamente scoperto che Lee Kyoung-mi, regista e una dei due sceneggiatori, ha già un film acclamato dalla critica coreana all’attivo e ha pure lavorato con Park Chan-wook sul set di Lady Vengeance – insomma, non esattamente la prima scappata di casa. Tutta questa esperienza si riflette chiaramente nella cura per i dialoghi e per tutte le interazioni, anche quelle più semplici e transitorie: ciascuno dei personaggi intavola conversazioni brillanti, interessanti e spesso surreali con gli altri, che permettono di decifrare un po’ meglio tutti i coinvolti: viene spontaneo il paragone con Bakemonogatari, anche il flusso di parole al secondo è più contenuto; in particolare la protagonista e Hong In-pyo (il professore sopra citato) danno vita sia a siparietti divertenti ma anche a scambi insospettabilmente intimi ed emozionanti, considerando il tono grottesco della maggior parte della serie, che permettono di cementare una certa empatia nei loro confronti e soprattutto per la riuscita della missione di Eun-young.
Indubbiamente è proprio lei a brillare su tutti, grazie alla sua personalità decisamente atipica per un’eroina del genere: Eun-young è strana, scostante, spesso sgradevole e ha un incredibile senso del dovere; vive pochissima socialità tradizionale e tutti i rapporti che ha all’interno della serie sono tratteggiati in maniera vivida e brillante, dall’amica agopunturista ed esorcista part-time alla relazione (non specificherò di che tipo… ) con Hong In-pyo che ribalta le noiose dinamiche del ragazzo tormentato&misterioso aiutato dalla crocerossina di turno in maniere divertenti e originali. Vedere una protagonista così particolare in una serie tv mi ha fatto molto piacere, soprattutto considerando l’abilità della sceneggiatura nel farci provare empatia anche per una personalità così bislacca e sopra le righe: vogliamo che riesca a salvare tutti i suoi studenti dalle minaccie che incombono sulla scuola, ma anche che riesca a conciliare la sua vita da esorcista con la rigida società in cui si trova suo malgrado impigliata.

Eun-young impegnata a sparare a della bava particolarmente aggressiva. Sì, la pistola in plastica è un’arma d’ordinanza degli esorcisti.
Nonostante l’alta qualità dei dialoghi e la competenza nell’impilare una sopra l’altra questi tasselli di pazzia per costruire una torre che non crolli rovinosamente sotto il loro peso, la serie è semplicemente troppo corta per trattare ciascuno di questi con la competenza dovuta. Non mi ha affatto sorpreso scoprire che è tratta da un libro piuttosto corposo – intitolato, ehm, School Nurse Ahn Eun-young – e che gran parte del suo materiale è arrivato indenne alla stesura finale della serie: ci sono troppi personaggi, diversi dei quali avrebbero potuto essere fusi assieme senza danno per costruire archi narrativi meno sbrigativi e più emotivamente carichi; moltissimo minutaggio è dedicato a studenti che avranno poi un ruolo marginale in seguito, invece di focalizzarsi su due o tre persone da coinvolgere sistematicamente per la durata della serie. Sempre per mancanza di tempo da dedicargli, capita che alcuni dei nodi logici che tengono insieme la vicenda scricchiolino: la serie per la maggior parte è piuttosto abile nel mostrare solo l’essenziale, ma a volte anche quello manca e ci si trova a guardare una scena dalle dinamiche poco leggibili; non aiuta il fatto che il mondo sovrannaturale opera con regole e leggi abbastanza vaghe, che spesso possono lasciare confusi circa le reali dinamiche degli eventi.
Anche il finale soffre una cronica mancanza di spazio: non è un finale tremendo e troviamo risposta a quasi tutti gli interrogativi che ci assillavano, ma queste risposte sono presentate in modo eccessivamente sbrigativo, specialmente a fronte delle indagini degli episodi precedenti, e manca un po’ di impatto emotivo e di risoluzione dei rapporti tra diversi personaggi. È un peccato, considerando quanto la serie avesse brillato fino al sesto episodio, ma era anche la conclusione inevitabile di una produzione a cui è stata dato pochissimo respiro per raccontare una storia così ricca – o al contrario, della scelta di buttare troppa carne al fuoco per seguire il romanzo originale.
------------------------------------------------------ ANGOLO SPOILER --------------------------------------------------------------
Per esempio, l’incidente di Hong In-pyo non diventa mai rilevante per la storia, nonostante nei primi episodi sembri essere un mistero importante da risolvere. Anche il fatto che la Safe Happiness sparisca immediatamente dalla scuola senza alcuna conseguenza per i protagonisti appare un po’ forzato: davvero anche il campo di forza di Hong In-pyo smette di interessarli non appena la scuola viene distrutta? Sarebbe bastato un episodio in più per chiarire questi punti più oscuri.
---------------------------------------------------- FINE ANGOLO SPOILER -----------------------------------------------------------

Ringraziamo Netflix per l’impossibilità di fare screenshot delle cose di cui voglio parlare, sia mai che qualche pazzo là fuori scelga di guardarsi senza pakareh la serie usando gli screen dell’amico anziché digitando serie sub eng sulla barra di ricerca di Google. Un vaffanculo è sempre d’obbligo.
Insomma, The School Nurse Files è molto divertente, assolutamente fuori di zucca e sorprendentemente coerente: nonostante l’eccessivo affollamento di personaggi ed eventi che la rendono faticosa da seguire e non sempre limpida nei suoi salti logici (e talvolta del tutto incomprensibile), merita una visione se almeno qualcuno degli elementi che ho citato cattura il vostro interesse. La serie si trova su Netflix, ma in mancanza di un abbonamento ci sono tanti altri mezzi perfettamente legali e per nulla legati a criminose attività marittime per procurarsela: date una chance a questi soffici polipetti!
3 notes
·
View notes
Text
Quando una stella muore: Stars Die
Che c’è di meglio per risollevare gli animi di un po’ d’apocalisse? Mi pare proprio il periodo giusto per segnalare della narrativa appartenente all’ameno filone dell’orrorifico – specificamente, quella che parla di come gli esseri umani si comportano davanti alla fine del mondo. Alieni, guerre nucleari, carestie o una semplice influenza che si scopre contagiosissima e mortale: artisti di ogni genere sono (insospettabilmente?) prolifici nel descriverci gli ultimi giorni dell’umanità contro qualcosa più grande di lei, anche se forse mai come adesso, per qualche misteriosa ragione che proprio non riesco ad immaginarmi. Su una nota meno goliardica, sono però convinta che questo genere di storie non alimentino necessariamente solo ansia e terrore, ma che siano in grado di disinnescare la paura della morte, se lette con lo spirito giusto; leggere della fine del mondo può riconciliarci non solo con la nostra mortalità, ma con quella di tutte le cose: “mal comune mezzo gaudio” sarà anche una frase fatta un po’ troppo comoda, ma mi è sempre parso molto confortante sapere che tutto ciò che vive affronterà prima o poi la sua fine.
Certo, inscrivere il nostro personalissimo percorso dalla nascita alla dipartita in un ciclo universale può essere fonte di smarrimento e alienazione, specialmente quando toglie importanza alla nostra individualità, ma questa relativizzazione dell’importanza delle nostre paure e il suo inserimento in una dimensione comunitaria può anche essere tranquillizzante, seppur in maniera poco ortodossa. Insomma, leggere della fine del mondo può essere un passatempo terapeutico! Oppure solo un modo per passare qualche ora della vostra vita a guardare gente morire in modi creativi – lungi da me insinuare che non si tratti di una ragione più che valida per godersi qualche disaster story.

Certo, avrei potuto scrivere un post sulla fantascienza apocalittica senza citare una canzone di Giorgia, ma mi piace pensare di aver reso il mondo un posto migliore scegliendo di non farlo.
La segnalazione di oggi è un videogioco – tecnicamente un walking simulator, ma non riapriamo quel dibattito – di ispirazione dichiaratamente lovecraftiana che ci cala nei panni di Dybowski, una misteriosa osservatrice che arriva con una barca su un’isola sorta in mezzo al mare dopo una criptica conversazione con un interlocutore a cui promette di registrare tutto ciò che succederà. Sembra che la sua presenza lì sia dovuta ad una crisi causata da un Varco (Hole) comparso al centro dell’Europa pochi anni fa; esso ha dato inizio ad un’ondata di malattia e di morte ancora inspiegabile, ma un piccolo gruppo di ricercatori, convinti che l’isola sia l’unica speranza di salvezza per l’umanità, vi si sono recati per studiarla e comprendere che cosa sia e perché sia comparsa all’improvviso in concomitanza con l’aggravarsi della malattia del Varco. Una volta messo piede sull’isola, però, Dybowski ha davanti a sé completa libertà: è possibile interagire con gli scienziati presenti e scoprire le motivazioni che li hanno portati lì e le scoperte che hanno fatto fino a quel momento, ma è una scelta altrettanto valida quella di esplorare l’isola per conto proprio, senza badare minimamente alle altre persone presenti sul sito di ricerca. Il modo in cui sceglieremo di passare il tempo ci indirizzerà verso un finale in cui avremo alcune risposte circa il destino del mondo e l’origine del Varco, nonché sul passato di alcuni personaggi, protagonista compresa.

Tutto normale. Il gioco è un po’ meno giallo di così, ma qualcuno ha dimenticato di disattivare flux prima di fare qualche screenshot.
L’ambiente nel quale ci muoveremo per la mezz’ora necessaria ad arrivare al primo finale è indubbiamente spiazzante. L’isola è a tutti gli effetti una gigantesca massa di carne aliena, piena di protuberanze, bozzi e conformazioni anomale del terreno; la torre che svetta su tutta l’isola (ribattezzata Hollow Tower) è un alto ammasso di tunnel e cavità dai colori bizzarri e dalla consistenza viva. La resa complessiva è parecchio inquietante, considerando anche i ristretti mezzi tecnici del videogioco indie, anche grazie al filtro pixellato che permette di nascondere i limiti più evidenti del motore grafico e di rivelare le forme più strane della flora dell’isola gradualmente man mano che ci si avvicina, aumentando il senso di meraviglia di fronte a queste strutture incomprensibili; siamo oltretutto gettati in una situazione in cui abbiamo pochissimi riferimenti su dove andare o che cosa cercare. Infatti la premessa del gioco, carica di urgenza per un mondo che ha i giorni contati, permette agli altri personaggi di offrire solo spiegazioni scarne e minimali, presupponendo dettagli geopolitici che la protagonista conosce ma il giocatore certamente no; unendo questa prima confusione con la natura aliena dell’isola in gran parte inesplorata – niente bussola e niente mappa: le indicazioni degli scienziati sono l’unica guida che abbiamo – l’esperienza di Stars Die consiste in larga parte nell’interfacciarsi con misteri e problemi che comprendiamo in maniera molto parziale. È una scelta che per forza di cose alienerà molti giocatori e che in certi momenti risulterà frustrante, ma è senz’altro la più coerente per un horror che, cogliendo il senso dei migliori racconti di Lovecraft, vuole mettere a confronto l’uomo con l’assolutamente Altro: l’alieno, una forma di vita talmente differente da quelle a cui siamo abituati che ogni interazione con essa non può che generare fraintendimento, confusione e terrore.

Eldridge che scruta il cielo. Tra pochi secondi inizierà ad urlarci contro, ma sua discolpa siamo effetivamente un po’ delle teste di cazzo.
Infatti l’Altro con cui Dybowski si interfaccerà nel corso della ricerca sarà mistico e sfuggente: se iniziate quest’esperienza sperando di ottenere tutte le risposte sul Varco e sull’epidemia mortale che ha colpito l’umanità, arrivati ai titoli di coda sarete pronti a lanciare il mouse contro il muro. Il gioco fornisce naturalmente una serie di interpretazioni e di punti di vista sul rapporto che si costruisce tra le strutture dell’isola e il resto dell’umanità, ma di fronte al contatto con entità non-umane è impossibile comprendere appieno i nessi causa-effetto e le motivazioni che li hanno portati fino a noi; paraculo? Per la maggior parte del gioco mi sento di dire di no. I finali migliori di Stars Die sono sicuramente quelli che riescono a dosare con abilità il fascino dell’ignoto e le sequenze d’impatto che ci mostrano in che modo l’isola misteriosa è collegata al destino della Terra, coerentemente con le nostre scelte finali. Ciascuno dei membri del team di ricerca ha infatti le proprie motivazioni per essere lì e un’idea precisa su che cosa sta succedendo: a seconda di chi scegliamo di supportare verso la fine vedremo il finale da diversi punti di vista e descritto coerentemente con essi, dal militare Eldridge che è lì perché tiene famiglia alla fredda capo-spedizione Miyazawa che vuole assicurare un futuro all’umanità con ogni mezzo necessario.
Purtroppo non tutti i finali sono all’altezza delle premesse. Quelli che portano a rimanere per l’inizio della fine permettono effettivamente di ottenere qualche risposta in più circa la natura dell’isola e delle entità responsabili dei suoi fenomeni più bizzarri, ma gli altri sono frettolosi e poco significativi in termini di contenuto (quello di Eldridge in particolare), limitandosi ad un effetto shock seguito dai titoli di coda, senza nemmeno farci ottenere qualche informazione in più sul personaggio principale dell’ending; la curiosità spinge immediatamente a cercare gli altri finali ricominciando a giocare, ma più si ripete l’esperienza e più ne vengono messi a nudo i limiti. Uno degli elementi più interessanti e originali del gioco dovrebbe essere lo svolgimento in tempo reale, per cui è possibile mancare eventi o conversazioni a seconda di come si sceglie di impiegare il proprio tempo: ci si potrebbe aspettare che ciò abbia un impatto significativo sulle scelte del giocatore e sul finale, ma non è così; troppo spesso la scelta è tra “assistere ad una conversazione” o “non fare nulla”, considerando anche la scarsa interagibilità degli elementi dell’isola, e all’atto finale potremo comodamente parlare con tutti i personaggi disseminati nella zona di gioco prima di fare la nostra scelta, con una sola eccezione. Ad una struttura molto più lineare del previsto che allontana replay dopo replay il senso di urgenza dal giocatore si aggiungono anche dei dialoghi rigidi e tremendamente innaturali, spesso anche privi di punteggiatura (le maledette virgole!), che tendono alla sbrodolata filosofica più che ai ritmi di una naturale conversazione, anche tenendo in conto delle circostanze particolari in cui avvengono. Insomma, una serie di mancanze che rendono l’esperienza ripetuta per la caccia ai finali un’esperienza più seccante che coinvolgente; il mio consiglio è quello di giocarlo al massimo due volte e arrivare almeno ad un finale che coinvolga Rygg o Miyazawa, che sono quelli più ricchi di interazione con le forme di vita aliene che dovrebbero essere al centro della storia raccontata.

Senza filtro si vede tutto un po’ più nitidamente, ma alcune texture smettono di avere senso; se non avete problemi di vista consiglio di tenerlo attivato.
Facendo un rapido bilancio, le mie considerazioni possono sembrare meno entusiaste rispetto a quelle fatte in segnalazioni precedenti, e a tutti gli effetti Stars Die è, a causa di limiti tecnici e di storytelling, un’esperienza adatta ad una nicchia di giocatori persino più piccola di altra narrativa che ho consigliato; tuttavia, se siete fan di Lovecraft e l’atmosfera degli screenshot vi ispira abbastanza, consiglio di investire una mezz’ora del vostro tempo: costa poco, si può ottenere anche gratis da un drive su itch.io per volontà stessa dello sviluppatore (ma se potete cacciate il denaro, ché son meno di cinque euro), ed è una tra le esperienze nel panorama indie fantascientifico duro&puro che mi è rimasta più impressa degli ultimi tempi.
1 note
·
View note
Text
Carcinizzazione fuori controllo: Chelabron
Non sono un’amante dell’high fantasy. Com’è facile intuire, considerando che ho aperto un blog di narrativa insolita, quando leggo speculative fiction desidero soprattutto scoprire mondi il più possibile alieni rispetto a quello in cui, in mancanza di imprevisti à la isekai, mi toccherà passare il resto dei miei giorni; difficilmente l’high fantasy uscirà dai paletti piuttosto rigidi che il sottogenere impone, ed è raro quindi che mi regali autentici momenti di meraviglia. Amo alla follia il New Weird, e sono costantemente a caccia di romanzi con ambientazioni ricche di sistemi magici complessi, animali mostruosi, biomi in cui le leggi fisiche sono alterate in modi imprevedibili e fondamentali: ancor più della fantascienza, il fantasy permette di immaginare le interazioni uomo-natura più impensabili e dalle conseguenze più interessanti da esplorare, che siano filosofiche, biologiche, fisiche o una qualche combinazione delle tre. Immaginate la mia gioia quando finalmente sono riuscita a leggere anche qualche scrittore italiano che si è allontanato dai sentieri battuti del fantasy tolkeniano, con qualche deviazione occasionale nell’urban YA e nel (sigh) paranormal romance, per avvicinarsi alle bizzarrie che mi sono tanto care.
Titania Blesh è una di queste. L’ho conosciuta inizialmente grazie ad Acheron Books, che mi ha fatto scoprire il suo A colpi di Cannonau: non essendo i pirati cosa mia (Black Sails a parte, s’intende) ho però virato immediatamente su Chelabron, edito dalla Dark Zone, che fin dalla sinossi sembrava invece assai più nelle mie corde. In un mondo abitato da minacciosa e letale megafauna, l’unica garanzia di sopravvivenza per la specie umana sembra risiedere nella simbiosi con i granchi locali, sul cui dorso vengono costruite intere città; Niniin, abitante di una prospera cheliopolis, desidera diventare Cerebrale e far parte della ristretta élite che ha l’onore di controllare il Granchio Rosso attraverso una delicata combinazione di ormoni e manipolazione neurale – ma l’esame è complesso e tutti cercano di metterle i bastoni tra le ruote, dai suoi genitori fino all’insopportabile ma geniale Sandros, Cerebrale di punta della cheliopolis. Ad Aquaforta, invece, Arenaria è convinta che la colonia si stia approssimando alla fine: il granchio su cui vivono è immobile da anni, la carestia strazia gli abitanti, ma suo padre si rifiuta di indurre l’artropode al movimento; la scoperta di un’arma leggendaria potrebbe però cambiare definitivamente la sorte della cheliopolis… Ma a che prezzo?

In copertina: Arenaria e il Chelabron. Not depicted: la sua scorta infinita di battute orribili.
Fin da subito il romanzo si distingue per l’ambientazione science-fantasy piuttosto originale. Forse costruire città su dorsi di animali giganti non è un’idea così nuova, ma il rigore e la cura con cui il mondo abitato dalle nostre protagoniste è progettato e tutti i piccoli dettagli che permettono di comprendere in che modo vivono gli abitanti delle cheliopolis rendono la lettura una continua scoperta. Si tratta di un’ambientazione poco science e molto fantasy ma piuttosto coerente, che nonostante qualche sbavatura – fatico a credere che abitanti di città separate da centinaia di anni parlino la stessa lingua – ricostruisce un microcosmo complesso e interessante da esplorare. Nonostante sia necessario acclimatare il lettore in un’ambientazione in cui sono presenti parecchi concetti alieni o almeno non immediatamente ovvi, Blesh si rifiuta di piazzare lunghi paragrafi di spiegoni in cui ci racconta vita, morte e miracoli della megafauna, o sgradevoli as you know, Bob in cui i personaggi informano il lettore di cose che sanno già: complice anche la prima persona, ma soprattutto una scrittura limpida che punta all’immersività totale, tutti i concetti necessari vengono introdotti a tempo debito e sempre saldamente dal punto di vista di Niniin o di Arenaria, ciascuna con una voce ben distinta e molto godibile. Ci sono davvero poche pulci da fare allo stile, anche se ogni tanto mi è capitata sotto gli occhi qualche frase sgradevole o dei dialoghi un po’ legnosi – un vero peccato, visto che sembra un problema di (mancanza di) editing piuttosto che di prima stesura: sono parti facilmente limabili e la scrittura è di solito assai trasparente e permette di entrare comodamente nella testa delle nostre protagoniste.
Non era a posto un corno di niente.
[...] si stava prendendo ad amichevoli pugni [...]
Abbassò il fucile di qualche grado [...]
“Se non è l’eroina della Tragedia di Tantaariat!”
Alcune frasi un po’ innaturali (corsivo mio). Va anche detto che il tono del romanzo è piuttosto scanzonato e pieno di espressioni molto colloquiali, e c’è molta soggettività nel decidere che cosa “suona bene” e cosa no.
Infatti il secondo grande punto di forza del romanzo è proprio il filtro con cui sia Niniin che Arenaria percepiscono gli eventi del romanzo; non solo abitano in due cheliopolis diverse, ma appunto per questo sono immerse ciascuna nella propria cultura e nei propri schemi mentali. Le colonie non sono interscambiabili: ciascuna di queste è politicamente organizzata in modi specifici, ha cultura e convinzioni circa il granchio che li ospita radicalmente diverse e utilizza modalità per manipolarlo che differiscono persino nei termini utilizzati: Chelabron/Kelabron, Cerebrum/Cerebellum... Persino termini comuni come babbo/papà variano, permettendoci immediatamente di riconoscere il punto di vista che stiamo seguendo, senza nemmeno bisogno del nome ad inizio capitolo. Buona parte del romanzo ruota attorno ad un conflitto armato che porta all’incontro tra popolazioni diverse, con tutte le difficoltà e i rischi che ciò comporta: le pagine che descrivono l’interazione tra gli abitanti di Aquaforta e quelli di Sococos sono tra le più interessanti del libro, ed è un peccato che non siano tante, visto che la maggior parte sono dedicate ai conflitti dei “piani alti” che coinvolgono i genitori di Niniin, i Generalissimi, e la Maiora, che gestisce i Cerebrali e le influenze che possono avere sul Granchio Rosso. Anche il rapporto di ciascun personaggio con il Granchio e il modo in cui le società delle cheliopolis si relazionano con la megafauna è un tema centrale, ed è indubbiamente uno dei più intriganti; il rapporto simbiotico che lega le specie si collega ai misteriosi poteri del Chelabron, l’arma che dà il titolo al libro, ed è al centro della narrazione di Niniin, che ha studiato per anni il Granchio Rosso e ne è rimasta affascinata. La nostra protagonista è schiacciata tra il Cerebrum e l’esercito, e nel corso della storia sarà costretta a prendere decisioni sempre più difficili per poter diventare una Cerebrale, lottando contro i genitori guerrafondai ma anche contro il suo terrore paralizzante della violenza.

Adorabile, vero? Ora immaginatevelo gigante. Rassicurante come il muso di un Eva in berserk che fa capolino dalla vostra finestra al sesto piano.
Niniin è un’ottima protagonista: è facile solidarizzare con lei per la sua vita faticosa di secondogenita, ignorata dai genitori perché bollata come vigliacca e segnata dalla tragedia che colpì Sococos quando lei era ancora bambina; viene naturale fare il tifo per lei e avversare istantaneamente Sandros, il rivale che le impedisce l’accesso al Cerebellum con piccolezze di ogni genere, e man mano che ci avviciniamo alla fine l’ansia per il suo destino è palpabile. Il suo arco del personaggio ruota tutto intorno allo sconfiggere la paura, e anche nei suoi momenti di codardia e di indecisione riusciamo bene a comprendere le sue motivazioni e a provare empatia per lei: vogliamo che sconfigga i suoi demoni e che riesca ad arrivare ai suoi obbiettivi. Purtroppo al suo punto di vista si affiancano le pagine dedicate ad Arenaria, che è una protagonista decisamente più debole.
In teoria l’aspirante eroina di Aquaforta sarebbe stata un ottimo contraltare alla paurosa e insicura Cerebrale, con la sua spacconeria e la sua propensione all’azione (per non parlare dei suoi terribili giochi di parole); tuttavia, nonostante inizialmente sembri che la sua evoluzione si costruisca in maniera speculare a quella di Niniin – dal coraggio irresponsabile alla cautela ragionata – le sue azioni, anche quelle dalle conseguenze drammatiche, non diventano il motore di nessun cambiamento significativo. Senza addentrarsi in spoiler eccessivi, ad un certo punto del romanzo Arenaria fa una scelta impulsiva che diventa una delle concause del disastro principale narrato nel romanzo; sembra un momento catartico per l’inizio di una trasformazione, ma Arenaria dedica pochissimi pensieri alle sue responsabilità e anzi liquida queste difficoltà con un “vabbè, alla fine è stato necessario” – conclusione potenzialmente interessante ma troppo rapida e indolore per costituire un momento di pathos. Non c’è un vero e proprio arco di trasformazione parallelo a quello di Niniin, o un altro tipo di evoluzione, e proprio per questo si fatica a sentire attaccamento per una protagonista così statica e immune al cambiamento; mi ha stupito, specialmente in un romanzo così attento per altri versi ad una costruzione drammatica soddisfacente.
------------------------------------------------------ ANGOLO SPOILER --------------------------------------------------------------
Anche alcuni punti di trama mi hanno lasciato un po’ perplessa (once again, SPOILER! Smettete di leggere qui e filate a leggere Chelabron, che ne vale la pena): la coincidenza del ritrovamento di Tantaariat proprio alla fine del romanzo, considerando le distanze percorse e la quantità di cheliopolis in giro mi pare un filo troppo fortuita, ma anche la necessità della Maiora di usare un Cerebrale per sabotare il neurone riproduttivo mi sembra poco credibile – d’accordo, c’è il rischio di danneggiare il granchio sparando o colpendo il neurone a distanza, ma mi sembra comunque un’alternativa migliore del sacrificio vano di diversi Cerebrali e di centinaia di altre persone per le migrazioni del granchio, almeno dal suo punto di vista.
---------------------------------------------------- FINE ANGOLO SPOILER -----------------------------------------------------------
Nonostante una protagonista poco incisiva (su due, però) e qualche dialogo un po’ innaturale, Chelabron racconta una storia interessante in un mondo originale e ben costruito, ricco di elementi affascinanti le cui implicazioni sono abbastanza ben esplorate; se a ciò aggiungiamo anche uno stile che ha ben in mente che cosa fare per coinvolgere il lettore in prima persona, sono ben felice di passare sopra ai suoi difetti per godermi un romanzo che parla di granchi giganti. Meglio, un romanzo che parla di granchi giganti pieno di dad jokes fatti da una figlia! Questa sì che è vera sovversione dei ruoli di genere.
1 note
·
View note