#accoglienza nel medioevo
Explore tagged Tumblr posts
Text
“Sant’Andrea in Contesto”: Convegno Internazionale su Assistenza e Ospitalità nel Medioevo a Vercelli e Novara. Due giornate di studio e riflessione per celebrare gli 800 anni dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli e approfondire il ruolo degli ospedali medievali
L'8 e il 9 novembre 2024, Vercelli e Novara ospiteranno il convegno internazionale “Sant’Andrea in Contesto. Assistenza, ospitalità e ospedali presso monasteri e canoniche regolari del medioevo europeo”, un evento organizzato dall’Università del Piemonte
L’8 e il 9 novembre 2024, Vercelli e Novara ospiteranno il convegno internazionale “Sant’Andrea in Contesto. Assistenza, ospitalità e ospedali presso monasteri e canoniche regolari del medioevo europeo”, un evento organizzato dall’Università del Piemonte Orientale (UPO) per celebrare l’ottocentesimo anniversario dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli. Questo incontro, in collaborazione con il���
#&039;Università del Piemonte Orientale#accoglienza nel medioevo#Alessandria today#Alessandro Barbero#antichi ospedali#architettura monastica#assistenza ai viandanti#Campus Perrone#canoniche regolari#Commemorazione#conoscenza del medioevo#Convegno internazionale#convegno storico#Cripta di Sant’Andrea#cultura medievale#cultura religiosa#cura dei bisognosi#cura nel medioevo#dibattito storico#divulgazione culturale#Eleonora Destefanis#eventi Novara#eventi Vercelli#Fondazione Comunità Novarese#Google News#Incontro pubblico#italianewsmedia.com#medioevo europeo#Ministero della Cultura#monasteri medievali
0 notes
Text
IL COMMENTO
Trattato come un delinquente. Prima del processo aveva subito un provvedimento di allontanamento da Riace. Non poteva rientrare nel suo paese nemmeno per fare visita al padre vecchio e malato. Considerato peggio di un mafioso. Si dà il caso, però, che Mimmo Lucano non sia un mafioso, ma un cittadino onesto, buono e generoso. Una testa dura, come tante in Calabria. Ci troviamo di fronte ad una contraddizione clamorosa tra legge e giustizia. Non sempre la legge va d’accordo con la giustizia. Spesso per fare o avere giustizia si deve cambiare una legge. È stato fatto tante volte. Ma è un processo lungo e laborioso. Richiede a volte battaglie, movimenti, petizioni popolari, referendum, prima che il parlamento si decida a cambiare una legge ingiusta o a promuovere dei diritti. È stato così per lo Statuto dei lavoratori. È così per lo ius soli. È stato così per il delitto d’onore, per l’aborto, per il divorzio, e tanti altri esempi si potrebbero fare. Il diritto, che sta alla base della legge, si evolve, segue la storia, si aggiorna in base ai mutamenti storici e politici. Al tempo dei greci e dei romani, la schiavitù non era illegale. Nel medioevo i privilegi feudali e la servitù della gleba erano legali. Il diritto non è neutro. Il più delle volte si limita a codificare norme, convenzioni, costumi, già in uso. Trasforma in legge lo status quo. In genere prende atto dei rapporti di potere. Con la rivoluzione francese la borghesia nascente rovescia il vecchio mondo feudale, plasmato a misura dell’aristocrazia, stretto da vincoli, privilegi e regole che impedivano l’accumulazione del capitale, il libero mercato e lo sviluppo industriale. Per andare a tempi più recenti, durante i governi a guida Berlusconi abbiamo visto anche leggi ad personam, reati declassati o spariti dal codice da un giorno all’altro. Il diritto, dunque, è stato sempre modellato sulla base degli interessi della/e classe/i al potere. È la storia. Fuori della storia e del buon senso sono i giudici di Locri. Per fare funzionare il modello Riace, un modello di accoglienza e di inclusione studiato in tutto il mondo, Mimmo Lucano ha dovuto infrangere leggi vecchie e inadeguate. Come quella, ad esempio, che non dà diritto ai bimbi che nascono e studiano in Italia di avere la cittadinanza. O come quella che nega la casa popolare, il diritto ad un alloggio agli immigrati regolari che sono residenti in Italia da meno di 10 anni. Mimmo Lucano si è inventato il lavoro, ha messo in movimento un’economia asfittica. E per fare questo ha dovuto inventarsi perfino una moneta alternativa. Un modo che permettesse ai nuovi arrivati di vestirsi e di mangiare, fino a quando il ministero dell’Interno, guidato allora da Marco Minniti ( e poi da Salvini), non si fosse degnato di trasferire un po’ di soldi per pagare i fornitori. A Riace case, botteghe artigiane, negozi, avevano riaperto i battenti. Il paese si era ripopolato, ritornando a nuova vita, al contrario di tanti paesi morti della Calabria. Ai coccodrilli che piangono per i borghi abbandonati, il sindaco di Riace aveva mostrato una via concreta per la rinascita. Un’alternativa allo spopolamento e all’abbandono dei villaggi. Dopo la rottura del latifondo e la riforma agraria, la Calabria è entrata nella modernità pagando un prezzo altissimo in termini di emigrazione. Ha fornito braccia a buon mercato allo sviluppo industriale del Nord e dell’Europa. Ha distrutto un artigianato fiorente che non ha retto l’urto del mercato dei prodotti industriali. Anche molti che avevano beneficiato della riforma agraria hanno abbandonato le campagne per lo scarso sostegno pubblico, indirizzato soprattutto ad agevolare l’attività edilizia e commerciale, oltre che posti di lavoro nella pubblica amministrazione. La Calabria diventa terra di consumo. Si sviluppa un’economia dipendente e funzionale alla crescita economica delle regioni centro-settentrionali. Con un ceto politico attento solo ad intercettare i flussi di spesa pubblica e a gestire affari e malaffari. In questo contesto non c’è posto per la Calabria dei villaggi, per le comunità rurali, collinari e montane. Mimmo Lucano ci ha fatto intravedere (in una piccola realtà) un’alternativa possibile, un modo innovativo e solidale per far rinascere i nostri borghi. Scontrandosi con l’ottusità della burocrazia e con politici attenti al loro tornaconto personale. Nel frattempo, Marco Minniti, dopo avere avuto tutto (e di più) dal suo partito, si è seduto sul comodo treno della Fondazione Leonardo. Mimmo, invece, se l’è dovuta vedere con magistrati che invece di perseguire l’illegalità mafiosa hanno acceso i riflettori sui suoi reati. Commessi con la convinzione di fare del bene. Era l’unico modo per salvare vite, per fare andare avanti una vera integrazione, per sbloccare situazioni impigliate nei meandri della burocrazia e o ritardate da leggi inadeguate. Mimmo Lucano è un «fuorilegge», ha agito in difformità di leggi ingiuste o sbagliate che non gli permettevano di agire a favore degli immigrati e degli abitanti di Riace. Non è certo un ladro o un criminale, come ce ne sono tanti anche in doppio petto. Questa condanna è una vergogna. Una grave ingiustizia. Chi non accetta le ingiustizie e si batte per il cambiamento non ha che schierarsi con lui, mostrando che non è solo e isolato, ma un punto di riferimento. Il voto del 3-4 ottobre è l’occasione. È il modo per esprimergli, non solo a parole, solidarietà. Gaetano Lamanna
22 notes
·
View notes
Text
Modena tra Guelfi e Ghibellini
Nel 1152, l’elezione di Federico I di Hohenstaufen, detto Barbarossa, a imperatore portò al potere un sovrano energico e deciso a far rispettare la sua legittima autorità sui comuni italiani (richiese, ad esempio, di essere lui a nominare i consoli). Nel corso delle sue spedizioni in Italia distrusse Asti (1154), Crema (1160) e, infine, Milano (1162), la più potente delle città avverse all’imperatore. Sottomise anche Roma, ma fu costretto a battere in ritirata per via di un’epidemia che decimò l’esercito imperiale. Con l’imperatore in Germania, i comuni si riorganizzarono nella Lega Lombarda (dicembre 1167) e lo sconfissero nella celebre battaglia di Legnano (29 maggio 1176). Si arrivò, così, alla tregua siglata con la Pace di Venezia (1177) e alla Pace di Costanza, dove si riconobbe la libera elezione dei consoli e l’autonomia comunale. Privi di un comune nemico, le città italiane ritornarono alle loro lotte tra fazioni, fino all’arrivo di un altro imperatore, Federico II, nipote del Barbarossa e Re del Regno di Sicilia. Incoronato nel 1215, ottenne l’appoggio di città come Pavia e Cremona e di signori feudali come Ezzelino da Romano, minacciando nuovamente i comuni, che di conseguenza riesumarono la Lega Lombarda (1226). Si arrivò alla guerra e Federico II riuscì ad avere la meglio a Cortenuova (1237), ma il valore delle sue vittorie fu minato dalle ribellioni in Germania, che lo costrinsero a distogliere l’attenzione dall’Itali, e dal Papa Innocenzo IV, che sosteneva i comuni nella loro lotta antimperiale, arrivando persino a scomunicare Federico II. Fu in questi anni che comparvero, nel contesto fiorentino, i termini “guelfo” e “ghibellino”, rispettivamente nel 1239 e nel 1242 negli anonimi Annales. Se ne ebbe, poi, notizia in una lettera dei Capitani fiorentini della “… pars guelforum …” (1248); nella cronaca fiorentina del 1248, compresa nel Chronicon de mundi aetatibus del notaio piacentino Giovanni Codagnello (Johannes Caputagni); in una lettera di Federico II (1248), in un registro di delibere di S. Gimignano (1248) ed in due lettere papali (1248 e 1250).

Le origini dei nomi risalgono alla lotta per la corona imperiale dopo la morte dell’imperatore Enrico V (1125) tra le casate bavaresi e sassoni dei Welfen (pronuncia “velfen”, da cui la parola guelfo) con quella sveva degli Hohenstaufen, signori del castello di Waiblingen (anticamente Wibeling, da cui la parola ghibellino). Successivamente, dato che la casata sveva acquistò la corona imperiale e, con Federico I Hohenstaufen, cercò di consolidare il proprio potere nel Regno d’Italia, in questo ambito politico la lotta passò a designare chi appoggiava l’impero (Ghibellini) e chi lo contrastava in appoggio al papato (Guelfi).
Tra la fine del XII secolo e la metà del XIII, in quasi tutti i Comuni di formarono due partiti che, pur recependo le originarie contese dinastiche germaniche, le modellarono sulla realtà italiana e municipale. Ora in Italia, poiché il Papa parteggiava per le casate guelfe, questa parte divenne il partito del Papa; del pari i ghibellini, persa la contraria coloritura dinastica, divennero il partito imperiale. Né tanto bastò, perché la complessa articolazione delle fazioni interne ai Comuni finì per generare in ciascuna città formazioni politiche i sottordine, spesso legate a consorterie plurifamiliari e clientelari.
“Si pensi alle acerbe contese tra fazioni nominalmente guelfe (le prime) e ghibelline (le seconde): a Firenze (1216) tra Fifanti e Uberti e tra Buomdelmonti ed Amidei; a Pisa fra Pergolini e Raspanti; a Genova (1241) fra Raspini e Mascherati; a Modena tra Anginoni e Fregnanesi detti Gualandelli (1188) e, poi, fra Aigoni (o Aginoni) e Grasolfi; a Bologna fra Geremei e Lambertazzi e tra Scacchesci e Maltraversi; ad Arezzo fra Parte Verde e Secchi; a Verona tra Capuleti e Montecchi.”[1]
S’instaurarono situazioni complicate, dove le nominali appartenenze guelfe e ghibelline non riescono da sole a spiegare lotte che hanno nelle faide familiari la loro matrice preponderante; il tutto aggravato dalle catene clientelari che accompagnavano ogni famiglia notabile, in cui le famiglie erano divise tra obbedienze ad una parte rispetto all’altra. Infine, nello stesso partito vi erano interminabili faide e repentini cambi di schieramento, seguiti da lunghi esili e bande di fuoriusciti (uno per tutti Dante Alighieri).
“Questi, poi, scacciati dalle loro città, cercavano in altre accoglienza e supporto per vendicarsi in armi della parte avversa. Si noti che la pluralità di gruppi e di interessi fu una costante dell’inurbamento, anche fuori d’Italia. Ora, però, mentre nelle città estere la tendenza prevalente fu la collaborazione fra i vari gruppi, nei comuni italiani lo scenario dominante fu una generalizzata conflittualità"[2]
La guerra proseguì sanguinosa fino alla sconfitta degli imperiali a Fossalta, vicino Modena, dove il figlio di Federico II, Enzo, fu preso prigioniero dai bolognesi (1249). La sua prigionia a vita diede il nome ad uno dei più famosi edifici cittadini, il Palazzo Re Enzo. La morte l’anno successivo di Federico II e la sconfitta dei suoi eredi nelle battaglie di Benevento (1266) e Tagliacozzo (1268) causò la perdita della corona imperiale e la dissoluzione successiva del partito ghibellino.
La stessa parte guelfa subì una profonda spaccatura. I guelfi si divisero in Neri, filo-papali, e Bianchi, moderati filo-imperiali. Storica in Firenze la lotta infinita e crudelissima che oppose le famiglie dei Donati, guelfi neri, e dei Cerchi, guelfi bianchi. Per il vero, tale sviluppo partitico non aveva quasi più legame con le iniziali fazioni dinastiche: i comuni erano in una guerra civile perenne, totalmente slegata dallo scontro Papato-Impero che aveva caratterizzato il Medioevo fino ad allora, mostrando la loro perdita di prestigio e di potere e la loro fine quali potenze sovra-nazionali.
Ciò non impedì agli Italiani di darsi battaglia sotto tali insegne per molto tempo.
È questo il caso di Modena e Bologna, con i primi da sempre ghibellini e i secondi filopapali. In un contesto di scontri per il possesso di alcuni castelli fortificati lungo il confine (Bazzano, Savigno, Monteveglio e Zappolino), i Bolognesi, guidati da Malatestino Malatesta, si spinsero nei territori di Passerino Bonacolsi, signore di Modena e Mantova, saccheggiandoli e scatenando la reazione dei modenesi, che conquistarono il castello di Monteveglio. Nella località nota come Ziribega, il 15 novembre 1325 si affrontarono il più numeroso esercito bolognese (35 mila/25 mila fanti e circa 2500 cavalieri) e il meglio addestrato esercito modenese, che poteva, però, contare su meno di 10 mila soldati di cui meno di 3 mila cavalieri. In aggiunta, Malatestino era giovane e inesperto e il capitano del popolo di Bologna, Fulcieri da Calboli, era accusato di essere un codardo, mentre l’esercito modenese era comandato da Rinaldo d’Este, comandante in capo dell’esercito ferrarese e dell’armata ghibellina, dal succitato Bonaccolsi, comandante esperto e spietato, da Azzone Visconti, figlio di Galeazzo Visconti, signore di Milano, a capo della cavalleria, coadiuvato dai ghibellini bolognesi Ettore da Panico e Muzzarello da Cuzzano, sanguinario signore dell’alta valle del Samoggia. Quest’ultimo conosceva perfettamente i luoghi dello scontro e questo fu decisivo per le sorti della battaglia.
Dopo alcune scaramucce la battaglia fu aperta solo nel pomeriggio dalla carica di Azzone Visconti, che colpì il centro dello schieramento bolognese presso i Prati di Saletto, il quale si ritrovò presto intralciato dal suo stesso numero in un terreno così difficoltoso. Nelle sue file di diffuse il panico e, approfittando del buio, i bolognesi si diedero alla fuga, lasciando sul campo circa 3000 morti. I vincitori li incalzarono fin sotto le mura di Bologna, schernendo i difensori con palii e giostre, ma ben sapendo di non avere le forze per assediarla. Si accontentarono di distruggere i castelli lungo la strada per Bologna e di “rapire” una secchia di legno, ancora oggi custodita nella Torre Ghirlandina e resa famosa dal poema eroicomico di Alessandro Tassoni, pubblicato nel 1624. Senza di esso la vicenda sarebbe stata probabilmente dimenticata, poiché la battaglia non portò a nessun cambiamento di fondo negli equilibri politici della regione.

Vittorio Trenti
Questo articolo è stato pubblicato sul Cimone, il notiziario del CAI di Modena. Per scaricarlo Cliccate Qui
Bibliografia V. Lenzi, La battaglia di Zappolino e la secchia rapita, Il Fiorino 2001 F. Menant, L’Italia dei comuni, Viella 2011 A. S. Scaramella, Le Guerre tra Guelfi e Ghibellini, Chillemi 2015 [1] e [2] http://zweilawyer.com/2017/10/16/guelfi-e-ghibellini/
#lookingforpiteco#pitechi#cultura piteca#storia#history#guelfi e ghibellini#secchia rapita#Vittorio Trenti#CAI Modena#Cimone
2 notes
·
View notes
Text
Ghironda, violino e la cornamusa. La musica de L'Orage, una super band folk valdostana. / Il Bullone - OrianaG, Eleonora Bianchi e Debora Zanni
Pubblicato su Il Bullone n° 35, maggio 2019.
Il nuovo album de L'Orage, band folk valdostana, "Medioevo digitale", è uscito ad aprile. Suoni tradizionali su testi che toccano l'attualità di cui anche Il Bullone si sta occupando da tempo: migranti, tecnologia, confronto generazionale...
Abbiamo ascoltato il CD in anteprima e intervistato Antonio Visconti, voce e chitarra della band.
«Il punto del disco è riprendere il filo di un discorso già iniziato, e molto elaborato, ma interrotto con l'attentato alle Torri Gemelle, che ha dato il via al nuovo terrorismo. Prima dell'11 settembre, al G8 di Genova a luglio, era fortemente presente, con quasi un milione di presenze, quel movimento globale apartitico, apolitico e pacifista che non era lontano dalla protesta di Greta oggi. Ecologia, accoglienza e parità di genere erano già temi portanti. L'infinita possibilità di informazione azzera la percezione della memoria, che costruisce ideali, pensiero critico. I millennials sembrano isolati dal processo di memoria. Il passato non è meglio, ma segna un tracciato. Non puoi capire Achille Lauro se non hai idea del lavoro di Vasco. Ascoltare i "vecchi" è un contatto tra generazioni importantissimo.»
Perché il nome L'Orage? «Dalla celebre canzone di Georges Brassens e non solo. È una parola che spesso appare nel mondo delle canzoni francofone e brilla in modo particolare, incuriosisce. In più dà la possibilità di creare moltissimi giochi di parole.»
Come mai vi siete assentati per 3 anni? «Nell’estate 2017 abbiamo deciso di prenderci un momento per noi anche per ciò che accadeva nel nostro privato. Io ho avuto un figlio, il chitarrista storico è andato via, e io, con più tempo a casa, ho ricominciato a studiare la chitarra elettrica. Ci siamo dati tempo anche per valutare i cambiamenti del mondo musicale, più attivo su web e social, che non è subito stato nelle nostre corde. Siamo molto legati al contatto diretto col pubblico, dal concerto come festa.»
Com'è il contesto musicale valdostano? «È una regione piccola e per ciò molto "contemplativa": il rapporto con la natura è diretto e forte, e questo determina una grande creatività. La scena musicale è molto varia. Sono frequenti le fiere, le sagre, dove anche i più giovani ancora cantano insieme e ballano in coppia, cosa che non si vede quasi più. Noi siamo partiti da lì, affacciandoci al panorama italiano con una fan base già molto solida, di gente che con noi si diverte, fa festa. Mantenere un contatto forte con la tradizione (i fratelli Boniface sono musicisti da 4 generazioni, suonano ghironda, violino, cornamusa...), mescolandola a rock, cantautorato, elettronica ha portato qualcosa di nuovo.»
Di chi sentite di più l'influenza? «Realtà molto diverse. Rock alternativo anni 90, grunge, canzone d'autore italiana e no. I fratelli Boniface hanno il mondo celtico e il metal più cattivo, il punk folk. Poi il punk nord europeo, la ritmica africana. Il repertorio di cover che portiamo live spesso spiazza.»
Se ti diciamo Rivoluzione, Cicatrici e Viaggio... «Sono parole potenti. "La rivoluzione è nella testa", Lennon: quello che serve oggi, a partire dalle cose piccole come fare spesa con meno plastica. "Gli amanti cullano le cicatrici come segreti da svelare", Cohen: i ragazzini ne sono orgogliosi, è confortante averle da mostrare come segni di battaglia. Sono la memoria del nostro corpo, della paura affrontata. "Prego di trovare il grande viaggio tra le pareti di una scatola", Noir Desir. Viaggiare è bello, ma il vero viaggio è dentro.»
I B.livers hanno 3 parole: essere, credere e vivere. Le tue? «Inquietudine, intesa come valore; leggerezza, quella di Calvino che trova l'ironia anche nel dolore. E memoria, mezzo per prolungare la vita, espanderla e mantenerla attiva creando ricordi importanti.»
#intervista#l'orage#alberto visconti#valle d'aosta#musica#anteprima#il bullone#gullone#oriana gullone#orianag
0 notes
Text
capitolo 3
IL VALZTER DELL’IGIENE
Il concetto di “abitabilità” espresso nel PSC del 2008 è andato dal 2005 a braccetto con il tema della sicurezza.
Il 15 novembre 2005, l’allora sindaco di Bologna Sergio Cofferati rende pubblico il documento “Legalità e solidarietà per lo sviluppo economico, la coesione e la giustizia sociale”.
Il documento si presenta come una ferma presa di posizione contro “l’illegalità” e, sebbene nel documento ve ne siano solo alcuni accenni, le pratiche a cui si riferisce il documento riguardano in particolare la regolamentazione della cultura del divertimento e la questione abitativa.
Tra le ordinanze emanate dal 2005 al 2007 vi sono: la proibizione alla vendita di alcool in bottiglie di vetro dopo le 21.00 nella zona universitaria ed in Via del Pratello, l’obbligo di chiusura degli alimentari alle 22.00, la regolamentazione dell’orario di chiusura all’1.00 per i locali pubblici, la cancellazione della street parade, il divieto di effettuare piercing ai genitali, ai capezzoli e alle palpebre, così come tatuaggi estesi a tutto il corpo, il piano comunale contro i graffiti, lo smantellamento di diversi campi nomadi nella periferia cittadina, lo sgombero di diversi edifici occupati, la regolamentazione dei dehors dei bar e locali cittadini.

Queste pratiche hanno come obiettivo la creazione di un’urbanità igienizzata, che si riappropria di porzioni del proprio territorio da poter successivamente affidare ad investimenti privati, ed un nuovo tipo di cultura del divertimento, accuratamente costruita attraverso pratiche urbane.
La Bologna contemporanea, bonificando la propria aria, le proprie strade, i propri muri, i corpi dei suoi cittadini, si è aperta all’arrivo di nuovi capitali allontanando parte della propria composizione sociale, reinventando contemporaneamente i propri cittadini.
A Bologna però, cibo, cultura del divertimento, questione abitativa, attivismo politico sono intrecciati. Per comprenderlo basta seguire le vicissitudini dell’area dove oggi si trova la Trilogia Navile.
Fino al 1936 l’area era destinata a terreno agricolo. Successivamente due delle invenzioni belliche della I guerra mondiale furono convertite in strumenti agricoli: il nitrogeno degli esplosivi permise di inventare i pesticidi ed il carrarmato fu trasformato in trattore. Per poter ammortizzare l’investimento in questi nuovi costosi strumenti, che permisero di triplicare la produzione agricola, furono necessari grandi appezzamenti di terreno. A Bologna, come in tutte le città industrializzate, i terreni da sottoporre a sfruttamento agricolo furono quindi gradualmente spostati dai perimetri urbani, grazie anche al minor costo dei mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio. Questo processo permise quindi alle città di iniziare ad ingrandirsi occupando i terreni agricoli limitrofi ai propri confini.
Per questo motivo Bologna ebbe la necessità di dotarsi di un grande mercato agricolo. Nel 1936, grazie alla prossimità della ferrovia, venne inaugurato il Mercato Ortofrutticolo del Navile, un’invenzione necessaria a permettere lo scambio di un numero crescente di merci agricole per un numero crescente di popolazione urbana.

Un’esplosione è un evento travolgente. Un’esplosione di gioia ci rende nuovi. Dall’esplosione del big bang si dice che abbia avuto inizio l’intero universo. L’esplosione di una bomba distrugge vite e territori. Un’esplosione di rabbia può distruggere un rapporto. L’esplosione del motore a scoppio fa avanzare un veicolo. Dalle esplosioni passano la vita e la morte, vi si ritrovano uniti la luce più accecante e l’ombra più profonda. Un’esplosione cambia molte cose. Un’esplosione è la fine di qualcosa e l’inizio di qualcos’altro, ed è stato così anche per Bologna. L’onda d’urto della bomba esplosa il 2 Agosto 1980 alla Stazione Centrale ha segnato la morte di una Bologna e la nascita di un’altra. Il suo eco non è terminato pochi istanti dopo le 10.25, ma si riverbera ancora oggi, le sue implicazioni sono racchiuse ed incorporate nella stessa forma urbana.

Lo squarcio nell’anima della città provocato dall’attentato, così come l’affermazione del ruolo di Bologna come nodo di scambio nazionale, resero necessari nuovi lavori sulla stazione.
Sono passati meno di 50 anni dal 1936 e nel Piano regolatore del 1985-89 si decise di delocalizzare il mercato ortofrutticolo nell’attuale area CAAB in vista della riprogettazione della stazione ferroviaria. Nella metà degli anni ’90 il mercato venne quindi dislocato, sempre in prossimità di una linea ferroviaria. Il vuoto nel Navile non venne però colmato a causa di una congiuntura macroeconomica non favorevole alla realizzazione dei progetti in previsione. Fu in questo periodo che il vuoto lasciato dal mercato ortofrutticolo fu riempito da progetti culturali indipendenti legati all’arte, al cibo, al corpo e alla cultura del divertimento, il LINK e l’XM24.

Con la chiusura del LINK nel 2004 per far posto al Comune di Bologna, e lo sgombero del 15 Novembre 2019 dell’XM24 per la realizzazione di uno studentato, un’altra componente indesiderata al progetto urbano, dopo i terreni agricoli ed il mercato ortofrutticolo, viene allontanata dal quartiere. La città ha a mano a mano espulso da quest’area le componenti non più desiderate, trasformando contemporaneamente il territorio, i corpi, il cibo, il mercato agricolo e i sistemi produttivi.
Tra i progetti più imponenti degli ultimi 10 anni di politica urbana vi è FICO Eataly World. Quello che viene definito un parco tematico dedicato all’agroalimentare, la Disneyworld del cibo, non è altro che un’arena che ridefinisce, surrogandoli, tutti gli aspetti che la città ha, nel corso di 100 anni, una dopo l’altro, allontanato dall’area del Navile. Luogo di coltivazione ed allevamento, di smistamento e vendita di prodotti agroalimentari, di svago, e di didattica per tutti i livelli scolastici, Bologna ha trovato il modo di assemblare e di integrare tutti questi elementi in un unico dispositivo.

Questa trasformazione non è avvenuta tuttavia senza costi. Da FICO gli habitat di coltivazione ed allevamento sono accuratamente ricreati, il processo produttivo è esibito in modo edulcorato, i ristoranti sono matrioske dentro un centro commerciale, la biodiversità proclamata all’interno del parco è frutto di una selezione operata all’interno del mercato economico.
La vendita della cultura enogastronomica Made in Italy ed i marchi DOC, IGP, STG, DOCG, operano sull’intero processo di produzione e consumo del cibo le stesse alterazioni che le decisioni politiche attuano sulla città, per poterne permettere l’inserimento all’interno del mercato economico.
Il marketing del cibo, come il marketing urbano, utilizza i meccanismi di igienizzazione ed eliminazione delle componenti indesiderate.
Dopo la crisi del 2008 e la conseguente crisi del manifatturiero, Bologna decide di investire nel rapporto tra cibo e turismo, passando necessariamente per invenzioni urbane, ricostruendo paesaggi, quartieri, edifici ed interni.
Non è un caso che nel Marzo 2009 il comune di Bologna trovi un accordo con Ryanair, la principale compagnia aerea low cost europea, per l’apertura di una base operativa nell’aeroporto Guglielmo Marconi, spostando gradualmente la maggior parte dei voli dall’aeroporto di Forlì allo scalo bolognese, fino a raggiungere gli attuali collegamenti con 60 aeroporti in Europa.
Tra il 2013 e il 2018 i turisti nel capoluogo sono cresciuti del +46%, così come si è assistito ad un boom di ristoranti (+31.9%), minimercati (+48%), caffetterie (+233%) nel centro storico.
Parallelamente l’arrivo di piattaforme digitali come Airbnb ha modificato ulteriormente la composizione urbana. Il servizio ha visto crescere gli annunci pubblicati in Italia dagli 8.126 del 2011 ai 354mila del 2017. Oggi secondo il portale “Airbnb Inside” gli annunci su Airbnb a Bologna sono 3.542, di cui 2.333 sono annunci per interi appartamenti, con un prezzo medio per notte di 76€ ed una media di occupazione per ogni annuncio di 104 notti all’anno.

Uno di questi appartamenti si trova proprio all’ultimo piano di Via Tibaldi 17. Il gestore, Carlo, la cui famiglia ha costruito l’edificio negli anni ’70, è anche proprietario di altri alloggi nello stesso stabile. Descrivendoci i vari avvicendamenti negli appartamenti ci parla di una situazione attuale molto definita. Se nel corso degli anni al piano terra si è passati dalla sede del Quartiere Navile al Parrucchiere Cinese, nei piani superiori sono passate famiglie di immigrati, proveniente dall’India, dal Bangladesh, dalla Cina, studenti universitari, single, famiglie. A causa di una serie di problemi, tra cui sfratti per morosità, emissioni olfattive e sonore disturbanti, oggi non affitta più nessuno degli appartamenti ad immigrati e ad universitari col fine di tutelare il proprio patrimonio ed in favore di un modello di convivenza non conflittuale. Il target ideale è il single, lavoratore, una forma di istituzione che perlopiù non emette emissioni sonore ed olfattive sgradevoli e che garantisce la solidità finanziaria richiesta.
Anche qui, l’igienizzazione urbana e l’orientamento verso i capitali influenza i corpi e crea un’asimmetria nelle potenzialità di accesso al mercato abitativo.
Le proteste di fronte allo Student Hotel di Via Fioravanti del 1° Ottobre 2020 si inquadrano all’interno di questo contesto. Gli alloggi diminuiscono ma gli studenti fuorisede sono passati dai 36mila del 2015 ai 41mila del 2019 e la nuova città, igienizzata, sembra non fornire più loro un’adeguata accoglienza.

Il sentimento che ha mosso la manifestazione è frutto anche di un altro evento molto recente. Il 12 Settembre 2019 è stata formalizzata la candidatura dei portici di Bologna a patrimonio dell’umanità UNESCO. I portici sono un dispositivo architettonico “abusivo”, nato nel basso medioevo, per ospitare gli studenti universitari immigrati in città. La loro configurazione deriva dalla necessità di aumentare la cubatura abitativa, senza sottrarre spazio pubblico in una città chiusa dalle mura medievali, e quindi non in grado di ampliarsi facilmente. Se i portici diventassero patrimonio dell’UNESCO comporterebbero un aumento della pressione turistica ed un’ulteriore riduzione di spazi abitativi disponibili per gli studenti.

La nascita di nuove forme di disuguaglianza all’interno del Navile è quindi frutto di una gigantesca performance i cui attori sono ryanair, le emissioni sonore, l’attentato del 2 Agosto, la mortadella IGP, i dehor, i tatuaggi, lo student hotel, la deregolamentazione dell'industria aerea europea del 1997, i portici.
Valorizzazione del patrimonio storico, attrazione di nuovi capitali, aumento della produttività agricola e promozione della cultura gastronomica locale, nascono con buone intenzioni ma il transito di queste componenti attraverso diverse sezioni della realtà ne devia inevitabilmente i propositi, in modi molto spesso imprevedibili anche dalla politica stessa.
1 note
·
View note
Link
31 MAR 2020 10:09
ITALIA-ALBANIA: PARDO APPARECCHIA IL DERBY DELL’AMICIZIA SU INSTAGRAM - IL PREMIER EDI RAMA SPIEGA A "TIKI CASA" LA DECISIONE DI INVIARE 'UN ESERCITO BIANCO' NEL NOSTRO PAESE E INVITA L’EUROPA A FARE COME "IL MILAN DI SACCHI" - GIULIANO SANGIORGI RICORDA GLI SBARCHI DEGLI ALBANESI IN PUGLIA. E RIVELA... - EX GIOCATORE DI BASKET, EDI RAMA PARLA DELLA NAZIONALE, DELLA JUVE, DI ZOFF E DI MOURINHO - IL TWEET DI LAPO - LA STORIA DELL'AMICIZIA CON IL "VATE" BIANCHINI - VIDEO
-
Francesco Persili per Dagospia
"Siamo in una guerra mondiale contro il coronavirus. Non si può vincere solo giocando in difesa, con il catenaccio. Qui ci vuole un’Europa che faccia come il Milan di Sacchi. Gli Stati campioni si mettano a disposizione della squadra”. Il premier albanese Edi Rama interviene a “Tiki casa”, la versione social di “Tiki Taka”, e torna sulla decisione di inviare in Italia ‘l’esercito bianco’ di 30 medici e infermieri per l’emergenza coronavirus. “Non possiamo combattere divisi all’interno delle proprie frontiere, senza reagire insieme”.
“Non siamo privi di memoria e non abbandoniamo mai l’amico in difficoltà”, aveva detto il primo ministro di Tirana in un discorso che ha raccolto tantissimi consensi (non solo) sui social. Gratitudine e senso di una memoria comune. “Mi ricordo gli sbarchi in Puglia negli anni ’90”, rivela Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. “Con mio padre andammo a fare la spesa e portammo generi alimentari al porto di Brindisi. Provai un dolore fortissimo. Credo che l’Albania ricordi la nostra accoglienza…”. Due popoli che si danno la mano e condividono la sofferenza di questo tempo.
“La conta dei morti ogni sera suscita una enorme tristezza – prosegue Edi Rama - Siamo in una guerra in cui l’onnipotente esercito americano e il modestissimo esercito albanese valgono lo stesso, cioè zero. Parliamo di intelligenza artificiale ma quando il nemico arriva nel nostro mondo non ci sono mascherine, non si trovano respiratori. L’Europa è la nostra casa comune. Se minaccia di bruciare non si può restare appartati e aspettare che il virus vada via. Spero che questa crisi si trasformi in opportunità per approfondire come vogliamo vivere e cosa vogliamo essere”.
Ex giocatore di basket, Edi Rama ha l’Italia nel cuore. Dall’altra parte dell’Adriatico, al tempo della dittatura, l’Italia era l’America. E si tifava per gli azzurri. “Eravamo chiusi in un bunker, la sola finestra erano le partite di calcio della Nazionale italiana”. Il “Vate” Valerio Bianchini lo ricorda studente d’arte nel 1988 al tempo di una trasferta della Scavolini Pesaro in Albania in cui il futuro premier albanese svolgeva il ruolo di interprete. Lapo Elkann si è esaltato davanti alle sue foto con le giacche della Juve: “Adesso mi è tutto più chiaro perché l’Albania è guidata da un grande Uomo”. L’ex sindaco di Tirana rivela a Pardo che le sue simpatie bianconere risalgono al tempo di Dino Zoff la cui foto campeggiava sopra il suo letto. “Prima di spegnere la luce lo guardavo”. “Ho avuto una debolezza solo quando è arrivato Mourinho all’Inter. Ho gioito per i suoi successi. Tutti hanno i loro peccati…”
EDI RAMA: UN GIOCATORE DI BASKET CHE HO CONOSCIUTO BENE E DI CUI VOGLIO RACCONTARVI L'AMICIZIA.
Dal profilo Facebook di Valerio Bianchini
Nel 1988, allenavo la Scavolini che, avendo vinto il campionato la stagione precedente , partecipava all'Eurolegue. Come già mi era successo con Cantù, le prime qualificazioni ci facevano incontrare il Partizan di Tirana, una competizione che non dava pensieri ma che anzi suscitava in noi grande curiosità per il piccolo Paese blindato da un tetro dittatore che seminava le campagne di fortificazioni militari a difesa della Nazione dall'invasione prossima degli italiani.
I ragazzi scherzavano con i nostri americani, Cook e Daye, ricordando loro che l'Albania era il paese più comunista che si potesse immaginare. Daye, che sospettava di essere preso in giro, venne da me per sapere la verità. Io non potei che confermare quanto aveva sentito dai compagni. L'Albania era effettivamente il paese più comunista conosciuto. Aggiunsi che non avevano rapporti né con la Russia di Breznev, né con la Cina di Mao, perchè entrambi i paesi erano considerati dagli albanesi troppo di destra.
Completai le informazioni dicendo che l'Albania intratteneva relazioni diplomatiche solo coi khmer rossi della Cambogia, che per gli americani erano nient'altro che i temutissimi sterminatori dei loro soldati nella guerra del Vietnam.
Partimmo da Falconara per un breve volo di mezzora al di là dell'Adriatico. Darren Daye si sedette accanto a me , un po' pallido in volto, nonostante la sua abbronzatura naturale. Mi chiese: “ Coach, quante ore di volo ci sono per Tirana?” “Mezz'ora “ risposi. “ Wow, esclamò Darren, L'Italia è così vicina alla Cambogia?” A ulteriore conferma della scarsa familiarità degli americani col mappamondo.
Arrivati a Tirana, ad accoglierci con i funzionari del governo c'era anche un ragazzo alto, distinto e gentile. “Sono un giocatore di basket e poiché parlo la vostra lingua, sarò il vostro interprete”.
La cosa m meravigliò non poco, perchè solitamente i nostri accompagnatori all'Est erano agenti dei servizi segreti con l'aspetto truce dei personaggi di Le Carré. Il ragazzo, oltre che appassionato di basket che sapeva tutto sul campionato italiano, era colto e la sua conversazione brillante. Passò molte ore con me e fu immediata amicizia. Era uno studente di arte e mi condusse a visitare il Museo di Scanderbeg, l'eroe albanese. Mi faceva mille domande e negli occhi aveva un gran desiderio di volare a di là dell'Adriatico, lontano dalla cupa dittatura di Henver Hoxha, che teneva l'Albania in una specie di medioevo comunista.
Venne il momento della nostra partenza e Edi Rama era all'imbarco con noi. Mi regalò un ritratto da lui dipinto di una giovane fanciulla in abiti del suo folclore. E aveva negli occhi una grande tristezza e un desiderio insopprimibile di venire con noi. Lo salutai con calore, convinto di rivederlo a Pesaro, quando il Partizan fosse arrivato per la partita di ritorno. Ma quando giunsero gli albanesi lui no era con loro. Era rimasto in Albania.
Una ventina d'anni dopo mi telefona Marzorati e mi dice che Edi Rama il sindaco di Tirana desidera contattarmi. Edi è famoso. Ha appena vinto il premio internazionale di “Sindaco dell'anno” davanti a Veltroni , sindaco di Roma. Edi aveva trasformato la grigia e degradata Tirana di Hoxha in una nuova imprevedibile città, ricca di giardini e con le vecchie case ridipinte in mille colori come un quadro dadaista. Era successo che pocodopo la nostra visita, Edi era riuscito a fuggire a Parigi per studiare arte. Da Parigi coordinava una specie di resistenza albanese con la pubblicazione di fanzine che facevano inviperire il regime.
Quando Hoxha crollò assieme al comunismo internazionale col muro di Berlino, in Albania si scatenò una sanguinosa guerra di fazioni politiche. Edi tornò per visitare i suoi e una notte gli tesero un'imboscata e lo massacrarono di percosse. Il medico disse che a salvarlo era stata la sua corporatura di giocatore di basket. Trovò ancora rifugio in Francia e intanto le cose in Albania andavano sistemandosi. Morì il padre ed Edi tornò per il funerale e il primo ministro gli offrì il ministero della Cultura. Cominciò così una carriera politica che oggi lo vede Primo Ministro.
Edi, da sindaco, si ricordò dell'allenatore con cui aveva stretto amicizia da ragazzo e mi invitò con mia moglie per un soggiorno nell'Albania che stava cambiando. Mi fece fare un viaggio lungo le coste incontaminate di quella meravigliosa sponda dell'Adriatico, fino al teatro romano di Butrinto, ai confini con la Grecia. Rinsaldai l'amicizia e capii dall'ampiezza della sua visione politica che Edi non si sarebbe limitato a fare il sindaco della capitale. Ieri il nostro Renzi per chiudere il semestre europeo a guida italiana ha scelto l'Albania recandosi a incontrare Edi Rama.
Una scelta dettata dall' esempio di un Paese uscito dalla dittatura verso la modernità sotto la guida geniale ed ispirata di un ragazzo che giocava a basket.
0 notes
Photo

L’incantevole borgo di Campli è un piccolo gioiello d’Abruzzo, situato in provincia di Teramo. È uno di quei luoghi dove le tradizioni secolari sono parte integrante della vita degli abitanti, poco più di 7000 anime, e nel quale il tempo sembra scorrere a ritmi piacevolmente rallentati. Uno scrigno di arte e storia, arroccato sulle colline Teramane a circa 30 chilometri dall’Adriatico. Le origini di questo insediamento si perdono in tempi antichi. Come testimoniano i reperti archeologici rinvenuti in quest’area, il territorio di Campli era abitato sin dal VIII secolo a.C.: gli scavi effettuati nella necropoli della vicina Campovalano hanno riportato infatti alla luce centinaia di tombe appartenenti ad un arco temporale che va dall’età del bronzo alla conquista romana. È solo nel Medioevo però che Campli acquisisce importanza e prestigio, fino a vivere il suo momento di massimo splendore, fermento artistico e vivacità politica tra il XVI ed il XVIII secolo quando a governare la città è la famiglia Farnese. Oggi Campli si offre ai suoi visitatori orgogliosa delle sue bellezze e consapevole del suo fascino. Fiera inoltre di essersi rialzata con incredibile forza dal devastante terremoto che nel 2009 ha colpito la regione Abruzzo. Cosa vedere a Campli Campli è facilmente raggiungibile in auto ed il modo migliore per godere delle sue atmosfere è quello di perdersi senza fretta tra le sue vie, passeggiando a piedi e scovando ogni scorcio del borgo abruzzese. È proprio camminando lungo Corso Umberto I, il lungo viale che taglia in due la città, che i più attenti e curiosi potranno scoprire un piccolo tesoro celato all’interno di un cortile. Si tratta della Casa del Medico e dello Speziale, un idilliaco palazzo che ha nei secoli cambiato più volte la sua funzione passando da essere un edificio religioso, adibito tra le altre cose a luogo di accoglienza e cura dei neonati non voluti dalle famiglie, a prestigiosa residenza nobiliare. Le ambientazioni dei suoi cortili e del suo loggiato sono decisamente da non perdere, per un bagno di quiete e relax. Proseguendo poi verso la piazza principale del paese, Piazza Vittorio Emanuele ci si ritrova circondati da due dei luoghi di interesse principali di Campi. Sulla destra si erge la Chiesa di Santa Maria in Platea, un sito carico di spiritualità e custode di importanti opere artistiche. La cattedrale prende il suo nome dalla statua in essa alloggiata, ritraente una Madonna col Bambino che rivolge lo sguardo alla piazza della città, ed ha saputo resistere alle scosse sismiche che l’hanno colpita anni fa. Sulla sinistra di Piazza Vittorio Emanuele svetta invece il Palazzo del Parlamento, chiamato anche Palazzo Farnese, uno dei palazzi civici più antichi di tutto l’Abruzzo, ed oggi sede del Municipio cittadino. Nella parte nord del paese sorgono uno accanto all’altro la Chiesa di San Francesco e l’importante Museo Archeologico di Campli. La Chiesa San Francesco è stata edificata nel 1227 ma ha purtroppo subito ingenti danni a seguito del terremoto, ed è rimasta per lungo tempo chiusa ed ammirabile solo dall’esterno. Il Museo Archeologico invece ha sede negli ambienti dell’antico convento di San Francesco e raccoglie i numerosissimi reperti archeologici rinvenuti nell’area di Campli e dintorni, molti dei quali provenienti da Campovalano. Campli tra spiritualità e usanze antiche Una delle particolarità di Campli è il suo forte legame con il mondo spirituale e proprio dietro Palazzo Farnese si nasconde un luogo legato a doppio filo con la sentita religiosità degli abitanti del borgo: la Scala Santa. Costruita XVIII secolo, la celebre Scala si trova a ridosso della Chiesa di San Paolo, ed è una scalinata di 28 gradini in legno di quercia intrisa di religiosità e misticismo. Secondo un’usanza in vigore fin dal 1772, i fedeli che la percorrono in ginocchio raccolti in silenziosa preghiera e passano attraverso i dipinti che ricoprono le pareti laterali della gradinata, rievocazioni della Passioni di Cristo, vedono perdonati tutti i loro peccati. Un’Indulgenza Plenaria insomma, di espiazione e rinascita, che precede la scalinata per la discesa, percorribile in piedi accompagnati invece da affreschi rappresentanti simbolicamente la Resurrezione. Un rituale imperdibile, da mettere in atto in prima persona o semplicemente da osservare con rispetto. Eventi e sagre a Campli: buon cibo e genuinità La regione Abruzzo è sinonimo anche di buon cibo e tradizioni gastronomiche d’eccellenza. Il ricco palinsesto di sagre paesane di Campli è spesso legato alla sue migliori offerte culinarie, e tra le vie del paese genuinità e socialità si uniscono in un calendario di manifestazioni popolari dal fascino autentico. Imperdibile se si passa da Campli nel mese di agosto è la Sagra delle Porchetta Italica: un vero concorso tra i produttori di questo squisito prodotto di carne suina, durante il quale gli estimatori dei panini caldi farciti di succulenta carne alla brace vivono momenti paradisiaci per le papille gustative. Il tutto accompagnato da concerti, parate e intrattenimento di vario genere. L’estate di Campli è fatta anche di Festa della Pizza e di Sagra del Tartufo di Campovalano, altri due cavalli di battaglia del menù di ricette tradizionali: tra le bancarelle delle fiere paesane o comodamente seduti nei numerosi ristoranti della zona, non fatevi scappare nemmeno un assaggio delle altre specialità camplesi, come il timballo teramano, le acciughe sottolio cotte nell’aceto, i calcioni, la frittata di basilico o la pasta al sugo di lepre. E per deliziare anche l’udito, Campli è palcoscenico di interessanti momenti musicali come il Campli Music Festival o altri eventi dedicati ai più svariati generi e gusti, che colorano la bella stagione del borgo abruzzese. https://ift.tt/2O3cXZN Cosa a vedere nel bellissimo borgo di Campli L’incantevole borgo di Campli è un piccolo gioiello d’Abruzzo, situato in provincia di Teramo. È uno di quei luoghi dove le tradizioni secolari sono parte integrante della vita degli abitanti, poco più di 7000 anime, e nel quale il tempo sembra scorrere a ritmi piacevolmente rallentati. Uno scrigno di arte e storia, arroccato sulle colline Teramane a circa 30 chilometri dall’Adriatico. Le origini di questo insediamento si perdono in tempi antichi. Come testimoniano i reperti archeologici rinvenuti in quest’area, il territorio di Campli era abitato sin dal VIII secolo a.C.: gli scavi effettuati nella necropoli della vicina Campovalano hanno riportato infatti alla luce centinaia di tombe appartenenti ad un arco temporale che va dall’età del bronzo alla conquista romana. È solo nel Medioevo però che Campli acquisisce importanza e prestigio, fino a vivere il suo momento di massimo splendore, fermento artistico e vivacità politica tra il XVI ed il XVIII secolo quando a governare la città è la famiglia Farnese. Oggi Campli si offre ai suoi visitatori orgogliosa delle sue bellezze e consapevole del suo fascino. Fiera inoltre di essersi rialzata con incredibile forza dal devastante terremoto che nel 2009 ha colpito la regione Abruzzo. Cosa vedere a Campli Campli è facilmente raggiungibile in auto ed il modo migliore per godere delle sue atmosfere è quello di perdersi senza fretta tra le sue vie, passeggiando a piedi e scovando ogni scorcio del borgo abruzzese. È proprio camminando lungo Corso Umberto I, il lungo viale che taglia in due la città, che i più attenti e curiosi potranno scoprire un piccolo tesoro celato all’interno di un cortile. Si tratta della Casa del Medico e dello Speziale, un idilliaco palazzo che ha nei secoli cambiato più volte la sua funzione passando da essere un edificio religioso, adibito tra le altre cose a luogo di accoglienza e cura dei neonati non voluti dalle famiglie, a prestigiosa residenza nobiliare. Le ambientazioni dei suoi cortili e del suo loggiato sono decisamente da non perdere, per un bagno di quiete e relax. Proseguendo poi verso la piazza principale del paese, Piazza Vittorio Emanuele ci si ritrova circondati da due dei luoghi di interesse principali di Campi. Sulla destra si erge la Chiesa di Santa Maria in Platea, un sito carico di spiritualità e custode di importanti opere artistiche. La cattedrale prende il suo nome dalla statua in essa alloggiata, ritraente una Madonna col Bambino che rivolge lo sguardo alla piazza della città, ed ha saputo resistere alle scosse sismiche che l’hanno colpita anni fa. Sulla sinistra di Piazza Vittorio Emanuele svetta invece il Palazzo del Parlamento, chiamato anche Palazzo Farnese, uno dei palazzi civici più antichi di tutto l’Abruzzo, ed oggi sede del Municipio cittadino. Nella parte nord del paese sorgono uno accanto all’altro la Chiesa di San Francesco e l’importante Museo Archeologico di Campli. La Chiesa San Francesco è stata edificata nel 1227 ma ha purtroppo subito ingenti danni a seguito del terremoto, ed è rimasta per lungo tempo chiusa ed ammirabile solo dall’esterno. Il Museo Archeologico invece ha sede negli ambienti dell’antico convento di San Francesco e raccoglie i numerosissimi reperti archeologici rinvenuti nell’area di Campli e dintorni, molti dei quali provenienti da Campovalano. Campli tra spiritualità e usanze antiche Una delle particolarità di Campli è il suo forte legame con il mondo spirituale e proprio dietro Palazzo Farnese si nasconde un luogo legato a doppio filo con la sentita religiosità degli abitanti del borgo: la Scala Santa. Costruita XVIII secolo, la celebre Scala si trova a ridosso della Chiesa di San Paolo, ed è una scalinata di 28 gradini in legno di quercia intrisa di religiosità e misticismo. Secondo un’usanza in vigore fin dal 1772, i fedeli che la percorrono in ginocchio raccolti in silenziosa preghiera e passano attraverso i dipinti che ricoprono le pareti laterali della gradinata, rievocazioni della Passioni di Cristo, vedono perdonati tutti i loro peccati. Un’Indulgenza Plenaria insomma, di espiazione e rinascita, che precede la scalinata per la discesa, percorribile in piedi accompagnati invece da affreschi rappresentanti simbolicamente la Resurrezione. Un rituale imperdibile, da mettere in atto in prima persona o semplicemente da osservare con rispetto. Eventi e sagre a Campli: buon cibo e genuinità La regione Abruzzo è sinonimo anche di buon cibo e tradizioni gastronomiche d’eccellenza. Il ricco palinsesto di sagre paesane di Campli è spesso legato alla sue migliori offerte culinarie, e tra le vie del paese genuinità e socialità si uniscono in un calendario di manifestazioni popolari dal fascino autentico. Imperdibile se si passa da Campli nel mese di agosto è la Sagra delle Porchetta Italica: un vero concorso tra i produttori di questo squisito prodotto di carne suina, durante il quale gli estimatori dei panini caldi farciti di succulenta carne alla brace vivono momenti paradisiaci per le papille gustative. Il tutto accompagnato da concerti, parate e intrattenimento di vario genere. L’estate di Campli è fatta anche di Festa della Pizza e di Sagra del Tartufo di Campovalano, altri due cavalli di battaglia del menù di ricette tradizionali: tra le bancarelle delle fiere paesane o comodamente seduti nei numerosi ristoranti della zona, non fatevi scappare nemmeno un assaggio delle altre specialità camplesi, come il timballo teramano, le acciughe sottolio cotte nell’aceto, i calcioni, la frittata di basilico o la pasta al sugo di lepre. E per deliziare anche l’udito, Campli è palcoscenico di interessanti momenti musicali come il Campli Music Festival o altri eventi dedicati ai più svariati generi e gusti, che colorano la bella stagione del borgo abruzzese. Campli è un bellissimo borgo dell’Abruzzo che, nonostante il terremoto del 2009, conserva la sua bellezza nei palazzi d’epoca e nei monumenti.
0 notes
Text
Questioni di stile
Del 7 aprile 2019
Di Lorenzo Firmani
Questa settimana in Italia c’è stato un episodio che mi ha particolarmente colpito.
A Roma, più precisamente a Torre Maura, un ragazzino di 15 anni, sfida un esponente di Casapound in una battaglia dialettica a cui risponde colpo su colpo.
Simone con modi cortesi e calmi riesce a far spiegare le sue ragioni e le sue idee, chiarendo che “Secondo me nessuno deve essere lasciato indietro. Né italiani,né rom, né africani,né qualsiasi tipo di persona…”
In questo quartiere di Roma negli ultimi giorni si è accesa una polemica contro un centro di accoglienza che in questi giorni sta ospitando 60 Rom.
Queste proteste sono state fatte dagli abitanti della zona sostenuti appunto da Casapound. Una potesta rabbiosa e violenta che ha impedito anche di portare il pane a questa gente.
La gente protesta e non vuole questa gente nei suoi quartieri ma è davvero giusto escludere queste persone?
Chi discrimina i Rom è poco informato su chi sono e sulla loro cultura. Associamo la parola Rom a parole come ladri, rapiscono i bambini, non lavorano queste sono le cose che si associano spesso a questo popolo. Sono parole che tendono ad una forte discriminazione verso questo popolo.
Noi diamo con molta facilità giudizi di pancia e più difficile invece creare una opinione e giudizio cercando di essere informate bene.
Miei lettori proprio perché vi voglio bene informati vi parlo un po' della storia dei Rom.
Partiamo dalla parola Rom, questa parola significa uomo libero.
I Rom sono un popolo di origine antica più precisamente ha origini asiatiche, in India, queste sono le origini dei 7 milioni di persone che si sono stabilite in Europa.
Sono stati sempre in viaggio attraversando diverse parti del mondo e hanno avuto sempre diverse persecuzioni violente e forzature da parte dei governi per integrarle senza però rispettare la loro cultura e tradizione.
La loro cultura si è sempre distinta tra l’abbigliamento pittoresco, la loro musica e la chiromanzia.
In molti paesi la cultura romanì è entrata a far parte del folklore locale: il flamenco in Spagna,
i violinisti ungheresi, i cymbalisti romeni, la canzone russa “Oci ciornie”.
La musica romanì ha
fortemente influenzato più di un compositore, ad esempio Brahms nelle sue “Danze ungheresi”,
Liszt, Bartŏk e Mussorgski. Alcuni generi musicali derivano dai rom, come la Czardas e il Verbunkos,
ma anche tanta musica balcanica oltre al jazz manouches, uno degli stili del jazz europeo il cui
precursore è stato il leggendario manouche Django Reinhardt.
In Italia invece non riusciamo ad accettare questo popolo. Non riusciamo nemmeno a integrare ne gli immigrati e ne tanto meno le persone che si sono perfettamente integrate nel nostro paese ma che non riusciamo nemmeno a dargli la cittadinanza. Tranne quando i politici sono talmente pressati dai Media che debbono concedere per un gesto eroico la cittadinanza. Perché una persona nata in Italia debba fare l’eroe per essere cittadino italiano?
Noi siamo un paese che sta ancora discutendo ancora su queste questioni.
Nel mondo invece i paesi si sono evoluti e sviluppati in modo maggiore rispetto a noi,uno di questi sono gli Stati Uniti.
E’ notizia proprio di pochi giorni fa, l’elezione del nuovo sindaco di Chicago, un sindaco che possiamo tranquillamente dire che fa la storia. perché? Perché è una donna, è afroamericana ed è gay.
Tre caratteristiche che forse in Italia sarebbe difficile da vedere a differenza dell’America che seppur con tante lotte e violenza nel passato sono riusciti a fare quell passo evolutivo che noi non abbiamoil coraggio di fare.
In America sono riusciti a capire cosa vuol dire evolversi a livello sociale anche se le discriminazione esistono ancora.
Chicago è una città che ha sempre vissuto tantissime disuguaglianze sociali e lotte tra polizia e minoranze per non dimenticare la violenza data dalle armi da fuoco.
Il neo sindaco, Lori Lightfoot ha fatto la propria campagna elettorale puntando proprio sulla riduzione delle disuguaglianze sociali e razziali.
La città dell'Illinois ha deciso di fare un passo avanti nel futuro per migliorare gli aspetti più negativi di cui ha bisogno.
La società americana sembra di vivere in un presente futuro che guarda sempre avanti cercando di svilupparsi al meglio mentre noi stiamo ancora cercando di un passato molto remoto e vecchio degno del Medioevo o addirittura della preistoria.
Se ci fossero più persone come Simone che riescono a mettersi in una posizione diversa da quella della politica dell’odio che ci viene alimentata dai partiti, sarebbe tutto diverso. Basta solo pensare che i Romani erano già più moderni di noi nel capire la società.
Per fortuna che il futuro è di ragazzi come Simone, Riccardo e Ramy, tre ragazzi che vedono un Italia diversa che guarda al futuro e che non fa distinzione di genere o di razza.
Il futuro è vostro e dovete cambiarlo.
Nota bene
Visto che i Blogger sono discriminati perché si eice che non sanno ricercare le fonti sappiate che le mie fonti per scrivere questo cappuccino sono Amnesty e il sito Open di Enrico Mentana penso che entrambe siano fonti più che affidabili. ��
#Roma #periferie #contestazioni #Rom #Casapound #giovani

0 notes
Text
I will write this message both in Italian and in English so that you can understand me. Scriverò questo messaggio sia in italiano sia in Inglese, cosicché tutti possiate capirmi.
English:
My name is Aril and I'm 19 years old. I live in southern Italy, and I’ve grown up with the values of acceptance, respect, life and personality. I have my whole life, with its huge misfortunes and small joys, but it’s my life. During my life, it has often happened to hear extremely strong news that has questioned the society and the values it has. By 2015, however, these questions have become extremely common and dominate the minds of each of us. "Why does evil exist?" "Why are innocent people killed for something they don’t know if it exist or not?", "Why do people want to terrorize us for a religion?" The more questions we create, the fewer answers we have and the man is weak: if he doesn’t have certainties, he invents them. So, they start the phenomena of racism and they start looking for a scapegoat to unload all the blame that maybe there are in society. Speaking of all the attacks that have been in these years, we are brought to terror, someone reminds us that "You are all human, you all have to die and we are to determine when." Every time there is an attack there is reflection, panic, fear... Then you find the culprit and his accomplices and life returns as before. Then there is another attack and again... it repeats the same story. The common point of these attacks is the belief in a religion, the mode of attack and the will to terrorize. The problem of these attacks is not only security, but it’s also another: first of all, the relationship with who is Muslim. Immediately, he is designated as one of the terrorists and everyone will say "All your fault and the immigrants."
But I tell you, it is not a religion to define a terrorist. The terrorist uses religion as an excuse for his actions. They use the saying "The end justifies the means." For them, "religion" justifies their work. The problem is what they (terrorists) profess is not religion. It’s not faith.
No religion speaks of killing children. No religion professes mass murder to gain some power. No religion says, "More kids and teenagers are killed, the bigger the prize you will have." In history, it has happened several times that religion was used as an excuse for action: even for us Catholics happened in the Middle Ages. Another consequence is indifference: personally, after years of terrorist attacks, I became indifferent. As if it was a daily thing. And this must not happen, it cannot happen! We must not become accustomed, we must not be indifferent, we must not give up. And we have to react. Reacting together, not surrendering. Not falling in indifference, in prejudices. But together, we young people can change the world. Or rather, this is the only hope that remains to me: to be able to change the world. Not pray. But closeness to the victims. Shares. For all those who suffer. Not only in England. Not just in the Philippines. But all over the world. Italiano:
Il mio nome è Aril e ho 19 anni. Vivo nel Sud Italia, e sono stata cresciuta con i valori dell'accoglienza, del rispetto, della vita e della personalità.
Vivo una vita tutta mia, con le sue enorme disgrazie e le sue piccole gioie, ma è la mia vita. Durante la mia vita, è spesso capitato di sentire delle notizie estremamente forti che hanno messo in discussione la società e i valori che quest'ultima ha. Dal 2015, però, queste domande sono diventate estremamente più frequenti e dominano la mente di ognuno di noi.
"Perché esiste il male?",
"Perché delle persone innocenti vengono uccise per qualcosa che non si sa se esiste o meno?"
"Perché delle persone vogliono terrorizzarci per una religione?".
Più domande ci creiamo, meno risposte abbiamo e l'uomo è debole: se non ha certezze, se le inventa.
Quindi, iniziano i fenomeni di razzismo e si parte alla ricerca di un capro espiatorio, per scaricare tutte quelle colpe che, magari sono della società.
Parlando di tutti gli attentati che ci sono stati in questi anni, noi veniamo riportati al terrore, qualcuno ci ricorda che "Siete tutti umani, tutti dovete morire e siamo noi a stabilire quando.". Ogni volta che c'è un attentato vi è la riflessione, il panico, la paura... Poi si trova il colpevole e i suoi complici e la vita torna come prima. Poi accade un altro attentato e di nuovo... si ripete la stessa storia.
Il punto in comune di questi attentati sono la credenza ad una religione, la modalità di attacco e la volontà di terrorizzare.
Il problema di questi attentati non è solo la sicurezza, ma è anche altro: innanzitutto, il rapporto con chi è musulmano. Immediatamente, viene designato come uno dei terroristi e tutti diranno "Tutta colpa vostra e degli immigrati."
Ma vi dico: non è una religione a definire un terrorista. Il terrorista usa la religione come scusa per le sue azioni. Loro usano il detto "Il fine giustifica i mezzi.": per loro, la "religione" giustifica il loro operato. Il problema è quella che loro (I terroristi) professano non è religione. Non è fede.
Nessuna religione parla di uccidere bambini. Nessuna religione professa l'omicidio di massa per istaurare un qualche potere. Nessuna religione dice "Più bambini e ragazzi ammazzate, più grande sarà il premio che avrete.".
Nella storia, è capitato più volte che la religione venisse usata come scusa per le azioni: anche per noi Cattolici è successo nel Medioevo.
Un'altra conseguenza è l'indifferenza: personalmente io, dopo anni di attacchi terroristici, sono diventata indifferente. Come se ormai fosse una cosa quotidiana. E ciò non deve accadere, non può accadere! Non dobbiamo abituarci, non dobbiamo essere indifferenti, non dobbiamo arrenderci.
E dobbiamo reagire. Reagire insieme, non arrendendoci. Non cadendo nell'indifferenza, nei pregiudizi. Ma insieme, noi giovani possiamo cambiare il mondo.
O meglio, questa è l'unica speranza che mi rimane: quella di poter cambiare il mondo.
Non preghiere. Ma vicinanza alle vittime. Azioni. Per tutti coloro che soffrono. Non solo in Inghilterra. Non solo nelle Filippine. Ma in tutto il mondo.
#manchester#marawi#terroristattack#attacco terroristico#religion#religione#no more violence#no more blood#world#pray for the world
5 notes
·
View notes
Text
“Viaggio nel Medioevo”: spettacolo e visita gratuita al Castello di Montalbano Elicona
“Viaggio nel Medioevo”: spettacolo e visita gratuita al Castello di Montalbano Elicona
Sabato 1 e domenica 2 giugno si replica a distanza di un mese, con la stessa formula ma con tante nuove sorprese in termini di animazione ed accoglienza, “Viaggio dal Medioevo”, lo spettacolo della compagnia Batarnù, la visita guidata al Castello svevo aragonese ed al centro Medioexpò di Montalbano Elicona (Messina).
I Batarnù sono una compagnia di teatranti, giullari e fuochisti, indirizzata…
View On WordPress
0 notes
Photo

"Noi non siamo come loro". Ma vogliamo diventarlo. I leghisti: "I musulmani sono diversi da noi! Noi siamo occidentali, i nostri valori sono superiori ai loro! Quelli stanno ancora al Medioevo! I loro leader politici usano ancora la religione, il loro libro sacro e gli altri simboli religiosi per fare politica e fare presa sul proprio popolo!". Sempre i leghisti: "L'Italia è solo cristiana! Io voto Salvini perché durante i comizi si rivolge al nostro Dio, al nostro Messia, alla Madonna e a tutti i Santi! Viva Salvini che durante i comizi bacia il rosario e brandisce il Vangelo!" I leghisti: “I musulmani sono fanatici, estremisti e intolleranti, riempiono gli edifici dello Stato di simboli religiosi, perfino nelle scuole e guai a chi li tocca! Nei loro Paesi non accettano alcuna cultura o religione diversa dalla loro! Provateci e vedete cosa succede!” Sempre i leghisti: “Guai a chi tocca il crocifisso nelle nostre aule! Basta con questi musulmani che si inginocchiano e pregano! Guai se aprite un luogo di culto diverso dal nostro nella mia città! Provateci e vedrete cosa succede!” I leghisti: “I musulmani nei loro Paesi impongono perfino quale carne gli altri debbano mangiare e quale no!” Sempre i leghisti: "Gli immigrati devono mangiare i tortellini con il ripieno che decidiamo noi! Devono mangiarli con il maiale e non con il pollo! Maledetti infedeli! I leghisti: “I musulmani non credono nella scienza e perseguitano gli uomini di cultura!” Sempre i leghisti: “Basta con questa storia del riscaldamento globale che dicono gli scienziati! Basta con questi professoroni!” I leghisti: “I musulmani impongono alle donne cosa indossare e cosa no! Insultano le donne! Non le rispettano! Non tollerano la libertà! Non tollerano gli stranieri nella loro terra! Li trattano male! Non sono accoglienti e col cazzo che ti danno un lavoro se sei straniero!". Sempre i leghisti: “Boldrini sei una cagna! Michela Murgia sei una scrofa! Le donne non devono indossare il velo! Decidiamo noi cosa devono indossare! Possibilmente poco! Basta stranieri nel nostro Paese! Via! Dateli in pasto ai pesci che hanno fame! Basta accoglienza! Basta lavoro agli stranieri!". "Perché noi siamo diversi da loro. Loro stanno ancora al Medievo. Mica come noi". Emilio Mola
40 notes
·
View notes
Text
Caro Luglio,
mi trovo a scriverti di nuovo. Ho sperato per un anno intero di potermi rivolgere a te con parole dolci e leggere come petali, ma le spine di questa mia vita hanno il sopravvento su di me pure oggi. Non smetti di stupirmi con la tua capacità di disattendere ogni mia più sperata aspettativa. Sì, sono nato nei tuoi giorni, ma perché la tua non è un’accoglienza materna, familiare? Perché mi trovo sempre in un angolo buio a chiederti le ragioni della tua ingiustizia?
Sei un mese caldo, ma neanche troppo rispetto ad Agosto, e tra le tue folate di calore sono iniziate le tue prime ore. Come una lancetta incessantemente in movimento mi hai ricordato dell’incedere delle settimane, così io ho iniziato a scarcerare le ansie dei miei doveri, scolastici in particolar modo. E che lo dico a fare che nemmeno uno di questi è stato adempiuto? Tra le tue braccia ritrovo sempre una certa incapacità nel soddisfare ciò che è da soddisfare, in primis me stesso, gravato delle mie aspettative e delle mie speranze. Insomma, sulla carta tutto mi ricollega a te, ma nelle gallerie del mio sangue non riesco a estrarre neanche un quarzo grezzo della tua familiarità, della tua accoglienza, di un tuo abbraccio, di casa.
Se devo pensare a una metafora che ti battezzi quest’anno, mi viene in mente un orizzonte che traccia il sottile confine tra i due firmamenti terresti, quello marino e quello celeste. Il primo intorpidito nelle viscere dei propri flutti, grigi come la roccia e freddi come il ghiaccio, il secondo smunto e patinato da un triste filtro polveroso. Delle nuvole si muovono in una lenta marcia a passo funebre sull’invisibile pavimento d’aria, abbandonando a un mare di sale timide e deboli gocce; sembrano stanche pure di sollevarsi di quel piccolo peso; ma non sono restie dal tempestare, diluviare o grandinare per paura di dissolversi una volta scaricatesi, piuttosto sono stanche di essere sempre le solite vittime di quel ciclo idrico perpetuo e ingiusto. Nuvole stanche su un mare piatto, pianto e investito da piccoli cerchi tracciati su un cielo riflesso. Triste come immagine? Be’, non potrebbe essere altrimenti. Caro Luglio, quello triste sei tu, ora, oggi, per me.
Il 12 Luglio è stato un illusorio raggio di sole. Apprezzare il volto di una stella spesso lontana in quel giorno mi ha rinvigorito il battito cardiaco. A seguito mi sono direzionato da due cari alberi macchiati da rughe di vita, che, in una dolce e tranquilla conversazione mi hanno ripotato a una condizione bambinesca, ma gioiosa. E la sera, coronato da un binomio confidenziale, mi sono addormentato convinto che quello sarebbe stato solo l’inizio. Ma, ora, oggi, per me, quello era solo la fine. Fine di una piccola parentesi di sorrisi vissuti.
Non sto a ritracciare con il pensiero le profonde e infette ferite incisemi nel tempo dal Mar Ligure. Resta di fatto che, evaporate una serie infinita di scontentezze e rancori, sono rimasto carico più che mai di tuoni e fulmini inesprimibili. E questa inespressività ha dettato, come una legge celeste, decisa da uno Zeus fastidioso e a me ostile, che io non potessi scaricarmi in folgore e in sfogo, ma che dovessi fagocitarmi e, in uno stato di forte dolore, metabolizzare tutta quella carica di rabbia e tristezza. Armato di parole e proposizioni, con le quali ti sto scrivendo, sono ancora una nube nera e ottenebrante, oltre che ottenebrata. Il minimo sfiorarsi di nembi crea in me un’irritante folgore che spesso è attirata dalle pelli dei poveri innocenti che mi sono a tiro. Ma che mese è mai questo? Caldo in quali termini? Io non riesco che a vederti e vedermi burrascoso, sempre in cerca di una maledetta procella da infierirmi.
Ad essere sincero quel giorno (5 Agosto), alla fine, le parole mi sono mancate. Sai, a non parlare che con sé stessi per manciate di settimane si iniziano a risentire delle profonde deficienze sul fronte comunicativo. Già non posso considerarmi un baluardo dell’espressività in questo mio piccolo medioevo, ma se pure le sillabe mi rifuggono… sono stato molti giorni a riflettere sul fatto che sostanzialmente il problema si sta rivelando essere l’estate di per sé. A ripensare alla sua gemella dell’anno passato, non riesco a non notare e patire certe congruenze. Certo che non c’è paragone fra queste due esperienze temporalmente lontane, ma infierire alle mie papille un sapore già saputo e sperimentato amarissimo non mi pare certo una grande rivoluzione. Come quando, ancora cullati dall’innocenza fanciullesca, i piccoli bambini decidono di valutare l’effetto rovente del fuoco con il quale si sono già scottati. Una tentazione che non riesce ad astenersi dal riammaliarmi e sedurmi con quelle sue danze concupiscenti e conosciute sbagliate. Eppure sembra che un sentimento intimo e magnetico non faccia che portarmi a una crasi dolorosissima, ogni volta, con questa ballerina dal ventre così sterile. È la Tristezza che balla? O forse la Noia? Se fosse invece la Solitudine? Sarà mai possibile incantarsi alle flessioni sensuali di una ballerina senza nemmeno riuscirne e codificarne i tratti somatici?
Caro Luglio, mi verrebbe ora da denominarti mese funesto, col tuo funesto vento e le tue funeste notti passate a cullarsi nel nulla, mi riduci ogni sera a soffrire del mio operato incompiuto, non perfettamente azzeccato. In molti credono in me e in quel giardino potenzialmente fiorito di fiordalisi spensierati e gioiosi. Quel potenziale, quel maledetto potenziale! Rimane sempre nella sua concezione astrale ma non formata; che potesse cadere tutta quella concezione di stelle e realizzarsi in me, così da realizzarmi! Rimango sempre come un gran scultore che vede in una grezza roccia marmorea le turgidità umane e millimetricamente azzeccate, in realismo ed emozione provocata, di un eroe proveniente dai più lontani anfratti mitologici, vestito con la sua perfetta nudità e le sue gesta eroiche, ma che in fin dei conti si stanca di reggere il peso che si accumula nello scalpello e lo getta via. Quante statue avrebbero potuto decorarti, Luglio! Quanti movimenti eroici si sarebbero potuti incanalare nella galleria dei tuoi trentun giorni! Eppure…
Percepisco sempre più pesantemente la mia mutevolezza. Inaspettata e, più di tutto, sempre lenta nell’accordarsi con la mia consapevolezza. Starò forse sprecando ore della mia vita irrisolta e irrisoluta nello scriverti questa lettera; starei potendo fare qualcosa: una scossa tellurica a questa landa piatta di noia e sterrata di spleen. Però le parole sono davvero gli unici fiori che sembrano disseminabili in questo mio tragitto estivo; gli unici fiumi che riescono a sgorgare dalla mia sagoma. Quello che mi chiedo, però, è perché tu, detto e considerato il mese ornato dall’aura luminosa della LUNA, non abbia in qualche modo cercando anche solo di sollevare una marea impertinente e rinvigorente che potesse smuovermi e smussare quegli angoli che non stanno poi solo scomodi a chi ci si taglia; un mulinello che mi trascinasse vorticosamente nelle viscere di questo marasma e che, facendomi capire la bellezza del respiro solo in quella situazione in cui proprio respirare è impossibile, provocandomi crampi e contorsioni ai muscoli, mi caricasse di una forte e impellente necessità di capire, capirli (gli altri) e capirmi. Perché, caro Luglio, non mi hai travolto e mi hai, invece, lasciato stagnante in quella situazione da amareggiato naufrago insolato?
Caro Luglio, non smetterai mai di essermi padre e madre e, anche se so che non sarà questa mia supplica e estorcerti un’accoglienza e un vigore nuovi e finalmente sazianti, non ripresentarti armato di una verga di tristezza e una frusta di noia, coprendomi con una volta celeste di solitudine; presentati con il tuo manto stellare, sì, capitanato dalla tua sovrana, monarca delle notti, e stupiscimi, però, con la tua bellezza, con la tua ricchezza, con la tua rigogliosità, con la tua essenza. Con la tua e quindi mia felicità.
Caro Luglio, t’amo e ti lascio al tempo. Ritorna forestiero di occasioni e persuadimi, come sai tu, a divenire pellegrino di vita degnamente vissuta.
5 e 10 Agosto 2018
0 notes
Link
Afrin”. Dov’è? Cos’è? Ancora un nome che sorge, sconosciuto, dalle cronache del mondo, dalle macerie fumanti della guerra civile siriana. Un tempo era stata Deraa, in altre fasi di questa storia, e in parte in una storia diversa; poi Kobane, nei mesi dell’avanzata dell’Isis che sembrava inarrestabile; quindi Aleppo, Raqqa. Questa storia è lunga, ampia. Riconduce a Tunisi e al Cairo, fino allo Yemen e al Bahrain, fino a Teheran. Siria: perché è fondamentale sostenere Afrin? La resistenza che Afrin, in queste ore, conduce contro il secondo esercito della Nato, sola come Davide contro Golia, tra i cadaveri dei bambini che restano sotto le macerie dei bombardamenti di un esercito che vanta tecnologia israeliana, elicotteri italiani e carri armati tedeschi, non è che l’esito di sette anni di rimescolamenti e caos seguiti al sommovimento popolare delle primavere arabe. Non è possibile comprendere il senso degli avvenimenti di Afrin se non si tiene fermo questo sguardo lungo, che poi ci impone di risalire soltanto fino all’altro ieri. Cosa ne è stato delle “primavere”, quali processi hanno messo in atto? Dove le insurrezioni, le elezioni, i colpi di stato, le guerre civili hanno condotto le popolazioni del Nordafrica e del Medio oriente? La Siria settentrionale divenne presto epicentro ambiguo della rivoluzione siriana, con tutte le sue oscurità e contraddizioni. Nel luglio 2012, mentre bande di islamisti delle campagne attorno a Manbij e Jarablus attaccavano Aleppo, Afrin, cittadina dell’estremo nord-ovest, cacciava le forze governative e dichiarava la propria comune, in coordinamento con Kobane. L’analogo organo di autogoverno dichiarato a Shech Maxsud, quartiere curdo di Aleppo, sarebbe stato evacuato con migliaia di profughi proprio ad Afrin, mentre l’antica città siriana veniva travolta dagli scontri tra regime, islamisti e Ypg. Ancora oggi la comune di Aleppo si riunisce ad Afrin, uno dei luoghi più belli della Siria, difeso, con efficacia, dalle Ypg, sebbene circondato da anni dall’ostile Turchia a nord e a ovest e dalle forze islamiste ad essa alleate a sud e a est. Tuttora il cantone di Afrin, confederato con Manbij, Kobane, Qamishlo e Hasakah fino a Raqqa, è luogo di accoglienza permanente per migliaia di profughi provenienti da Aleppo, Idlib ed altri territori. Proprio una famiglia intera di profughi arabi è tra le prime vittime dei bombardamenti a tappeto dell’aviazione turca in queste ore. Dicevamo: Afrin, Aleppo, Kobane, Raqqa. Siamo abituati a considerarle storie separate, ma è un fazzoletto di terra, e le loro storie politiche, anche durante la guerra, sono più legate di quanto si pensi. Quando guidavo in quelle zone, nel 2016, era straniante dirigersi verso l’Eufrate da Tel Abyad e veder scritto: “Aleppo: 30 Km” o “Raqqa: 50 Km”; “Confine Turchia: 5 Km”. Tutto era vicinissimo, eppure distante. La rivoluzione confederale, il regime, lo Stato islamico. Eravamo tutti lì, tra strade lunghe come le statali tra Napoli e Salerno, o Milano e Cremona; eppure si sapeva che sarebbero stati necessari anni, e migliaia di morti, per aprirle, ed ancora molte di esse, in quell’area, sono chiuse a causa dell’invasione turca di quell’estate, che ha indebitamente sottratto alla popolazione siriana le città di Jarablus, Al-Rai e Al-Bab, consegnandole a milizie di tagliagole islamisti legati al braccio siriano di Al-Qaeda, che gli ineffabili giornalisti italiani chiamano “moderati” e che ora, sotto il vessilo “usa e getta” di quello che una stampa patetica chiama ancora “Free Syrian Army”, vorrebbero portare ad Afrin, città che sperimenta da sei anni l’autogoverno e la rivoluzione delle donne, il medioevo oscurantista del presidente turco – o qualcosa di peggio. Oggi Afrin resiste quale esito di un lungo processo, che affonda le sue radici certo nella storia della guerra civile siriana e della lotta per la più ampia liberazione del Kurdistan, ma anche nella vicenda complessa di primavere inizialmente arabe, poi curde, ed oggi anche persiane. Fu difficile, non lo si ricorderà mai abbastanza, comprendere che cosa fossero quelle “primavere”. In molti, ricordiamolo ancora, diedero per scontato che si trattava semplicemente del desiderio di “libertà” tra i giovani: meno burocrazia, meno polizia, magari meno tradizione. Appena tre anni dopo, nel 2014, quando in Egitto una dittatura feroce, in parte benedetta dalle sinistre, reprimeva un’ondata islamista impressionante, e parte della Siria e dell’Iraq erano in mano a un autoproclamato e agghiacciante Stato islamico, tutti erano pronti a giurare che nella pancia dei territori musulmani, soprattutto quando è vuota e quando protesta, c’è sempre e soltanto l’islam, e che a una primavera “democratica” in qualche modo “fasulla” e agita internamente da logiche reazionarie, era seguito un inverno salafita. Non si comprende l’attuale sfida tra le colline di Afrin se non si cerca di sciogliere e comprendere quel nodo, ancora irrisolto: liberazione o sharia? Cosa vogliono quelle società? Cosa vuole la Siria, la Turchia? Le società di oggi sono non solo socialmente stratificate, ma socialmente spaccate, e non secondo direttrici che seguono pedissequamente i confini di classe. Ayman al-Zawahiri, leader globale di Al-Qaeda, fu prudente nel 2011. Le modalità e i contenuti delle manifestazioni mal si conciliavano con il futuro per quei popoli che Al-Qaeda ha in mente. Quelle manifestazioni sembravano, anzi, un pericolo per l’egemonia sociale islamista tanto quanto per le istituzioni al potere; non nel senso che fossero anti-religiose, ma perché qualsiasi iniziativa “autonoma” di parti consistenti della popolazione costituisce per i movimenti salafiti l’inizio della via della dannazione. Gli islamisti, benché si siano talvolta ispirati dal punto di vista organizzativo ai movimenti marxisti degli anni Sessanta (si pensi all’egiziano Sayyed al-Qutb, importante proprio per Zawahiri) sono per definizione qualcosa di diverso da un’avanguardia, poiché il diritto che intendono restaurare non può essere prodotto, neanche in via mediata o indiretta, di una “volontà” o “interesse” popolare. La diffidenza di Al-Qaeda per le primavere fu condivisa, soprattutto in Egitto, dagli stessi Fratelli musulmani, che pure ammettono la partecipazione politica alle istituzioni secolari al fine di restaurare uno stato islamico: i loro dirigenti rimasero a guardare le manifestazioni di gennaio e febbraio. Tanto loro quanto i salafiti furono però abili ad attendere e a far subentrare la loro agenda quando la repressione produsse prevedibili precipitazioni violente della situazione, in diversi contesti. Questa politica di attesa e di intervento violento, da parte delle organizzazioni islamiste, fu possibile soprattutto perché ceti politici e affaristici ideologicamente analoghi ad essi sono al potere in Qatar, nei paesi del Golfo, in Turchia. Erdogan, in particolare, ebbe l’abilità di presentarsi come una sorta di rappresentante morale del presunto nocciolo identitario, e perciò surrettiziamente assunto come “islamico” delle primavere dei paesi arabi, ipotecando un profitto politico dovuto al consenso di masse che non avevano necessariamente aderito alle manifestazioni, e tanto meno alle assemblee, ma si sarebbero recate ovunque alle urne nel contesto stravolto dai nuovi scenari. Là dove le urne non sono mai state aperte, come in Siria, ha invece agito con spregiudicatezza, armando migliaia di miliziani interessati a costituire, sotto diverse sigle e bandiere, uno stato islamico. Questa combinazione di appoggi a partiti elettorali o a milizie, ha costituito, in tandem con l’analoga azione di Arabia e Qatar, la trasformazione dell’apertura storica del 2011 in una mera collezione di “opposizioni” islamizzate e statalizzate. E allora? Non è forse normale che gli stati propongano i propri cambiamenti, i propri contenitori culturali e politici, i propri progetti di recupero e di dominio? Senz’altro. Quello che ci dovrebbe interessare e perché non esista una politica alternativa da parte di forze rivoluzionarie altrettanto abili e organizzate. In nessun luogo, se non nelle regioni curde, chi voleva un cambiamento reale ha avuto l’opportunità di poter contare su un’organizzazione politic che sostenesse, interpretasse e difendesse la popolazione e le sue aspirazioni. Le sinistre arabe hanno mostrato una volta in più qual è lo stato in cui versano, finendo per appoggiare i regimi, esprimere posizioni frazionistiche e inconcludenti o riconciliarsi con le istituzioni esistenti. In questo, hanno mostrato quali e quanti siano le affinità, oggi, tra sinistre arabe ed europee. È stato il vuoto pneumatico di una prospettiva organizzata di liberazione – che non può venire dal nulla, ma deve originarsi da percorsi sedimentati e capaci di parlare alle, ed essere parlati dalle, popolazioni – che ha lasciato le masse egiziane, tunisine, yemenite e di gran parte della Siria nelle mani della propaganda di stato o degli stati avversari del proprio stato, di cui le organizzazioni islamiste sono state i lacchè. L’esperienza decennale e la forza politica e militare del Pkk in Turchia in Iraq, del Pyd in Siria, e dell’analogo partito Pjak, attivo in queste settimane in Iran, ha permesso e permette un’alternativa concreta e differente. Un’alternativa che benché inizialmente circoscritta alla regione curda, è stata in grado – lo si è visto in Siria, ma anche in Turchia e in Iran – di uscire ampiamente dal Kurdistan in termini ancor più politici che militari, e collaborare con realtà non curde operando, cosa ancor più importante, nell’orizzonte della produzione di nuove soggettività politiche arabe, femminili e maschili, in Siria. Per questo se la resistenza di Afrin contro il presidente Erdogan non può essere in questo momento che militare, il suo significato è politico. A trent’anni dal crollo del Muro di Berlino e a un secolo dalla Rivoluzione d’Ottobre la volontà di agire nella consapevolezza che senza un’organizzazione rivoluzionaria si finisce ostaggio del capitale e dello stato anche quando li si vuole rovesciare, la possiamo trovare sulle colline di Afrin, non altrove. Forse per questo i pochi carri armati e i pochi blindati delle Ypg possono apparire ad alcuni l’ultima sedimentazione, l’ultimo grido di guerra di un anelito storicamente finito – con i suoi richiami libertari, la sua propaganda inflessibile, le sue vertigini maoiste; eppure, se è vero che non esiste considerazione neutra della storia, e che nostro compito è vedere le tendenze che si danno materialmente per poterle rafforzare, Afrin è per noi oggi l’inizio. La percezione di questo genere di pericolosità politica di chi ricarica i Kalashnikov e le Dushka tra i suoi villaggi e sulle sue colline si alza in queste ore o decresce, non a caso, con l’aumentare delle distanze. Il governo turco sente quella prossimità come minaccia palpabile non perché le Ypg abbiano intenzione di attaccare la Turchia – idea ridicola – ma perché il contagio, in Turchia, è in atto da diversi anni, in una lotta durissima che, nell’indifferenza quasi totale del resto del mondo, sta sconvolgendo completamente quella società. Per la Russia, l’Europa e gli Stati Uniti, invece, che giustamente non prendono in considerazione tale contagio, consapevoli della caratura degli oppositori in casa propria, i partigiani di Afrin non sono che pedine utili all’occorrenza, da usare e sacrificare secondo le contingenze. Per Asad, infine, sono “traditori”, ossia così arroganti da pensare di poter evitare di sottomettersi al do ut des degli intrighi mediorientali non divenendo opposizione statalizzata a loro volta. A sette anni dall’inizio delle rivoluzioni e della guerra questo rifiuto dimostra però che uno sbocco luminoso ai rivolgimenti sociali è possibile. Dimostra che l’inverno salafita o, in Europa, quello veteronazionalista e fascista, sono certo una realtà, ma non una necessità. Le donne e gli uomini di Afrin lo hanno detto chiaro: piuttosto che cedere le armi al regime o agli islamisti, resisteranno soli, con spirito di sacrificio; e preferendo questa strada per il sogno di una rivoluzione che si rifiutano di concepire altrimenti che come mondiale, cadono nel paradosso di dimostrare che qualcosa del genere c’è, semplicemente con la propria resistenza. Ci sveglieranno dal sonno torbido che ci aveva convinti, talora, che le vittorie derivino da un fato più o meno materialistico, e non dal credere in esse e nel riporvi la dedizione necessaria? Al momento, della possibilità per noi di interrompere questo sonno, non ci sono altre prove se non lei, Afrin. Non dobbiamo sostenerla perché sennò “cade”. Un’esperienza come questa non può cadere. Afrin vince anche se i compagni muoiono tutti, per una strana verità che dovrebbe esserci familiare. Siamo noi che, se non lo comprendiamo, siamo condannati ad ammettere che stiamo sopravvivendo in ginocchio. Davide Grasso
0 notes
Text
A Casalbeltrame. Semplicità e ricchezza
Un gruppo di case contadine si stringe a cerchio a rievocare il ricordo della protezione dei suoi abitanti sotto attacco; l’eco lontana del Medioevo risuona ancora. Intorno, uno specchio d’acqua riflette i profili delle grandi cascine circostanti, nascondendo al proprio interno il segreto e silenzioso germogliare di uno dei più semplici frutti della terra. Ogni chicco di quel riso racchiude una storia che si tramanda e la fedeltà al territorio: ci troviamo nella campagna della provincia novarese, a Casalbeltrame. Il piccolo paese, che conta poco più di novecento abitanti, è entrato nel novero delle città slow. Adagiato sulla grande piana piemontese, Casalbeltrame fa parte di quel panorama carico di un «fascino discreto e struggente», come hanno annotato Teresa Scacchi e Gianfranco Podestà nel loro libro-guida Viaggio in Piemonte. Lo sguardo dello spettatore si distende lungo la pianura, per risalire poi i contorni del maestoso Monte Rosa e perdersi nelle tinte del tramonto durante le sere di bel tempo. Discendendo nuovamente verso Casalbeltrame, l’attenzione ci porta a scoprire, passo dopo passo, tante piccole perle che fanno la ricchezza di questo centro.
Cultura come cibo e cibo come cultura
Medioevo, rinascimento ed epoca moderna si uniscono a Casalbeltrame, tanto nelle testimonianze storiche quanto nella cultura. Le case si raccolgono intorno al ricetto, struttura tipica del medioevo piemontese, mentre all’interno dell’abitato troviamo tracce di storia più recente nell’ottocentesco Palazzo Bracorens di Savoiroux, che ospita, oltre alla sua bellezza intrinseca, diverse mostre di arte pittorica e scultorea. L’imponente costruzione, eretta su tre piani, è inoltre sede di Materima, il progetto per la creazione di una “cittadella della scultura”. Materima si estende per più di ventimila metri quadri nel comune di Casalbeltrame, all’interno del Parco delle Lame di Sesia, occupando diversi luoghi, tra cui un’antica cascina appositamente restaurata e una parte del Palazzo Bracorens. L’idea di fondo è quella di dare vita a una sorta di bottega rinascimentale dove scultori e artigiani possano mettere in atto la propria creatività trovando a disposizione attrezzi e mezzi per ogni esigenza: spazi e strumenti pratici per la lavorazione dei materiali, ma anche spazi teorici, grazie alla messa in comune delle conoscenze e al progetto di una biblioteca a tema “scultura”. La calcografia è invece in funzione nella seconda delle cinque chiese “matrioska”, una fila di cinque edifici disposti in ordine decrescente che delinea una particolarissima struttura architettonica.
Le chiese “matrioska” – Casalbeltrame
Le chiese “matrioska” delimitano lo spazio di uno storico cascinale che coniuga cultura e buon cibo: in un’ala, infatti, trova accoglienza il museo etnografico L’civel, il quale, grazie alla presenza di storici carri e attrezzi agricoli unita ad attività multimediali, racconta il lavoro contadino di un tempo; nell’altra ala, invece, il lavoro agricolo di oggi si trasforma in pietanza, servita ai tavoli del ristorante Pane, amore…Poderia. “Semplicità, cura e gioia” è il motto di questo ristorante, che offre un menu diverso ogni mese, proponendo piatti tradizionali spesso rielaborati in modo da venire incontro all’esigenza “moderna” e diffusa di una dieta sana.
Dando uno sguardo alle proposte gastronomiche, possiamo imbatterci in una gustosa focaccia di riso Venere accompagnata da lardo alle erbe, ma anche in una più leggera insalatina di risi aromatici con verdure di stagione. Nelle varie portate, spicca sicuramente come elemento centrale il riso: si potrebbe dire che questo cereale fa tutt’uno con il territorio piemontese orientale, o, quanto meno, con la sua cucina locale, e ai fornelli di Pane, amore…Poderia non si pone limite alla fantasia nell’utilizzarne ampiamente tutte le varietà. Il riso “classico” è utilizzato nella preparazione dei “risutin” e della “paniscia”, piatto tipico fatto di fagioli, salame dell’olla, pomodoro e, naturalmente, riso. Il riso Venere, introdotto nella coltura dal 1995, viene impiegato nelle insalate, nei pizzoccheri e persino nei dolci! Una fetta di Torta Paradiso o di Sacher, entrambe al riso Venere, attendono gli ospiti a fine pasto. Inoltre, ogni pietanza è servita con focacce di riso Ermes e Venere, nonché con il trio di immancabili ingredienti: “semplicità, cura e gioia”. L’intento di Roberta e Fabio, proprietari di Pane, amore…Poderia, è proprio quello di creare un ambiente di gioia semplice e condivisa, all’insegna del buon cibo e del buon vino: «Pane, Amore…Poderia è uno spazio alternativo di condivisione in cui ritrovare il tempo per noi stessi, la libertà di scegliere e il piacere di gustare insieme». Un intento, dunque, in piena linea con la filosofia slow e che ha contribuito a rendere tale Casalbeltrame.
Pane, amore … Poderia - Vicolo della chiesa 4 - Casalbeltrame (NO) - Italy Tel: 3471084179 - e-mail [email protected] www.paneamorepoderia.com
Il ciclo delle stagioni, il ciclo del lavoro
In queste zone di campagna, il lavoro agricolo segue i ritmi dei cicli stagionali e dona al paesaggio aspetti e colori diversi: lo scintillare dell’acqua che inonda le risaie in primavera, l’oro delle spighe in estate, l’argento delle brine invernali… Proprio l’inverno è il momento più adatto per godersi il calore di una cena in compagnia e assaporare i risultati della risicoltura. A Casalbeltrame e dintorni sono numerosissime le aziende che si impegnano nella coltivazione di risi di qualità, che finiranno sulla tavola dei ristoranti elaborati in gustose ricette. C’è anche chi, in aggiunta, ha pensato a pranzi e cene “casalinghi”: l’azienda agricola Sala Rita, specializzata nella produzione dello zafferano, ha combinato la passione per questa spezia con l’alimento locale tradizionale, preparando risotti pronti di tutti i tipi (alle zucchine, ai carciofi, al radicchio…), senza mai dimenticare un pizzico di zafferano.
La pratica della coltivazione del riso ha radici lontane in Piemonte e negli anni le tecniche di coltura e di irrigazione si sono sviluppate sempre più, raggiungendo un’efficienza da primato. Nonostante l’introduzione di pesticidi e macchinari moderni, lo spirito pare rimasto inalterato nel tempo e, talvolta, anche alcuni mezzi: l’azienda Falasco di Casalbeltrame, ad esempio, è attiva da generazioni nella selezione dei migliori tipi di riso, con un occhio di riguardo a quelli meno comuni, e si avvale tuttora della manodopera stagionale. L’attenzione all’ambiente e la ricerca del particolare sono caratteristiche di questa azienda, che propone anche prodotti derivati a base di riso come biscotti, pasta e farine.
Tradizione e novità si combinano anche nell’attività dell’azienda Riso Buono di Luigi e Carlo Guidobono Cavalchini, situata sempre a Casalbeltrame nella tenuta La Mondina. La famiglia Guidobono Cavalchini ha le sue origini nobili nella stirpe dei Gautieri, i quali si trasferirono nel novarese verso la fine del Seicento, introducendo innovazioni nei metodi di coltivazione e irrigazione. Le generazioni che si sono susseguite hanno portato avanti questo lavoro con successo e ora si producono tanto risi classici come il Carnaroli quanto varietà particolari quali l’Artemide (un incrocio tra il Venere e un riso di tipo Indica).
L’abbraccio del silenzio fuori dal tempo
La cura e l’amore per il territorio si mostrano non solo nei campi, ma anche nel preservare certe zone naturali caratteristiche, come la Riserva naturale speciale. Quest’ultima fa parte della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame e accoglie più di duecento specie di uccelli nei vari periodi dell’anno; l’altra area della riserva è denominata Riserva naturale Orientata ed è adibita a coltura.
Il silenzio avvolge queste terre, ricche di acque che bagnano le risaie, tratti di natura pura e piccoli centri densi di cultura e storia. Il corso del tempo, per certi aspetti, pare quasi essere arrestato in paesini come Casalbeltrame, con il suo modo di vivere slow. La ricerca dell’abbraccio del silenzio era stata fatta propria dallo scrittore Sebastiano Vassalli, che aveva finito per trovarla nella piccola frazione Marangana di Biandrate, a pochi chilometri di distanza da Casalbeltrame. Qui possiamo osservare quella che era la sua abitazione, con un’iconica scritta sulla porta d’ingresso: “i soli stanno soli e fanno luce”.
L’inseguimento della quiete e della solitudine si accompagna all’amore per i luoghi in cui queste vengono raggiunte e all’accettazione anche dei suoi elementi più…scomodi: fuori dalla casa di Vassalli compare una curiosa scultura, il “monumento alla zanzara”, in ferro battuto e dorato. Anche le zanzare, complici l’abbondanza di acqua e l’umidità, fanno parte per Vassalli dell’ambiente novarese, gli appartengono da sempre, e in quanto tali vanno accettate o, per lo meno, sopportate.
Casalbeltrame e le piane novaresi sono tutto questo: semplicità, paesaggi talvolta melanconici che variano ciclicamente insieme ai ritmi della natura e del lavoro e una tranquillità avvolgente, punteggiata però da luoghi di convivialità e gioia, come Pane, Amore…Poderia.
Gloria Bargigia
Per imparare a conoscere il riso attraverso l'analisi sensoriale www.acquaverderiso.it
Tutte le immagini di questo articolo sono di ph. Giovanna Dal Magro – sito www. ART-PHOTO-IMPACT.Giodal.it
Casalbeltrame e pane, amore…poderia A Casalbeltrame. Semplicità e ricchezza Un gruppo di case contadine si stringe a cerchio a rievocare il ricordo della protezione dei suoi abitanti sotto attacco; l’eco lontana del Medioevo risuona ancora.
0 notes
Text
Leonardo da Vinci, il mulino di Bagnarola e la collocazione temporale dei fogli del Codice L
SOMMARIO
A) Introduzione B) Le fonti a disposizione C) Cronologia di compilazione delle pagine D) Il mulino di Bagnarola (di Cesenatico) E) I fogli attribuibili al mulino di Bagnarola F) Corrispondenze temporali tra il Codice L del Da Vinci e il Caos del Fantaguzzi G) Bibliografia
A) Introduzione
Parlare di collocazione temporale nell’ambito delle pagine del celebre Codice L di Leonardo Da Vinci significa cercare di incasellarne la redazione sulla base di ipotesi il più possibili aderenti alle prove oggettive arrivate fino ai giorni nostri. Un’analisi dettagliata di questo tipo di collocazione può avvenire prendendo in considerazione 3 elementi: le date effettivamente riportate da Leonardo stesso, elemento certo, la cronologia suggerita dai luoghi indicati in quanto in ordine di visitazione, elemento presumibile, e la cronologia suggerita dall’ordine di compilazione delle pagine stesse del Codice. Un quarto elemento, puramente residuale, riguarda ciò che specificatamente viene disegnato quando la presenza del soggetto possa essere legata a una determinata collocazione temporale.
Sembra banale esercizio di ripetizione l’indicare la cronologia classica attribuita al viaggio di Leonardo in Romagna disponibile in rete e sui principali libri sull’argomento[1], ovvero:
· 21 giugno 1502: probabile primo giorno di permanenza ad Urbino, dove Leonardo giunge insieme a Cesare Borgia;
· 30 luglio: ultimo giorno della permanenza di Leonardo ad Urbino;
· 1 agosto: primo giorno a Pesaro;
· 8 agosto: a Rimini dove annota, tra l'altro, l'armonia delle cadute d'acqua della Fontana cosiddetta "della pigna" nell'attuale piazza Cavour;
· 10 agosto: Leonardo é a Cesena per la festa di San Lorenzo;
· 15 agosto: é ancora a Cesena dove effettua il rilievo delle mura e redige altre note e schizzi di fortificazioni;
· 6 settembre: é a Cesenatico dove disegna una planimetria del porto canale e una veduta a volo d'uccello del borgo marinaro;
· 10 settembre: probabile arrivo a Imola; forse nei giorni precedenti é stato a Faenza dove ha disegnato la cattedrale. A Imola Leonardo realizza la mappa della città;
· 10 dicembre: probabile partenza da Imola.
Tuttavia analizzando bene l’elenco troviamo 3 mere supposizione non adeguatamente provate: il 21 giugno (“probabile primo giorno di permanenza ad Urbino”), il 10 dicembre (“probabile partenza da Imola”) e pure il 10 agosto, data non specificatamente riportata sul foglio 46 verso.

Codice L, 46 verso – Dispositivo visto alla Fiera di San Lorenzo
Sulla pagina si legge infatti “Alla fiera di San Lorenzo a Cesena 1502” e non “Il giorno di San Lorenzo”, pertanto sarebbe opportuno indagare su quanti giorni durasse la fiera, in che giornate fosse uso farla e, verificato il calendario dell’epoca, dare infine un range di collocazioni temporali che ovviamente supponiamo si discosterebbero al massimo di qualche giorno dal 10 agosto. Anche l’arrivo a Imola del 10 settembre non è supportato da fonti ma semplicemente immaginato per analogia con gli spostamenti di Cesare Borgia.
B) Le fonti a disposizione
Le fonti che possono esserci utili per questa ricerca sono fondamentalmente quattro: il Codice L stesso, la lettera-patente firmata da Cesare Borgia il 18 Agosto 1502, la mappa di Imola datata 10 settembre 1502 e, in forma residuale, cronache coeve come ad esempio quelle del Fantaguzzi che a onor del vero mai citano alcuna nota diretta su Leonardo e sul suo viaggio in Romagna.
Il documento fondamentale, ovvero il Codice L stesso, va innanzitutto analizzato per quello che realmente era: un taccuino di 94 pagine (94 fogli recto e 94 fogli verso) per prendere appunti. Non aveva un nome impresso sulla copertina: la denominazione “Codice L” è semplicemente postuma. Non aveva numeri di pagine impresse: anche la numerazione è postuma e probabilmente opera di Francesco Melzi, allievo e erede del Da Vinci. Non si può dire nemmeno che avesse un verso di utilizzo specifico, tant’è che vi si possono trovare anche all’interno dello stesso presumibile periodo alcune pagine redatte da un verso, come ad esempio il dispositivo meccanico visto a Cesena alla Fiera di San Lorenzo, e altre redatte dal verso opposto, come ad esempio il rilievo del Portocanale di Cesenatico.

Codice L, 66 verso – Rilievo del Portocanale di Cesenatico
Le dimensioni ridotte del taccuino stesso, 10.9 x 7.2 cm, lo rendevano particolarmente adatto ad essere “tascabile” e quindi sempre a disposizione, in quanto in sostanza delle dimensioni di un moderno tablet molto piccolo. E’ non di secondaria importanza sapere che questo taccuino non è stato utilizzato solo e specificatamente per il viaggio di Leonardo in Romagna e anzi, come vedremo di seguito, buona parte del contenuto non ha nulla a che fare con la Romagna e forse nemmeno con i primi del 1500. Infine gli schizzi dei rilievi riportati potrebbero essere anche solo la malacopia di ben più dettagliati prospetti delle città visitate, come ad esempio la mappa di Imola, a maggior ragione per la presenza di fogli che trattano argomenti secondari e per i quali il Borgia avrebbe probabilmente avuto scarso interesse.
La lettera-patente firmata da Cesare Borgia il 18 Agosto 1502 è il documento le cui indicazioni sono abitualmente tra le più fraintese. Tante volte si legge che a Leonardo sarebbe stato dato incarico dal Duca Valentino di “vedere, mesurare, et bene extimare” i luoghi e le fortezze della Romagna ma questa affermazione non può che risultare incompleta ad una semplice prima analisi del documento. Innanzitutto perché la lettera è datata 18 agosto, e presumibilmente ricevuta da Leonardo da Vinci quantomeno solo alcuni giorni dopo, mentre il suo viaggio è iniziato almeno almeno il 30 luglio precedente se non molto prima come ipotizzato dagli storici; non ha senso la presenza di una lettera di incarico ad incarico già iniziato da tempo. In secondo luogo la lettera non è destinata A Leonardo da Vinci ma è redatta PER Leonardo da Vinci; è destinata quindi ad essere osservata, traducendo, da tutti i luogotenenti, i castellani, i capi d’esercito, i condottieri, gli ufficiali, i soldati e i sudditi.


Lettera Patente redatta dal Duca Valentino (Cesare Borgia), datata 18 Agosto 1502 a Pavia con traduzione
L’unica motivazione genericamente riportata è quella di dover provvedere alla sistemazione dei luoghi e delle fortezze; non ne viene indicato il motivo reale ovvero se sia più un censimento o una redazione funzionale ad un ammodernamento delle infrastrutture, magari in chiave militare. Il motivo reale del viaggio, a meno di nuove scoperte documentali, lo si può solo ipotizzare e nulla di più; lo conoscevano probabilmente solo i diretti interessati e il “vedere, mesurare, et bene extimare” è unicamente funzionale a questo motivo non esplicito. La tempistica ci può inoltre far riflettere sulle motivazioni di una così tardiva redazione di un lasciapassare. Forse Leonardo ha problemi con le Signorie locali durante l’espletamento delle sue mansioni? Forse fa menzione al Duca Valentino di queste difficoltà e richiede il suo aiuto? Quest’ultimo specifica infatti esplicitamente nella lettera, traducendo, che Leonardo deve avere libero passo e accoglienza ovunque, essere esente da qualsiasi pagamento per sé e per chi lo accompagna, deve essere agevolato in ogni modo negli esami e nelle misurazioni, gli si debbono mettere a sua richiesta uomini a disposizione e gli si deve prestare qualunque assistenza, aiuto o favore che richiederà. Perché non dare già dall’inizio tutta questa facoltà d’azione se non a seguito di problemi insorti successivamente?
La mappa di Imola appare come un’opera totalmente differente dai fogli del Codice L; dettagliata, colorata, curata, ampia, un documento certamente idoneo ad essere presentato a chi gli avesse commissionato la spedizione e soprattutto un documento non compreso all’interno del Codice L. Leonardo arriva a Imola il 10 settembre 1502; è difficile pensare che solo allora cominci a dedicarsi alla redazione di un documento ben fatto e quindi è plausibile che siano andate perse tante altre opere analoghe relative al suo viaggio in Romagna. Si stima più in generale che i 2/3 delle opere su carta del genio fiorentino siano andate perse.

Mappa di Imola realizzata da Leonardo Da Vinci
Tra le altre fondi coeve risalta in particolare la raccolta di cronache raccolte nel Caos di Giuliano Fantaguzzi, la cui versione considerata in questa dispensa è quella a cura di Michele Andrea Pistocchi e edita dall’Istituto Storico Italiano per il Medioevo (ne esistono anche altre edizioni). Il testo non cita mai Leonardo Da Vinci o il suo incarico in Romagna ma è comunque un immenso tesoro di nozioni e date su cui tentare una correlazione con i fatti dell’epoca.

Copertina della raccolta di cronache Caos di Giuliano Fantaguzzi, a cura di M.A.Pistocchi
C) Cronologia di compilazione delle pagine
Il Codice L non è un taccuino destinato al viaggio in Romagna di Leonardo da Vinci. E’ un taccuino che contiene ANCHE e in buona parte degli appunti redatti durante tale viaggio. All’interno però vi sono anche appunti relativi ad un inventario datato 4 aprile 1497 e a dettagli e note relativi alle città di Siena, Firenze, Piombino, Orvieto, Milano e Ricorboli (FI), oltre a tanto altro materiale non databile o localizzabile. Apparentemente non vi è una consequenzialità di redazione, neanche prendendo in considerazione solo le mete del suo viaggio in Romagna; tuttavia è possibile identificare per grandi linee un metodo di compilazione. Immaginiamo di avere un nostro libretto vuoto analogo e immaginiamo di utilizzarlo per nostri appunti non organizzati. Ogni tanto lo utilizzeremo da un verso, partendo a caso probabilmente da una delle prime pagine, e ogni tanto lo utilizzeremo dall’altro verso, partendo sempre a caso probabilmente da una delle prime pagine. Proseguendo nella compilazione casuale del taccuino, da un verso o dall’altro, tenderemo pian piano a portarci sempre più verso il centro del libretto, compilando quindi cronologicamente la parte centrale in un momento successivo rispetto alle pagine che più sono vicine alle copertine.

Ipotesi cronologica di compilazione del Codice L
Questo tipo di compilazione pare essere lo stesso rilevabile nelle pagine del Codice L; i fogli dalla prima di copertina al 15 recto (31 facciate) paiono tutti slegati dal viaggio in Romagna, ad eccezione del foglio 8 recto, dove il dettaglio di una colombaia di Urbino è l’unico presente sul foglio, e del foglio 6 recto, dove la stessa colombaia viene riproposta e datata 30 luglio 1502 ma apparentemente disegnata nello spazio residuale rispetto a un (precedente?) rilievo di un terreno con scolatoio.

Codice L, 6 recto – Rilievo di terreno con scolatoio e dettaglio di colombaia d’Urbino
Nello stesso intervallo di pagine si contano altre 3 facciate vuote, 11 recto, 12 verso e 13 recto, dove Leonardo da Vinci avrebbe potuto effettuare altre annotazioni postume. Allo stesso modo non hanno grande attinenza col viaggio in Romagna, o comunque riportano al massimo note relative ad Urbino, i fogli dal 78 verso all’ultima di copertina (35 facciate); le due facciate dedicate ad Urbino, prima tappa del viaggio, sono proprio sul limite dell’intervallo considerato, ovvero la 78 verso e la 79 recto, mentre alcune annotazioni relative a ciò che vede a Pesaro sono scritte sul retro copertina, forse usata come pagina vuota “di emergenza”. La pagina 82 recto riporta uno schizzo di “carro da Cesena” ma pare più che altro un piccolo disegno realizzato utilizzando dello spazio residuo in una pagina già compilata precedentemente.

Codice L, 82 recto – Dettaglio di carro da Cesena
Nelle facciate rimanenti c’è poi uno spazio meno definito che va indicativamente dalla 15 verso alla 33 verso dove si alternano elementi che potrebbero avere a che fare col viaggio ed elementi che richiamano altre città; dal disegno della rocca di Cesena, con presunto schizzo della cattedrale di Faenza, alle scale d’Urbino, a considerazioni su schizzi di caduta dell’acqua, che potrebbero far pensare ad un legame con l’appunto dell’8 agosto sulle armonie idrauliche della fontana di Rimini, passando per dettagli di una campana di Siena e considerazioni sull’Arno di Rusciano a Ricorboli (FI).

Codice L, 15 verso – Possibile schizzo della cattedrale di Faenza (sopra) e dettaglio di rocca di Cesena (sotto)
Nell’ultimo intervallo di facciate residuo, ovvero dal foglio 34 recto al foglio 78 recto, non c’è altra indicazione di città se non quelle del suo viaggio in Romagna, 12 richiami in tutto su un totale di 89 facciate. Non solo; ad eccezione di 17 facciate consequenziali e dedicati al volo degli uccelli, questi fogli riportano quasi esclusivamente rilievi, disegni architettonici, considerazioni e schizzi meccanici, probabilmente quanto di più legato vi fosse allo scopo del suo viaggio in Romagna. I rilievi a Cesenatico di Leonardo, gli ultimi in ordine di datazione certa presenti sul Codice L, risultano in posizione centrale rispetto allo stesso; dal foglio 66 verso al foglio 68 recto; anche questo un caso?

Codice L, 68 recto – Vista aerea di Cesenatico

Ricostruzione del foglio 68 recto[2]
Se risultasse attendibile questo empirico, nonché istintivo, metodo di compilazione del taccuino potrebbe risultare logico dedurre che le stesse 17 facciate consequenziali dedicate al volo degli uccelli sarebbero state compilate tra fine agosto e inizio settembre 1502, in quanto centrali, e precedentemente rispetto ai rilievi di Cesenatico in quanto trovare così tante facciate libere consequenziali è sempre più difficile man mano che si riempiono le facciate di un taccuino; sarebbe bello pensare a un Leonardo da Vinci proprio sulla spiaggia di Cesenatico intento a studiare il volo dei gabbiani prima di dedicarsi agli impegni per il Duca Valentino.

Codice L, 61 verso – Considerazioni sul volo degli uccelli

Codice L, 54 verso – Considerazioni sul volo degli uccelli
Tale ipotesi pare inoltre essere confermata dalla disposizione delle pagine del codice che in ordine cronologico risulta il successivo, ovvero il Codice K o più nello specifico il K1. Al foglio 2 recto prosegue infatti il racconto del viaggio di Leonardo in Romagna tramite gli appunti sui pastori alle radici degli appennini che utilizzano un corno del quale amplificano il suono avvicinandolo ad una cavità molto più grande. Ma non solo; come molte tra le presunte ultime pagine del Codice L riportano studi sul volo degli uccelli, così altrettanto il Codice K prosegue dal foglio 3 recto con numerose pagine di appunti sul volo degli uccelli.

Codice K1, 3 recto – Descrizione di concavità utilizzata dai pastori per amplificare il suono

Ricostruzione[3] in disegno della pagina 3 recto

Riproduzione[4] reale della pagina 3 recto a Sogliano sul Rubicone
D) Il mulino di Bagnarola (di Cesenatico)
Vi sono indizi tali da far supporre che la tecnologia dell’antico mulino di Bagnarola, localizzato alla fine dell’attuale via Torri, potesse essere stata abbozzata da Leonardo da Vinci proprio sul Codice L. Li riassumo in breve:
· Il mulino è stato realmente realizzato dai Frati di Santa Maria del Monte nel 1505 e il viaggio di Leonardo in Romagna è solo di 3 anni prima;
· I frati richiedono, con petizione del 29 luglio 1505, l’autorizzazione al governatore di Cesena (dipendente dall’autorità papale di Giulio II) di poter realizzare un mulino e il cronista coevo Fantaguzzi riferisce che nello stesso anno lo costruiscono. Dati i tempi stretti probabilmente l’inizio dei lavori, e ancor di più il progetto del mulino, sono antecedenti e magari richiesti a suo tempo già a papa Alessandro VI, padre di quel Cesare Borgia che ha inviato Leonardo da Vinci in missione nelle Romagne;
· Lo schizzo di Leonardo al foglio 63 verso riporta una macina da mulino per trazione animale. I fogli dal 69 recto al 71 recto riportano dettagli e considerazioni specifiche su ruota e flussi di un mulino ad acqua. Come da testimonianza di una mia prozia, ultima persona in vita ad aver visto coi suoi occhi il mulino prima che fosse chiuso e poi distrutto durante la guerra, il mulino ad acqua di Bagnarola poteva funzionare anche a trazione animale e la macina era effettivamente realizzata come quella nello schizzo di Leonardo;
· I fogli degli schizzi del mulino di Leonardo sono collocati poco prima e poco dopo rispetto ai rilievi di Cesenatico;
· I fogli degli schizzi del mulino di Leonardo non riportano eccentrici macchinari o bizzarre costruzioni, com’era stato per altri disegni, ma dettagli e indicazioni utili per l’effettiva e pratica realizzazione di un efficiente mulino ad acqua;
· Leonardo da Vinci per andare da Cesena a Cesenatico, tra il 15 agosto e l’8 settembre, per forza di cose è passato dalla “via Nova”, l’attuale via Cesenatico che anche allora collegava le due località, passando quindi per forza di cose da Bagnarola, località già allora esistente nonché grande fattoria e principale sostentamento economico dei Frati di Santa Maria del Monte. Gli stessi frati avevano a Bagnarola proprio la loro residenza estiva;
· Tali schizzi non sono mai stati rivendicati per qualsivoglia altro mulino né risultano in quel periodo nel cesenate altri mulini in corso di realizzazione.

Codice L, 63 verso (dettaglio) – Macina di mulino a trazione animale
Era ipotizzabile anche la possibilità che i tranci di uve appese disegnati a Cesena (foglio 77 recto) fossero successivi agli schizzi di Cesenatico in quanto la vendemmia arriva solitamente verso metà settembre, ipotizzando quindi un secondo passaggio da Bagnarola; tuttavia, come riporta il Fantaguzzi, quell’anno fu una torrida estate e non è da escludere quindi una vendemmia anticipata. Testualmente[5], parlando del periodo tra luglio e agosto: “Questo anno stete dui mixi che non piobe e fo caldi grandissimi insuportabilli”.
Tale indizio oltretutto, alla luce di quanto riportato precedentemente, risulterebbe superfluo dato che, qualora il metodo di collocazione temporale dei fogli trovasse riscontro, la presenza delle pagine del mulino tra quelle più centrali del Codice L nonché la vicinanza con quelle relative a Cesenatico darebbe ulteriore valore alla collocazione temporale vicina all’8 settembre e avvalorerebbe la tesi sostenuta: che Leonardo da Vinci avesse realizzato tali schizzi proprio per il mulino di Bagnarola.

Codice L, 77 recto – Uve appese viste a Cesena

Riproduzione[6] delle uve appese viste a Cesena
Ma c’è un ulteriore importantissimo indizio. Nella traduzione integrale della lettera-patente del 18 agosto 1502 che Cesare Borgia mette a disposizione di Leonardo da Vinci è possibile leggere anche che “su qualunque opera si intraprenda nei nostri domini, tutti i costruttori sono tenuti a consultarsi con lui (Leonardo), attenendosi alle disposizioni ch’egli vorrà impartire.”. Questo è un dettaglio di primaria importanza; il Duca Valentino in sostanza OBBLIGAVA tutti coloro che nel 1502 avessero avuto intenzione di costruire una nuova opera a consultare preventivamente Leonardo da Vinci e ad ATTENERSI ALLE SUE DISPOSIZIONI; quindi anche i frati, intenzionati eventualmente già in quel periodo a realizzare un mulino, sarebbero stati OBBLIGATI a rivolgersi a lui. Per svelare un legame tra gli schizzi di Leonardo e il mulino di Bagnarola non è quindi più necessario cercare della corrispondenza dove i frati richiedano al Governatore l’assistenza di Leonardo o genericamente di un ingegnere; basterebbe trovare una lettera o una petizione antecedente all’estate del 1502, magari tramite l’Archivio di Stato di Cesena, dove i frati dichiarano la loro intenzione o il loro interesse alla realizzazione di un mulino nella fattoria di Bagnarola.
E) I fogli attribuibili al mulino di Bagnarola
Per capire meglio cosa riportassero i fogli con le pagine che nella nostra ipotesi potrebbero riferirsi ad uno studio per la realizzazione del mulino di Bagnarola procedo qui di seguito ad una dettagliata descrizione individuale con tanto di traduzioni[7], o meglio di esplicitazioni dell’illeggibile scrittura di Leonardo, in quello che viene definito il cosiddetto linguaggio in “volgare”.
Il foglio 63 verso riporta una macina da mulino a trazione animale con diametro e leva dimensionati in braccia.

Codice L, 63 verso
Un “braccio fiorentino” corrisponde a 0,583 metri (altri si differenziano per circa una decina di centimetri o poco più) pertanto se la consideriamo come riferimento, essendo Leonardo originario della provincia di Firenze, ricaviamo una leva dimensionata a 5,83 metri e una macina con un diametro di 2,04 metri. Vediamo sulla parte centrale del piano, quella percorsa dalla macina, un’area probabilmente ribassata e quello che probabilmente è un canaletto che dal centro arriva fino alla fine del piano, forse per permettere all’olio di fluire verso una zona di raccolta.
Da un’approssimativa proporzione questo piano risulterebbe disegnato attorno ai 10 metri di diametro. Nell’uso abituale di questo tipo di macine la parte di estrema sporgenza della leva veniva legata all’animale da traino che, girando attorno al piano stesso, provocava la rotazione della macina e il conseguente schiacciamento di grano, olive o quant’altro fosse posto nella parte centrale.

Esempio di macina a traino animale[8]
Nella parte inferiore della pagina è invece riportato un edificio circolare che probabilmente non ha attinenza con la macina, essendo questo apparentemente dotato di un fossato e quindi più adatto ad essere considerato come una fortezza. L’unico legame apparente tra la macina di mulino e l’edificio è la forma circolare di entrambi.
Il foglio 69 recto riporta due appunti distinti con rispettiva descrizione. In alto vediamo considerazioni meccaniche sulla trazione di un elemento posto su di un piano inclinato e come varia questo gravare al variare del peso dell’altro. Non pare un appunto immediatamente riconducibile ad un mulino o quantomeno ad appunti utili alla realizzazione di un sistema idraulico.
Nella parte bassa del foglio vediamo invece schematizzato il disegno di una ruota, ovvero la ruota di un mulino ad acqua, con il flusso d’acqua che procede per caduta a circa 45 gradi. Leonardo da Vinci appunta di come la potenza dell’acqua nei raggi della ruota vada misurata nel raggio (o forse intendeva più precisamente nel diametro) f-g, punti riportati agli estremi della ruota stessa.
L’indicazione di dove misurare la potenza dell’acqua, così come il disegno stesso, non pare qualcosa di visto in loco ma più una serie di indicazioni poste sotto forma di progetto teorico.

Codice L, 69 recto
Il foglio 69 verso riporta prevalentemente dei dettagliati schizzi per la realizzazione della ruota di un mulino nonché un appunto sui fossi, probabilmente canali del mulino.
La prima figura in alto a destra riporta la sequenza di realizzazione delle pale della ruota del mulino: pale che a raggio si congiungono al centro della ruota, quindi che la sostengono strutturalmente, intervallate da 2 pale fissate all’estremità terminale della ruota su una struttura che riprende il profilo della circonferenza. Subito sotto Leonardo illustra il sistema di fissaggio degli stessi: due coppie di pioli che, battuti alle estremità, si bloccano reciprocamente. I fori dove vanno inseriti questi pioli sono illustrati nello schizzo in alto a sinistra del foglio. Ovviamente l’acqua del mulino, grazie all’azione rigonfiante che ha sul legno, provvederà ad assicurarne una costante tenuta in tiro.
Questi disegni non sembrano l’indicazione di qualcosa che Leonardo vede ma appaiono come un disegno redatto ad uso e consumo di chi quella ruota le deve disegnare. Non avrebbe probabilmente infatti visto i fori liberi per l’inserimento dei pioli ma solo i componenti assemblati.
La parte inferiore del foglio è invece dedicata al disegno di due canali dove scorre l’acqua. Riporta il testo “Storie da ssechare, i fossi dove l'acqua superassi”. Quel termine “storie” è stato tradotto nel libro che ho come riferimento nel termine “motore” anche se, visto il disegno, secondo me il termine più adatto sarebbe “stole”. Quelle strisce appese ad una sorta di trave che va da riva a riva sembrano essere stole che Leonardo vede o suggerisce per “seccare i fossi”. Non è chiaro se sia uno strumento per scavare il fosso, per mantenerlo asciutto a valle della chiusa, come una sorta di barriera d’anticamera, o per altro scopo.

Codice L, 69 verso
Il foglio 70 verso è direttamente collegabile al disegno teorico riportato alla pagina 69 recto. La stessa ruota di mulino, disegnata ora con 4 raggi principali e 12 raggi intermedi secondari, riceve l’acqua anche in questo caso da un canale inclinato. Il testo, scritto con la solita calligrafia semi-indecifrabile, non è chiaro nemmeno per gli storici e dice approssimativamente che “L'acqua a n perchote in a linia dal cientro alla circunferentia della piv brieve della rota”. Pur senza riuscire ad individuare con precisione il dettaglio teorico che Leonardo vuole evidenziare, è plausibile notare come anche in questo caso sia riportato un dettaglio teorico utile per l’efficiente realizzazione di una ruota di mulino.
Tuttavia un dettaglio importante che salta meno all’occhio di primo impatto e che invece può chiarire definitivamente che questo non è stato un mulino visto, quindi già esistente, ma solo ideato da Leonardo è il seguente: nel foglio 69 verso abbiamo una chiara successione di 2 raggi secondari intervallati da raggi strutturali principali diretti al centro della ruota mentre nel foglio 70 recto abbiamo una successione di 3 raggi secondari intervallati da raggi strutturali. Come se questo non bastasse, nel foglio 69 verso i raggi strutturali appaiono, approssimando, con una divergenza attorno ai 30 gradi mentre nel foglio 70 recto i raggi strutturali appaiono a 90 gradi tra di loro. E’ quindi questo un chiaro indizio, che si abbina ai numerosi appunti teorici riportati di pugno da Leonardo sui fogli stessi, del fatto che quella ruota di mulino molto probabilmente non è stata vista ma solo ideata. E in quel periodo mi risulta che nel Cesenate stesse per essere realizzato solo un mulino: quello di Bagnarola.

Codice L, 70 verso
Il foglio 71 recto, l’ultimo preso in considerazione e verosimilmente legato ai precedenti, riporta il disegno di una sorta di canale, probabilmente il canale inclinato dove scorre l’acqua portata alla ruota del mulino, e dove pare esservi un’indicazione non meglio specificata di dove la pressione sia buona o “trista”.

Codice L, 71 recto
F) Corrispondenze temporali tra il Codice L del Da Vinci e il Caos del Fantaguzzi
Esaminando cronaca per cronaca il Caos del coevo Fantaguzzi è possibile determinare alcune corrispondenze di datazioni che, stranamente, non vengono proposte dagli storici. Qui di seguito ne viene proposto un breve elenco.
La prima data che viene proposta tipicamente un po’ ovunque in merito al viaggio di Leonardo da Vinci in Romagna è il 21 giugno 1502 che viene definito come “probabile primo giorno di permanenza ad Urbino, dove Leonardo Da Vinci giunge insieme a Cesare Borgia”. Tuttavia il Caos del Fantaguzzi al foglio 64v ci propone uno scenario forse un po’ troppo movimentato per rischiare di perdere in guerra un ingegnere. Infatti recita testualmente: “A dì 20 giugno el duca V(alentino), venuto da Roma velocissimamente, se retrovò a Spoleti con parte de lo exercito; et a dì 21 prexe Caio (Cagli) cità del duca d’Urbino. Et a dì ditto prese la cità de Urbino et 400 castella con tutto el suo ducato e forteze e Santo Leo. Cosa miracollosa et incredibille. Et fo messo a saco parte del conta’ d’Urbino. Et lo duca dì’Urbino fugì a Castello Novo de viniciani già de miser Gotofredo da Isei toltolli da Guido Guerra. (…)”.
Non so quali documenti attestino la presunta venuta assieme al Borgia ma mi sembrerebbe uno scenario troppo rocambolesco ed incerto per scegliere di portarsi appresso il Da Vinci. Del resto la prima data riconducibile ad Urbino è quella dello schizzo della Colombia datata 30 giugno 1503 quindi non c’è urgenza di anticiparne l’arrivo, per quanto il Duca Valentino potesse essere sicuro del suo ingresso trionfale in città; più probabilmente Leonardo da Vinci arrivò solo quando le acque si erano già calmate da qualche giorno.
A conferma di questo sempre al foglio 64v un’altra cronaca recita: “A dì 24 giugno el dì de san Zoanno el duca fè bandire a Cesena che avea preso Urbino, però che el duca non li era stato fedele; (…)”. Quindi solo il 24 giugno, giorno di San Giovanni, il Duca Valentino comunica ufficialmente a Cesena di aver preso Urbino. Se ne andrà solo il 2 luglio, come riportato al foglio 65r: “El duca V(alentino) a dì 2 luglio sgomberò Urbino e con le gente d’arme e parte del suo exercito andò verso Toscana e tutte le fanterie bene in ordine”.
Di seguito vengono indicate due cronache del foglio 65v che, per comune appartenenza, ci dicono che siamo nel mese di agosto: “La artilleria vene de campo da Urbino; passò a Cesena e andò a Forlì a dì 3 d’agosto. (…)” e “A Roma d’agosto fo morto in casa sua un + del papa che portava la croce del papa”. L’ultima cronaca del foglio riporta: “El cardinal Borgia Legato, miser Agabitto e miser Ramirro venenno a Cesena”. Un’ipotesi possibile è che Leonardo Da Vinci abbia raggiunto Cesena assieme ai 3 sopra citati. Il motivo dell’ipotesi (sottolineo, dell’ipotesi) lo spiegherò nei paragrafi più avanti; per ora mi limito a una descrizione dei personaggi. Il cardinale Borgia è sicuramente Juan Borgia “il maggiore”, nipote di Papa Alessandro VI e cugino del più noto e abile Cesare Borgia; ebbe vari incarichi diplomatici ma sempre e comunque in secondo piano rispetto al cugino.
Miser Agabitto era sicuramente Agapito Geraldini Di Amelia, definito l’ombra di Cesare Borgia. Riporto un breve estratto[9]: “Agapito era divenuto la figura indispensabile nella gestione dell'attività diplomatica del Valentino. Non rari furono i suoi incontri coi grandi uomini del tempo, tra cui Leonardo da Vinci, chiamato dai Borgia a ispezionare fortini ed a redigere progetti per opere difensive in Romagna”. Miser Ramirro era infine Ramiro di Lorca, condottiero di ventura[10] che a giugno “Partecipa all’azione contro Urbino; corrompe il castellano Ludovico Scarmone che gli consegna San Leo.”, a luglio/agosto “Raccoglie a Cesena 700 fanti tra gli abitanti e li conduce all’assedio di Santarcangelo di Romagna. Ad agosto rientra a Cesena” e a settembre è “ad Imola”. Il Fantaguzzi lo definisce “homo diabolico”. L’arrivo di Agapito ad agosto a Cesena, per quanto indicato sopra, mi fa come detto ipotizzare che Leonardo Da Vinci sia partito da Rimini (8, 9 o 10 agosto) e arrivato a Cesena (8, 9 o 10 agosto) assieme a loro.
Sul foglio 66r del Caos del Fantaguzzi troviamo quindi una conferma in merito alla lettera patente redatta da Cesare Borgia per Leonardo Da Vinci il 18 agosto 1502, ovvero solo a metà del suo incarico in Romagna. La lettera è firmata “Pavia, 18 agosto 1502” e proprio al foglio 66r una cronaca riporta di come: “El re de Franza da Pavia andò a Genoa e ‘l duca V(alentino) con lui; (…)”. Questa conferma del luogo purtroppo non aggiunge nulla alle modalità della consegna della lettera patente a Leonardo da Vinci.

Cesare Borgia, Duca di Valentinois e Duca di Romagna – Fonte: wikipedia
Tuttavia accanto alla prima ipotesi indicata sopra possiamo aggiungerne una alternativa, ovvero che Juan Borgia, Agapito Geraldini di Amelia e Ramiro di Lorca abbiano raggiunto si Cesena, ma non tra l’8 e il 10 agosto provenendo da Rimini ma successivamente al 18 agosto provenendo da Pavia. Qui sarebbe interessante approfondire il tema tramite storici che abbiano accesso a fonti più approfondite di quelle a mia disposizione, pur consapevole che la Lettera Patente potrebbe essere stata anche recapitata tramite un anonimo appositamente incaricato.
Una voce che propende per questa ipotesi alternativa, e quindi per la consegna della lettera patente da parte di Agapito Geraldini, proviene dallo storico Fiorenzo Laurelli[11] che in una nota cita quanto segue: “Anche la biografia di Leonardo di Vecce, pur riportando il celebre salvacondotto, non fa alcun accenno diretto al Geraldini: l’autore descrive il latinorum della solenne intestazione e l’«elegante scrittura umanistica» del testo riferendoli ad «un segretario borgiano» (cfr. VECCE, Leonardo, cit., p. 212). D’altra parte, l’intera vicenda del Vinci presso il Valentino è tracciata in pochissime pagine in un saggio che, naturalmente, deve trattare non solo del periodo borgiano bensì l’intera biografia e l’opera del Vinci. Su Agapito, oltre a CANSACCHI (cit.), cfr. N. MACHIAVELLI, Legazioni e commissarie, Milano 1964.
Per dimostrare con quanta superficialità Agapito Geraldini fu rappresentato da molti studiosi, rammenteremo che in BELTRAMI (cit., p. 21) il salvacondotto di Leonardo figura firmato, nella trascrizione diplomatica, da «Agapitus Beraldinus», e sempre Beltrami ricorda che «in un elenco di personaggi di qualità, al seguito di Cesare Borgia, è menzionato Messer Agabito da Amelio segretario» (ibid.). Nella nota 1 aggiunge, per soprammercato, che, leggendo la firma della lettera-patente, «nella trascrizione comunicata al Della Valle, il nome del segretario era stato interpretato A. Basyl.» (ibid.). Il Geraldini è, per finire, l’«Agapito da Narni» indicato da G. PEPE ne La Politica dei Borgia (Napoli 1946, p. 145), mentre in I. CLOULAS (I Borgia, Roma 1988) è chiamato «Agapito Gherardi di Amelia»; più spesso è ��il fedele segretario» (alle pp. 212, 249, 315, 330, 393), altre volte è «il fedele servitore» (p. 218).”. Questa tesi, oltre a sancire la firma dell’Agapito riportata al centro della lettera-patente, avvalora il fatto che questa sia stata da lui portata a Leonardo proprio di ritorno da Pavia, e probabilmente anche da lui redatta.
Le due ipotesi non sono comunque incompatibili dato che il Fantaguzzi specifica che “El cardinal Borgia Legato, miser Agabitto e miser Ramirro venenno a Cesena” ma non specifica necessariamente che vi fossero arrivati insieme, dalla stessa città di provenienza e magari neanche esattamente lo stesso giorno. Rimane plausibile quindi anche l’ipotesi del Borgia e/o del Ramiro provenienti da Rimini e dell’Agabitto proveniente da Pavia.
Sempre al foglio 66r del Caos c’è però una cronaca ancora più interessante che recita: “El cardinale Borgia vene a stare a Cesena con la famia del duca e alogiò a discrezione in casa di citadini con danno suo e discunzo asai. E a dì 8 setembre se partirono e andonno a Imola”. Come accennato qualche paragrafo più su, anche Ramiro di Lorca è localizzato a Imola nel mese di settembre, pur non potendo sapere se lo spostamento sia avvenuto contemporaneamente, se non insieme, a quello del cardinale.
Questa testimonianza ha dell’eccezionale in quanto lega perfettamente con gli spostamenti di Leonardo Da Vinci che come sappiamo per certo il 6 settembre è a Cesenatico e il 10 settembre, coma da supposizione degli storici ampiamente accettata, è a Imola. Proprio questa coincidenza troppo forte rafforza anche le precedenti ipotesi, pur nella doverosa necessità di approfondirne i riscontri. Se confermata, renderebbe forse un po’ più debole l’ipotesi della sosta di Leonardo Da Vinci a Faenza, togliendo almeno 2 giorni all’intervallo di date ipotetico; tale ipotesi è infatti unicamente sostenuta dalla presenza al foglio 15 verso del Codice L di un edificio che “assomiglierebbe vagamente” alla cattedrale della cittadina.
Tra l’altro, giusto per aprire una parentesi colorata, a fine 2014 venne diffusa la notizia[12] di un Faentino appassionato di storia che si fece finanziare da una banca locale una ricerca tramite georadar allo scopo di individuare “un camminamento tra la piazza del Popolo, dai piedi dello scalone di Palazzo Manfredi, alla Cattedrale, studiato da Leonardo Da Vinci”, ovvero quanto disegnato proprio sotto alla presunta cattedrale locale. Non so se tale ricerca abbia poi mai avuto luogo ma sicuramente non avrà dato la soddisfazione sperata; se lo studioso avesse preso in mano la decifrazione del Codice L in Italiano volgare liberamente disponibile in rete avrebbe da subito capito che i due schizzi non sono legati tra di loro in quanto quello riportato nella parte inferiore della pagina altro non è che la rocca di Cesena, in quanto proprio Leonardo Da Vinci vi scrisse affianco “Rocha di Cesena”.
Chiudiamo la parentesi e torniamo al Caos del Fantaguzzi; sempre sul foglio 66r leggiamo che “A dì 11 el duca V(alentino) venne a Imolla de Franza de settembre. Et la rocha e corte fè alegreza”. Cesare Borgia quindi si ritrova l’11 settembre a Imola con Leonardo da Vinci, col cugino Cardinale e forse, perché no, anche con la sua ombra Agapito Geraldini di Amelia, pure se non viene citata nella cronaca.
Su quale fosse il ruolo di Leonardo Da Vinci nei piani di Cesare Borgia se ne sono dette tante e probabilmente tutte ipotesi compatibili. C’è chi afferma che il Duca Valentino volesse fare un censimento delle sue nuove conquiste, chi propende più per l’incarico di studiare migliorie o nuove opere e chi infine ritiene più plausibile la necessità di studiare rinforzi di tipo militare per le fortezze delle città del Ducato di Romagna. Tra le tante ipotesi ascoltate non avevo mai avuto notizia invece dei piani che il Borgia, per voce di cronaca del Fantaguzzi, aveva su Cesena proprio in corrispondenza del suo arrivo a Imola: “(…) E volea fare a Cesena palazo, canale, Rota, studio, cecha (zecca), piaza in forteza, agrandare Cesena, fontana in piaza duchessa, corte a Cesena, fare el Porto Cesenatico et finalmente farse re de Toschana et poi imperrator de Roma con castello Santo Angello. (…)”. Tra i tanti progetti riportati, quel “canale” probabilmente fa riferimento al progetto, mai realizzato, di realizzare un lungo canale che congiungesse Cesena con Porto Cesenatico.

Leonardo Da Vinci, autoritratto – Fonte: wikipedia
Invito chiunque voglia approfondire, dare contributi o suggerire fonti terze a contattarmi.
G) Bibliografia:
· Il Codice L, di Leonardo Da Vinci – Edizione elettronica con decifrazioni in Italiano volgare a cura de L'Institut de France di Parigi;
· Il Codice K1, di Leonardo Da Vinci – Edizione elettronica con decifrazioni in Italiano volgare a cura de L'Institut de France di Parigi;
· Leonardo Da Vinci e Cesena, a cura di Pino Montalti – Edizioni Giunti;
· Caos di Giuliano Fantaguzzi, a cura di Pistocchi M.A. – Edito da Istituto Storico per il Medio Evo;
· Da S.Agata a Macerone, Nove secoli di insediamenti fra la Mesola e il Pisciatello, a cura di Claudio Riva – Edito dalla Banca di Credito Cooperativo di Macerone;
· Bagni pubblici romani a “Villa Bagnarola” di Cesenatico, a cura di Bruno Ballerin, in Romagna arte e storia n.90 del 2010 - Edito da Romagna arte Storia;
· Storia di Cesena III, La dominazione pontificia, a cura di A.A.V.V. – Edito dalla Cassa di Risparmio di Cesena e Bruno Ghigi Editore;
· Storia di Cesenatico, a cura di Davide Gnola – Società Editrice “Il Ponte Vecchio”.
[1] Fonte: Storia di Cesenatico di D. GNOLA, Soc. Editrice Il Ponte Vecchio Cesena
[2] Ricostruzione visionabile presso il Museo della Marineria di Cesenatico realizzata nel contesto della mostra “Leonardo da Vinci al Porto Cesenatico”, fonte: www.barchedepocaeclassiche.it
[3] Fonte: http://divisare.com/projects/4219-Pino-Montalti-Le-Concavita-Di-Leonardo-Da-Vinci a cura di Pino Montalti
[4] Il progetto delle "concavità" inserito all'interno del Parco San Donato di Sogliano al Rubicone (FC)
[5] Fonte: G. Fantaguzzi, "Caos", a cura di Michele Andrea Pistocchi
[6] Fonte: presentazione del libro “Leonardo Da Vinci E Cesena” di Pino Montalti, su http://divisare.com/albo/78-Ordine-degli-Architetti-Pianificatori-Paesaggisti-e-Conservatori-della-provincia-di-Forl-Cesena/projects/4213-Pino-Montalti-Leonardo-Da-Vinci-E-Cesena
[7] Fonte: http://warburg.sas.ac.uk/pdf/cnm20b2242029v5.pdf
[8] Fonte: Museo dei Brettii e del Mare di Cetraro (CS), http://www.museodeibrettiiedelmare.it/it/poi/museo-di-arte-e-mestieri-antichi/
[9] Fonte: Sito della famiglia Geraldini, http://www.geraldini.com/content/46/agapito-geraldini-di-amelia--ombra-di-cesare-borgia.html
[10] Fonte: Sito dei condottieri di ventura, http://www.condottieridiventura.it/index.php/lettera-l/1319-ramiro-di-lorca
[11] Fonte: Fiorenzo Laurelli, “La prima signora Elisa, o della committenza del ritratto di Monna Lisa Gherardini, detto La Giocona”, Rivista Storica del Sannio, anno 2000.
[12] Fonte: http://www.ravenna24ore.it/news/faenza/0046635-faenza-un-georadar-alla-ricerca-del-camminamento-leonardo-vinci
#bagnarola#cesenatico#bagnarola di cesenatico#leonardo#mulino#leonardo da vinci#mulino ad acqua#caos#fantaguzzi#borgia#cesare borgia#storia#codice L
0 notes
Photo
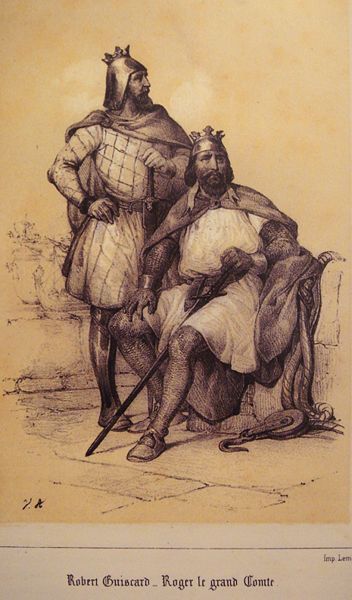
Nuovo post su http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/06/02/litinerario-seguito-da-federico-ii-salpato-da-brindisi-il-28-giugno-1228/
L’itinerario seguito da Federico II salpato da Brindisi il 28 giugno 1228
Giugno, lunedì 05, h. 09.00. Accoglienza ore 8.45
Brindisi. Palazzo Granafei-Nervegna (g.c.)
Sulla rotta della Francigena del Mare
Quando le luci della notte si rifletteranno immobili sulle acque verdi di Brindisi Lascerai il molo confuso dove si agitano parole passi remi e macchinari L’allegria starà dentro di te accesa come un frutto Andrai a prua fra i negrumi della notte Senza alcun vento senza alcuna brezza solo un sussurrare di conchiglia nel silenzio Ma dall’improvviso rollio presentirai le cime Quando la nave rotolerà nell’oscurità serrata Ti troverai spersa all’interno della notte nel respirare del mare Perché questa è la vigilia di una seconda nascita
(Sophia de Mello Breyner Andresen, Itaca)
Lunedì 5 giugno 2017, in occasione della XXXII Regata velica Internazionale Brindisi – Corfù, la Società di Storia Patria per la Puglia, in collaborazione con il Circolo della Vela e il Comune di Brindisi, organizza un incontro di studi per la presentazione della Via Francigena del Mare, rotta storica sulla quale si attesta la Regata.
Atti e testimonianze evidenziano come nell’età normanno-sveva l’imbarco dei pellegrini da Brindisi alla volta di Gerusalemme, ad faciendum passagium yransmarinum, proseguisse facendo generalmente tappa a Corfù, Cerigo, Creta, Rodi, Cipro, per poi approdare a San Giovanni d’Acri. Si tratta dell’itinerario seguito da Federico II salpato da Brindisi il 28 giugno 1228 per la sua expeditio seu transfretatio in Terram sanctam. Il I maggio 1229 l’imperatore s’imbarcò ad Acri per fare rotta verso Brindisi ove giunge il 10 giugno dello stesso anno. Per il viaggio di ritorno sono noti soltanto due scali intermedi, Tiro e Limassol, ma sembra molto probabile che il tragitto abbia ricalcato quello di andata, che a sua volta aveva seguito il classico itinerario per mare da Occidente verso Levante. Ogni popolo del Mediterraneo è unito dal mare più di quanto non lo sia dalle vie di terra; Platone fa affermare a Socrate nel Fedone: “ritengo che la terra sia grandissima e che noi, dal Fasi alle colonne d’Ercole, non ne abitiamo che una ben piccola parte, solo quella in prossimità del mare, come formiche o rane intorno a uno stagno”.
La Regata Internazionale Brindisi Corfù ripercorre a vela, oggi come allora, un tratto di quella rotta con l’obiettivo di unire e diventare un punto d’incontro tra i popoli grazie a quello spirito sportivo e agonistico da sempre linguaggio universale capace di creare le più salde e costruttive sinergie tra gli uomini. Sulla stregua di questo ideale, nelle edizioni comprese tra il 2000 ed il 2002, la regata fu rinominata “Regata per i Diritti Umani“, sotto l’egida delle Nazioni Unite.
Il Convegno, che vede anche il patrocinio del consolato di Grecia a Brindisi, prevede la partecipazione di storici e studiosi che presenteranno le evidenze e le testimonianze storiche legate alla Via Francigena del Mare, con l’obiettivo di raccogliere materiale storico-scientifico di supporto alla candidatura della rotta all’Associazione Europea delle vie Francigene e al Consiglio d’Europa per il suo riconoscimento ufficiale.
Nella circostanza sarà avanzata la candidatura del Sistema difensivo territoriale brindisino quale sito da inserire nella World Heritage List, della Convenzione sul patrimonio mondiale.
Comitato Scientifico:
Pasquale Corsi – Università di Bari
Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia
Pasquale Cordasco – Università di Bari
Direttore del Centro Studi Normanno-Svevi dell’Università di Bari
Hubert Houben – Università del Salento
Professore I Fascia. Ordinario di Storia Medievale, Presidente del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Ordine Teutonico nel Mediterraneo
Luciana Petracca – Università del Salento
Professore aggregato di Storia Medievale; Professore aggregato di Archivistica
Giancarlo Vallone – Università del Salento
Preside Facoltà di Giurisprudenza. Professore I Fascia. Ordinario di Storia delle istituzioni politiche
Maria Stella Calò Mariani – Università di Bari
Docente emerito di storia dell’arte.
Programma
Lunedì 5 giugno 2017
ore 08.45 Registrazione dei partecipanti
ore 09.00
Saluti degli organizzatori e delle autorità
ore 9.30.
Sulla rotta di levante. da Brindisi a corfù verso gerusalemme
Interventi introduttivi
Francesco Rutelli
Coordinatore del Gruppo per le Antiche Vie Culturali e Religiose, in primis la via Francigena, presso il Pontificio Consiglio della Cultura
Massimo Tedeschi
Presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene
Relazioni
Giuseppe Maddalena Capiferro
Società di Storia Patria per la Puglia
Brindisi e la crociata di Federico II
Marco Leo Imperiale
Archeologo medievista – Università del Salento
Diari di pellegrinaggio tardo medievali
Giuseppe Marella
Viator Studies Centre dell’Università del Salento
Da Brindisi a Corfù verso Gerusalemme nel medioevo
Luici Oliva
Viator Studies Centre dell’Università del Salento
Il viaggio petrino dalla Terrasanta a Roma
Cristian Guzzo
Società di Storia Patria per la Puglia
I Normanni e le vie di comunicazione nel meridione d’Italia
Giacomo Carito
Vice Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia
Sulla rotta Brindisi Corfù tra reale e immaginario
ore 11.30
Sulla rotta da levante a ponente.
Presentazione della candidatura del Sistema difensivo territoriale brindisino quale sito da inserire nella World Heritage List, della Convenzione sul patrimonio mondiale
ore 11.45
Tavola rotonda sulla proposta di candidatura
ore 12.30 Coffee break
Moderano: Francesca Mandese del Corriere del Mezzogiorno e Giuseppe Rollo della Società di Storia Patria per la Puglia
#Antiche Vie Culturali e Religiose#Federico II#Via Francigena#Miscellanea#Pagine della nostra Storia#Spigolature Salentine
0 notes