#12motiviperleggere
Explore tagged Tumblr posts
Text
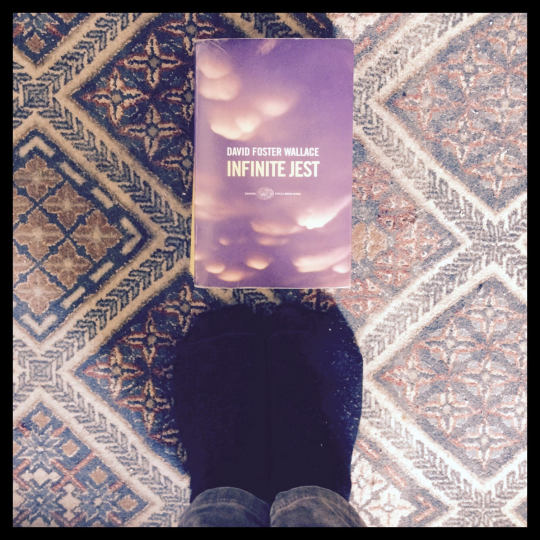

Libro 14. David Foster Wallace, “Infinite Jest” (Stile Libero Einaudi)
“L’ho finito. L’ho letto in tutti i modi che ho trovato [9] e l’ho finito. Mi sento strana, un sacco, come se niente fosse più come prima o come quando ti manca l’aria e tipo vai veloce veloce da sott’acqua ed esci e prendi un sacco di aria e tossisci. Niente è più come prima” (sms Marta a Giuseppe, 18 Dicembre 2017).
Una delle mie attuali ossessioni è contare tutto. Di questo forse dovrebbe parlarne Giuseppe – che ne ha più coscienza di me - ma ad ogni modo so di aver letto un quantitativo di libri che sfugge al mio controllo e ai miei conteggi. Libri belli, libri lunghi, libri senza i quali non posso immaginarmi a vivere alcunché, libri di cui vergognarsi, libri noiosissimi, libri simpatici, libri istruttivi. Una smania consumistica che mi ha fatto passare da un libro all’altro per accrescere il mio egocentrismo culturale – la mia erudizione - e poter dire “ecco: sono nella cultura, sono nel giusto, sono nell’intelligenza e nella coscienza critica” in questa smania opprimente di investimento immaginario secondo cui la libreria è vista come luogo di culto, il libraio come un santone in quanto sempre nell’inopinabilità, l’oggetto libro come reliquia e il tempo di lettura come l’unico che valga davvero la pena vivere in quanto “arricchimento”. È molto difficile scrivere quanto detto “ad alta voce” perché sono consapevole di stare mettendo in evidenza tutta la mia miseria in modo assolutamente inassolvibile. E continuo dicendo che quando ero bambina preferivo stare ferma in un luogo a leggere Roal Dahl piuttosto che mettermi a giocare con altri bambini. A otto anni lessi Jane Eyre e m’immersi nella dimensione temporale del romanzo ed ero l’orgoglio dei più, sfoggiandomi come una me necessariamente staccata dalla realtà e dalla necessità, dunque “più” di tutti gli altri e di tutto il resto. Quando ero adolescente iniziai a frequentare le persone che non avevano niente in contrario a parlare con me con cui parlavo poco perché per parlare e per ascoltare qualcuno prendevo un libro e col senno di poi io non posso che guardare con una certo disaccordo e disappunto questo approccio di cui purtroppo la maggior parte dei lettori – convinti del proprio fondamentale ruolo all’interno della società – non si rende neanche conto. E forse è anche giusto così.
Per quanto questa mia consapevolezza sia estremamente fresca, non posso che guardarmi indietro e comprendere (e contare) tutti quei crash nel mio sistema che hanno interrotto questo vizioso trastullarsi in se stessi. Il problema reale di questi crash risiede in quello che una volta disse Deleuze: “[…] quello in cui credo sono gli incontri. E gli incontri non si fanno con le persone. Si crede sempre che gli incontri si facciano con le persone, ma è terribile, quello fa parte della cultura […]. […] gli incontri non si fanno con le persone, ma con le cose: incontro un quadro, un’aria musicale, una musica. Ecco cosa sono gli incontri”. E il 12 Dicembre 2017, in una catarsi senza rimedio, scrissi banalmente un post su Facebook in cui elencai tutti gli incontri che cambiarono il mio quotidiano (cosa significherebbe d’altronde “Vita”?) e dopo il quale mi è stato praticamente e fisicamente impossibile leggere per un lasso di tempo prolungatissimo qualsiasi altra cosa. Scrissi:
“In ordine, i motivi per cui No U Turn e rabbie e dolori sparsi: Fernando Pessoa, Il Libro dell'Inquietudine; Gilles Deleuze, Differenza e ripetizione; James Joyce, Ulisse; la Bibbia; Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra; Dante Alighieri, La divina commedia. HO DIMENTICATO L’ETICA DI SPINOZA!”
Quarantanove mesi – in un totale sezionato in parti ineguali nel tempo – in cui abbandonai la letteratura (per la vita? per la quiete?). Ma il primo libro di questo elenco (omesso appositamente nel copiato del post in quanto oggetto di questo articolo/recensione) il cui incontro ha spazzato via tutto il resto, altri titoli compresi, è Infinite Jest di David Foster Wallace.
“Un grosso libro vuol dire che il lettore passerà molto tempo a leggere […]*: 17 mesi, per l’esattezza.
Definire la struttura di Infinite Jest è estremamente difficoltoso. La storia (che può essere descritta così solo a posteriori, in quanto il libro è strutturato in un processo di presentazione dei fatti dal minuscolo al gigantesco e avvolgente tutto) si sviluppa attorno a un nucleo centrale, cioè la presenza fantomatica di un film d’intrattenimento - dal titolo omonimo – “così appassionante e ipnotico da cancellare in un istante ogni desiderio se non quello di guardarne le immagini all’infinito, fino alla morte” (come troviamo scritto nella quarta di copertina). Il nucleo centrale snoda da sé due macrostorie a sé stanti (ma confluenti nel nucleo stesso): la vita all’interno dell’Eta, un’accademia tennistica agonistica, e la vita all’interno dell’Ennet, un centro di recupero dalla dipendenza da qualsiasi sostanza. Di fianco, quasi come collante e rimando continuo tra le due parti tra loro e tra loro col nucleo, vi è la vita sotto copertura di coloro che disperatamente cercano Infinite Jest. Da queste due macrostorie (più appendice) si sviluppano a propria volta davvero non so quante altre storie e quanti altri racconti, ognuno assolutamente indipendente dagli altri, ma rientranti necessariamente in un quadro che serve a riportarci - per intreccio, simbologia, riferimento, citazione - alla propria macrostoria di riferimento o alla seconda, per sfociare nel nucleo e chiudere un cerchio che ad una prima lettura sembra non poter aver quadratura. Potremmo persino dire che l’intrattenimento filmico Infinite Jest sia il cuore di tutto l’apparato libro, un cuore da cui parte strutturalmente una grande vena e una grande arteria e da cui le storie si diramano capillarmente ed entro cui ritornano – grazie alle valvole (le storie sottocopertura) - in un ciclo infinito dal movimento rotatorio di ripetizione senza il rischio di collasso. O ancora una struttura a piramide che dalla vetta si dirama sempre più giù, sempre più in basso, dall’ “idea filmica” Infinite Jest alla merda che tocchiamo con mano di un dato tossico cacatosi nelle mutande o alla disperazione di pori dilatati e sudore di quel giocatore ragazzino. O ancora, potremmo usare la spiegazione convincentissima tratta da una conversazione del 1996 tra Michael Silverblatt e l’autore (https://www.youtube.com/watch?v=DlTgvOlGLns):
M.S.: “Non so come, esattamente, parlare di questo libro […] ma a volte mi è venuta in mente questa idea, magari immaginaria, cioè che il libro è scritto in frattali. […] Ho pensato che il materiale sia presentato in modo da permettere a un argomento di essere introdotto in piccolo, dopodiché si apre un ventaglio di tematiche, di altri argomenti, e poi eccoli di nuovo presentati in una seconda forma che include, anche loro in piccolo, altri argomenti e poi presentati di nuovo come se quello che viene raccontato fosse…. Non sono molto pratico di questa scienza, è solo che mi sono detto che i frattali dovevano essere così”
D.F.W.: “Avevo sentito che sei un lettore in gamba. È una cosa presente a livello strutturale. In effetti è strutturato come una cosa che si chiama Triangolo di Sierpinski che è un genere di frattale piramidale anche se a essere strutturata come un Triangolo di Sierpinski era la bozza che consegnai a Michael [Pitch, editore] nel 1994 e che ha subito alcuni tagli provvidenziali e mi sa che ne è venuto fuori un Triangolo di Sierpinski un po’ sbilenco. Ma è interessante, è uno dei modi strutturali in cui bene o male dovrebbero comporsi”
[…]
M.S.: “[…] mi sembra che in questo libro - che contiene sia la banalità sia la straordinarietà di veramente molti tipi di esperienza, oltre alla banalità dell’esperienza straordinaria … -”
D.F.W.: “E alla straordinarietà dell’esperienza banale”
M.S.: “… andava trovato un modo [di organizzarsi] e mi entusiasmava il fatto che fosse strutturale, che il libro trovasse un modo di organizzarsi capace di farti sapere. Sono analogie che poi ricorrono in tutto il libro […]”
D.F.W.: “Si tratta di capire se una cosa è vera o no. […] Voglio dire che molta della struttura che c’è dentro è più o meno decisa lì per lì a seconda di cosa mi sembrava vero e cosa no. […] è solo quando arrivi all’incirca a metà [del libro] che secondo me si comincia a vedere il barlume di una struttura. Poi, certo, il grande incubo è che la struttura la vedi solamente tu mentre per gli altri è un gran casino”.
In prima istanza, arrivati come dice Wallace a metà del libro, è dunque la struttura – oltre alla grandezza/lunghezza del volume (“I libri grossi sono più una sfida, sono intimidatori. […] Infinite Jest all’inizio non era pensato per essere così lungo. Iniziò come una narrazione frammentata, multipla, con alcuni personaggi principali e […] a un certo punto diventò chiaro che sarebbe stato molto lungo”*) – a rendere certamente cerebrale e affascinante la lettura. Il fascino è amplificato dalla presentazione caotica di nomi di sconosciuti che raccontano la propria personalissima storia di abuso, violenza, aggressione, disperazione, gioia fittizia, quotidianità spicciola e bellezza in una frammentazione davvero difficile da digerire e tremendamente spiazzante. Le microstorie scorrono veloci (nella prima parte del libro) come sangue nei capillari fino a raggiungere i vasi sempre più grossi, sempre più grossi per arrivare al cuore (3/4 del libro) e vivere il ricircolo, tornando indietro (fino alla fine del libro, ricominciando). È questo un movimento che si percepisce non solo leggendo, ma anche fisicamente: una spinta frenetica, un trascinamento - ecco, sì - un trascinamento forzato che ostacola la parte dentro di te che continua a dire NO NO NO BASTA COSì NO NON POSSO LEGGERE PIÙ! E il perché di tutti questi no - quantomeno all’inizio, perché poi subentra una sorta di rassegnazione e abbandono totale alla lettura – è non tanto il modo in cui Wallace ironizza gli avvenimenti, rendendoli ancora più disperati, ma la normalità violenta e la violenza normalizzata che permea il quotidiano in e di ogni persona che respira in tutti i qui e in tutti gli adesso del pianeta. Per quanto Wallace abbia detto come Infinite Jest volesse essere “qualcosa che avesse la stessa densità mentale dell’America di oggi, una sorta di gigantesco tsunami di roba che ti travolge”*, questo distacco che confinerebbe tutto il travolgente agli Stati Uniti è totalmente annullato, ritrovandoci in una globalizzata impotenza che ci fa rientrare in una dimensione in cui tutto il descritto “è proprio così” e non potrebbe essere vissuto altrimenti. Credo sia corretta l’affermazione di David Lipsky secondo cui “leggere David Foster Wallace era come spalancare gli occhi sul mondo”: vediamo davvero Kate Gompert a digrignare i denti e provare pietà mai per se stessa, ma per uno psicotico depresso uguale a lei; vediamo e sentiamo davvero il respiro di Joelle sul suo velo; sentiamo davvero l’odore acido della sostanza uscire dai pori di quella prostituta senza denti, per le troppe pipe fumate, che partorisce il suo bambino morto che porterà sempre attaccato a sé e che puzzerà nella sua graduale decomposizione sotto il sole cocente dell’estate. “[…]ho provato una specie di … non lo so … tenerezza nei confronti dei personaggi e il narratore per lo straordinario sforzo impiegato a scriverlo. Non sembrava una difficoltà fine a se stessa. Sembrava come una difficoltà immensa ben spesa perché c’era qualcosa di importante da dire riguardo alla difficoltà di essere umani. Aveva bisogno di essere triste e non c’erano altre vie per raccontare ciò” (Michael Silverblatt).
Potrei scrivere moltissimo sull’intreccio della storia, sulla personalità dei personaggi, sui nove modi possibili per leggere questo libro, sulla voluta assenza di narrazioni sessuali (due sole eccezioni) ad evidenziare un’impossibilità empatica nel controsenso per cui raccontare una storia a persone troppo prese a narrare se stesse rende ogni narrazione puro fiato. Potrei parlare delle note (la più lunga è di 19 pagine) o potrei incentrarmi sulle specifiche pedantesche e maniacali di ogni farmaco/sostanza riportati nel volume o la precisione di Wallace nella descrizione degli stati emotivi verbali di alcuni personaggi [es. Hal Incadenza: pag.3: siedo _ pag.1023: ero _ pag.1039: camminai _ pag.1076: stavo _ pag.1089: forse sonnecchiai / forse avevo sonnecchiato / pensai _ pag.1130: .... _ pag.1140-41: ricordavo/ricordo/ricordavo]. Non lo farò. Leggerlo?
Infinite Jest è un libro geniale non tanto per gli elementi descritti, non solo per gli elementi non descritti, non esclusivamente per questa enorme fatica dell’autore. Credo che lo sia perché davanti al Povero Tony (il personaggio che ho amato di più non solo per la sua storia, per la descrizione, ma soprattutto per il modo in cui è perennemente inserito in tutto il testo) e alla sua disperazione così lontana dalla mia io non posso far altro che zittirmi. Non si ride. Non si piange. Qualche volta un ghigno. Ma è il silenzio a caratterizzare ogni pagina, questo silenzio invadente, questa tenerezza sconcertante che elimina la possibilità di giudicare anche l’atto più meschino, anche la situazione più repellente, a favore di una nuda consapevolezza della miseria mia, tua, di tutti loro, di tutti noi.
“Un libro per tutti e per nessuno” è questo Infinite Jest che non lascia tregua, ti fracassa il cranio e spezza il cuore. Non leggetelo. Fatelo per voi. Perché dopo non si torna indietro. A meno che non accettiate la possibilità di non leggere alcunché, dopo, continuando a vivere questo silenzio, almeno per un po’.
M.
Ci rivedremo in Gennaio
* THE END OF THE TOUR (tratto dal libro intervista di David Lipsky a David Foster Wallace)
*Charlie Rose intervista Wallace https://www.youtube.com/watch?v=9lVHhliP5s4

#1 : "Leggo, io"

#2 : "imparate"
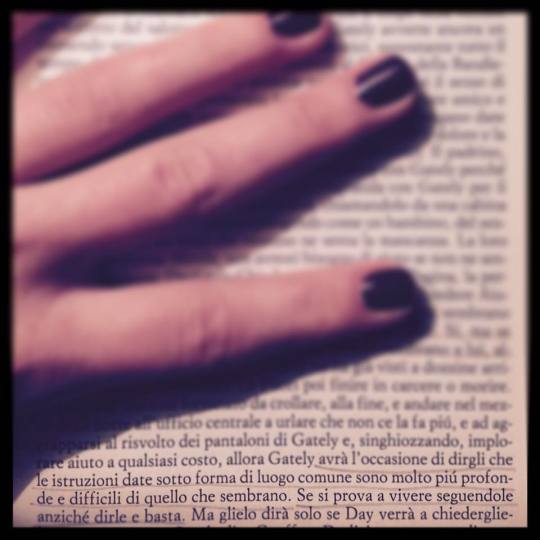
#3 : luoghi comuni
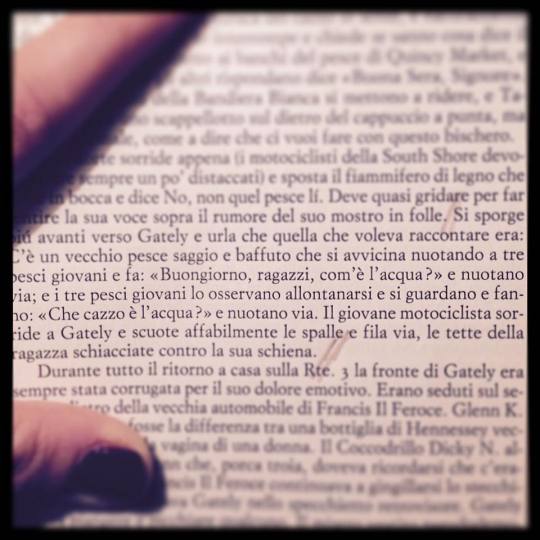
#4 : "che cazzo è l'acqua?"

#5 : cicloide
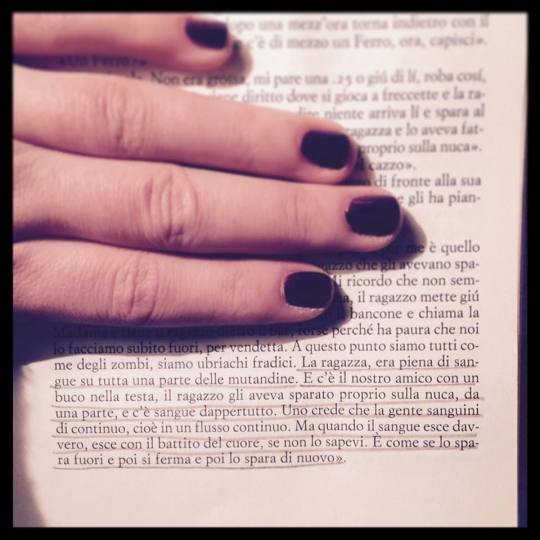
#6 : "quando il sangue esce davvero"

#7 : urlare

#8 : le Cose Vere

#9 : "il mondo delle arti degli Usa"

#10 : la Cosa = depressione
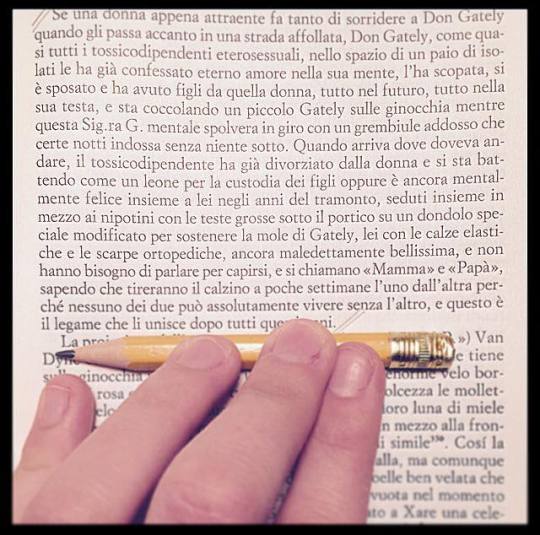
#11 : i tossicodipendenti eterosessuali

#12 : credetemi
#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#david foster wallace#infinite jest#stile libero#stile libero einaudi#einaudi#editore#libro#citazione#citazione libro#frasi libro#fotografia#recensione#lettura condivisa#lettura consigliata#martaacciaro
3 notes
·
View notes
Text
#PremioCampiello2017 : Donatella Di Pietrantonio, “L’Arminuta”, Einaudi


Se ne sente l’odore.
Della macchina su cui l’arminuta (la “ritornata”) si siede, piangendo, per ritornare nella casa in cui è cresciuta.
Dei denti storti e saliva acidula di pubertà di quella che si scopre essere sua sorella, Adriana.
Dell’incrostazione giallognola della canottiera del padre.
Della veste smanicata comprata al mercatino dalla\della madre – quella biologica – con le ascelle pelose e bagnate dal sudore della fatica.
Della salsa di pomodoro, che se hai le mestruazioni mica li puoi toccare i pomodori, mica le puoi toccare le bottiglie, sennò infradicisce tutto e si porta iettatura!
Dello sperma che macchia le lenzuola di Vincenzo che la guarda - all’Arminuta -come fosse l’estranea che di fatto è. E pensieri incestuosi tra fratelli.
Si sente l’odore di pipì sul materasso, l’odore dell’agghia per il soffritto, l’odore e tanfo delle verdure cucinate a brodaglia.
Si sente la pesantezza di stanze non areate, di salsedine: quel giorno della fuga al mare.
E i rumori, in sentori ancora più forti e intesi, nelle scarpe strascicate a cosce larghe e piedi a papera di Adriana, nelle legnate di mamma, nelle seggie spostate con noncuranza in cucina e il corpo sbuffante che si siede per sbucciare patate.
Il rumore delle scale fatte di corsa, delle aule di paese, di Vincenzo che ritorna a casa e sorrisi sul viso.
Il rumore delle vesti eleganti di una tutrice dal nome altisonante e regale che non la vuole più e il rumore dei soldi che le lascia per provvedere alla sua istruzione.
È un libro semplice “L’Arminuta” di Donatella di Pietrantonio, edito Einaudi. Semplice come può essere semplice la storia di ognuno di noi, nella naturalezza del suo compiersi. Nessun enfatizzazione dei traumi presenti in questo libro, primo tra tutti quello che viene descritto magistralmente – senza eccessive pomposità: l’abbandono doppio che la protagonista è costretta a vivere da parte dei genitori biologici che la consegnano a genitori affidatari che a loro volta la riconsegnano ai biologici, dopo molti anni, in una contesa e, al tempo stesso, disfatta di quella che è la stabilità emotiva di una ragazzina che non riesce a trovare appigli, se non in se stessa, sui quali contare per andare avanti. E “andare avanti” è ciò che più punge nella lettura di queste pagine: nessuna possibilità di riscatto nella vita (se non forse nello studio?), nessuna possibilità di rivincita, di perdono, di comprensione. Forse comprensione, ma non adesso: in un futuro e ipotetico poi, perchè adesso è tutto solo e semplicemente “così”. L’Arminuta, buttata di materasso in materasso, di casa in casa, di gradini in gradini, vive un’esistenza racchiusa in una valigia – qualche oggetto, molti ricordi, le scarpette da ballerina – pronta ad essere spostata continuamente a seconda dei capricci e delle necessità del mondo adulto. Un mondo adulto che vive la giovinezza della protagonista e dei suoi fratelli come non necessaria, adultizzando Adriana – sebbene bagni ancora il letto – e Vincenzo che gestisce pericolosamente la sua vita - incompresa a se stesso - con cattive compagnie in cambio di prosciutti grossi per sfamare la famiglia.
Mondo adulto e mondo adultizzato (della triade tra fratelli, in questo rapporto di necessità, amore e passione) si incontrano e scontrano in una stridente armonia di fatti, in una miracolosa quotidianità sfiancante e appagante in cui la vita ti si appiccica addosso anche se non sai che fartene, anche se non ne sei capace.
“Io forse parlo un po’ troppo, certe volte” - ha ammesso ansimando per la salita. “Non hai colpa se dici la verità. È la verità che è sbagliata”.
M.

#1 : pizzicotti

#2 : "i nostri corpi"

#3 : sugo e leggende

#4 : capitolo chiuso

#5 : madre

#6 : "pochi minuti dopo la promessa, già non credevo più che saremmo rimasti insieme"

#7 : ordine

#8 : "l'igno-"

#9 : "adatta alla vita"

#10 : favola

#11 : la verità

#12 : miseria
#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#donatella di pietrantonio#l'arminuta#einaudi#einaudi editore#editore#libro#citazione#citazione libro#frasi libro#fotografia#recensione#lettura condivisa#lettura consigliata#martaacciaro
9 notes
·
View notes
Text


Libro 6. John Williams, “Stoner” (Fazi Editore)
Ci sono delle volte – la maggior parte, io credo – che entrare in una libreria non è più quel sogno di bambina in cui si viene inebriati dal buon profumo delle copie appena rilegate, la lucentezza delle copertine. Un certo tipo di viscosità gommosa, fastidiosissima alle unghie, dei nuovi Adelphi. Il design di grafiche ricercate di Einaudi: monocromi spezzati. L’incomprensibilità delle copertine di Giunti editore. Ti aggiri tra le sezioni calpestabili scandite da aiuole di Best Seller. Passo lento, strascicato. E il disincanto ti prende tutta, quando sei là non per un titolo in particolare, ma per farti catturare da quel qualcosa. Solo che questo qualcosa, alla fine, nella maggior parte dei libri di recente pubblicazione, non lo trovi. Torni a casa, felice del tuo acquisto, ma è una felicità con riserva, perché in fondo lo sai che non sarà mai lo stesso che leggere Dumas, Wallace. Un pregiudizio prolungato: proprio io che penso di non avere mai pregiudizi, diventando così, con questa sola frase, la regina di tutti i pregiudizi. Ma perché non ho comprato un classico, mannaggia a me?
Con il premio “pregiudizio dell’anno 2017 d.C” entrai un giorno con mia zia alla Feltrinelli (Palermo). Il bello di mia zia, tra le tante cose belle, è che è sempre tutta di fretta, ma capita che a un certo punto non sia più di fretta ed è bella quando passeggia disincantata, cervello in funzione, occhi sui titoli dei libri, accarezza le cose, “Lella, sono alla sezione poesie, vieni!”. Quando andiamo in libreria Lella mi regala sempre un libro e, solitamente, ne compro uno da me (magari quel gran mattone di libro dal gran mattone di lista che porto da anni nel portafogli con titoli perlopiù di classici e autori di nicchia) e uno lo compra lei, che prima andava da Fabrizio di Modus Vivendi e Fabrizio le consigliava sempre il libro giusto per me. Ora prendo io le veci di Fabrizio. Lei mi aspetta, io giro, sfogliando i titoli, e dico “Va bene questo” e così sia, un amen da autoparlante. Quel giorno, il 10 Ottobre 2016 (grazie Instagram, per ricordarmi date assolutamente insignificanti), Lella mi regalò Stoner di John Williams (Fazi Editore). E in realtà, caro lettore (a cui ricordo che non sto qua mica a fare il critico – io – ma porto avanti l’esclusivo mio dovere personale di lettore – a mia volta -), caro lettore – dicevo – non avrò per te giri di parole, perchè Stoner è un capolavoro. Un capolavoro, e nulla più. Per rifarmi alle attentissime e condivisibilissime parole di Peter Cameron, che ne ha curato la postfazione all’edizione italiana: “La prima volta che ho letto Stoner sono rimasto sbalordito dalla qualità della scrittura, dalla sua pacatezza e sensibilità, dalla sua implacabile chiarezza abbinata a un tocco quanto mai delicato. […] la narrazione volteggia sopra la vita di Stoner e cattura ogni volta i momenti di una realtà complessa con limpida durezza […], e attraversa con leggera grazia il cuore del lettore, ma la traccia che lascia è indelebile e profonda”.
È vero, tutto vero, ed è un libro bellissimo e per molto tempo, quando lo finii, mi ricordò per certi aspetti Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa: la storia di un uomo che per quanto possa essere chissà cosa, chissà chi, chissà perché, vive nella sua insignificanza colmo del significato della propria vita. Un viaggio, quello di Stoner, più lungo di quello del principe Fabrizio, in quanto Fabrizio lo troviamo già sposato con prole, mentre William Stoner è solo un ragazzino di campagna (e, vedendolo crescere, cresciamo con lui, ci confrontiamo con lui). Ad ogni modo credo, per quanto opinabile possa essere il mio giudizio di lettore, che la tensione e l’attenzione che il lettore ripone nelle parole di questi due libri sia la medesima. Stoner, come il Gattopardo, non è un libro dai colpi di scena, dalle grandi gesta eroiche, dalle istrioniche battute, dai capoversi da sottolineare per intero, ma è un libro semplice, delicatissimo, che come una goccia, a poco a poco, ti trapassa prima la carne, poi il muscolo, poi l’osso e diventa parte di te, la parte che vede le cose come sono per la prima volta senza affanno: la tragedia umana come tragedia umana, perché è solo una tragedia, perdio, e nulla più, nulla di angosciante, e infine morire, con la naturalezza degli occhi stanchi: alzatina di spalle. La normalità della vita: alzatina di spalle. Gli errori compiuti di continuo: una pazienza enorme verso noi stessi. Questa enorme capacità di John Williams, come a suo tempo Tomasi di Lampedusa, di creare una scrittura chiara senza necessitare di fraintendimenti, eppure così limpida da far confondere e smarrire, è una rarità nella scrittura contemporanea. Il postmoderno, ma forse da ancor prima, ha creato il mito del massimalismo concettuale anche in scrittura: la moda del dire, ad esempio, “il mio corpo è una macchina perfettamente funzionante e organizzata in modo tale che sappia naturalmente come espletare i bisogni corporali in una ripetitività continua giornaliera che aliena il quotidiano, creando un sistema circolare fondato sull’urina della mia vescica”, semplificabile con la più banale “ogni mattina alle 7 faccio la pipì”. Stoner rinuncia al mito della complessità e si dà al pubblico, al lettore, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua banalità, in tutta la sua armonia perfetta del linguaggio comune, popolarissimo, esemplare nella sua grammatica, commovente nel suo pensiero universalmente comprensibile, universalmente condivisibile, universalmente vissuto.
Sono tanti i temi affrontati in questo libro, senza alcuna pretesa moralistica: le scelte universitarie e le conseguenze implicanti, la decisione del partecipare o no ad una guerra come assunzione o meno di una responsabilità collettiva, un matrimonio nato fallito e la capacità di abituarsi alla scomodità relazionale e al non demordere per una stupida promessa fatta che forse stupida mica lo è, l’abbandono della prima donna amata per rispetto alla classe a cui si appartiene e al ruolo che la convenzione sociale ritiene, la difficoltà d’approccio di un padre verso una figlia alcolizzata. Tutti temi, questi, riconducibili all’unico grande tema che è: la scelta. Stoner è una storia di scelte, di “non si può tornare indietro” e “nessuna seconda possibilità”. Stoner è la storia di tutti noi, è l’accettazione totale, seppur in una frustrazione certamente consapevole, di tutti quelli che sono gli errori e i rimpianti delle nostre vite. La vita di Stoner è la nostra vita, è la nostra storia e nessuno ne scampa e ne scappa. Non si può. Significherebbe fuggire da noi stessi, ma per quanto corriamo, lo sappiamo, è sempre da noi che bisogna tornare. E tornando, Stoner ci insegna che, in fondo, forse, non ci è andata tanto male; in fondo, forse, non ha neanche così tanta importanza, ormai. Forse, in ultimo, come cantano i Baustelle: “La vita è tragica. / La vita è stupida / però è bellissima essendo inutile. / Pensa al contrario e poi ti ammazzi subito. / Pensare che la vita è una sciocchezza aiuta a vivere. / Non avere mai paura / non stare male per qualcosa che non è / non tremare mai la sera / ricordati che stai giocando a un gioco senza vincitori. / Lo so, la vita è tragica / la vita è stupida però è bellissima essendo inutile. / È solo immagine / un soprammobile. / Pensare che la vita non è niente aiuta a vivere. / La vita è tragica però è fantastica essendo inutile. / È solo immagine/ è tutta estetica. / io penso che la vita non è niente e provo a vivere”.
M.

#1 : sentire

#2 : chi

#3 : la gentilezza

#4 : giustificarsi

#5 : tradimento

#6 : "non morire mai"

#7 : "non era che"

#8 : espletare

#9 : "non ha importanza"

#10 : qui ed ora

#11 : spietatamente

#12 : "primavera non bussa, lei entra sicura"
#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#john williams#stoner#fazi editore#editore#libro#citazione libro#frasi libro#fotografia#recensione#lettura condivisa#lettura consigliata#martaacciaro
2 notes
·
View notes
Text
“Lolita” di Vladimir Nabokov incontra “La figlia femmina” di Anna Giurickovic Dato

“Sembra essere il suo primo libro, mi dissi, ma lo dobbiamo leggere come se fosse l’ultimo volume di una lunghissima serie, la continuazione di tutti quei libri […] le poesie […] i drammi […] i romanzi […]. Poiché c’è continuità, tra un libro e l’altro, nonostante la nostra abitudine a giudicarli separatamente. E dovrò anche considerare questa donna sconosciuta come discendente di tutte quelle altre donne di cui abbiamo prima parlato, e vedere che cosa ha ereditato delle loro caratteristiche e delle loro limitazioni. […]. I libri, chissà come, s’influenzano fra di loro” (V. Woolf, “Una stanza tutta per sé”, ed. economica Feltrinelli).
Chi avesse comprato, o semplicemente sfogliato in libreria, “La figlia femmina” di Anna Giurickovic Dato sarà stato certamente attratto quanto me dalla copertina: “Thérèse Dreaming” di Balthus. È un olio su tela di cui sconosco le dimensioni. La ragazzina Thérèse siede in una stanza anonima a gambe leggermente divaricate, scomposta sulla sua sedia, le mani sopra la testa. Le pennellate delle braccia e delle mani di Thérèse sono grumose a tratti, una sporcizia sedimentata da adolescente; la camicetta è bianca, ma di un bianco sbiadito per il sudore e una pulizia non certamente abituale; le ascelle hanno una rapida pennellata acidula; la gonna purpurea è di un tessuto pesante che lei prontamente scopre allargando le gambe, quella destra con il ginocchio ripiegato verso terra, quella sinistra piegata e alzata, mostrando cosce non più dalla pennellata materiale, ma liscia e corposa, da pizzicotti e lividi evidenti, sbucciature. In ultimo le mutandine. Quando ho preso in mano il libro per la prima volta ho subito posato il mio indice sull’intimità celata di Thérèse, come se potessi toccare la consistenza della sua pelle e questa è certamente un’affermazione che potrà spiazzare chiunque stia leggendo. Fate attenzione e non affrettate le vostre conclusioni. Dicevo – dunque – che posai il dito sulla striscia bianca dipinta e pensai subito ad Humbert e al suo gesto sognante (che io non provai accarezzando la copertina) che bramava incessantemente l’umidità di Lolita. Balthus, con una maestria che in molti conosciamo, ha dipinto non una ninfetta qualsiasi, ma proprio Dolores Haze. Ritrovare proprio lei come copertina de “La figlia femmina” è stato un incentivo non indifferente nella scelta dell’acquisto in libreria.
Iniziando a leggere il libro constatai che la prima impressione fornitami da quel dipinto non fosse altro che la conferma che tra “La figlia femmina” e “Lolita” ci fosse un collegamento, un filo, una giusta e quasi ovvia prosecuzione, quasi un tassellino in più che si aggiunge alla tradizione letteraria che espone il dramma della pedofilia e delle sue conseguenze all’interno di un nucleo familiare e di un animo umano. Un tassellino in più che spiega questi stessi precedenti libri sulla tradizione del tema. “La figlia femmina”, preso a sé, è un libro forse come tanti, con un po’ troppi cliché per il mio personalissimo gusto di lettore. È un libro che non eccelle per lo stile o per l’originalità della storia. Un libro semplice, probabilmente, ma molto gradevole alla lettura per la sua scorrevolezza, al di là della crudezza della storia in sé. “Sensuale come una versione moderna di Lolita”, leggiamo nella seconda di copertina. No: forse stiamo sbagliando! Quel “come” è disturbante, perché non è un libro “sensuale come”, ma è un libro che è molto di più. “La figlia femmina” è un libro che probabilmente potrà diventare fondamentale per la comprensione di certi aspetti non facilmente accessibili di “Lolita” stessa, non tanto per i richiami che Anna Giurickovic Dato fa (non so quanto inconsapevolmente): il francese non tradotto in ambedue i libri, questo concentrarsi molto più sulle gambe entusiaste delle due bambine (così ben evidenziate dall’immagine di Balthus) rispetto al resto, ad esempio. È un libro, quello della Dato, che non può esser giudicato separatamente da “Lolita”. Non del tutto almeno, perché se ne perderebbe qualcosa, la parte più importante: il suo essere prosecuzione di una visione specifica.
I due aspetti che più colpiscono e che credo siano imprescindibili per un’esaltazione vicendevole dei volumi riguardano certamente le madri in questione (Charlotte, per Lolita; Silvia, per Maria) e il rapporto che gli adulti hanno con l’intelligenza di queste ragazzine acerbe, adultizzate nell’immaginario adulto genitoriale.
Prima di inoltrarci nella questione, però, riassumiamo le trame dei due libri, per chi non li avesse letti. “Lolita” di Vladimir Nabokov, pubblicato nel 1955, è la storia di “Humbert Humbert”, uomo dal passato segnato da un lutto, quello del suo primo amore, che segnerà tutta la sua storia sentimentale e sessuale. Humbert, pur avendo provato ad avere una vita che lui stesso definisce normale, non può invece che soccombere ai suoi impulsi più segreti: l’attrazione per quelle che egli stesso definisce “ninfette”, in una ricerca spasmodica nel ritrovare anche solo un centimetro di pelle e del ricordo di Annabelle. La ricerca termina nel momento in cui Humbert si trasferisce in America dall’Europa e incontra, nella sua nuova casa, la figlia della sua affittuaria Charlotte: Dolores Haze, Lolita. Successivamente il matrimonio con Charlotte e il decesso della stessa, Lolita e Humbert diventano amanti e la violenza si perpetua sulla ragazza, sulle prime consenziente in modo del tutto ingenuo, ogni notte per molti anni. Lolita scapperà e Humbert finirà i suoi giorni in galera per l’omicidio dell’unico uomo che Lolita abbia mai amato, Quilty. “La figlia femmina” di Anna Giurickovic Dato, edito da Fazi editore, è invece la storia di Silvia che narra la vicenda della sua storia familiare: Giorgio, il marito, abusa sessualmente e segretamente della figlia Maria, nella totale inconsapevolezza della moglie. Alla morte di Giorgio, i fantasmi di Maria faranno vivere madre e figlia in una condizione decisamente alienata e alienante, in un turbinio di sensazioni inconsuete che travolgono anche Antonio, nuovo compagno della madre, sedotto dalla (ora) tredicenne Maria.
I due libri affrontano il medesimo tema da punti di vista, intenzioni e angolazioni del tutto differenti. Ma, volendo ora ritornare alle due questioni tirate in causa, cioè il rapporto che tutti questi adulti hanno con l’intelligenza di queste ragazzine adultizzate e la questione di queste madri, in una compenetrazione di rimandi e citazioni, possiamo affermare che la prima questione, apparentemente più ingarbugliata della seconda, è invece più lineare, anche perchè gli autori ci forniscono una chiave interpretativa difficilmente opinabile. Charlotte definisce Lolita disgustosa sotto ogni punto di vista: sboccata, sporca, sfacciata, chiassona, disubbidiente, pigra e in definitiva considera la figlia in modo così ingiusto a causa di una competizione inconscia sviluppata nel rapporto madre-figlia da ambedue le parti. Humbert stesso la trova a tratti stupida e limitata, ma soprattutto volgare – lo ripete di continuo – oltre ogni modo e probabilmente per questo deliziosamente eccitabile. Mentre la madre non si ricrederà mai sulle sue convinzioni su Dolores, proprio a causa della competizione sviluppatasi che la porterà a non mettersi mai in discussione per non far crollare quell’equilibrio che la autonomina ottima e incompresa madre, Humbert, nel 32° capitolo della seconda parte del romanzo, si ricrede, di colpo, in una epifania, e scrive: “[…] così disse la mia Lolita: < Sai, quel che v’è di così orribile nella morte è il fatto che si rimane completamente soli >; e mi colpì il fatto […] ch’io non sapevo assolutamente nulla dell’intelligenza del mio tesoro e che, con ogni probabilità, dietro gli spaventosi cliché giovanili, v’erano il lei un giardino e un crepuscolo, e il cancello di un palazzo … regioni offuscate e adorabili, precluse nel modo più lucido e assoluto a me, nei miei contaminati stracci […] poiché notavo spesso che, vivendo come vivevamo, lei ed io, in un mondo di perversione totale, ci sentivamo in preda a uno strano imbarazzo ogni volta che cercavo di parlare di qualcosa di cui lei e un più vecchio amico, lei e un genitore, lei e un fidanzato realmente normale, io e Annabelle, […] noi tutti avremmo potuto conversare … un concetto astratto, un dipinto, il minuzioso Hopkins o il frammentario Baudelaire, Dio o Shakespeare, qualsiasi argomento genuino. Lei corazzava la propria vulnerabilità con la trita impudenza e con il tedio […] oh mia povera bambina coperta di lividi”. Al contrario, Silvia parla di Maria, per tutta la durata de “La figlia femmina” come di una ragazza davvero intelligente, acculturata per i troppi libri divorati; sembra quasi vantarsene con il lettore poichè Maria non frequenta più una scuola e pensa lei stessa, così piccola, alla sua educazione culturale. È quello che ogni figlio si augurerebbe dai propri genitori, che ci credano tanto intelligenti. Ma Silvia, nel suo squallore e nella medesima competizione che Charlotte aveva creato con Dolores (e che in definitiva per forza di cose si crea tra madri e figlie, anche se non tutte sfociano chiaramente nel patologico e che per questo motivo è giustificabile nel bambino, quanto ingiustificato nell’adulto), al primo tentativo, seppur azzardato, di una risposta composta dalla figlia (“Le fontane hanno un gran senso poetico, io trovo. Così come i fiumi, non so. L’acqua che scorre, l’acqua che porta via”), ecco subito che non ad alta voce, ma dentro di sé, Silvia pensa e ribatte “dice Maria con l’aria di chi vuol fare un po’ l’adulta”. Sembra la frase innocente di un’innocente madre, ma credo sia un esempio calzante delle ipocrisia che Silvia racconta a se stessa, per cui è “giusto” assecondare il pregiudizio secondo cui, per essere una buona madre, si debba reputare il proprio figlio intelligente: ipocrisia che viene frantumata dai pensieri celati e osati solo al lettore. Silvia, per quanto sia inopportuno definirla una pessima madre o una pessima donna, è di certo una persona problematica che, se fosse stata più presente a se stessa in tutte le circostanze della sua vita, esattamente come Charlotte, non avrebbe fatto sì che si venissero a creare quelle cause scatenanti, molto prima degli abusi sessuali stessi, che hanno portato solo in ultima istanza agli abusi stessi su queste figlie. Queste due donne quasi complici nella loro inadeguatezza genitoriale, così assorte da loro stesse e ingiustificabili nel momento in cui esse stesse si pongono in competizione con le proprie figlie (perché il contrario è un processo assolutamente normale), sembrano quasi scambiarsi di ruolo nei due libri, per cui Charlotte è tutto quello che Silvia non riesce a dire ad alta voce neanche al lettore, se non di sfuggita e senza dar peso eccessivo, e Silvia, di contro, è l’interpretazione quotidiana e specifica di ciò che Nabokov non ha sufficientemente (e a ragione) descritto su Charlotte: il modo di preparare il pranzo, ad esempio, e le aspettative che esso comporta avendo a casa “il nuovo amato”, in ambedue i casi. È sorprendente la qualità delle chiarificazioni su alcuni aspetti di queste madri che avviene dalla lettura dei due testi, in successione.
In ultimo, ed anche questa volta, come nella mia precedenze recensione su “Lolita”, mi ritrovo ad ammettere il medesimo anche per “La figlia femmina”: i capitoli migliori sono quelli in cui le ragazzine sono in procinto d’avere contatti fisici e maliziosità con i maschi adulti presenti, e questo senso di insoddisfazione sensuale che il lettore prova nel non vedere compiere qualcosa che si sa sia moralmente sbagliato è qualcosa di così sinistro che ci apre visioni su noi stessi (noi in quanto io e in quanto comunità) che, però, tratteremo “non ora, non qui”.
M.
#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#vladimir nabokov#annagiurickovicdato#lolita#la figlia femmina#mondadori#deagostini#fazi editore#editore#libro#recensione#balthus#quadro#opera#martaacciaro
1 note
·
View note
Photo

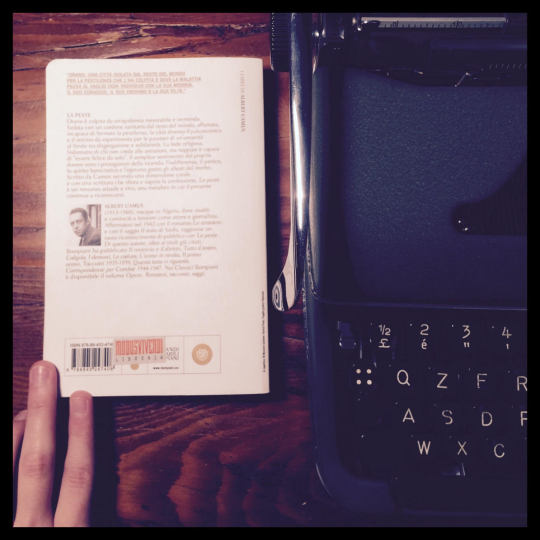
Libro 1. Albert Camus, “La Peste” (Edizione Bompiani)
Il 15 Giugno ero a Milano. Preparavo bagagli per tornare finalmente a Palermo dopo mesi di assenza. Il mio compagno, affaccendato anche lui, esclamò "Oh, hanno registrato un caso di meningite fulminante a Palermo!". Allarme rosso per la mia ipocondria, perché i problemi, finché non sono problemi "nostri", sono solo l'ennesima notizia noiosa sentita da qualche parte, ma se era (a) Palermo il problema, allora il problema era anche mio. Raggelata dall'egoismo e dalla pochezza di questo pensiero, feci comunque spallucce, continuai a preparare i miei bagagli e l'indomani partii, arrivai a casa e iniziò un bombardamento mediatico che registrò ogni giorno nuovi casi e nuove morti causate dalla meningite.
Giornalisti sciacalli o meno (tanto da farmi ringraziare costantemente Giorgio Gaber per aver scritto "Io se fossi Dio", in cui malediceva "veramente i giornalisti e specialmente tutti"), mi resi conto di voler trovare un modo per non farmi trascinare da una nevrosi da contagio che stava coinvolgendo tutti e in cui tutti (o quasi) caddero. Era l'alba di un giorno a caso e decisi di combattere la mia ipocondria, il mio egoismo concettuale, la paura di un'ipotetica trasmissione, leggendo il libro che più di tutti, pensai, avrebbe potuto aiutarmi in quel preciso momento: "La Peste di A.Camus" (Edizione Bompiani). Lo aprii e lessi, a pagina 30, che "I flagelli, invero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa" e mi sembrò così strano che invece noi si stesse facendo tutto il contrario e come dal 1947 ad oggi le credenze al riguardo potessero essere tanto diverse. E lessi, ancora, a pagina 32, come "pochi casi non fanno un'epidemia".
Non avevo certo bisogno di Camus per comprendere questo, ma mi rendevo perfettamente conto che l'azione del prendere dalla libreria questo libro già letto e il rileggere attentamente le sue parole, mi mettevano nella condizione di credere che quello che stavo facendo era effettivamente chiedere "Ok, Albert. Tu che hai immaginato così bene un'epidemia come la peste, proprio come Salgari ha immaginato la giungla nera, vorrei chiederti delle cose, esattamente come le chiederei a Salgari se dovessi fare un'escursione nelle foreste dell'Amazzonia. E invece no. Parlo con te, ché sei il più adatto al caso, te ne renderai conto anche tu". E se vi aspettate che questa sia una recensione che vi spieghi per filo e per segno l'intreccio del romanzo, lo studio psicologico dei personaggi, l'analisi del rapporto che il Dottor Rieux ha con sua moglie, con sua madre e con i pazienti tutti, non lo farò. Non lo farò perché tutto questo è già stato spiegato e approfondito in chissà quante tesi, chissà quante recensioni di persone che riescono a prendere un libro e sezionarlo come un chirurgo seziona i lembi di carne da eliminare da un paziente obeso. Non che io non lo sappia fare, ma qua, adesso, è realmente necessario, al fine della nostra storia e consapevoli delle centinaia di persone che già l'hanno fatto, parlare del fatto che la storia ruoti attorno a cinque personaggi centrali, che vivono la peste in modo diverso, benedicendola, rifuggendone, affrontandola, annoiandosene, accettandola? E' davvero necessario scriverne così, o dire che questi stessi personaggi non sono che la traduzione in sentimenti dei possibili modi che abbiamo per affrontare qualsivoglia insidia, davanti ad uno scenario disarmante come la malattia, in genere? L'inevitabilità della morte.
La questione, credo, non sia porsi a un libro come l'annoiato che sceglie un titolo a caso per il semplice piacere della lettura. Quello esiste, esiste anche, ma è così riduttivo - ho imparato negli anni - farsi sopraffare da un libro per la questione noia, perché la noia stessa si farebbe scambiare, piuttosto che aversi, con qualsiasi pochezza di spirito e pensiero, e ci accontenteremmo di tutto, soverchiati dalle parole. Lo puoi fare a 16 anni, quando ti stai formando. Ma arriva un momento in cui è giusto comprendere il perché ci si approcci a qualcosa, e il come.E dopo gli anni della formazione si arriva ad un punto in cui, nel momento stesso in cui apri un libro, te ne freghi dell'introduzione, della cronologia, te ne freghi di contestualizzare l'opera all'interno della storia. Sei solo tu e c'è solo lui - O lei - perché lo scrittore prende effettivamente corpo come fosse un fantasma e tu, aprendo il libro, che hai aperto perché avevi delle domande specifiche da porgli, rimani fermo, zitto e ascolti tutto quello che ha avuto la necessità di comporre. Porsi in silenzio di fronte alle parole di questo scrittore; a tratti fermarlo e dirgli "Ok aspetta un attimo, ti rendi conto di quanto sia grave questa cosa che stai dicendo?", o quanto sia bella, o quanto sia importante, o quanto sia così ovvio che ci si sente instupiditi dal non averlo pensato prima, da solo. E allora lo ringrazi, o ti arrabbi: "Cosa stai dicendo, accidenti a Te!". L'opera parla sempre da sola, se è davvero un capolavoro. Ti risponde. Vivi insieme a lui (scrittore) e insieme a lei (storia). E in quelle mattine d'Estate, tra una notizia e l'altra dei casi di meningite che continuavano a sbucare da ogni parte d'italia, io mi ripetevo "pochi casi non fanno un'epidemia, M., e te lo sta dicendo uno che il flagello lo ha visto davvero". Perché scrivere è vedere davvero, aver vissuto davvero tutto quello che non si è vissuto. E il lettore che si pone in questi termini rispetto alle parole di qualcun altro vive esattamente allo stesso modo il libro, la vita. E io, che stavo vivendo non un flagello, non un epidemia, ma qualcosa che a torto o ragione volevano spacciare per tale e che venne vissuta da tutti noi come tale, non ho potuto far altro che ritrovarmi in tutti quei personaggi minori del libro, quelli di cui nessuno parla, la vera anima vibrante, il prurito impaziente, lo sragionamento, gli slanci emotivi brevissimi. Quei personaggi impauriti nel vedere il proprio caro affetto dalla peste e il dilemma interiore di credere questo stesso caro, sì, come vittima della malattia sua, ma soprattutto flagello della morte mia, nostra. Provai lo stesso terrore quando il mio compagno tornava alle 4 di mattina dalla movida palermitana, mi dormiva accanto e si affacciava lo stesso dilemma interiore, le stesse fantasie di quei familiari, la stessa paura della quarantena, dell'isolamento, dell'ipercontrollo mancato, la disillusione del futuro, la consapevolezza di un eterno qui ed ora, la genuinità dei sentimenti senza ipocriti fronzoli, l'accettazione della morte.
Leggere La Peste di Camus ci insegna come non possa esistere un unico modo per affrontare la malattia, per affrontare in definitiva "la" questione: la morte. Esistono più e più modi. Qualsiasi sia, questo modo - la maledizione di dio o l'assoluta devozione, aggrapparsi alla speranza, il cinismo compiaciuto - rimaniamo assolutamente ignari del perché "tocchi a lui piuttosto che a me" quella morte orrenda e se io rimango qua, in qualsiasi modo io ne rimanga, è forse giusto che ci si occupi della vita, in tutti i qui ed ora che ci è dato avere senza possibilità di controllo.
M.
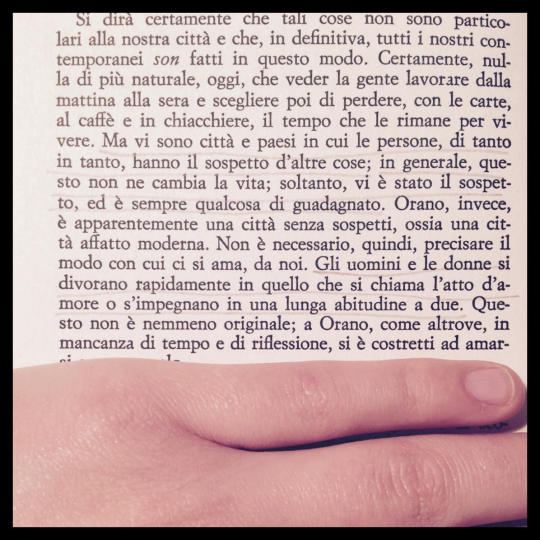
#1: amarsi senza saperlo
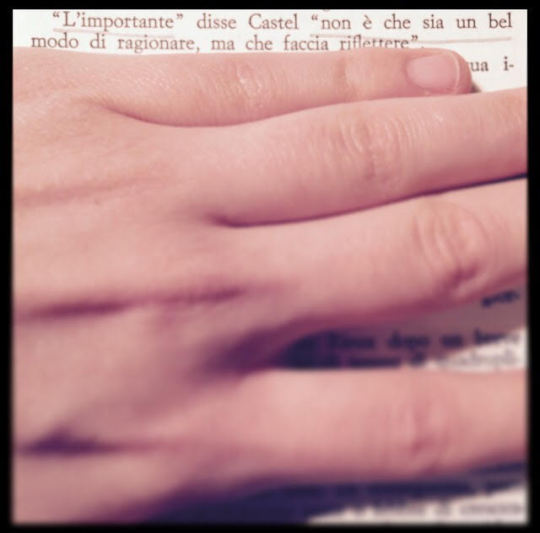
#2: riflettere
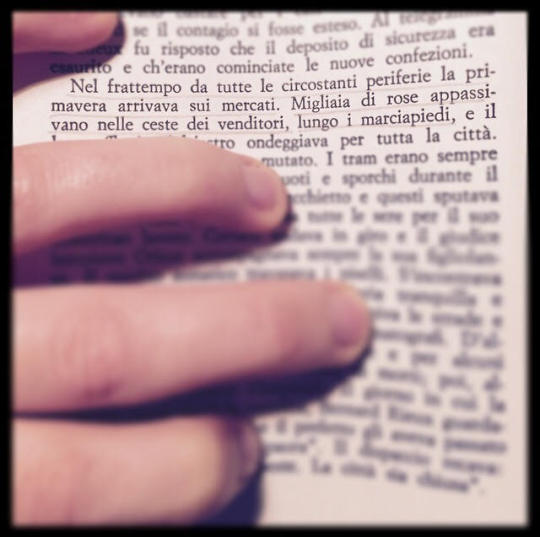
#3: la primavera sui mercati
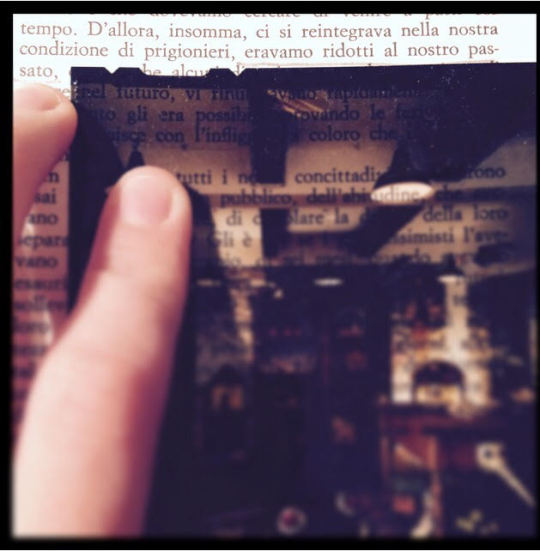
#4: il passato (e Nostalghia)
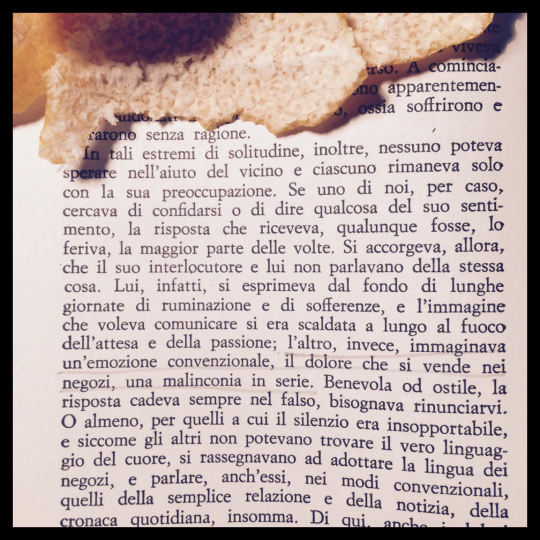
#5: il dolore che si vende neinegozi
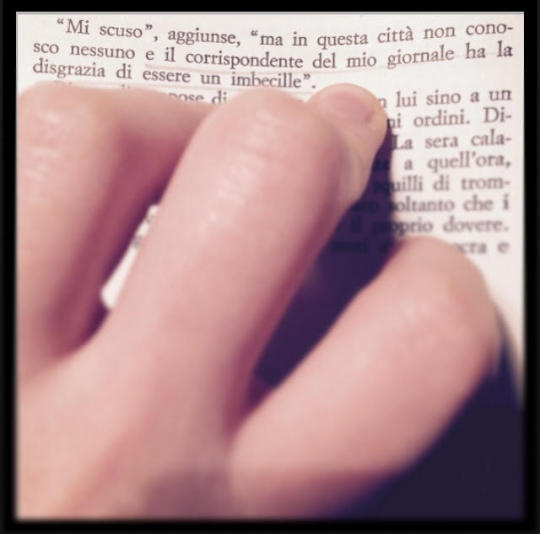
#6: “io se fossi dio maledirei davvero i giornalisti e specialmente tutti” (Gaber)
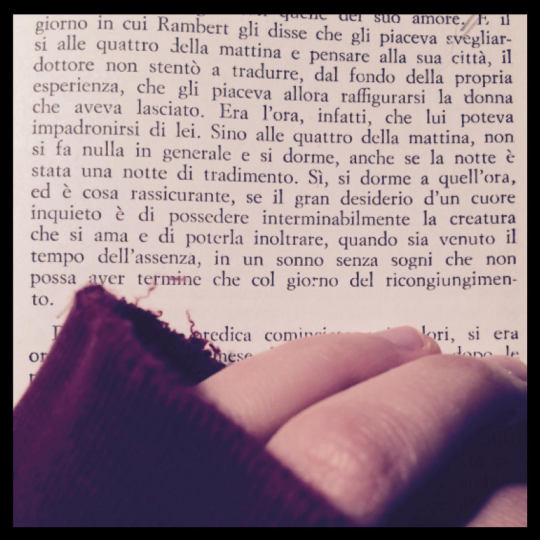
#7: mancanze
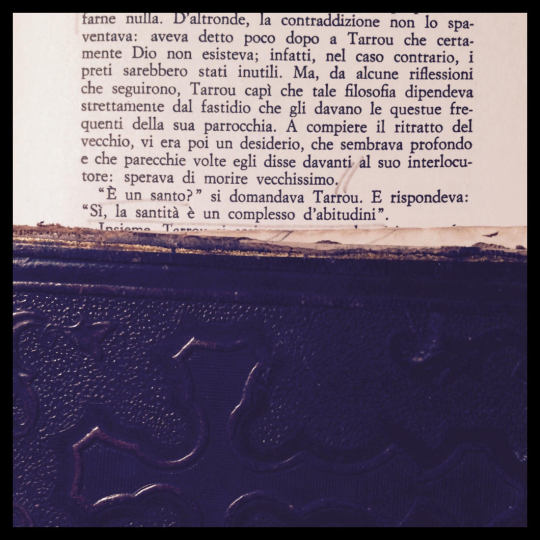
#8: “i convenevoli del quotidiano fatti preghiera” (C. Bene)
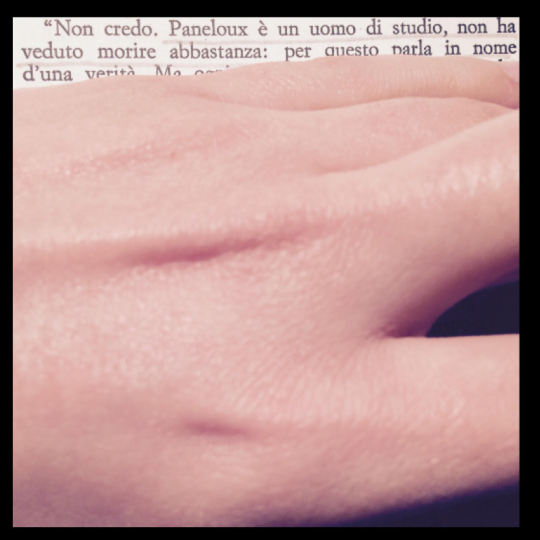
#9: in nome della verità
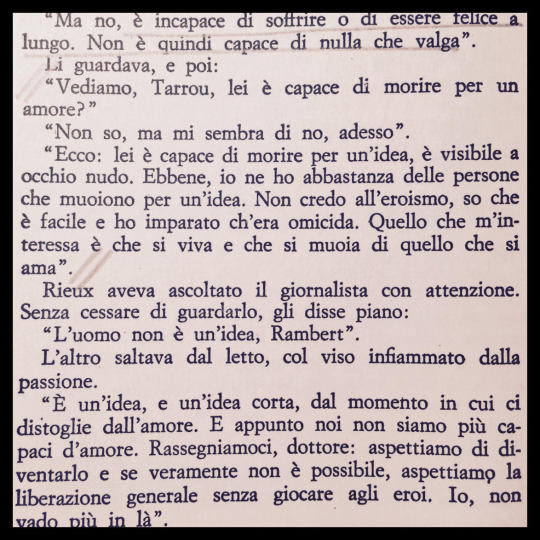
#10: morire per le idee
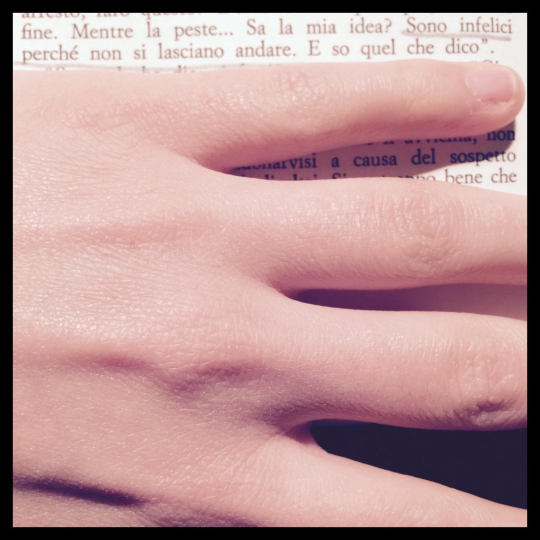
#11: lasciarsi andare
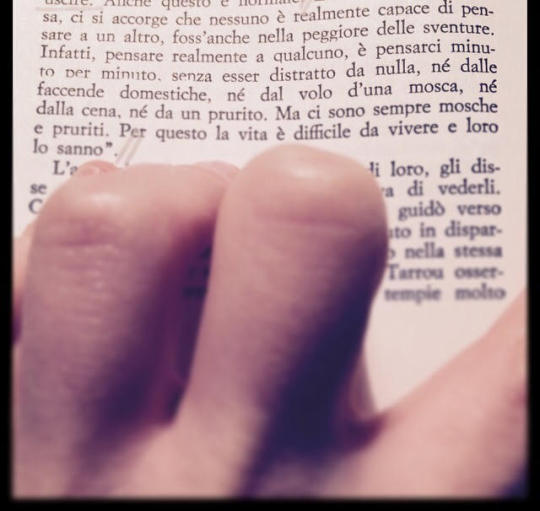
#12: mosche e pruriti, lo sappiamo tutti
#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#albertcamus#lapeste#bompiani#editore#libro#book#citazione#fotografia#recensione#letturacondivisa#letturaconsigliata#martaacciaro
1 note
·
View note
Text
#PremioStrega2017 : #3 Nicola Ravera Rafele, “Il senso della lotta”, Fandango Libri


Tempo fa parlai - con il qualcuno della mia quotidianità - dell’amore:
- Io sono innamorata di lui e proprio non lo so dire perché, non te lo so raccontare, non so trovare le parole giuste per capire cosa effettivamente mi faccia sentire e vivere questo
- E per fortuna! Che se tutte le parole venissero fuori, se razionalizzassi il tuo sentimento, se lo sapessi “dire” questo sentimento, allora forse avresti smesso di amare
Non capisco perché - (non è vero, in realtà lo capisco) - ma quando si ama un libro, proprio come una persona, (per la sua struttura, per la storia, per le parole, per tutto quello che non viene detto ma compreso ugualmente) è difficile parlarne. Il pensiero non si fa affatto profondo, sfugge. Rimangono a galla moltissime banalità. Banalità, tra l’altro, che non voglio cogliere solo per dirvi “oh, che libro eccezionale!”. Credo che parlare de “Il senso della lotta” di Nicola Ravera Rafele (edito Fandango Libri) sia un po’ come tradirlo: questo libro parla per se stesso in un modo talmente evidente e completo che ogni mia parola in più lo offenderebbe. Ed è un pensiero davvero serio, il mio, a riguardo. Nessuna enfasi. La semplicità è condicio prima: parlare con parole asciutte e chiare di qualcosa di difficile come l’utopia rivoluzionaria, il terrorismo, l’abbandono, la bugia, la distruzione vi può dare una ragione sufficiente per andare immediatamente in libreria e toccare con mano la copertina bellissima firmata Luigi Ghirri. Fatelo vostro, vi prego e – davvero – non voglio dire nulla di più e mi limiterò a dire che è certamente questo il vincitore (purtroppo non ufficiale) del Premio Strega 2017, ingiustamente tralasciato a favore di libri di opinabile solidità strutturale, tematica, contenutistica.
Vi lascio alle parole dello scrittore, intervistato da Rai Letteratura, da cui ho tratto le citazioni che qui riporterò per informarvi sul perché è nato questo libro. Per tutto il resto, leggetelo e abbandonatevi alla storia di Tommaso (38 anni, giornalista) che stravolge la sua vita per ricomporre se stesso alla luce delle verità apprese sulla morte dei sui genitori (terroristi), riportando in vita anche loro, nella memoria e nella storia, a svantaggio dei misfatti e della vita comoda, “nicchia calda” , che cela quella verità al quale Tommaso si aggrapperà disperato a discapito di tutto.
“Tommaso scopre a un certo punto di non sapere tutta la verità sui suoi genitori: […] la sua vita poteva anche non andare completamente a pezzi su una scoperta del genere […]. […] Perché crolla in questo modo? Perché la nicchia che si era costruito era una specie di cuccia calda, era in realtà una quinta teatrale […]. […] ho la sensazione che sia un po’ una tendenza della mia generazione: […] questo enorme indistinto in cui viviamo, questo mondo diventato così faticoso da leggere, dov’è così faticoso trovare un proprio posto e sopravvivere [che] ci ha un po’ costretti ad arretrare, a perdere terreno. Ci siamo spesso accontentati di costruirci – appunto – delle nicchie che ci contenessero senza andare a vedere cosa c’era al di là, perdendo proprio una parte di quel rapporto col sogno, con l’utopia che era stata la caratteristica più forte della generazione dei nostri padri”.
“Quando ho cominciato a scrivere questo romanzo, o meglio quando ho cominciato a costruire la storia, avevo un problema stilistico […] legato al contenuto. Dovevo portare il mio protagonista [Tommaso] a scoprire e a far scoprire al lettore una storia in parte avvenuta trent’anni fa. Allora […] – visto che non volevo che fosse una giustapposizione – […] volevo che Tommaso scoprisse le cose con noi e ci portasse dentro. […] l’unico modo che ho trovato è stato [creare] un collage, cioè portarlo attraverso persone che incontra, pagine di diario, giornali - qualunque cosa – dentro, piano piano, alla storia. […] L’altra scelta forte che ho fatto è quella del presente storico. Il libro fa avanti e indietro dal passato al presente: avevo molta paura di appesantire la narrazione che era ricca […] di eventi, storie da raccontare. […] certe volte recuperavo Michele e Alice negli anni ’70 e raccontavo una parte successa tra l’ultima volta che li avevo visti prima e quando li ritrovavo e lì, fossi andati al passato remoto, avrei rischiato di incartarmi in una quantità di trapassati […]. Volevo evitare, data la complessità della struttura, di affaticare il lettore con una pagina troppo pesante”.
“Mi interessava, in questo romanzo, raccontare il passaggio dalla linea d’ombra verso l’età adulta di due generazioni così diverse. Quella dei padri, quella della generazione degli anni ’60 e ’70 è un passaggio verso l’età adulta […] con troppe parole, infestato di mitologia […]; dall’altra parte c’è il diventare grande di Tommaso, un trentottenne di oggi: per lui diventare grande è un percorso verso la verità, verso la demistificazione, come se crescere fosse progressivamente far aderire il vero sé a quello che ci si è raccontati, ed è un percorso di crescita completamente antieroico, a differenza di quello dei genitori, tutto ripiegato verso la riflessione su se stessi e sul proprio posto nel mondo”.
( http://www.letteratura.rai.it/articoli/nicola-ravera-rafele-il-senso-della-lotta/37701/default.aspx )
M.

#1 : ipocondria

#2 : le storie degli altri

#3 : giocare

#4 : riusciremo a sopravvivere?

#5 : l'accento

#6 : la rivoluzione

#7 : Kant

#8 : "era solo vuoto"

#9 : "vale meno?"

#10 : OK

#11 : la paura

#12 : autoindulgenza
#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#nicola ravera rafele#il senso della lotta#fandango#fandango libri#fandango editore#editore#libro#citazione#citazione libro#frasi libro#fotografia#recensione#lettura condivisa#lettura consigliata#martaacciaro
0 notes
Text
#PremioStrega2017 : #2 Wanda Marasco, “La compagnia delle anime finte”, Neri Pozza


Vincenzina muore. Rosa ha paura: paura di vestire la carne morta di sua madre, paura della paura stessa. “Sei venuta dal niente e dalla paura, ma’”, dice Rosa alla madre morta e mentre lo dice lo ricorda a se stessa, nata dal niente del padre Rafele messo “a gobba” sopra sua madre, nata dalla paura di Vincenzina di continuare a non esistere bene “quando si vorrebbe solo esistere bene” (cit.W.M.). La paura diviene per Rosa una malattia: “I medici l’hanno chiamata con un altro nome, ma era la paura”. Non ci pensare più, andrà tutto bene, le dice Vincenzina prima di morire, perché madre e figlia “vivono e muoiono in una dimensione speculare che quasi sta a dimostrare quanto la morte dell’una significhi svelare la verità dell’altra”, come ci ricorda l’autrice in un’intervista per Rai Letteratura (http://www.letteratura.rai.it/articoli/wanda-marasco-le-vite-di-napoli/37261/default.aspx).
Ci si accorge della bellezza di quest’ultimo libro di Wanda Marasco, “La compagnia delle anime finte”, sin dalla prima pagina. Napoli, teatro a cielo aperto, accoglie la storia - reinventata da Rosa – dei suoi genitori, in una sfilza di misfatti febbricitanti: è la Napoli del dopoguerra, “la Napoli stratificata, stratificata nei luoghi, nei significati, nelle epoche storiche”, zoppicante nelle sue incertezze, quella che accoglie le storie delle due famiglie del romanzo: “la famiglia della miseria [Vincenzina] e la miseria della nobiltà decaduta [Rafele]” (cit. W.M.) che genera questa terza famiglia, quella di Rosa e dei suoi fratelli, disgraziata nelle storie di Rafele, nelle storie di rione, nel tentato riscatto sociale, nell’usura e nella violenza ignorante, raccontato da Rosa in un modo che atterrisce per la sua asprezza.
“Sono creature del degrado […]Ho sempre sentito una sorta di attenzione - di attrazione – verso le persone nate nel degrado, le persone dell’abbandono” ci dice Wanda Marasco, che crea i suoi personaggi non da una ispirazione familiare autobiografica, ma da certe vicende (di altri) vissute come occhio esterno.
I rapporti familiari sono il nucleo concatenante per tutto il libro in un continuo alternarsi di racconti delle due famiglie, l’una – quella di Vincenzina – così povera nelle sua stanza nuda e affollata e inquinata dalla cattiveria della madre, l’altra – quella di Rafele – che con arroganza “cerca di conservare uno status perduto” essendo incapace di “adattarsi alla nuova storia”. Elemento comunque sono queste madri disperate (ognuna della propria disperazione) e il fatto che ogni membro delle due famiglie è certamente a sé – per sé – ma è come se acquisisse dignità storica e individuale solo nel rapporto con gli altri membri del gruppo: un nulla che diviene qualcosa solo in funzione del contesto abitato, finanche nella separazione, nel rinnegare - mai del tutto - le proprie pareti, le proprie origini.
Queste contraddizioni - il fare parte di un luogo rinnegato continuamente - si sposa perfettamente con il linguaggio utilizzato, in un rimando continuo di io-noi, famiglia-mondo, binomi incontro-scontro da cui ci si deve proteggere eppure salvare: l’italiano e il napoletano si intrecciano in una fluttuazione costante di episodi, stati umorali, sentimenti: “le due lingue sono connesse perché connesse all’evoluzione dell’interiorità dei personaggi”, in una Napoli le cui strade sono colme di questo intreccio linguistico tra pubblico (italiano) e privato (napoletano), qui usato “più [come] una coloritura che appartiene solo alle brevi frasi del discorso diretto” (cit. W.M.).
Leggere i libri di Wanda Marasco significa entrare in una dimensione poetica che contrasta e al contempo ci svela la brutalità della vita dei suoi personaggi. È un libro che fa male, questo, per la semplicità con cui vengono descritti certi orrori quotidiani, certe volgarità, certe bassezze, mai enfatizzati, ma riportati nella loro legittimità fastidiosa e invadente, talune volte invalidante, delle/nelle nostre vite e che ci fanno comprendere certi aspetti di noi che spesso preferiamo tenere nascosti per paura: una paura identica, comune, a quella di Rosa.
M.

#1 : i panni della morte

#2 : il padre

#3 : il mercato

#4 : "una sintesi dei sentimenti"

#5 : "comica e randagia"

#6 : il fazzoletto

#7 : dita intrecciate

#8 : "ti vuoi fidanzare con me?"

#9 : "designarci a giudici"

#10 : "chi"?

#11 : Annarella

#12 : la malattia
#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#wanda marasco#la compagnia delle anime finte#neri pozza#editore#libro#citazione#citazione libro#frasi libro#fotografia#recensione#lettura condivisa#lettura consigliata#martaacciaro
0 notes
Text
#PremioStrega2017 : #1 Teresa Ciabatti, "La più amata", Mondadori


“È un libro che gioca molto con la realtà, con la verità. Inizia con questa ossessione di sapere […] chi fosse veramente mio padre e diventa un’ossessione. Poi, lungo il libro, mi libero da questa ossessione e la domanda diventa più “chi sono io?”. […] la risposta che cerco è […] liberarsi dall’ossessione di conoscere la verità. Che poi la verità è quella che abbiamo vissuto noi, è questo che alla fine capisco io. […] nel paese sono la principessa, in città sono nessuno. Forse è un libro che inizia con delle identità di personaggi molto caratterizzati, molto forti, e piano piano […] si mischiano tra la folla, diventano delle persone qualunque, prima di tutto io […] quello che scopro da adulta è che io sono una qualunque, una qualsiasi” (http://www.letteratura.rai.it/articoli/teresa-ciabatti-la-scoperta-di-essere-normali/36561/default.aspx).
Tendenzialmente si preferisce leggere un classico. Un classico, essendo appunto un classico, ha sempre qualcosa da dirci sia sul tempo che è stato sia sul tempo che è. Presumibilmente sul tempo che sarà, per il medesimo principio. Un classico ci dà una quieta certezza e, sebbene io non ne neghi la fondamentale importanza che esso ricopre all’interno della vita di un lettore, ad esso ci affidiamo quasi per partito preso. Abbiamo un pregiudizio nei confronti del classico: Kafka ci deve piacere, ad esempio, perché è intellettualmente stimolante ed emotivamente asfissiante. Pasolini è quasi indiscutibile: chi è intelligente lo deve amare: così profondo, così rivoluzionario. Che dire poi di Wallace, diventato un classico dell’ipercervelloticismo (che non esiste, ma rende l’idea), geniale nella sua scrittura postmoderna, quando spesso neanche si sa cosa sia il postmoderno. Deleuze, nel suo abbecedario, afferma la sua preferenza nell’approcciarsi all’intera bibliografia di un solo autore, in una precisa esclusività, per capire davvero un percorso e delle parole in una comprensione totalizzante, e di non avere comunque tempo da dedicare alle nuove letture, le nuove uscite, che denigra con indifferenza, ma senza pregiudizi.
Che sia per pregiudizio, che sia per mancanza di tempo, le nuove uscite sono cose da lettori in spiaggia, gente non impegnata, editori tutti volti alla pubblicità e al mercato, al monetizzare le dita su carta di qualcuno. O almeno questa è l’opinione dei più. Ecco, io credo che non sia così. Riconoscendo che oggi tutti scrivono e che questo ha portato ad un decadimento stilistico e tematico, riconoscendo come anche il Premio Strega abbia quasi premiato, negli ultimi anni, il “meno peggio” dell’editoria, credo tuttavia con fermissima convinzione che un libro come “La più amata” abbatta tutto il detto sopra e si stagli tra gli scaffali delle librerie come libro bellissimo, commovente, terribilmente vero, terribilmente doloroso, profondo, ossessivo, intelligentissimo. Un sospiro di sollievo in una massa inqualificabile di noia stampata su carta.
Alla fine dell’intervista per le videocamere di Rai Letteratura, Teresa Ciabatti afferma di non aver forse più nulla da scrivere, essendosi svuotata della complessità ossessiva della sua vita: una volta uscita da lei, fattasi corpo tramite le pagine di un libro edito Mondadori, cosa avrà più da dire? E leggendo il suo libro le rispondiamo: Teresa, non importa, davvero. Non importa se non scriverai più nulla. È la qualità e non la quantità e tu sii coraggiosa, rimani coraggiosa nel volerti fermare se reputi di non poter superare la tua personalissima storia di tutti. Perché è di tutti, Teresa, anche se ci parli di un padre ingombrantissimo, medico, sciatto e ricco, anche se ci parli di una madre rinunciataria, confusa, problematica e di un fratello distante. La tua storia, la storia di tutti.
Aprendo la prima pagina si rimane schiacciati, schiaffeggiati da una scrittura tagliente, spigolosa, irriverente, puntualissima e più si va avanti e più si crede che questo crescendo debba terminare, non terminando difatti mai. Si arriva stremati alla fine del libro per la capacità – difficilissima da trovare in una persona – di dirsi le cose come veramente stanno, valicando la vergogna, il giudizio, in una strafottenza stanca e rassegnata.
Teresa Ciabatti ci fa entrare nel suo mondo, ma ancor di più dentro se stessa, in un rimando continuo di ricordi puri d’infanzia e infanzia rivissuta con mente adulta, creando una tensione emotiva che ci lascia esenti da giudizio. Si rimane così, spiazzati ad ascoltare, incapaci di dire la propria opinione non necessaria perché è lei stessa che lo fa per noi: si pone come narratrice, protagonista, giudice, principessa, sognatrice, cinica, investigatrice, curiosa, schietta, imperdonabile. A noi non rimane altro che sospendere la nostra capacità valutativa. Un’apnea cognitiva struggente che lascia spazio ad emotività tutta e che ci dà la possibilità di porci timidamente quelle domande - su di noi e sul contesto familiare che abitiamo - che lei ha avuto il coraggio di vivere, regalandoci la possibilità di farlo a nostra volta.
M.

#1 : "Mi chiamo Teresa Ciabatti"

#2 : fragilità

#3 : "lui..."

#4 : scusami

#5 : la famiglia

#6 : "e dunque"

#7 : "prima che vi accorgiate che sono grande"

#8 : "Teresa fa schifo"

#9 : "non preoccuparti"

#10 : "dove sei pedofilo?"

#11 : mamma

#12 : "sii onesta, Teresa Ciabatti"
#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#teresa ciabatti#la più amata#mondadori#editore#libro#citazione#citazione libro#frasi libro#fotografia#recensione#lettura condivisa#lettura consigliata#martaacciaro
0 notes
Text


Libro 8. Jane Austen, “Ragione e Sentimento” (BUR Rizzoli)
“[…] ai primi dell’Ottocento una famiglia di classe media possedeva soltanto una stanza di soggiorno […]. Se una donna scriveva, doveva scrivere nel soggiorno comune. […] A ogni modo, in quella stanza era più facile scrivere una prosa, o un romanzo, di quanto non fosse scrivere una poesia o un dramma. Non ci voleva tanta concentrazione. Così scrisse Jane Austen fino alla fine dei suoi giorni. <<Come potesse fare tutto questo>> scriveva sua nipote nella sua Memoir <<non si capisce, poiché non aveva uno studio proprio in cui isolarsi, e gran parte della sua opera è stata scritta nella stanza di soggiorno della famiglia, dove era soggetta a ogni sorta di interruzione. Ella aveva cura che né le persone di servizio né i visitatori si accorgessero della sua occupazione, della quale soltanto la famiglia era a conoscenza. Jane Austen nascondeva i suoi manoscritti o li copriva con un pezzo di carta assorbente. D’altronde tutta l’educazione letteraria che poteva avere una donna agli inizi dell’Ottocento era un’esercitazione nello studio dei caratteri, nell’analisi delle emozioni. Per secoli la sua sensibilità si era educata sotto l’influenza di quella stanza da soggiorno comune. Di essa le erano rimasti impressi i sentimenti; aveva sempre davanti agli occhi lo spettacolo delle relazioni umane”.
I soggiorni di Ragione e Sentimento, pensai allora: Il soggiorno del Signor Dashwood e i litigi sottaciuti tra parenti; il soggiorno della nuova casa nel Devonshire delle Signorine Dashwood e Signora e l’amore per un uomo sbagliato; il soggiorno del Signor Middleton e gli incontri dell’alta società di campagna; il soggiorno della Signora Jennings a Londra e le cortesi visite contraccambiate. Una camera-mondo nella vita di Jane Austen (perfettamente descritta da Virginia Woolf) che diviene camera-mondo in ogni suo romanzo. Gli esterni sono soltanto protagonisti di un paesaggismo neanche così ben descritto, neanche tanto a lungo, neanche nel dettaglio; le cucine sono nascoste; i pranzi sorvolati; le camere da letto, forse, un’attenzione più viva nella condivisione con il lettore del dramma interiore sempre taciuto nell’unico palcoscenico della vita di allora: il soggiorno. Ben arredato, poco arredato, vistosamente arredato. Cornici e disegni mediocri, complimenti per i disegni mediocri, giustificazioni per disegni che forse mediocri non sono. Ninnoli. Ventagli. Poltroncine. Se ne sente persino il rumore di stoffe di vestiti nel momento della seduta sui sofà. Una gamba che si sposta. Lo sguardo che dal libro passa al bucolico e non ne torna indietro.
Ciò che è veramente incredibile in Jane Austen, anche per un lettore come me che non ama affatto il genere al quale i suoi romanzi appartengono, è lo smarrimento immaginifico conseguente alla lettura di ogni suo testo. Si rimane totalmente spiazzati in quella consapevolezza - che sovviene appena si inizia la lettura – nel “vedere proprio tutto”. Nei libri di Jane Austen le descrizioni fisiche sono ridotte al minimo, così come le descrizioni dei luoghi. Eppure ogni capriccio, ogni dettaglio emotivo è definito così bene e con parole così chiare, semplici e difficilmente fraintendibili che i nasi, le braccia, le sopracciglia, la corporatura e le movenze di tutti i personaggi si vanno delineando in una composizione perfetta della scena. Chiudendo il libro, questi stessi personaggi - denigrati tanto spesso da un carattere e un gusto come il mio – ti accompagnano in quella che è la tua quotidianità. Te li ritrovi a tavola a bere il brodo. Li ritrovi svenuti sulle poltrone che richiedono i sali profumati per riprendersi subito dopo. Li ritrovi che piangono in posizioni quantomeno scomode, affacciati alla finestra.
Per molto tempo mi sono chiesta il perché i miei gusti mi abbiano spinto a preferire una donna e scrittrice come Charlotte Bronte a Jane Austen. Ma è davvero un problema di gusti? Un problema caratteriale? In fondo, ambedue parlano di storie d’amore. Ambedue parlano attraverso delle donne eroine. Ambedue parlano di lieto fine, di matrimonio come apice della felicità. Eppure continuavo a preferire Jane Eyre a Ragione e Sentimento o ad Orgoglio e Pregiudizio. Perché? La risposta arrivò un giorno, sfogliando Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, da cui trassi la citazione iniziale e da cui traggo questa citazione: “Questo forse era il più grande miracolo di tutti. Una donna [Jane Austen], agli inizi dell’Ottocento, che scriveva senza odio, senza amarezza, senza paura, senza protestare, senza predicare […] ed è per questo che la personalità di Jane Austen pervade ogni sua parola; e […] se qualcosa fece soffrire Jane Austen, questo qualcosa fu soltanto la limitatezza della vita che le era stata imposta. Ella non viaggiò mai; non attraversò mai Londra su un autobus, né fece colazione da sola in un ristorante. Ma forse la stessa natura di Jane Austen non le faceva desiderare ciò che non aveva. Il suo talento e il suo ambiente si accordavano alla perfezione. Dubito però che si possa affermare lo stesso di Charlotte Bronte […]. Il libro [Jane Eyre] si era aperto al dodicesimo capitolo, e una frase richiamò la mia attenzione: <<chiunque mi può biasimare, se vuole>>. Perché biasimavamo Charlotte Bronte? mi domandavo. E mi misi a leggere: diceva che Jane Eyre soleva salire sul tetto […] per guardare il paesaggio lontano, al di là dei campi. E allora desiderava – ed è per questo che la biasimavano – <<allora desideravo il potere di una visione capace di varcare quei confini; […] desideravo di possedere assai più esperienza pratica di quanta ne possedevo; più contatto con i miei simili, più conoscenza dei diversi caratteri di quanto la mia cerchia mi poteva offrire […] credevo nell’esistenza di altre forme più vivaci di bontà e volevo vedere quello in cui credevo. Chi mi biasima? Molti, senza dubbio, che mi chiameranno scontenta. Non posso farci nulla, l’irrequietezza è nella mia natura; a volte si agita in me fino a diventare dolorosa... È inutile dire che gli esseri umani dovrebbero accontentarsi della tranquillità […]. Di solito si crede che le donne siano molto calme: ma le donne sentono tutto quanto sentono gli uomini; hanno bisogno di esercitare le loro facoltà e di trovare un campo per i loro sforzi […]; soffrono di costrizioni troppo rigide […] ed è meschino da parte dei loro prossimi più privilegiati dire che esse dovrebbero limitarsi alla confezione di budini e di calze, a suonare il piano e a ricamare borsette. È una frivolezza condannarle, o ridere di loro, quando cercano di fare o di imparare più di quanto la tradizione considera opportuno per il loro sesso. In quel momento di solitudine, spesso sentivo le risate di Grace Pole…>>. Questa è una spiacevole interruzione, pensai. Sconvolge, imbattersi così in Grace Pole. La continuità del testo viene turbata. Si potrebbe dire […] che la donna la quale scrisse queste pagine aveva in sé più genio di quanto ne avesse Jane Austen; ma basta rileggerle e osservare in essere quel gesto di fastidio, quell’indignazione, per capire che non riuscirà mai a esprimere interamente il suo genio. I suoi libri saranno deformati e contorti. Ella scriverà con rabbia, quando dovrebbe scrivere tranquillamente. Scriverà con scioccamente, quando dovrebbe scrivere saggiamente. Parlerà di se stessa quando dovrebbe parlare dei suoi personaggi. È in conflitto con il suo destino”.
Charlotte Bronte, interrotta continuamente nel suo soggiorno e infastidita per ogni richiamo, ogni rumore. Ma non Jane Austen, così calma nella sua sedia, così calma anche nella descrizione del dolore e del dramma, mai enfatico seppur fortissimo, trattato come ciò che di più comune esista in vita, come ciò che è appunto la vita e su cui non si deve andar contro, ma che bisogna accettare con tutta la forza di cui (non) siamo capaci. Leggere Ragione e Sentimento è imbattersi nelle avventure emotive di due sorelle, l’una riflessiva e razionale, l’altra passionale e irragionevole, che vivono amicizia, amore filiale, amore per se stesse e amore per il proprio uomo in modo diverso, in cui il primo modo di sentire non ne esclude l’altro, in cui non vi è un giusto modo di provare l’emozione, come non vi è giustificazione a forzare il proprio destino, chè se qualcosa dovrà accadere accadrà naturalmente e non sarà la forzatura per mano propria a cambiare in meglio una sorte che bisogna accettare come condizione unica per essere liberi in quella che è la necessità della vita.
M.

#1 : la famiglia

#2 : "donde forse non ti"

#3 : accalappiare

#4 : il decoro

#5 : il pittoresco

#6 : "per quanto possibile diversi da me"

#7 : denti

#8 : ipocrisia borghese

#9 : spropositi

#10 : "niente da dire"

#11 : "e poi"

#12 : "lei non ha idea"
#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#jane austen#ragione e sentimento#bur#biblioteca universale rizzoli#rizzoli#editore#libro#citazione#citazione libro#frasi libro#fotografia#recensione#lettura condivisa#lettura consigliata#martaacciaro
0 notes
Text


Libro 7. Virginia Woolf, “La Crociera” (GTE Newton)
Qualche mese fa comprai su Depop un ciondolo portafoto antico, di inizio ‘900. Che sia antico lo rivelano tante cose, tra cui un vellutino sporco su cui inserire la foto del compianto defunto. Il mio compianto defunto è Virginia Woolf, autrice che non scoprii in giovane età, come le sorelle Bronte, ma davvero tardi: 27 anni. Eppure a casa il tomo (di mia madre) volume 1 “Woolf – Tutti i Romanzi” mi guardava e riguardava e io distoglievo lo sguardo: “è troppo presto, troppo”. Ed era presto davvero e forse bisogna avere occhi allenati alla lettura per amare così profondamente le pagine di Virginia Woolf. Il suo primo libro che mi trovò – perché fu lui a trovarmi in una prima fila di una botteguccia milanese di volumi a due euro – fu “Orlando”, in un’edizione tutta speciale non tanto per l’edizione in sé (la medesima de “La crociera” che andremo oggi a trattare, inserita nella raccolta di romanzi dell’autrice edita da GTE Newton), ma per l’appartenenza di una certa Sandra (è proprio questo il bello dei libri di seconda mano), probabilmente una donna o un uomo che stava attraversando la difficile e penosa fase del cambio sesso e che espresse tutto il suo disagio mediante certe sottolineature di certe frasi composte da Virginia. Una storia nella storia. Per molti mesi fu un pensiero incessante e fu così che Sandra mi trovò e insieme a lei anche Virginia, il fantasma a me più caro, che tengo sul mio petto dentro il mio ciondolo e le cui parole risuonano in me come una tempesta.
La scrittura di Virginia Woolf è sempre differente eppure uguale, in un continuo paradosso, in un continuo entrare e uscire da situazioni e personaggi eterogenei che costruiscono e costituiscono storie del tutto credibili, plausibili, reali e per questo – spesso – non si può sfuggire ad un certo livello di identificazione. “La crociera” è il suo primo romanzo (1915) in cui “Rachel Vinrace si imbarca per il Sud America sulla nave di suo padre e dà il via ad un percorso di scoperta di sé in una sorta di viaggio mitico moderno” (https://it.wikipedia.org/wiki/La_crociera). Ornella De Zordo scriverà che “non uno, ma due, sono i viaggi a cui allude il titolo altamente simbolico del primo romanzo scritto da Virginia Woolf. Sono viaggi per acqua (un elemento legato al moto e al cambiamento che ricorre nel testo come presenza costante) e tutti e due assumono le connotazioni di progressione interiore, di percorso all’interno della coscienza”. E sebbene questo sia riferito principalmente alle vicende di Rachel durante tutto il corso del viaggio in nave e durante il soggiorno in terra ferma, questa particolare circostanza introspettiva - che si riversa su carta attraverso parole legate in monologhi interiori o dialoghi dalle sfumature profonde fino al riversamento nelle più cordiali banalità – è oggetto di ogni personaggio del romanzo, sebbene in modo più particolareggiato soltanto per alcuni: Helen Ambrose, zia di Rachel, fautrice del soggiorno in terra ferma come secondo metaforico viaggio della nipote, e che affronta anch’essa – nel rapporto con la giovane – un viaggio di comprensione; Terence Hewet e John Alaric Hirst, due amici antagonisti in intelligenza e profondità del sentire, in un continuo rimando a riferimenti altri e inceppamenti linguistici e tematici (soprattutto l’Hirst) per la sua totale incapacità empatica e un egotismo perfettamente descritto.
Il romanzo è un buon romanzo per i tre quarti del libro: scorrevole, piacevolissimo, ironico. Ci si immerge in esso con facilità, trovando tematiche interessanti come il rapporto dell’io con il sé, il rapporto del sé con le circostanze entro cui svolgiamo le nostre vite, il giudizio su ciò che sia socialmente accettabile per una donna (pensare/fare) e il punto in cui essa debba fermarsi, l’introspezione della donna in genere, il rapporto uomo/donna nel rapporto formale/amicale/sentimentale. Ci si chiede, però, ad un certo punto, un qualcosa come “Ok Virginia, ma cosa vuoi dirmi davvero?”. La risposta arriva, in tutto il suo splendore, nell’ultima parte del libro, assolutamente travolgente nella sua imprevedibilità che pone il tema della morte come centrale e pone Rachel non più come la classica eroina di romanzo ottocentesco (vedi Jane Eyre), ma una donna comune, incapace come tutti di tener ferma la propria vita nel seguire i progetti e gli obiettivi prefissati, sopraffatta e soverchiata dall’inaspettato (che è la vita stessa) a cui non possiamo che arrenderci, dolcemente. Il libro esplode, così, bellissimo, in un compiuto articolato, giocoso e profondissimo in cui Virginia Woolf ci mostra l’essenza della vita, la morte come compimento della vita, la sciocchezza del trattenerci invece che lasciarci andare al flusso dei nostri giorni.
Leggere Virginia Woolf è vivere la vita in ogni sua forma. Il senso di pienezza che si prova fisicamente leggendo i suoi libri (poco importa se conseguente la frustrazione per certe letture di certe pagine o di esaltazione per la lettura di certe altre) è talmente forte che non potrei non consigliarvi: innamoratevi di lei e se non potete di lei almeno delle sue parole! Innamoratevi persino di questo primo romanzo perfettamente riuscito e che non ha, seppur nella sua immaturità, neanche uno dei difetti di tutte le prime volte di certi scrittori d’oggi.
M.

#1 : naturalmente

#2 : Cristo, o qualcosa

#3 : "non le pare?"

#4 : legami

#5 : sentire

#6 : stanze vive

#7 : "così, e basta"

#8 : questo e quello

#9 : "grazie al cielo"

#10: "c'è qualcosa di più ridicolo?"

#11 : amare

#12 : morire
#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#virginia woolf#la crociera#i mammut#grandi tascabili economici newton#GTE Newton#editore#libro#citazione#citazione libro#frasi libro#fotografia#recensione#lettura condivisa#lettura consigliata#martaacciaro
0 notes
Text


Libro 5. Charles Bukowski, “Donne” (Tea)
Come iniziare questa recensione senza essere banale? Concedendomi (tu, lettore) una banalità: “Henry "Hank" Chinaski è un personaggio di fantasia presente nella maggior parte dei romanzi, racconti e poemi dello scrittore Charles Bukowski. Misantropo, alcolizzato, nelle sue storie si trova quasi sempre in condizioni di instabilità; viaggia attraverso l'America passando da un lavoro a un altro e da una donna all'altra. Visto lo stile di vita anticonvenzionale e dissoluto di Bukowski (e una certa somiglianza nei cognomi), Chinaski è spesso considerato il suo alter ego” (https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Chinaski). Potrebbe bastare questo per scrivere una recensione cumulativa degli scritti di Bukowski? Sì. Probabilmente.
Quando ero adolescente ho letto, uno dopo l’altro, senza stancarmene mai, ogni libro, romanzo, storia, racconto di questo scrittore strano, divertente, bruttissimo, butterato. Leggevo e mi appassionavo a quel linguaggio volgare quasi come se la miserabilità e la trascuratezza fosse un traguardo da raggiungere per vivere una vita vera. Ed inoltre, anche un altro aspetto, proprio come accade oggi con Instagram: la vita, quella vera – appunto - è sempre quella degli altri, mai la propria. E quindi si scorre una foto dopo l’altra, una pagina di Bukowski dopo l’altra, inebriandosi di questa facilità di rapporti, incontri, feste, tutte così “vere” e lontane dai propri rapporti, incontri, feste, inspiegabilmente inferiori nella propria – a quanto pare - finzione. Quando si è adolescenti questo concetto è ridondante in ogni minuto di veglia, nella continua insufficienza d’espressione e di esperienza e sarebbe troppo semplice affermare che una volta adulti e maturi la questione si tramuti in pensieri profondi e lontani da questa visione superficiale dell’esistenza, della quotidianità. Quello che capita più spesso, invece, è la paura di questo fantomatico quotidiano, rinnegandosi la serenità, inseguendo la sciatteria linguistica, l’intercambiabilità di attimi e persone, tutto per profumare di afrodisiaca “vitalità vera” questa simulazione di realtà.
Che noia. Perché tutti noi, non so quanto inconsapevolmente, siamo schiavi di questo meccanismo annichilente e avvilente. Che noia, dunque. Una noia che è un prurito da pellaccia sporca come quella di Chinaski, sudaticcio e gonfio, con la pelle scabbiosa che cade a pezzi dal tanto bere, una sabbia finissima che cosparge e benedice ogni angolo della casa, che si appiccica sul letto, sulla moquette, sui divani di pelle, quando ce li hai. Una noia, la sua, presa, esaminata ed esaltata all’inverosimile (del tutto vero). Una noia che non ci sembra noia, ma che altro non è se non noia nella sua forma più pura. La bravura di Bukowski, veramente poco opinabile, per quanto non necessariamente apprezzabile, soprattutto nel mio modo entusiastico, credo consista nell’aver reso assolutamente normale il grottesco della quotidianità noiosa, stronza e soffocante, rendendolo quasi attraente, sognabile, seppur nella sua insignificanza di sostanza e di cui lui è sì tanto consapevole da ubriacarsi di continuo.
“Donne” è il miglior romanzo di Bukowski, in cui si massifica ed enfatizza non solo uno stile di vita, non solo una visione d’esistenza, ma in cui sono descritti con una precisione pignola, pedante e maniacale tutti gli aspetti caratteristici della sua scrittura e delle sue storie: l’alcol e la sua assunzione costante per far accadere qualcosa o distrarsi dal fatto che non accade nulla; le conversazioni dirette e senza filtri di morale; l’essere in un luogo senza neanche saperne il perché; le donne continuamente cambiate come mutande sporche; il sesso meccanico e spassionato, popolarmente lurido e pornografico nelle inquadrature incessanti e particolareggiate nella loro essere semplicemente così. Leggere Bukowski è come guardare un film pornografico anni ’80, con un filtro dai toni caldi e sfocati, con una trama intrigante, ma inconsistente, ed un fluire di “cose messe lì” ed esaltate al solo scopo di produrre una sensazione di eccitante trasgressione totalmente fine a se stessa. Mai come in Bukowski il senso del “qui ed ora” prende corpo e assume una forma concretissima nel suo affaccendarsi nelle strade assolate percorse da sandali slabbrati e talloni ruvidi di certe donne. Tra tutte, però, Laura. Solo lei. E l’amore. E come tutto, d’improvviso, possa mutare.
M.

#1 : gli scrittori

#2 : "in culo alla morte"

#3: il cinema

#4 : "poi, lentamente"

#5 : le belle donne

#6 : "e poi basta"

#7 : gli scrittori, ancora

#8 : "si beve per far succedere qualcosa"

#9 : "e l'amore?"

#10 : le scelte

#11 : lo slancio

#12 : la morale
#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#charles bukowski#donne#tea#tealibri#edizionitea#teadue#editore#libro#citazione libro#frasi libro#fotografia#recensione#letturacondivisa#letturaconsigliata#martaacciaro
0 notes